Wie Blumen
(/viewuser.php?uid=953008)
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** 1.01 - Occhi di Cielo ***
Capitolo 2: *** 1.02 - Gibsy ***
Capitolo 3: *** 1.03 - I Trollmann ***
Capitolo 4: *** 1.04 - Ancora di salvezza ***
Capitolo 5: *** 1.05 - Quelli come noi ***
Capitolo 6: *** 1.06 - Buone intenzioni ***
Capitolo 7: *** 1.07 - Schönower Heide ***
Capitolo 8: *** 1.08 - Divergenze tra Trollmann ***
Capitolo 9: *** 1.09 - Io non gioco ***
Capitolo 10: *** 1.10 - Figlio della guerra ***
Capitolo 11: *** 1.11 - Il culmine ***
Capitolo 12: *** 1.12 - Necrologio ***
Capitolo 13: *** 1.13 - Il riscatto di Rukeli: lo zingaro re di Germania ***
Capitolo 14: *** 1.14 - Icaro ***
Capitolo 15: *** 1.15 - Il lupo tra i leoni ***
Capitolo 16: *** 1.16 - L'orgoglio di Rukeli ***
Capitolo 17: *** 2.17 - Perdere il controllo ***
Capitolo 18: *** 2.18 - Lo stilista di Ostrava ***
Capitolo 19: *** 2.19 - Ogni respiro è per te ***
Capitolo 20: *** 2.20 - Alla maniera di Johann Trollmann ***
Capitolo 21: *** 2.21 - Facciamo un gioco ***
Capitolo 22: *** 2.22 - Nessuno è come Gipsy ***
Capitolo 23: *** 2.23 - Rita ***
Capitolo 24: *** 2.24 - Tutto cominciò da uno sguardo ***
Capitolo 25: *** 2.25 - Un posto nel mondo ***
Capitolo 26: *** 2.26 - Devlesa ***
Capitolo 27: *** 2.27 - Io non vorrei ***
Capitolo 28: *** 2.28 - Farà freddo senza di te ***
Capitolo 1
*** 1.01 - Occhi di Cielo ***
INTRODUZIONE
Sì, si tratta di un romanzo biografico. Sì, si parlerà di un atleta.Prima di rischiare il linciaggio, vi dico che ho letto il regolamento e so che non si dovrebbero postare storie sugli sportivi. Ma io l'ho fatto comunque e non perché sono trasgressiva, ma perché: 1. Lo sportivo in questione è morto da un pezzo, non credo si offenderà. 2. Non è solo una storia sportiva: la vita da atleta riguarderà solo la prima parte. Il resto della storia sarà pressoché romantica e drammatica. Scrissi un messaggio all'amministrazione, un mese o due fa, perché effettivamente è una storia a metà tra il "sì, si può pubblicare" e il "no, scordatelo", perciò volevo delucidazioni. Alla fine ho deciso di farlo comunque, magari qualcuno la noterà e deciderà di tirarmi le orecchie perché non si fa oppure dirmi che va bene comunque. O la va o la spacca, se anche viene cancellata da qui, io continuerò ad aggiornarla su Wattpad. In molti hanno raccontato la storia di Johann Trollmann: autori (uno a caso? Dario Fo), cantanti, attori teatrali. È stata raccontata mille volte. Ne parlano giornali, articoli su internet, video in spagnolo su youtube(?). Giustamente si soffermano tutti sulla carriera sportiva di Trollmann e il gesto assoluto di scherno alla razza ariana. Io però volevo concentrarmi su un altro aspetto, perché sono romantica e melensa dall'inizio dell'estate: l'amore. Trollmann rimorchiava tantissimo, non scherzo, però ci fu una donna sopra le altre e allora mi sono chiesta: perché? Cosa aveva di più rispetto a tutte le altre donne che ha avuto? Non ho trovato risposte, in quanto di quella che fu sua moglie non si sa niente. Mi sono rimboccata le maniche e ho montato su un personaggi, inventandomi ogni cosa di lei eccetto il nome e le origini cosacche. Vedetela così: è la storia d'amore di due sub-umani durante il Terzo Reich. Inoltre ho voluto scrivere questa storia per dare un contributo alla sua diffusione. Perché non è possibile che venga ignorata e sepolta solo perché Trollmann era uno zingaro, non si può. È disumano. È una storia carica di potenza e di sfida, e non ci abbozzo che venga ignorata. Ho scritto questa storia cercando la verità dietro ogni fotografia di Trollmann, ho fatto ricerche e letto un sacco di documenti, alla fine sono persino riuscita a ricostruire - almeno in parte - la sua personalità. C'è un lavoro immenso dietro la semplice battutina di Trollmann, o dietro il semplice gancio destro. Partiamo dal fatto che non sono nemmeno appassionata di boxe e non ci capivo nulla: mi sono dovuta far aiutare da mio fratello, pugile, per capire cosa significava la vittoria ai punti, il knock-out tecnico, il jab HAHAHA. Ho guardato gli incontri di pugilato di città e su internet, anche quelli degli anni '30, per cercare di capire l'ambiente e i vari ruoli (giudici, arbitro, secondi). Mi sono fatta una cultura, okay HAHAH DISCLAIMER
Le informazioni su Trollmann sono reperibili su internet. Io come fonti ho utilizzato:
- Johann-trollmann.de - fighstat.com / boxrec.com - rukelitrollmann-it.wixsite.com - "Buttati giù, zingaro" (Roger Repplinger, edizioni UPRE ROMA) Spunti per ricostruire il suo carattere li ho presi dal libro di Repplinger, in cui riporta alcune testimonianze della cognata, dei fratelli e degli amici in merito alla personalità (o che la lasciano intendere) di Trollmann. Vengono riportate anche stralci di articoli della rivista sportiva di settore Box-Sport, ma è affidabile solo in parte in quanto verrà poi "arianizzata" e spargerà diffamazione sul pugile. Ho scritto questa storia basandomi dunque su fatti reali, cercando la verità dietro ogni foto. Con l'aiuto di libri, di testimonianze, di musica e di immagini. Su internet è presente un video che include 10 secondi di uno dei combattimenti di Johann Trollmann. * * *
Atto primo:
Il pugile Questa è la storia di un pugile impigliato tra pezzi di memoria e filo spinato. Nato 'zingaro da sterilizzare', la danza dei guantoni faceva innamorare. Esplose ad Hannover la mia fama di campione: per tutti Rukeli, l'albero, era il mio nome. - C.F.F., "Come fiori" 1 - Himmel Augen
Tirava di boxe da quando aveva otto anni.
Aveva cominciato per gioco, nel fango di Tiefanthall ad Hannover, con gli amici di merenda e piccole scorribande di quartiere. Ma dal gioco era nata la passione, e aveva cominciato a frequentare una palestra popolare che si appoggiava in una scuola elementare in via Schaufelder. Interruppe gli allenamenti solo a causa dello scoppio della Guerra, che l’hanno costretto a trasferirsi con la famiglia nelle campagne dello zio. Smise di tirare di boxe ma cominciò con la doma dei cavalli. E piccole lotte nel fango del pollaio. Il piccoletto aveva un’idea molto chiara della situazione politica della Germania. Cominciò ad ammirare personaggi con la forte morale: il gladiatore Spartaco, da cui trarrà sempre ispirazione, e Rosa Luxemburg, politica rivoluzionaria. L’uno fu lo schiavo che si ribellò all’impero romano, l’altra la donna sostenitrice del marxismo che fu assassinata per aver raccontato la verità. E poi? E poi era tornato ad Hannover. Si era unito alla BC Heros, veniva allenato da un ebreo. Era diventato campione regionale. Poi campione della Germania del sud. Poi campione della Germania del nord. Poi campione nazionale dei pesi medi dilettanti. Inanellava vittorie importanti. Fresco dell’ultimo titolo di campionato, aveva partecipato alle selezioni per le Olimpiadi di Amsterdam. Era arrivato in finale e l’aveva vinta. L’avversario era un pugile che aveva sconfitto altre volte, una vittoria facile e già prevista. All’ultimo momento, prima della partenza per i giochi olimpici, lo mandarono via. Venne preso il perdente. Era tornato ad Hannover, l’amaro in bocca. Era stato mandato via dalla BC Heros, insieme all’allenatore ebreo a causa del Mein Kampf. Si era unito alla BC Sparta Hannover-Linden, l’associazione sportiva dei lavoratori più famosa di Hannover, grazie all’amico Paul Schubert. Ed era stato trovato, finalmente, da un organizzatore del piccolo ring a Berlino. Un biondino con la cravatta, faccia grassa e precisa scriminatura laterale, la pancia gonfia da bevitore e la pipa sempre tra le labbra. Aveva guardato i corpi fumanti e scolpiti dei giovani pugili dilettanti, che si erano sfidati sul quadrato per farsi notare da lui. Ma Ernst Zirzow era lì per trovare lui. Non aveva idea di che aspetto avesse, sapeva solo che picchiava così veloce che neanche lo vedevi. E l’aveva trovato, infine, quel dì di giugno del 1929. Johann Trollmann, ventuno anni. La pelle calda e ambrata, i ricci neri, gli occhi neri e dal taglio famelico come quello dei lupi, le labbra carnose, i lineamenti decisi. I muscoli scolpiti, le gambe lunghissime ed agili, veloci. Johann Trollmann in quella palestra brillava come il sole, dotato di luce propria. Ernst Zirzow l’aveva guardato, aveva capito che la boxe, dopo di lui, non sarebbe mai più stata la stessa: quel pugile avrebbe rivoluzionato quello stile di combattimento statico e violento, con uno stile movimentato, agile, leggero. Era bravo e lo sapeva lui stesso, ma probabilmente quel ragazzo non immaginava il potenziale che aveva. Aveva visto anche che dopo aver vinto l’incontro con lo sparring partner aveva lanciato i guantoni e fatto un urlo di gioia, con tanto di linguaccia giocosa al perdente. Zirzow aveva arricciato il naso. Gli altri erano rimasti calmi e disciplinati anche se avevano vinto. Sembrava che non gli importasse del giudizio che quel manager si sarebbe fatto su di lui, come se volesse fargli capire che: “O mi prendi per come sono, oppure quella è la porta”. E Zirzow, un talento del genere, non se lo sarebbe lasciato sfuggire, a prescindere da ogni presunta complicazione caratteriale. «Come si chiama quello lì?» aveva domandato all’allenatore. Quello sembrò quasi scoppiargli a ridere in faccia. «Perché, vuoi allenare lui?» «Diavolo, dimmi solo come si chiama!» «Johann Trollmann, ma lo chiamano Rukeli. Zirzow, quello ti farà dannare. E poi è sinti» «Uno zingaro?» L’allenatore si strinse nelle spalle. «Tra i zingarelli il pugilato va forte, Rukeli combatte da quando aveva otto anni». Zirzow non aspettò un momento di più. «Ehi, tu! Trollmann!» Rukeli si voltò appena, lanciandogli un’occhiata oltre la spalla, con la coda dell’occhio. Le labbra tradirono un sorrisetto compiaciuto. Il manager, a vederlo con quell’espressione soddisfatta, boriosa, capì da subito che sarebbe stata dura gestirlo. «Vuoi diventare pro?» Stavolta il ragazzo si girò del tutto, le mani sui fianchi. «Io ci vengo con te, so fare solo questo. Ma ad una condizione» gli disse, un sorriso da mercante si aprì sul suo bel viso. «E sentiamo, cosa vuoi?» «Una moto.» allargò le braccia «E poi passo al professionismo». Zirzow si era passato una mano sulla faccia. Ad uno così, che tirava i guanti, urlava, faceva le smorfie, che si dimostrava da subito un ribelle… come poteva infilargli in testa la tecnica che volevano i tedeschi? Johann Trollmann aveva la testa dura, non teneva la disciplina. Ma il suo più grande difetto era un altro, apparteneva ad un popolo scomodo: era un sinti, uno zingaro. Baracche e burattini, Johann aveva seguito Zirzow a Berlino e se ne stava in una brandina sul retro della palestra. Gli andava bene, si adattava senza problemi in fondo. E poi, la mattina poteva cominciare subito con gli allenamenti. In palestra aveva avuto piccoli incontri con alcuni compagni, ancora non lo accettavano. Per alcuni era sempre lo “zingaro campagnolo”, il pugile “ballerino” che si muoveva come una scimmia. Poi aveva messo al tappeto uno che pesava sei chili di più, e aveva avuto la considerazione di tutti. Walter Leyendecker, l’allenatore, gli insegnava molte cose. Gli dava un indirizzo specifico. I suoi allenamenti erano estenuanti: corda, sacco, sparring, vuoto. Due volte alla settimana li portava in un centro di autobus e camion, e li faceva allenare con gli enormi pneumatici. Altre due volte la settimana gli esercizi si concentravano sul saper incassare. Ma aveva visto che Johann non era un ottimo incassatore, pur essendo forte fisicamente. «Sentimi, ragazzo» gli aveva detto un giorno, «tu sei una scheggia. Mi hai capito? Perciò fai una bella cosa: anticipa». E non gli erano servite altre parole. Anticipava l’avversario. Manteneva il contatto visivo e non distoglieva lo sguardo. E poi lo sentiva, sentiva quando stavano per partire i colpi, li vedeva prima. Si muoveva velocissimo ed entrava nella zona d’ombra dell’avversario. I suoi allenamenti si concentrarono su quella tecnica basata sulla velocità e la potenza, e sul fiato. Se voleva essere veloce e potente, doveva allenare il fiato. Johann non si stancava, aveva i polmoni d’acciaio. Il suo primo incontro da professionista, contro Willy Bolze, si disputò il 18 ottobre 1929 alla Spichernsaele di Berlino. Johann considerava Bolze un pugile scadente, visti i risultati precedenti. Combatteva tra i professionisti dal 1926 eppure non aveva vinto nemmeno una volta. Inanellava pareggi e sconfitte. La notizia che uno zingaro combatteva tra i professionisti di Germania, fece il giro di tutti i giornali del Paese. Cartelloni che annunciavano l’incontro erano in ogni angolo della città. Non si parlava d’altro. Venne il grande giorno. Fuori la Spichernsaele c’erano ammassati giornalisti in attesa di vedere questo famigerato zingaro. Johann era nello spogliatoio, sentiva la folla sugli spalti fare un gran chiasso. Aveva vinto quattro campionati, forse qualcuno lo conosceva pure a Berlino, ma non aveva mai combattuto in una grande città come quella, e nemmeno di fronte a tutta quella gente. «Ora rilassati e pensa di stare in palestra, a prendere a pugni la tua dannata ombra» gli aveva detto Leyendecker con un sorriso. Era un uomo possente, in passato era stato un pugile anche lui, dei pesi massimi. E ora si era ritrovato a gestire un indisciplinato peso medio. «Magari Bolze va al tappeto prima» commentò con un sorrisetto sardonico. «Ascolta, ragazzo. Al tappeto potresti andarci tu, se quel Bolze è indiavolato. Non sottovalutarli gli avversari» lo rimproverò stringendogli le fasce attorno agli avambracci. «Non lo sto sottovalutando.» replicò Johann «Parlo in base ai risultati precedenti. Dal ’26 ad oggi». E di fronte a quegli occhi neri, profondamente intelligenti, l’allenatore lasciò cadere il discorso. Accompagnò, insieme a Zirzow e l’aiutante Kaspar, il ragazzo alle bilance per misurare il peso. L’arbitro misurò Johann. «Centocinquantasei libbre! Settantuno chilogrammi». Qualche giornalista si accanì sul ragazzo, tempestandolo di domande. Zirzow si adoperò prontamente per scansarli. «All’angolo destro, in calzoncini bianchi. Ventiquattro combattimenti dal ’26. Willyyyy Bolze!» annunciò lo speaker «All’angolo sinistro, calzoncini neri. La novità di Berlino e il novellino del professionismo, signore e signori, lo zingaro. Johaaaaaann Trollmaaann!». Entrambi gli atleti erano ai loro angoli. Johann si tolse l’accappatoio nero, sfoggiando il corpo statuario. Le donne tra il pubblico esplosero in grida ed applausi d’apprezzamento. Il ragazzo si voltò a guardare l’allenatore e il manager, piacevolmente sorpreso, poi i suoi occhi tornarono sulla platea. Fece un timido cenno di saluto, e le acclamazioni si fecero più forti. «Ma per me?» si domandò, indossando i guantoni, incapace di distogliere lo sguardo dal pubblico. Non importava più se i flash delle macchine fotografiche gli dessero fastidio agli occhi. «E per chi sennò?» gli fece Leyendecker «Ma ti sei mai guardato allo specchio, ragazzo?» Non era la prima volta che le donne facevano quel baccano vedendolo. Gli capitava anche quand’era ragazzino e combatteva per i titoli regionali. Le ragazze della sua età lo osannavano, lo aspettavano dopo gli incontri, spesso andavano a cercarlo in palestra o a scuola. Una volta una di loro gli disse che aveva litigato col fidanzatino per Johann. E lui ci parlava con loro, scambiava due parole con chiunque volesse, parlando del più e del meno per una decina di minuti e poi si salutavano. Già a quindici anni mostrava un fisico da apollo, figurarsi ora che ne aveva ventuno ed aveva intensificato gli allenamenti. Pettorali e addominali scolpiti, il trapezio possente, i deltoidi perfettamente disegnati, le spalle larghe e il bacino stretto; le gambe lunghissime ed agili, muscoli elastici per un combattente che puntava all’agilità. E poi quel viso. Quel fascino tenebroso e selvaggio, così diverso dall’uomo tedesco tipico che aveva annoiato le donne di Berlino. «Te l’avevo detto che ti avrebbero ricoperto di attenzioni, qui» rise Kaspar, un compagno di palestra, un peso massimo, che gli faceva da aiutante. Johann indossò il paradenti e si fece aiutare a mettere l’altro guanto. Suonò il gong. Fu un incontro lampo. Lo proclamarono vincitore dopo solo un round. Johann ci rimase quasi male per averlo messo al tappeto così in fretta. Era stato preso dalla foga di dimostrare qualcosa a quegli sguardi di scherno. Nessuno dava un soldo di fiducia allo zingaro di Hannover, cresciuto tra scorribande e vicoli malfamati. Invece aveva buttato al tappeto Bolze. Al pubblico era piaciuto. Era piaciuto quello zingaro scherzoso, che tuttavia boxava con intelligenza. Gli appassionati e i giudici se n’erano accorti, ed era piaciuto. Per festeggiare, Zirzow e Leyendecker lo lasciarono stare tutta la serata, affidandolo a Hans e Kaspar. Il primo aveva ventitré anni, era alto, non particolarmente muscoloso, riccio e castano, aveva anche le gambe leggermente storte; il secondo aveva l’età di Johann, era un peso massimo, con la testa rasata e gli occhi piccoli, che gli aveva fatto da aiutante. Inoltre, con Kaspar si conoscevano già poiché ai campionati regionali amatoriali partecipò anche lui. «È ora di goderti la nottata, fratello.» gli disse Hans «Conosciamo un pub dove ci sono Fräulein niente male! E vista la tempesta di ormoni che hai scatenato lì dentro con un semplice saluto, direi che se scambi due parole con una donna la mandi in tilt!». Il locale si chiamava Der Blume. Era un pub alternativo, con musica jazz, manifesti femministi e marxisti. Sembrava ricavato dal vagone di un treno, le luci erano soffuse e morbide. Si accomodarono al bancone principale per ordinare delle birre. Signorine con aderenti abiti grigio antracite e cappellini giravano come ballerine tra i tavoli a prendere ordinazioni. La ragazza che servì Johann, Hans e Kaspar doveva avere venticinque anni. Era bella, riccia e mora, le labbra dipinte di rosso e le ciglia truccate di nero a risaltare gli occhi verde scuro. Fece un sorriso a Johann, che lui ricambiò con uno dei suoi. Kaspar gli mollò una gomitata. «Hai visto? Basta poco. Gli fai uno dei quei tuoi sorrisi da latin lover di Hollywood e ti cascano ai piedi» «D’accordo, d’accordo» rise. Quando arrivarono le birre ordinate, il fazzoletto di Johann aveva sopra stampato un bacio e c’era scritto un indirizzo. I suoi due amici esplosero in applausi scroscianti e pacche sulla schiena. Il ragazzo invece, era rimasto un tantino basito da come le donne berlinesi fossero aperte ad avances. Si allargò il colletto della camicia. Ci avrebbe pensato poi, ora doveva ingurgitare birra. Un’ora e mezza più tardi, i tre erano quasi ubriachi marci. Hans se ne andò a casa prima di far precipitare la situazione, Kaspar uscì per vomitare ma poi restò accasciato ad un palo della luce. Johann era rimasto dentro, la testa abbandonata sul bancone. Voleva riprendersi un attimo prima di andare a far visita alla cameriera con i capelli ricci. Chiese diversi bicchieri d’acqua. Si strofinò il naso, abbastanza soddisfatto di come si stava riprendendo in fretta e fosse piuttosto lucido. Si voltò, afferrando il cappotto per andarsene. Nell’esatto momento in cui si girò, vide quella scena. Un uomo sui quarant’anni, totalmente ubriaco e ben vestito, aveva allungato una mano sotto la gonna di una cameriera sui diciotto anni. Ma prima che potesse sghignazzare con il suo amico, la ragazza si era voltata per istinto. E per istinto gli aveva mollato un gancio destro in pieno viso, facendogli girare la testa dall’altro lato. Fu fulminea e lapidaria. L’uomo si alzò per metterle le mani addosso. Johann scattò in avanti, piazzandosi davanti a quella ragazzina. «Ehi, amico! Da quanto tempo che non ci vediamo, come ti vanno le cose?» improvvisò. «Non so chi sei, ma ti consiglio di toglierti di mezzo, ragazzo» biascicò. «Non credo sia possibile, mi spiace» allungò un braccio indietro, quasi volesse proteggere meglio quella ragazza. L’uomo gli sferrò un pugno al volto, ma lo prese male perché Johann fu più svelto e si spostò di lato. Entrandogli nella guardia, gli mollò un montante allo stomaco e lo mandò a terra. La cameriera fece capolino con la testa oltre le spalle del pugile, per sbirciare. Alzò gli occhi al cielo. «Tu, vieni con me» mugugnò al suo salvatore. Johann non fece domande e scavalcò il corpo agonizzante dell’uomo per seguire la ragazza. Non era tanto più piccola di lui, ma era senz’altro bassa. Non arrivava ai centosessanta centimetri probabilmente, e a lui, dall’alto dei suoi cento ottantatré centimetri, sembrava una bambina. Lei lo portò sul retro del locale, nella cucina ormai deserta. Aprì la cella frigorifera e ne estrasse un cubetto di ghiaccio. Gli fece un cenno distratto per farlo sedere. Lui saltò sopra uno dei sgabelli ai lati delle pareti e quando lei si voltò, la guardò per la prima volta. I capelli biondi come l’oro, leggermente arruffati e lunghi fino alle spalle. Ma gli occhi. Quegli occhi di cielo, infiniti e limpidi. Per Trollmann, fu il primo knock-out. La ragazza gli si fece vicino, ora erano alla stessa altezza, gli passò il cubetto di ghiaccio sullo zigomo arrossato. Poté ammirare il calore di quella pelle d’ambra, quella piccola cicatrice a forma di mezzaluna appena sotto l’occhio, e l’altra sulla parte finale della palpebra. «Almeno non ti viene il livido» gli spiegò, senza dargli troppa importanza. «Per un attimo ho temuto che mi rifilassi una busta di piselli o una bistecca» La cameriera sbuffò un sorriso sardonico. «Ti sei divertito stasera, svenuto sul bancone tre quarti del tempo?» «Mi sono divertito di più a vederti mollare quel destro al maniaco» le strizzò l’occhio. «A proposito, grazie. Quello viene qui tutte le sere e mi mette sempre le mani addosso» Johann si rabbuiò. «In che senso?» «Mi tocca dove non deve. Stasera ho infranto una bella regola» arricciò il naso. «Se mi dici i tuoi turni, vengo e te lo tengo lontano» Lei scoppiò a ridere, in una risata limpida e melodica che lui trovò molto bella. «Sei un buttafuori per caso?». Soddisfatta del lavoro con il cubetto di ghiaccio, diede un’ultima occhiata e lo posò di nuovo nella cella frigorifera. Si pulì le mani sulla gonna, senza badarci troppo. L’aveva guardata tutto il tempo: il suo viso dolce tradito dai sorrisi furbetti, quelle occhiate che gli lanciava di tanto in tanto da sotto le ciglia, l’atteggiamento scherzoso con cui si rivolgeva, la spontaneità nei gesti e negli sguardi, le curve dolci, quegli occhi infiniti. Aveva deciso che gli piaceva, gli piaceva quel fare sfrontato che mai aveva visto in altre gagé tedesche. Non aveva quel fare da chi ha voglia di una sveltina e non era ingessata. Lei sparì nel retro del locale, mentre la sala si svuotava. Johann l’aspettò fuori la porta, appoggiato ad un palo. Si accese una sigaretta, gliel’aveva passata Kaspar durante la sfrenata bevuta. Guai a loro se Leyendecker l’avesse saputo. Si guardò intorno, scrutando i visi di coloro che uscivano dal locale, in cerca della cameriera dai capelli ricci. Ma forse era a casa ora, e lo stava aspettando. Fece un passo verso la strada, ma poi si ricordò di quegli occhi di cielo. Non stasera. C’è qualcuno che voglio conoscere sul serio, prima. La ragazzina era uscita dal locale e si era fermata in mezzo al marciapiede. Indossava un paio di pantaloni scuri e una camicia con le bretelle, i capelli legati e un Borsalino grigio sulla testa. Johann la guardò interrogativo. «Sei ancora qui?» lo incalzò. «Ti aspettavo… ma come ti sei vestita?» indicò i suoi abiti, sbuffando il fumo della sigaretta. «Non sono affaracci tuoi.» gli puntò il dito contro «Perché mi aspettavi?» «Volevo salutarti. Non ti arrabbiare, biondina.» si difese, alzando un sopracciglio «Vuoi fumare?». Lei annuì, guardandolo in tralice. Johann le passò la sigaretta e la ragazza prese una boccata senza staccargli gli occhi di dosso, indagatrice. «Non sei tedesco.» commentò, sbuffando il fumo dalle narici «Sei un arabo?» domandò, riferendosi ai suoi lineamenti, mentre gli passava di nuovo la sigaretta. Sembravano aver stretto il tacito accordo di una boccata a testa. «Sono tedesco» la corresse, «e sono sinti». Temette di bruciarsi, rivelandole di essere zingaro. Capitava che qualcuno si allontanasse per paura di essere derubato o ché. Ma quegli occhi di cielo gli proibirono di mentire, se anche avesse voluto. «Ah, come il pugile che ha combattuto stasera» disse invece lei, inaspettatamente su di giri a quella notizia. Lui contenne una risata. «Hai seguito l’incontro alla radio? Ti ci vedo come appassionata di boxe, spiegherebbe molte cose, come il gancio destro» «Simpaticone, in città non si parlava d’altro, tutti parlano di questo pugile sinti, quindi stasera abbiamo seguito l’incontro dalla radio del pub. Non ci capisco molto di pugilato, ma deve essere proprio bravo.» gli sorrise «Un cliente abituale del locale, stasera è andato a vederlo prima di venire al pub. Ha detto che un pugile così non si era mai visto in Germania. E se lo dice quello lì, che gli incontri di boxe li ha visti tutti…!» «Non so il tuo nome» se ne uscì lui, guardandola di sbieco. «Nemmeno io so il tuo» replicò, con un sorriso di sfida. Johann alzò gli occhi al cielo. «Mi chiamo Johann» «Io sono Frieda. Beh in realtà mi chiamo Olga, Frieda è il secondo nome. Ma Olga non mi piace. Quindi Frieda.» gli regalò un sorriso da squalo «Aspetta, ma ti chiami come il pu… Oh, aspetta un momento!» Johann scoppiò a ridere, una risata profonda e roca, rumorosa e contagiosa. Le schioccò le dita sui bordi del cappello, spostandoglielo leggermente. «Non sei una tipa molto sveglia, eh, biondina?». Per tutto il tragitto verso casa, Frieda lo tempestò di domande sull’incontro A lui piacque come lei non disse mai zingaro, ma sinti. Gli scaldava il cuore, gli faceva sentire come se essere nomade fosse la cosa più bella del mondo e non esistessero pregiudizi o discriminazioni. Johann le confidò che quello era il suo primo incontro da professionista, ma le disse anche che era parecchio tempo che combatteva e che aveva già vinto campionati dilettantistici e regionali. Le disse che aveva partecipato alle selezioni per le Olimpiadi di Amsterdam ma, pur avendo vinto, non era stato preso perché zingaro. Lei non gli disse niente di sé, solo che viveva con il padre e che si vestiva da uomo perché aveva paura di camminare in strada da sola la notte, con la gonna. Le aveva dato ragione. Si fermò davanti a un portone, Johann l’aveva accompagnata a casa ma non si avvicinò. «Abiti qui?» Lei gli rivolse un’occhiata sarcastica, dando uno scossone al portone per aprirlo. «No, in realtà ho una vita segreta e vado a derubare condomini passando dall’entrata principale» «Dunque ora ho una rivale eh» ammiccò. Frieda sorrise, cogliendo la battuta stereotipata sugli zingari. «È stato un piacere conoscerti e grazie ancora. E… Trollmann. Buona fortuna per tutto. Ci si vede». Ma sapevano entrambi che, probabilmente, in una città come Berlino non si sarebbero più visti. Due vite che si incontravano senza promesse per il futuro, come le linee rette incidenti. A Johann questo non stava bene. «Aspetta.» bloccò il portone con una mano prima che lei potesse chiuderlo «Ti trovo sempre lì?» «Sempre… Un parolone.» gli sorrise «Lì, qui, oppure in nessuno dei due posti» Sospirò rassegnato, pur non perdendo il sorriso. «Ci si vede, allora. Buonanotte». Frieda ripensò a quell’incontro con un che d’orgoglio: Johann Trollmann aveva parlato con lei, non con le altre cameriere; aveva accompagnato lei, aspettato lei. Frieda non era tipa da perdersi in fantasticherie adolescenziali, seppur avesse appena diciannove anni, sapeva che probabilmente non l’avrebbe incontrato più quel Trollmann. Al massimo l’avrebbe visto sui giornali, ma parlarci di nuovo così? Non erano in un film o in un romanzo, che tutto andava sempre bene. Aveva la sensazione di averlo già visto, eppure era la prima volta che lo vedeva e non c’erano sue foto in giro per Berlino. Forse in un sogno. |
Capitolo 2
*** 1.02 - Gibsy ***
2 - Gibsy
4 luglio 1930 Da ottobre a luglio, Johann aveva combattuto dieci volte. Quello sarebbe stato l’undicesimo incontro. Aveva inanellato nove vittorie, aveva perso solo una volta a gennaio contro Erich Tobeck. E solo perché era stato così testone da voler combattere con la febbre. Kaspar aveva quasi gioito. «Magari è la volta buona che qualcuno ti ha messo apposto quella testa dura che ti ritrovi». Johann aveva sorriso. Ma ti pare. Si stava facendo largo nella categoria dei divi. Munito di quella bellezza selvaggia e tenebrosa, di quel corpo statuario, e di quell’ironia e solarità, aveva tutte le carte in regola ed era sulla buona strada per diventare il pugile più amato della Repubblica di Weimar. I cronisti e i giornali gli davano sempre più attenzioni, e la sconfitta morale avuta con le selezioni per le Olimpiadi sembrava solo un ricordo lontano. Birreria Bock di Berlino, a Kreuzberg Fidicinstraße, l’incontro col feroce Vogel. Aveva combattuto contro di lui già una volta. Il giorno del suo ventiduesimo compleanno, il 27 dicembre 1929, ed aveva vinto per knock-out. Si era regalato quel trionfo. La birreria Bock aveva un grazioso giardino con lanterne di carta, gazebi in sottile ferro battuto e tavoli bianchi laccati. L’interno era una lunga sala con un corridoio centrale e i tavoli ai lati, in fondo c’era una rientranza con una struttura sopraelevata. La parete sinistra era fatta di enormi finestre, il soffitto di travi di ferro e lampadari rotondi, bianchi. Per quell’occasione, avevano montato il ring al centro della sala e avevano allestito i tavoli tutt’intorno. Il tavolo dei giudici era stato sistemato sulla struttura sopraelevata nella rientranza in fondo alla stanza per garantire una buona visuale. C’erano quasi mille persone. In ogni incontro di Trollmann, il pubblico aumentava di volta in volta. Johann era nello spogliatoio. Kaspar gli stava stringendo le fasce sulle mani. Zirzow si era messo a fumare la pipa e Leyendecker massaggiava le spalle al giovane sinti. «Non devo dirti niente, ragazzo. Conosci lo stile di Vogel, sai come muoverti, e in ogni caso faresti come ti pare» «Stasera ci sarà Schmeling a vederti.» gli disse Zirzow «E poi andremo a cena con lui e il suo manager» A Johann si mozzò il respiro. «Ma… il campione del mondo dei pesi massimi?» Leyendecker gli schioccò le dita sull’orecchio, facendolo voltare di scatto per la sorpresa. L’allenatore scoppiò a ridere all’espressione del ragazzo. «E chi sennò?» «E viene a vedere me?» «Smettila di fare il pugile campagnolo, con questa tua umiltà. Se sei umile non vai da nessuna parte, a Berlino.» lo imbeccò Zirzow «Certo che viene a vedere te. Hai un enorme talento, non immagini neanche, e un bell’impatto sulle masse». Johann ammutolì. Max Schmeling era campione mondiale dei pesi massimi da poco, ed era un modello da seguire per il giovane professionista. Non riusciva a credere che il campione era venuto a vedere lui. Durante le operazioni del peso, fecero una foto a lui e a Vogel. Johann sorrideva, le mani dietro la schiena, la faccia pulita, gli occhi innocenti; l’altro era più aggressivo nell’atteggiamento, i pugni stretti lungo i fianchi e il mento alzato, lo sguardo sprezzante. Quando il fotografo finì di scattare la foto, Vogel gli lanciò un’occhiata di disprezzo. «Schmutziger Zigeuner» «Che hai detto?» lo incalzò Johann. «Ho detto che sei uno sporco zingaro. Ci vediamo sul ring, pagliaccio» e sputò di lato, voltandosi e andandosene. Era la prima volta che qualcuno lo disprezzava così apertamente, da quand’era a Berlino. Quand’era arrivato, credeva che certe cose nella boxe non contassero, che l’unica cosa che contava era il modo di boxare a prescindere dalle origini. Invece non era stato così. Dal suo debutto con Bolze, i giornali e i cronisti, e ora anche Vogel, rimarcavano le sue origini sinti e lo chiamavano zingaro. In generale senza disprezzo, ma a volte qualcuno lo diceva quasi volesse insultarlo. Ma Johann era questo, non doveva dimostrare di essere nessun altro. Salì sul ring. O meglio, saltò sul ring. Aveva deciso, da qualche incontro, che quella sarebbe stata la sua entrata in scena. Appoggiava la mano sul paletto e saltava le corde - a cento quarantacinque centimetri dal tappeto, se stava eretto lì vicino gli arrivavano appena sopra il gomito - a piedi pari, senza toccarle mai, e quando atterrava faceva un inchino che faceva esplodere la folla in una tempesta di applausi. Poi salutava con la mano e faceva scivolare via l’accappatoio dal corpo ambrato. Infine indossava i guantoni, e Kaspar l’aiutava a mettere il paradenti. Vogel era agguerrito, aggressivo. Cercava di costringerlo al combattimento ravvicinato ma Trollmann scivolava via, come il vento. Lo colpiva con jab di disturbo, gli sorrideva, e lo infastidiva con colpetti leggeri. Il puro gusto di dare spettacolo, e di dar fastidio a qualcuno che lo disprezzava. Poi aveva cominciato a picchiare più forte, nascondeva le rocce dei pugni dietro sorrisi. Infine aveva vinto ai punti. Una donna dai capelli nocciola gli lanciò un bacio. Lui scherzò, fece finta di afferrarlo e barcollò sul quadrato, inscenando uno svenimento. La folla rise, e anche Leyendecker. «Oh, piantala di fare il giullare!» aveva sorriso poi, trascinandolo via dal ring. Sputò il paradenti nel secchio di Kaspar e si gettò l’asciugamano sulle spalle. Non era sudato, solo un po’ sulla nuca. «Bell’incontro» cantilenò una voce familiare, mentre Johann si avviava verso lo spogliatoio. Non seppe dire con certezza come fece a sentirla, nel trambusto, ma si voltò. Incrociò due occhi di cielo e un ampio sorriso si aprì lentamente sul bel viso del pugile. Fece dietrofront, andando da Frieda. Come se una melodia lo incatenasse alla sua voce e lui non fosse in grado di resistere. «È la prima volta che ti vedo qui» disse solo. «Non seguo il pugilato, di solito» gli sorrise furbamente. Aveva una molletta che teneva a bada i capelli d’oro al lato del viso. Una camicia leggera a maniche corte, color crema, infilata nell’elastico della gonna a vita alta che non arrivava nemmeno alle ginocchia. Ai piedi, due graziose scarpe basse che lasciavano scoperto il collo del piede. «Quindi in altre parole sei venuta per me.» le fece un sorriso malizioso «Sono felice di rivederti. Ti trovo in forma» «Anche io mi trovo in forma» « “Grazie Johann, sei stato così bravo questa sera!” » simulò la voce da donna, sfarfallando le ciglia, prima di guardarla con un sopracciglio alzato. «Come sei egocentrico. Hai già le tue ammiratrici pronte a dirtelo e cadere ai tuoi piedi» replicò Frieda, con un sorriso malizioso, riferendosi al bacio lanciato da quella ragazza e intorno a cui lui aveva dato spettacolo. «Devo andare adesso, ho una cena con Max Schmeling.» ammiccò «Quando posso trovarti al pub?» «Non te lo dico» gli fece la linguaccia mentre si allontanava nella folla. «Non fare la preziosa!» le urlò, allargando le braccia «Okay, so dove abiti! Mi attacco al tuo campanello di casa nel cuore della notte, poi vediamo!» E nella folla, l’unica cosa che sentì fu la sua risata cristallina. Rise anche lui, e tornò nello spogliatoio. Durante la cena con Schmling e Machon, a Trollmann era stato offerto di seguirli in America e allenarsi lì con loro. Lontano dalla Germania. Lontano dalla sua famiglia. Lontano dalle bestie nere che attendevano smaniose nell’ombra. Aveva rifiutato. Il giorno seguente, in tarda mattinata, Rukeli saltò sulla sua nuovo motocicletta. Indossò il casco e gli occhialoni. Da Charlottenburg, dove abitava, arrivò fino a Zillestraße. Poco lontano. Il motivo era molto semplice. Frieda. Si fermò sotto il portone della ragazza, con la scusa di chiederle un favore aveva tutta l’intenzione di rivederla. E chissà, chiederle di uscire insieme, andare a bere qualcosa. Teneva con sé una busta di pantaloncini sportivi. Si avvicinò al citofono pieno di cognomi, ma non conosceva quello di lei. Al diavolo. Indietreggiò di diversi passi, fino al limite del marciapiede. «Frieda!» urlò, mettendo le mani vicino alla bocca per far rimbombare meglio la voce. La chiamò un paio di volte, qualcuno si affacciò per vedere chi fosse il pazzo che urlava sotto il palazzo. Alla fine, da una delle finestre centrali al terzo piano, si affacciò un viso conosciuto. La ragazza si appoggiò alla soglia della finestra, morse uno spicchio di arancia. «Sei completamente fuori di testa, Trollmann» Johann le fece un ampio sorriso, che lei ricambiò. «Sali. Terzo piano» gli disse poi e rientrò in casa. Pochi secondi dopo, sentì il ronzio del portone che veniva aperto. Il ragazzo salì le scale di corsa, al terzo piano trovò una porta aperta. Sul campanello c’era scritto Bilda. Entrò con cautela, chiudendosi la porta alle spalle. Si ritrovò in un piccolo ingresso con un comò al lato della porta, un orologio a pendolo e un attaccapanni. A destra una porta con i vetri portava nel salotto, a sinistra in cucina, e dritto di fronte a sé c’era un piccolo corridoio con altre quattro porte chiuse, probabilmente due camere, un bagno e un ripostiglio. Il pavimento era di legno chiaro, alle pareti c’era la carta da parati con un motivo floreale molto delicato, e quadri di paesaggi e qualche foto di quelli che dovevano essere i genitori di lei da giovani. Frieda era appoggiata al tavolo della cucina, il corpo avvolto da una vestaglia da camera in lino verde pastello, le gambe nude e i piedi scalzi. I capelli tutti arruffati. «Ti ho svegliata?» le chiese, facendo un passo nella sua direzione. «No, figurati. Ci pensano i vicini a svegliarmi, di solito.» sbuffò un sorriso «Posso offrirti qualcosa?» «Acqua, per favore». Si accomodò su una delle sedie intorno al tavolo, e osservò la ragazza trafficare nei scaffali e negli sportelli in cerca di un bicchiere e una bottiglia d’acqua minerale. Glielo passò facendolo scivolare sul legno del tavolo. «Una vera cameriera provetta» commentò, ironico. «Come mai sei venuto qui? Pensavo che ieri sera stessi giocando» non c’era acidità nella sua voce, solo divertimento. Una scintilla di sfida e ironia che brillava anche nei suoi occhi sfrontati. Lui sorrise, mentre teneva ancora le labbra sul bicchiere. Poi lo posò, e si pulì i lati della bocca con la punta delle dita. «Tu sai cucire? O conosci qualcuno che sappia farlo?» «Dipende, cosa devi fare?» si sedette vicino a lui, nel posto a capotavola. Johann tirò fuori i pantaloncini dalla busta e li posò sul tavolo. Erano quattro paia: uno nero, uno bianco, uno grigio con le righe nere, uno grigio e basta. «Mi sembrano integri. Cos’hanno che non va?» gli diede un’occhiata, tastando il tessuto. «Non c’è scritto il mio nome.» rispose, asciutto «Sapresti apportare questa piccola modifica per me?» «Basta prendere un pennarello» lo prese in giro. Johann alzò gli occhi al cielo. «Dai, altrimenti devo cercare un sarto. Volevo prima chiedere a te» Lei si sentì importante. «Sì che lo so fare. Posso farteli subito se vuoi, non ci vorrà molto». Il ragazzo annuì, e quando lei si alzò, la imitò. La seguì in una delle camere da letto. La sua, probabilmente. C’era un letto singolo dalle lenzuola candide tutte sfatte, e un altro lettino ancora perfetto. Si chiese se avesse un fratello o una sorella, ma le foto sul muro gli fecero capire che era figlia unica. La stanza profumava di lavanda, alle pareti c’erano appese fotografie di Frieda da bambina. Una bella bambina con i boccoli biondi e con enormi occhi di cielo. Foto di lei con sua madre e suo padre. Foto con un enorme gruppo di persone, non avevano l’aria di essere tedeschi. Foto di cavalli, di maneggi, di una ragazza che tendeva un arco con la freccia incoccata e puntava al cielo, sempre avanti, sempre in alto. Foto di una ragazza con due medaglie al collo e una coppa in mano. Poi c’erano articoli di giornale incorniciati, con la foto di una ragazza a cavallo intenta a saltare un tronco d’albero. Datata 1928, la scritta dell’articolo recitava: Deutscher Meisterin, Reiten cross-country. Ricordava di aver letto quei giornali e quegli articoli. Non fece domande, non subito. Frieda si era seduta di fronte alla macchina da cucire, aveva preso il primo paio di pantaloncini che le capitava a tiro e aveva inserito il filo d’oro. Posizionò il tessuto nero sotto l’ago del macchinario. «Cosa vuoi che ci scriva? Johann, Trollmann, oppure…? So che i tuoi sostenitori ti chiamano solo Troll, magari potrei…» gli chiese, riscuotendolo dai suoi pensieri. «Gibsy» la interruppe, distratto. Lei si girò col corpo per guardarlo. «Vuoi che ti scriva “zingaro” sui pantaloncini? Davvero? E perché con la b, Gibsy?» Johann fissò i suoi occhi neri in quelli di cielo. «Sui giornali mi chiamano Gipsy. Voglio stare al gioco, ma come dico io, quindi Gibsy. Mi chiamano zingaro, mi trattano da zingaro. Io sono zingaro e gli darò lo zingaro.» ripensò a Vogel la sera prima, con una punta di rammarico, tanto che abbassò appena la voce «Non voglio nasconderlo». Lei studiò il suo cambio di espressione, incuriosita. «Ti fai beffe di chi ti sbeffeggia.» sorrise «Mi piaci, Trollmann». Detto ciò, si voltò e cominciò a cucire la scritta d’oro sul tessuto nero. Lui si era seduto sul letto, e la guardava mentre lavorava. C’era qualcosa in lei che la rendeva diversa ma apparentemente ordinaria. Non aveva niente di più, fisicamente, rispetto alle altre donne tedesche, eppure era diversa. Non era come le altre. C’era qualcosa nel suo sguardo impertinente, una luce di libertà che sfavillava come fuoco. «Esattamente, quanti anni hai?» le chiese, inclinando la testa. «Diciannove. Saranno venti a settembre» «E sei così bassa?» la provocò. Lei non si voltò neppure, gli tirò il paio di pantaloncini appena finito dritto in faccia. «Stronzo di uno zingaro. Sei tu che sei alto.» stavolta lo guardò, con la coda dell’occhio «Che ti davano da mangiare, pane e concime?» «Beh sei un po’ bassa per me, in effetti.» meditò, considerando che c’erano venticinque centimetri di differenza tra loro «Ma per te potrei fare un’eccezione sai? Per il tuo umorismo» «Parli come se ce l’avessi solo tu» lo prese in giro bonariamente. «Che cosa?» Lei mimò il gesto della pistola con le dita della mano, senza voltarsi. Si girò solo per fargli un sorriso malizioso. «Il pistolino». Johann non riuscì a trattenere una risata. Fragorosa e roca, che coinvolse presto anche Frieda. Nessuna ragazza gli aveva mai parlato così. Era strano sentire una ragazza parlare così apertamente di quelle cose, di quei tempi. E poi, era difficile trovare una donna scherzosa come Frieda. Mentre le risate andavano scemando, la porta d’ingresso si aprì e si richiuse. Johann si allarmò, pronto a nascondersi. Non era bello farsi trovare in casa da solo con una ragazza. Lei, invece, restò tranquilla a cucirgli i pantaloni. Si fermò solo quando la voce di un uomo non troppo giovane la chiamò. «Sono in camera mia» si voltò verso la porta, appoggiandosi con le braccia allo schienale della sedia. Guardò Johann, ancora allarmato, e gli fece un sorriso più dolce di quel che sarebbe dovuto essere. Il padre di Frieda si affacciò in camera e vedendo il volto del pugile, quasi non gli caddero le braccia a terra. «Ma tu sei Johann Trollmann!» Il ragazzo scattò in piedi, un sorriso affabile e rilassato, da vero divo. Allungò la mano per stringere quella dell’uomo. Doveva avere circa cinquant’anni, gli occhi erano come quelli di Frieda, i capelli radi e biondo scuro, lo stesso colore dei folti baffi che caratterizzavano il viso. Il fisico possente nonostante l’età, la stretta di mano salda e forte. Il signor Bilda doveva esser stato forte come un toro da giovane. «È un piacere fare la sua conoscenza, signore» «Il piacere è mio, figurati. E chi se lo aspettava, il nuovo volto del pugilato tedesco in casa mia!» poi si rivolse alla figlia «Non mi avevi detto di voi due» «Papà, non farti strane idee.» sghignazzò «Ci conosciamo, tutto qui. Gli sto cucendo i pantaloncini» sventolò il tessuto in aria come una bandiera, mostrandogli infine il lavoro svolto. «Non me l’hai detto lo stesso.» borbottò il padre «Ti ha offerto qualcosa almeno?» domandò di nuovo rivolto a Rukeli. «Sì, signore» «Allora le sei simpatico» «Te ne vuoi andare? Stiamo parlando di cose serie» esclamò Frieda, esasperata. Johann aggrottò le sopracciglia. Il signor Bilda alzò le mani, ed uscì chiudendo la porta. Il ragazzo si appoggiò al tavolo con la macchina da cucire, per guardarla meglio, spavaldo. «Cose serie?» «Ti prego.» alzò gli occhi su di lui, sorridendo «Andava bene la scritta?» «Sì, non ho molte pretese» «Te la dovevi far andar bene comunque» replicò, con un sorrisetto furbo. «Sei tu?» indicò le pareti. Mentre attendeva la fine del suo lavoro, si era messo a sbirciare i titoli dei giornali incorniciati, aveva letto gli articoli. Campionessa nazionale di equitazione, disciplina cross-country, nel 1928. Pensò alle coincidenze. Lui veniva scartato dalle Olimpiadi, lei aveva toccato l’apice della sua carriera a soli diciotto anni. «Sembra una vita fa.» rispose in un sussurro «Non sono più campionessa» «Ti hanno spodestato? Troppo bassa?» cercò di sdrammatizzare. Lei sorrise. «Troppo cosacca. Troppo femmina. Troppo giovane.» alzò le spalle «Non potevano lasciare il titolo ad una come me, disonorava i tedeschi». Aveva toccato l’apice ed era caduta. Precipitata. E ora i ruoli si rovesciavano: lei cadeva, lui ascendeva. «Quindi sei cosacca. Russia?» «Ucraina. Ti ho deluso?» gli fece un sorriso da folletto dispettoso. Ma Johann lo vide, nel fondo degli occhi di cielo, una scintilla d’amarezza e frustrazione. Ecco perché lei non gli aveva parlato di niente, si vergognava. Gli slavi e in particolare gli ucraini, in Germania, non erano ben visti. Quasi al pari degli zingari. «E perché mai? Io sono sinti, che c’è di peggio?» ironizzò «Siamo così simili. Entrambi nomadi, entrambi scartati e visti sotto una cattiva luce dal mondo intero. Eppure siamo unici, sai? Proprio per le nostre tradizioni.» alzò le spalle «Dovresti imparare a fare della tua diversità, la tua forza. Cuciti una maglietta con scritto Kosak, io l’avrei fatto» «La fai facile tu.» gli sorrise, sardonica «Sei bello come un divo e bravo sul ring. E sei un uomo. Le donne non hanno vita facile. Sai no? La regola delle quattro K[1]. Se vedono una donna puntare troppo in alto, le tagliano le ali» fece il gesto delle forbici con le dita. «Mi hanno scartato dalle Olimpiadi, nel ‘28.» le ricordò «Tagliano le ali a tutti i diversi». Lei sbuffò un mezzo sorriso, lo sguardo più docile e mansueto. Gli passò un altro paio di pantaloncini, pronto. «Vedo che non sei uno che ragiona col pistolino o con i pugni allora, ce l’hai un cervello in quella testa riccioluta» «Va bene, allora visto che hai appurato che ho un cervello e hai ammesso che ti piaccio, ti farò una proposta indecente. Vuoi uscire con me?» [1] La regola delle “quattro K”. Concetto introdotto in Germania durante l’epoca Guglielmina, descrive con quattro parole in lingua tedesca il ruolo della donna: Kinder (figli), Kirche (chiesa), Küche (cucina), e Kleider (vestiti). |
Capitolo 3
*** 1.03 - I Trollmann ***
3 - Trollmann
«Incassa! Stringi quegli addominali!» gli urlò Leyendecker a bordo ring, le mani in tasca. Johann al centro del quadrato, le gambe piantate a terra leggermente divaricate, il mento incassato, i gomiti accostati al corpo. Sopportava pazientemente i colpi potenti di Kaspar. L’amico era più basso di lui, ma era un peso massimo col pugno di un orso. «Lui ci va leggero, ragazzo, ma Koska ci andrà giù pesante. Colpisci più forte, Kaspar!». Da due settimane avevano preso la decisione di provare a far combattere il giovane peso medio contro un peso massimo. Un orso di ottantacinque chili contro lo zingaro di settantuno. Johann strinse i denti sotto i colpi più forti dello sparring partner. «Se mi si incrina una costola e non combatto più sarà per colpa tua, vecchio» gli fece, accennando un sorriso di sfida. Leyendecker liquidò quella possibilità con un gesto della mano. Terminato l’allenamento, Johann si passò l’asciugamano sul corpo madido di sudore. Kaspar gli mollò un pugno giocoso al braccio, quasi a volersi scusare. In realtà Rukeli non voleva farlo quell’incontro, aveva paura. Quel bestione pesava quindici chili di più, e se ci restava secco? Alla fine ci avrebbe provato comunque, ma era preoccupato. Il pugilato è uno sport in cui si muore. In quel mese e mezzo non aveva più visto Frieda. Ogni tanto ci pensava, pensava di andare a salutarla, allora saltava sulla moto e andava al Der Blume. Non la trovava. Provava a casa sua, suonava al citofono e non gli rispondeva nessuno. La chiamava da sotto la finestra attirando sguardi severi, ma lei non si affacciava. Pensò che lei non volesse vederlo per chissà quale motivo, e se così fosse sarebbe stato bene chiarire. Non gli andava proprio di lasciar andare quell’amicizia. Un giorno era andato al pub, aveva chiesto di lei. Una ragazza di almeno ventitré anni, con i capelli rossi, bella come Venere, gli fece un sorriso di cortesia. «È partita. Non sapeva nemmeno lei quando sarebbe tornata» si strinse nelle spalle. «Tu sei sua amica?» si sedette al bancone. «Sì. Mi chiamo Hildi» lo guardò languida, «e tu sei il pugile Gipsy Trollmann» «Solo Johann» la corresse con un sorriso pieno di sottintesi. Lei inclinò la testa da un lato. «Come mai chiedi di Frieda?» «Non la vedo da un po’ e mi sono preoccupato. È mia amica» «Non credo proprio, non si diventa amici dopo un paio d’ore insieme, tesoro». Quella frase lo lasciò interdetto. Aveva pensato di chiedere a quella cameriera dai capelli rossi di vedersi più tardi, ma aveva un modo di fare che non gli piacque molto. Frieda era sfacciata e impertinente, ma aveva un atteggiamento molto leggero e bonario. Hildi no, sotto quell’impertinenza aveva una vena polemica e distruttiva, che non piacque molto a Johann. «Senti, se ti capita, dille solo che sono passato e che la saluto. E… dille di farmi avere sue notizie, se può» le lasciò un biglietto con l’indirizzo della palestra. Hildi fece un gesto d’assenso col capo e lui se ne andò in silenzio. Avrebbe dovuto mettere da parte il pensiero della ragazzina cosacca per il momento. 29 agosto 1930 Spichernsaele, Berlino. Quella sera, le mani di Johann Trollmann erano fasciate più strette per proteggerle meglio. Doveva essere rapido, picchiare forte, ricorrere ad ogni mezzo possibile e leale. Non poteva competere con quel bestione, poteva solo farlo stancare e smantellarlo. Ragionò un attimo sulla strategia da adottare, seppur ci fosse Leyendecker a parlargli nelle orecchie di una possibile tecnica da utilizzare. Gli stava massaggiando il braccio per sciogliere i muscoli e parlava, parlava e parlava. Sapeva che lo zingaro avrebbe fatto come voleva come al solito, ma doveva provarci a far valere le sue ipotesi. Johann Trollmann non l’ascoltava nemmeno. Eccolo di nuovo che saliva sul ring saltando le corde a piedi pari, la folla in delirio. Lanciò un bacio al pubblico e a qualche signorina alle prime file. Nei loro occhi lesse il desiderio, si compiacque dell’effetto che provocava alle ragazze. I suoi occhi si spostarono sul colosso di ottantacinque chili all’altro angolo. Il petto peloso come quello di un orso, gli occhi neri e piccoli come biglie. Rukeli trattene a stento una smorfia. «Non fare cose stupide.» gli intimò Leyendecker «Anticipa. Entragli nella guardia. Respira. Con lui non puoi giocare, Johann». Bisognava essere rapidi e concisi con Trollmann. Troppe parole distoglievano in fretta la sua attenzione volubile. «Speriamo che non dovranno raccogliermi con un cucchiaio quando quel grizzly avrà finito con me» borbottò, mentre Kaspar gli stringeva le cinghie dei guantoni. L’ultima parola uscì quasi sottoforma di sputo a causa del paradenti. Suonò il gong. Johann pregò ogni santo di non restarci secco sotto i pugni pesanti di quell’orso. Eppure si accorse in fretta che Koska non usava molto il cervello, puntava ai movimenti meccanici e alla forza bruta. Una mossa piuttosto pericolosa, quando si aveva a che fare con Trollmann, perché quelle mosse le conosceva e le anticipava tutte. Gli ronzò intorno mandando a vuoto ogni suo colpo. Il gigante si infuriava, metteva più rabbia nei colpi. Johann non distoglieva gli occhi dai suoi, gli leggeva l’anima e anticipava ogni movimento. Al quarto round Koska era stanco e infuriato per i jab di disturbo che gli rifilava lo zingaro. Non l’aveva colpito neanche una volta, era davvero umiliante. Il pugile ballerino non era né sudato né affaticato. Gli rifilò una serie di montanti e ganci che fecero traballare il colosso, e poi si allontanò con un paio di saltelli, a distanza di sicurezza. Lo scrutò a lungo con quegli occhi di lupo, un predatore a caccia. Aveva le braccia lungo i fianchi, camminava lungo il perimetro del ring. Golia in balìa di Davide, immobile al centro del quadrato. L’allenatore di Koska gli urlò di darsi una mossa e concludere il match. Leyendecker fischiò a Rukeli, gli fece segno di tenere la guardia alta. Trollmann non gli diede ascolto. Koska prese coraggio, si avvicinò allo zingaro masticando il paradenti. Solo allora Johann alzò la guardia, lo fissò negli occhi. Vide una vena sul collo del toro guizzare, capì che stava arrivando un gancio potente. Lo schivò come un gatto, e gli entrò nella zona d’ombra. Esplose in una raffica di colpi al costato e al viso. L’arbitro fischiò la fine del match. Vittoria ai punti per Trollmann, stracciante. La folla esplose in grida d’esultanza, urlavano il suo nome battendo i piedi a terra. Un peso medio aveva stracciato un peso massimo quindici chili più pesante, con velocità e intelligenza. Il ragazzo non si trattenne dall’improvvisare una danza fantasiosa e comica sul ring, che fece scoppiare a ridere la platea. Una moretta gli lanciò un mazzo di rose. La foto di quel gesto fece il giro della Germania. Lui afferrò quel dono, le sorrise in quel modo furbastro e rubacuori che solo lui aveva, e lei si sciolse. Hannover. Una settimana dopo era con l’amico Paul Schubert e Max Walloschke. Vecchi amici della Sparta Linden. Avevano deciso di vedersi in occasione di una gara di moto all’Eilenriede. Era arrivato alle tre del pomeriggio alla stazione centrale, Max era andato a prenderlo con la sua nuovissima macchina e Johann aveva commentato dando una pacca sul tettino. Poi insieme erano andati a prendere Paul, ed infine alla corsa di moto. Johann amava le moto da quand’era un ragazzino. La sua prima gara la vide a quindici anni, con i primi incontri dilettantistici in cui intascava un paio di marchi. Quanti bastavano per pagarsi il biglietto sugli spalti. La maggior parte delle volte ci andava da solo, poi tornava a casa e raccontava la gara ai fratelli più piccoli: con la mano destra simulava il gesto di dare gas e con la voce faceva ruggire i motori distinguendoli per marca, Albert e Stabeli scoppiavano a ridere ogni volta. Altre volte andava accompagnato, ma non sugli spalti. Johann, Julius e Ferdinand si arrampicavano sugli alberi vicino alla pista e stavano appollaiati sui rami. Era scomodo, ma si divertivano da matti. «So che ti sei fatto comprare una moto» cominciò Paul, dopo l’ondata di motociclette che passò in curva di fronte alla loro platea. «E devi sentire che rombo di tuono quando do gas!», imitò con la voce il suono della sua motocicletta. «Se fa davvero così, è una cagata!» lo prese in giro Max. «Tuona più forte.» si difese con noncuranza «Sempre meglio di quel pezzo di lamiera che chiami macchina» «Te la sogni! Non sai le nottate con le migliori Fräulein di Hannover in quella macchina!» «Fratello, non ho bisogno di una macchina per fare sesso in pace, non abito mica con i miei genitori» alzò una spalla, le sopracciglia inarcate in un’espressione trionfale. «Come sono le donne a Berlino?» domandò Paul. «Te ne presento qualcuna un giorno che vieni a trovarmi. Sono quasi tutte bellissime. Il loro profumo, i capelli, le labbra rosse. Qui non c’è quel tipo di donna, credimi» «E l’hai trovata quella sopra le altre oppure sei l’eterno scapolo?» La sua mente corse involontariamente a Frieda. Voleva davvero smettere di pensarci, a quella ragazzina, ma non ce la faceva. Guardava il cielo e vedeva i suoi occhi, parlava di donne e pensava a lei, guardava l’oro dei gioielli delle signore e ci vedeva i suoi capelli. Si grattò il collo, il pomo d’Adamo che sporgeva un poco ma non si vedeva molto per via del collo possente. «Sono tutte le mie.» ghignò, ma fu un momento perché presto tornò serio «Una ragazza c’è. Ci siamo visti tre volte, non so nemmeno che fine abbia fatto in questo periodo» «Quindi, fammi capire… Ha qualcosa in più ma non è la tua donna? Io intendevo se ti eri fidanzato o se c’era qualcuna che ti piaceva!» «Ma che fidanzato! Te l’ho detto, c’è questa ragazza che non ho capito se mi piace o no, ma che comunque è diversa dalle altre» «Cioè, com’è?» «Occhi azzurri, bionda» «Non è niente di che, poi tu hai un debole per le bionde. Me la ricordo Mathilde, sai?» esclamò Max mollandogli una gomitata. «Me la ricordo anche io! La tua prima cotta, la biondina che aveva perso la testa per te, e tu per lei, ai tempi dell’Heros!» aggiunse Paul, pungolandolo. «Lei è diversa da Mathilde» brontolò Johann, incrociando le braccia al petto. «Spero non sia come Isabel, allora. Dio, lei era insopportabile, non so come facevi. Proprio vero che più di un carro di buoi, tira solo la…» «Ma ti ricordi tutte quelle con cui sono stato?!» sbottò il sinti, senza fargli finire il proverbio «No, non è come Isabel, non è come Mathilde, non è come nessun’altra delle donne che ho avuto. Lei è Frieda, punto e basta. Scommetto che una ragazza così non l’avete mai conosciuta, non è classificabile. E comunque sembra una bambina. Ha vent’anni e pare averne quindici, è la ragazza più bassa che io abbia mai incontrato» «Si maneggia meglio» ammiccò Max. Johann arricciò il naso, ripensando al gancio dentro che Frieda aveva mollato a quello che l’aveva toccata sotto la gonna. Era piccola ma sembrava avere il pugno pesante, e non gli andava molto di testarlo sulla propria pelle. «Però è uno spasso» concesse con un’alzata di spalle. «Amici con benefici?» Johann lo guardò con le sopracciglia aggrottate e un mezzo sorriso incredulo. «Tu hai qualche problema, fratello, hai una fissa», esclamò facendo scoppiare a ridere Paul. Quando le moto ripassarono sulla curva davanti a loro, per l’ultima corsa, il pubblico esplose in un applauso e si alzarono tutti in piedi. Boxe, moto e donne. La vita di Rukeli, ventidue anni. Era tornato a casa la sera, dopo essere andato a ballare con Paul e Max in una delle balere che frequentavano fin da adolescenti. La sua casa a Tiefenthall era esattamente come la ricordava. Minuscola, grigia e puzzolente. Sua madre stava pulendo le stoviglie della domenica, suo padre fumava un sigaro alla finestra. Carlo e Mauso giocavano a carte sul tavolo, con Stabeli e Albert che li guardavano. Le sue tre sorelle erano grandi, non abitavano più in quella casa. Nemmeno Carlo, in realtà, però faceva spesso visita ai genitori. La prima era Maria, classe 1894, soprannominata “Bumsli” perché da piccola sbatteva (bumsen) su tutti gli oggetti di casa; poi c’era Anna, nata nel 1897, soprannominata “Lammchen” (agnellino) per via del faccino d’angelo; la terza sorella era Wilhelmine, del 1899, soprannominata “Kerscher” per via della bocca rossa come ciliegie (kirsche). Poi era arrivato Carlo, nato nel 1902. Carlo era solo il nome con cui lo chiamavano tutti, poiché si chiamava Wilhelm, in verità. “Carlo” perché kalo in romanì significava nero, e lui era il più scuro di tutti. Scuro di capelli, di pelle, di occhi. Era un po’ severo, ma alla fine neanche tanto se ci si faceva l’abitudine. Era sempre stato studioso e ligio alle regole, e contrario alla scelta di Johann di diventare pugile perché: «Diventerai stupido a forza di prendere le botte». Poi c’era Ferdinand, del 1904. I suoi capelli avevano riflessi ramati al sole, e quando si arrabbiava diventava tutto rosso, per questi motivi l’avevano soprannominato Lolo, che significava rosso in romanì. Adorava fare a botte. Per terzo, alla fine del 1907, era arrivato Rukeli, ovvero albero in romanì. Lo soprannominavano così perché i suoi capelli ricci crescevano come le fronde ed era alto e maestoso come il tronco di un albero. Dopo di Rukeli, arrivò Julius nel 1910. Lo chiamavano Mauso perché da bambino sembrava un topolino (maus). Aveva vent’anni. Poi c’era Albert, classe 1914. Anche lui tirava di boxe, aveva cominciato da bambino alla BC Heros con Johann. Imparò tanto dal fratello, era pieno di talento. Infine, nel 1916, era arrivato Heinrich. Ma per tutti era Stabeli, perché era secco come una bacchetta (stäbe). Tra di loro non si chiamavano col nome di battesimo, ma con i soprannomi. Ci erano così abituati che quando il maestro, alla scuola elementare, aveva chiamato Johann per nome la prima volta, lui non si era nemmeno voltato. Venne visto come un gesto di maleducazione e si beccò uno scappellotto. A Carlo piaceva la scuola, si era diplomato e laureato. Faceva sempre i compiti. A Johann, invece, non era mai piaciuta. Non riusciva a stare seduto sulla sedia, doveva sempre muoversi; e poi non poteva distrarsi un momento che subito veniva rimproverato. Gli piaceva studiare e imparare, leggeva moltissimo, ma non sopportava l’idea di dover stare seduto e non poter parlare. Insomma, non gli piaceva sottostare alle regole di altri. Non aveva neanche voluto imparare un mestiere, perché fin da quando aveva otto anni ed era salito sul ring la prima volta, si era impuntato che la sua strada era la boxe. Sapeva pescare, sapeva suonare il violino, sapeva andare a cavallo, sapeva ballare, pattinare e fare il pane. Correva veloce, sia con le gambe che con la motocicletta. Ma fare un mestiere? Non se ne parlava.mDa quando era salito su quel ring, aveva visto il suo futuro come un sogno. Il pugilato all’inizio non era apprezzato, anzi era quasi illegale: erotico, violento e brutale. L’unico sport che rendeva bestie gli uomini per un’ora e mezza, e dopo la doccia a fine incontro se ne andavano vestiti di tutto punto. Poi i pugili avevano cominciato ad avere successo. Venivano trattati al pari degli attori del cinema americano, come superstar e divi. Facevano film, pubblicità, set fotografici per le riviste. A Rukeli questa seconda parte non importava. Era salito su quel ring, aveva preso i primi pugni, perdeva sempre e si faceva sempre male, nel suo misero peso mosca. Aveva imparato che il pugilato era non arrendersi e non lasciarsi abbattere dal dolore fisico e dalla sconfitta, morale e sportiva. Perché errori e sconfitte nella boxe facevano male fisicamente, anche parecchio, e ci voleva una bella quantità di testardaggine per andare avanti. Aveva imparato che non era solo dare pugni, ma era anche non prenderli. Era un gioco. Il più bravo restava in piedi. E chi era il più bravo? Quello con più fiato, più abilità, più volontà. Anche prima della tecnica. Leyendecker gli aveva detto che un campione non si formava in palestra. Si formava dall’interno, da un sogno e da un progetto. Tutto il resto era conseguenziale. Da quando Johann aveva cominciato ad inanellare vittorie importanti, già da dilettante, aveva reso orgogliosi tutti i sinti di Hannover. Era considerato una specie di eroe, il barlume di speranza del suo popolo. «Sei uno sgangherato» lo salutò Friederike, sua madre, a modo suo. Johann le stampò un bacio sulla fronte, per rabbonirla, e diede una pacca sulla spalla del padre. «Com’è andato il rientro? E la gara?» gli chiese Schnipplo. «È stata assurda. Gli spalti tremavano!» «Mi fai l’imitazione delle moto?» gli chiese Stabeli, tirandolo per la giacca. E Johann partì con quel consueto gesto che faceva ogni volta. Mimò il manubrio, con la voce tuonò il rombo delle motociclette. Stabeli e Benni amavano quando lo faceva, era così divertente. Poi Rukeli condiva quelle imitazioni vocali con facce buffe, rendendo tutto più spassoso. «Quando ripartirai?» domandò Friederike. «Non parto. Il diciannove settembre ho un incontro alla Barghaus. Non mi conviene fare avanti e indietro» «Avremo l’onore di avere il grande Gipsy Trollmann per una ventina di giorni» commentò ironico Julius, lanciandogli uno sguardo divertito. Johann ricambiò il sorriso. Sì, era felice di essere tornato a casa. |
Capitolo 4
*** 1.04 - Ancora di salvezza ***
4 - Sicherheitsnetz
Con i soldi guadagnati e tenuti da parte dalle borse degli incontri vinti, aveva trovato un appartamento a Schluterstaße, numero 70, a Charlottenburg. Non molto grande, e non molto lontano dalla sua palestra. Per raggiungerla faceva una corsetta di riscaldamento, la mattina, tra le strade addormentate di Berlino. Di rado prendeva la moto. Aveva incontrato Frieda durante la prima settimana di dicembre, in serata dopo gli allenamenti, sulla strada dietro Schluterstaße. Era stato per caso. Lui era sulla moto e tornava a casa, lei era a piedi sul marciapiede con un quotidiano sottobraccio e le mani nelle tasche della gonna. La contemplò un po’ prima di fermarsi. Il modo in cui le oscillavano i fianchi mentre camminava, i capelli che si muovevano un po’ al vento, la forma affusolata del polpaccio, il piede stretto nelle scarpe col tacco basso. Accostò la moto al marciapiede, la spense. «Casa tua è dall’altro lato, biondina» Lei si fermò. «Trollmann?» In effetti avrebbe riconosciuto quella voce tra mille, quel tono che usava solo lui quando la chiamava biondina. «E chi sennò?» le sorrise, togliendosi occhiali e casco «Dove vai a quest’ora? Posso darti un passaggio, se vuoi» «In realtà non sto andando in nessun posto» ammise con un sorriso cauto. Sembrava stanca, quasi provata. Era dimagrita, se ne accorse dalle guance scavate. Aveva sempre avuto il visetto magro, ma così era troppo. Notò occhiaie scure che le cerchiavano gli occhi. Frieda sembrava spenta: l’oro dei capelli non brillava, gli occhi di cielo erano opachi, la labbra come ciliegie erano pericolosamente pallide. Gli salì un groppo in gola. Non l’aveva mai vista così, e gli fece un orribile effetto non vedere la scintilla dispettosa nel suo sguardo, ma solo il vuoto. La morte. «Vieni con me, ti porto via» le mormorò, facendole un cenno col capo e indicandole il posto sulla sella dietro di sé. Frieda non se l’era fatto ripetere due volte. Lasciò cadere il quotidiano, saltò sulla moto dietro di lui e si accoccolò alla sua schiena marmorea. Aveva un profumo che sapeva di libertà e spazi incontaminati, come pini e tabacco. Rukeli guidò fino alla palestra di Charlottenburg. Allo sguardo interrogativo di lei, si portò un dito alle labbra. «Non c’è nessuno a quest’ora. Anche gli inservienti se ne sono andati. La porta principale, quella lì, è chiusa. Ma sul retro ce n’è un’altra.» le spiegò, guidandola dietro il palazzo «Una notte Kaspar si è infuriato, ha quasi distrutto casa sua. Da allora lasciano una porta aperta, per quando qualcuno di noi sfuria» «A te è mai servito?» «No. Io non mi arrabbio» le sorrise, tenendole aperta la porta di metallo pesante. Accese poche luci, per non dare nell’occhio. Bastava quella potente del corridoio e quella sopra l’angolo dove venivano raccolte iscrizioni per fare un po’ di luce nella sala spaziosa. C’erano panche, un ring montato al centro, sacchi appesi a ganci da macellaio, sacchi piccoli di mais, specchi sulle pareti. «Senti, c’è ancora puzza di giovane adulto maschio e sudato» scherzò, cercando di farla sorridere un po’. «Io sento solo la tua di puzza.» gli lanciò un’occhiata maliziosa «Come mai qui?» «Hai l’aria di una che deve scaricare la rabbia o qualcosa. Vuoi prendere a pugni un sacco?» «Molto galante come primo appuntamento.» gli passò davanti, andando a prendere un paio di guantoni buttati all’angolo del ring «Non potevi invitarmi a cena oppure a bere qualcosa? Guarda che avrei accettato volentieri» «Buono a sapersi, allora lo farò. Ci sono tante cose che potremmo fare insieme, in effetti. Vuoi sapere la prima?» «Fammi indovinare. Sesso?» inarcò le sopracciglia in un’espressione sarcastica. «Beh, io non l’avrei detto in modo così diretto. Però visto che tocchi l’argomento in modo così brutale: sì, farei sesso con te» ammise con un’alzata di spalle e con naturalezza inaudita. Frieda sfarfallò le ciglia, colta alla sprovvista da quell’ammissione così sincera. «Credo che tu abbia il filtro bocca-cervello difettoso. Sei sempre così schietto?» «Hai cominciato tu, biondina.» ghignò «Quando sei tornata?» Le prese la mano per aiutarla ad infilare i guantoni da dieci once. Non poteva strattonarle il braccio come avrebbe fatto con i suoi colleghi. Frieda aveva la mano piccola, magra e delicata, le dita affusolate, il braccio sottile e la pelle di porcellana, liscia e morbida. Sul polso e sul dorso della mano intravedeva le venature lilla. «Hai delle mani molto belle» sussurrò, senza accorgersene. Non aveva nemmeno sentito la risposta di lei, preso com’era a sentire l’effetto di quella pelle morbida e liscia sotto le sue dita ruvide. «E tu non hai filtri. Sei proprio sconveniente» gli sorrise, alzando gli occhi su di lui e guardandolo da sotto le ciglia. Johann alzò le sopracciglia. «Se è per questo hai pure una bella pelle, bionda.» le confessò con un tono scherzoso «Non ho sentito la tua risposta» «Sono tornata stamattina» mormorò. Lui ricontrollò i guantoni. Ne indossò un paio anche lui, da dodici once, e le batté il pugno sul suo, con leggerezza. Si mise a ridere vedendo come erano grandi quegli arnesi su Frieda. «Posizione di guardia» si posizionò, lei cercò di imitarlo alla bell’e meglio. «Voglio solo tirare due pugni» protestò Frieda, bonariamente. «C’è tutta una preparazione dietro al semplice pugno. E tu hai la boxe nel sangue, biondina» «Stai cercando di raggirarmi con le tue subdole tecniche lusinghiere» lo pungolò, facendolo ridacchiare. Le diede un altro colpetto sul guantone. «Dico sul serio, per essere una che non segue nemmeno il pugilato, tiri ottimi colpi» «Mi ha insegnato mio padre. Una donna deve sempre sapersi difendere, anche se solo un minimo come nel mio caso» «Mi sembra giusto e saggio. Potresti approfondire, t’insegno io» ammiccò con le sopracciglia. Frieda scoppiò a ridere, abbassando le braccia e piazzandole sui fianchi. Inclinò la testa, lo studiò nella penombra della palestra. Lui si lasciò contemplare. «C’è qualcosa che non va?» le domandò, avvicinandosi di un passo. «Sono solo un po’ stanca. È stato un lungo viaggio» «Dove sei stata?» Non era aria di tirare pugni al sacco. Quello poteva essere il suo modo di sfogarsi, ma di certo non era quello di Frieda. Aveva accettato di indossare i guanti e scherzato sul tirare due pugni solo per sdrammatizzare. Nella sua ingenuità, non aveva tenuto in considerazione il fatto che Frieda potesse avere un altro modo di sfogare la negatività. Senza contare che era ridotta ad uno straccio. Si sfilò i guantoni, e tornò da lei per aiutarla a togliere i suoi. Gli sorrise, grata per essersene accorto, lui ricambiò con un sorrisetto sghembo. «In Ucraina» gli rispose infine, in un sussurro. Liberata di quei guantoni, si andò a sedere a bordo ring, appoggiandosi alle corde come se fosse un’amaca. Lui la seguì, ma restò in piedi per guardarla meglio. «Ti vedo davvero stravolta» Restò in silenzio a lungo. «Tu come ti sentiresti se il leader della Germania cercasse di sterminare tutti i sinti tagliando gli alimenti?» Lui non fiatò. Allora Frieda spiegò. «Stalin ha tolto gli alimenti alle comunità kulaki e cosacche, per via della collettivizzazione dell’agricoltura, sai. Io e mio padre siamo andati lì per portare via mio cugino Ivan, ma non l’hanno lasciato andare e non volevano mandar via neanche noi. Ecco perché ci abbiamo messo tanto a tornare.» sospirò «Lo chiamano moryty holodom. In ucraino, significa “infliggere la morte attraverso la fame”. All’inizio ce la cavavamo, mangiavamo grazie ad alcune conoscenze di Ivan. Poi però lui è sparito, noi siamo stati trattenuti e abbiamo patito la fame». Johann sembrò perdere ogni traccia di ironia e allegria nel viso. Era rimasto pietrificato. Immaginò solamente cosa stesse succedendo e cosa fosse accaduto a Frieda in quei mesi. «Ho visto cose orribili. Non credevo nemmeno che fossero possibili.» continuò «Una madre che veniva mangiata viva dai figli, perché aveva deciso di sacrificarsi pur di nutrirli con qualcosa. Il cannibalismo sembrava all’ordine del giorno». No. Non poteva immaginare il dolore di Frieda, si era sbagliato. Quando lei incrociò i suoi occhi neri, si sentì prosciugare le forze da quello sguardo infinito. Il peso del cielo. Si sentì come Atlante che reggeva la volta celeste. Quando abbassò lo sguardo, si sentì quasi rincuorato. Sentì che poteva riprendere fiato, sentì che il cuore stava tornando a battere. Non sapeva cosa dire. La verità era che non poteva limitarsi ad un banale “mi dispiace” e preferiva tacere piuttosto. «C’è qualcosa che posso fare?» le sussurrò, accarezzandole la spalla e la schiena. Lei chiuse gli occhi, accennò un sorriso. «Portami a cena. Sto morendo di fame» Johann sorrise debolmente, cogliendo una sfumatura tetra nella battuta di Frieda. «Con piacere» le tese la mano, invitandola ad afferrarla. D’altronde anche lui aveva fame. E anche se non l’avesse avuta, avrebbe portato Frieda a cena a prescindere. L’avrebbe ricoperta di cibo, le avrebbe comprato tutto ciò che desiderava pur di vederle prendere un po’ di colorito e la scintilla dispettosa nello sguardo che tanto gli piaceva. La ragazza lo guardò, nella penombra. «C’è un’altra cosa che potresti fare» «Farò di tutto». I suoi occhi neri sembrarono brillare, vividi e intensi. Si accorse in quel momento che per lei avrebbe spostato mari e monti. «Abbracciami». E Johann non si fece pregare. Quasi le si fiondò addosso. Strinse dolcemente a sé quel corpo minuto e dimagrito, inspirando forte il profumo di lavanda dai suoi capelli biondi. Le spalle piccole, la spina dorsale curvata per modellarsi al corpo di Johann, le scapole che sporgevano. La schiena compatta del pugile, le spalle ampie e il bacino stretto, le braccia forti che la stringevano delicate. L’unica cosa che voleva Frieda in quel momento era un abbraccio, e quello era il miglior abbraccio che qualcuno le avesse mai dato. Rukeli, col suo corpo stretto a lei, le comunicava che c’era. Era lì per lei, non sarebbe andato via. Una presenza forte e rassicurante, la sua ancora di salvezza. Ogni cellula sembrava dire “Sono qui, stringimi e andrà tutto bene, io non ti lascio”. E lei si era aggrappata alle sue spalle come se tutto il mondo stesse crollando tranne lui, tranne l’Albero. Pensò che il mondo poteva finire in quel momento e non le sarebbe importato niente, perché c’era lui ad abbracciarla. Pensò che se c’era lui, niente sarebbe potuto accadere. «Sento il tuo stomaco che brontola, bambina» le sussurrò, il viso affondato tra i suoi capelli. Lei ridacchiò. «Ancora un po’, poi andiamo». Johann sbuffò un sorriso e si accoccolò col viso sulla sua spalla, stringendola con dolcezza, senza mai abbandonarla. «Sono contento che tu sia qui. In Germania, al sicuro tra le mie braccia. Mi sei mancata, lo ammetto, ti ho cercata ovunque» Frieda avvampò, nascose appena il viso nell’incavo della spalla del ragazzo. «Anche io sono felice di essere qui, in questo momento. Sono a casa». Fu in quel momento che sentì qualcosa di strano scuotergli l’anima. Sentì quel legame che prima non aveva mai sentito, ma era forte come fil di ferro e lo legava a Frieda. C’era sempre stato e non se n’era mai accorto. Come se con lei, in qualche modo, si sentisse completo. Sentì come se la conoscesse già, ma non lei. La sua anima. Una sensazione di ancestrale familiarità. Come un remoto ricordo. Un sogno, una vita passata. Jaaneman. 11 dicembre 1931 Un nuovo incontro con Vogel. Era il quarto che disputava contro quel pugile. Il primo era stato il 27 dicembre 1929. Quando si era regalato per il suo ventiduesimo compleanno un bel knock-out al secondo round. Il secondo era stato il 4 luglio 1930. La volta in cui Vogel l’aveva chiamato sporco zingaro, e lui in risposta se l’era fatto cucire su tutti i pantaloncini che usava per salire sul ring e lo aveva battuto ai punti al sesto round. Il terzo era stato il 5 dicembre 1930. Aveva vinto ai punti all’ottavo round. Vogel era rimasto quasi sconcertato dai pantaloncini nuovi di Gipsy. Si sentì ridicolizzato, preso in giro davanti a quella parola che lui aveva usato per cercare di insultare lo zingaro. Quell’ultimo incontro lo stavano disputando l’11 dicembre 1931, poco più di un anno dopo dall’ultima volta, alla Tennis Halle di Berlino. Il soffitto era triangolare, con le luci al neon lunghe che seguivano il profilo del tetto. Al centro, nella sabbia rossa, era stato montato il ring. Vogel era più pesante ora. Pesava settantasette chili, contro i settanta di Rukeli. Ma Johann non lo temeva, conosceva il suo stile e sapeva come destreggiarsi. Per questo restò sorpreso quando l’altro lo attaccò accorciando le distanze. All’inizio aveva incassato, cercando di inquadrare il nuovo stile di Vogel. Al suo angolo, Leyendecker gli massaggiò le spalle. «Che ti succede?» Scosse la testa, rivoli di sudore scendevano sulla fronte dalla cute. «Acqua». L’aiutante gli passò la spugna, lui la succhiò e sputò nel secchio. Respirò forte, il fiato corto. «Non riesco, non ho più fiato». L’aiutante gli allargò le narici per farlo respirare. «Ti sei fatto prendere dalla foga di diventare campione, dalla foga della vittoria. Lo guardi come se fosse un sacco da boxe.» gli rispose Leyendecker, lapidario «Hai dimenticato che ogni incontro ti mette davanti il pugile che saresti potuto essere. Rimettitelo in testa» «Secondo Box-Sport per avere la meglio su di te bisogna costringerti alla rissa, al combattimento ravvicinato.» se ne uscì Zirzow «Credono che tu non sappia combattere in questo modo, visto che preferisci le distanze» «Non c’è problema». Tirò forte su col naso, Leyendecker gli rimise il paradenti bianco. L’allenatore aveva dannatamente ragione. Non viveva più l’attimo, non metteva più tutto sé stesso nell’incontro come se fosse l’ultimo. Puntava troppo al futuro, alla vittoria che non era mai scontata. Tutti sono capaci a vincere. Durante le ultime riprese, Rukeli riprese il controllo. Dominò il ring. Vogel cercava di costringerlo alla rissa, cercava di inchiodarlo agli angoli o alle corde. Johann assecondava, dimostrando a lui e a Box-Sport che sapeva combattere anche in quello stile. Si pestarono un po’. Vogel tentò di nuovo di chiuderlo nel combattimento ravvicinato. Trollmann tenne le gambe divaricate, gli mollò un buffetto giocoso sull’orecchio per dargli fastidio e provocarlo, e si mosse veloce per allontanarsi dalle corde mentre l’avversario era distratto. All’ultimo round, Rukeli impose di nuovo il suo stile. Vogel doveva inseguirlo, ma non lo trovava mai. Era Trollmann che trovava lui, però. Vinse ai punti all’ottavo round. Box-Sport non cercò più di descrivere un modo plausibile per annientare lo zingaro, perché aveva capito che non ce n’erano. Passarono due anni, era il 1932. Trollmann era uno di quelli sempre pronto alle stupidaggini, alle sfide in strada, ma anche a grandi generosità. Rukeli non risparmiava. Quando aveva i soldi li spendeva. Se un amico era in difficoltà non ci pensava due volte a dargli tutto quello che aveva. Quando girava in strada e si fermava nei parchi, vedeva i bambini giocare. A volte giocava con loro, altre volte gli andava a comprare cesti di caramelle e dolci di ogni genere. Altre volte ancora si perdeva in ragazzate, e spaventava i ragazzini arrivandogli alle spalle e facendo il verso dell’orso. Loro scappavano e lui rideva. Si era perso in scemenze anche l’anno prima, durante un incontro a Dresda, in cui si presentò alla cerimonia del peso con due ore di ritardo. Aveva preso una multa di cinque franchi per questo. Gli anni precedenti erano stati il suo trionfo. La media annuale era tra i dieci e i tredici combattimenti, un enorme record per un pugile. Era ricercato ed estremamente temuto nella categoria dei medi e mediomassimi, gli altri pugili gli stavano alla larga e quando sapevano che dovevano affrontare lui si spaventavano non poco. Perché Rukeli Trollmann non era solo veloce come il vento e i pugni come rocce, ma aveva anche un gran cervello. Boxava con l’astuzia di una volpe, era insidioso. Dare pugni e non prenderli, divertire il pubblico e vincere. Non aveva bisogno di provare dolore per entrare nel vivo del match, odiare l’avversario o sentirsi un vero uomo. Lui non odiava nessuno, tantomeno l’avversario, che al contrario era visto come un importante componente della sua performance. Il rispetto era massimo. Non era un pugile aggressivo. Non gli piaceva perdere sangue o avere lividi in faccia, complice anche la sua consapevolezza di essere bello. Non aveva bisogno di avere cicatrici per sentirsi un pugile, per sentirsi virile. Anche se le cicatrici sul viso le aveva anche lui, alla fine, erano inevitabili. Le mosse provate meccanicamente in palestra, sul ring di Rukeli non funzionavano perché le conosceva e così sapeva qualcosa in più dell’avversario, sfruttando la falla. Faceva una finta, l’avversario ci cascava e veniva trafitto. Era umiliante, vedevano il loro punto debole ridicolizzato davanti a un folto pubblico. Qualcuno non la prendeva bene e bolliva di rabbia. Rukeli lo sapeva quando, e si manteneva freddo, alzando un po’ la fiamma dove lasciava a cuocere l’avversario. Quelli andavano fuori di sé, commettevano il doppio degli errori, e lui vinceva. Abbatteva avversario dopo avversario. Non mancava di fare un po’ il buffone. Parlare con quelli alle prime file durante il match, salutare e flirtare con le ragazze, lanciando baci, oppure semplicemente dando fastidio all’avversario con atteggiamenti spavaldi, come i pugni bassi, occhiolini, buffetti sulle orecchie. La sua popolarità si estendeva oltre il ring. Venivano stampati poster, le agenzie pubblicitarie chiedevano il suo viso per cartelloni e manifesti, veniva invitato a programmi radiofonici, riviste femminili a risvolti rosa parlavano della sua vita privata e delle sue conquiste a bordo ring. Le persone lo fermavano per strada, chiedendo saluti e autografi. Era amato, Rukeli. Con quella bellezza tenebrosa e selvaggia, il sorriso di sfida, lo sguardo penetrante, profondo e intelligente, il corpo scolpito. Il pugile più amato della Repubblica di Weimar. Non aveva molto tempo per una vita privata o relazioni durature: solitamente le sue avventure notturne non andavano oltre l’alba o due settimane di relazione. Ogni tanto si concedeva giorni di riposo, in cui faceva compere o andava a divertirsi. Nottate in giro per Berlino con Kaspar ed Hans, cinema, sale da ballo, pub. Donne e moto, moto e donne. Ogni giorno, ogni notte. Spesso usciva con Frieda. La sua più cara amica e complice di dispetti. Non andava spesso ai suoi incontri, ma quando lo faceva si materializzava vicino a Zirzow e Leyendecker, all’angolo di Trollmann. Lui la vedeva, incrociava i suoi occhi, e si facevano grandi sorrisi. Tra una ripresa e l’altra, lei gli massaggiava le spalle o lo faceva bere. Quando si faceva male, c’era lei a medicarlo. Conosceva un sacco di trucchetti per far smettere di sanguinare o sgonfiare le sacche di sangue. Non gli lanciava baci, non gli urlava incitamenti, non gli diceva proprio niente. Questo all’inizio l’aveva lasciato perplesso, perché le altre donne lo facevano ma lei no. Però poi alla fine dell’incontro lo abbracciava, fregandosene del sudore, gli accarezzava i capelli e gli faceva i complimenti anche se magari perdeva. Era un lenitivo per l’anima. Per vedersi più spesso, lui aveva chiesto i suoi turni al pub. Quando finiva l’andava a prendere, mangiavano insieme quando potevano. Facevano lunghe passeggiate tirando calci ai sassi, lungo lo Sprea, nel parco Tiergarten o al centro commerciale più in voga di Berlino, il KaDeWe. Gli piaceva prenderla a braccetto, o passarle il braccio sulle spalle. Era piccola e sentiva un istinto protettivo nei suoi confronti. Gli piaceva mostrarsi con lei in pubblico. Giocavano a biliardo, bevevano birra, andavano al cinema e in sale da ballo. Poi lui la riportava a casa con la moto. Si divertivano insieme. Qualche volta, dopo cena, si infiltravano nella palestra a Charlottenburg e infilavano i guantoni. Frieda faceva le caricature degli avversari di Johann, ma anche di Johann stesso spesso e volentieri, divaricando le gambe quasi a fare la spaccata come faceva lui, oppure saltellando qua e là. Altre volte, la mattina, lui accompagnava Frieda al maneggio dove si occupava dei cavalli. Vide tutti i trofei vinti, non solo d’equitazione, ma pure di atletica leggera, tiro con l’arco e ginnastica. Lei gli aveva detto che era una delle migliori atlete regionali anche in quelle discipline, ma non la fecero mai competere a livello nazionale. Gli disse che avrebbe voluto fare l’università e diventare antropologa, ma costava troppo e tempo che aveva racimolato i soldi, ecco che le donne non potevano più iscriversi. Johann trovava Frieda davvero divertente, spassosa, con la sua vena impertinente e rilassata. A volte si adombrava, pensando all’Ucraina, e non le si poteva dire niente che s’infuriava. E quando succedeva, poi anche Johann s’intestardiva. Finivano che non si parlavano per giorni, poi lui le andava a chiedere scusa urlando sotto la sua finestra. Il loro rapporto era unico: forse più di un’amicizia, o forse no, ma erano in perfetta sintonia. L’unica donna con cui Trollmann non era stato a letto, l’unica che lo faceva indiavolare perché parlava troppo o troppo poco e lo contraddiceva per il puro gusto di farlo, l’unica con cui passava pomeriggi insieme all’insegna del divertimento e non nottate di fuoco, l’unica con cui condivideva emozioni e aspetti intimi del suo essere. Le donne nella sua vita andavano e venivano, un via vai senza limiti. Donne che desideravano essere solo portate a letto e che lui accontentava senza remore, donne che gli si avvicinavano solo per vantarsi di essere state con il pugile. Donne piatte, prive di ogni ambizione o significato per lui. Ma Frieda era sempre stata il suo punto fermo, il suo pilastro incrollabile. Era sempre stata lì con lui, nel bene e nel male. C’erano giorni in cui Johann voleva vedere solo lei, né Kaspar né Leyendecker. Solo Frieda. E lei c’era. Sempre. |
Capitolo 5
*** 1.05 - Quelli come noi ***
5 - Diejenigen wie uns
1 giugno 1932 A Berlino era stato allestito un luna park, con bancarelle e spettacoli in strada. Era una bella serata, non particolarmente calda, l’aria profumava di foglie e boccioli. Johann era con Frieda, Kaspar e la sua fidanzata Gilda, e Hildi, la migliore amica di Frieda che non stava tanto simpatica a Rukeli. La ragazza parlò tutta la serata, parlava tantissimo e sempre di sé. Nel giro di una cena tutti insieme e la passeggiata per le bancarelle, avevano scoperto tantissime cose sul suo conto. Brunhilde conosceva Frieda dalla scuola superiore, era più grande di un paio d’anni, facevano atletica e ginnastica insieme. Era una tipa molto aperta ad avance, gli uomini facevano a gara per accaparrarsi una delle sue occhiate languide e sorrisi mansueti. Ma era tutt’altro che docile. Non era una testa matta, sapeva quello che faceva ed era giudiziosa, semplicemente si divertiva a passare notti di fuoco e spezzare il cuore ai poveri malcapitati il giorno dopo. Veniva da una famiglia benestante con sette fratelli molto più grandi di lei, era cresciuta con una certa malizia e una certa educazione che la rendevano un tantino viziata. Ma neanche molto, visto che lei era l’ultima e non veniva considerata più di tanto dai genitori ormai anziani e i fratelli impegnatissimi con le loro vite. Ad Hildi non era mai importato, aveva tutta la libertà che voleva e si era costruita da sola. L’allegra compagnia si fermò a mangiare pannocchie abbrustolite, sedendosi al tavolo di un piccolo chiosco. Johann quella sera non staccava gli occhi da Frieda. La ragazza indossava un vestitino sbarazzino, bianco con le stampe di fiori neri, stretto da un nastro nero sul girovita e con i lacci che si congiungevano sulla nuca; portava un paio di scarpe col tacco basso grigie, che lasciavano scoperto il delicato collo del piede. I capelli stranamente ordinati e pettinati, il trucco nero sugli occhi a risaltare le iridi di cielo. Sapeva essere dannatamente elegante e fine. Credeva di averla vista in tutte le salse ormai: con i vestiti da campagnola, vestita da uomo, con la vestaglia da camera, vestita da cameriera. Seduti ad un tavolo vicino a loro, c’era un gruppo di uomini con un molosso al guinzaglio. Il cane non faceva che abbaiare, gli occhi iniettati di sangue, poi cominciò a ringhiare verso Johann, cercando di mordergli le gambe. «Il cagnaccio la deve smettere, altrimenti gliene mollo uno» Il padrone si mise a ridacchiare. «Non credo che riusciresti a prenderlo o fargli male» Rukeli sorrise e si passò la lingua sui denti, sembrava voler assaggiare i propri canini. «Se lo stendo, voglio venti marchi» «Andata». Si accordarono velocemente su come organizzare quell’ “incontro”. Andarono in una lunga strada appartata, leggermente in discesa. L’uomo e il cane arrivarono al punto più alto, Rukeli restò in fondo. Al suo segnale, il padrone sciolse il molosso. Quello non vedeva l’ora di andare ad aggredire lo zingaro, e corse a perdifiato verso di lui. Si diede lo slancio con le zampe posteriori, e saltò fino a quasi azzannargli la faccia. Johann fu più svelto, si spostò indietro e gli mollò una manata sul muso. Il cagnaccio cascò a terra con un tonfo e restò lì, succube. Il padrone si aspettava che si sarebbe rialzato ancora più agguerrito, invece era rimasto lì. Dunque il ragazzo allungò la mano per prendersi i venti marchi che gli spettavano, e si allontanò con gli altri. «Certo che sei una testa matta, tu» commentò Gilda, sorridendo frivola. «È un eufemismo» replicò Kaspar, con dolcezza. «Signore e signori» esordì Johann, camminando all’indietro per guardarli in faccia, le braccia allargate teatralmente, «con questi soldi sfiderò la signorina Bilda qui presente al tiro al bersaglio» «Questi pugili… mettono al tappeto un paio di persone e si sentono i re del mondo.» fece lei, con un sorriso sfacciato «E se vinco?» «Poi ci pensiamo. Accetti la sfida?» «Ti pare che mi tiro indietro?» Sorrise come uno squalo, sapeva che lei avrebbe accettato. Hildi l’aveva guardato come fosse un folle. Johann costrinse Frieda a prenderlo a braccetto, con quel fare simpaticamente invadente. Con l’altro braccio decise di prendere a braccetto Hildi. La rossa era alta parecchio, misurava almeno centosettanta centimetri, forse poco di più, era sottile. Frieda invece era piccola, gli arrivava alla spalla, ma aveva dolci curve e un corpo a clessidra. Così diverse, eppure entrambe estremamente aggraziate, in comune avevano la finezza regale delle nobildonne. Si fermò davanti al banco del tiro a segno, pagò i venti marchi per i cinque colpi di Frieda e i cinque che spettavano a lui. Dovevano colpire i cinque bersagli a distanze e grandezze differenti con una pistola a pallini. «Prima le signore» disse il commerciante, porgendo la pistola a quella delicata fanciulla. Lei gli pianto le dita ai lati della mano, facendolo rivolgere a Johann. «Prima i campioni». Lui non se lo fece ripetere. Prese la pistola, mirò e sparò. I primi tre colpi presero il centro, il penultimo era un po’ esterno. Prese la mira per l’ultimo colpo. Frieda gli pungolò il fianco per dargli fastidio, Johann le si rivolse con un sorriso da lupo. «Smettila, bambina.» le intimò in un sussurro «Mi fai arrabbiare» «E se ti arrabbi che fai, Gipsy?» Lui sparò, ma il suo colpo fece cilecca. Lanciò uno sguardo di sfida alla ragazza, che nel mentre afferrò la pistola che le porgeva il mercante. Altri ragazzi in fila lì dietro sghignazzarono. La delicata fanciulla, così ben vestita e così bella, sembrava tutto tranne che in grado di impugnare una pistola e fare centro. Invece quando colpì tutti e cinque i centri dei bersagli, commerciante e ragazzi in coda restarono stupefatti. Le fecero i complimenti per la mira, e ricevette in premio un peluche a forma di elefantino viola. Quando si allontanarono dal banco, Frieda posò il pupazzo su una panchina e incrociò le braccia al petto. Il sorriso da folletto mentre guardava Johann. «Allora? Il mio premio» «Sei una che pretende» «Terribilmente» ma non gli diede troppa importanza. «Potevi dirmelo che hai una mira da cecchino» «Ti saresti tirato indietro» «Mai. Vuoi il tuo premio?» «Direi di sì, ti ho stracciato.» ammiccò con le sopracciglia «Non rifilarmi uno dei tuoi scherzi idioti, voglio un premio serio». Johann alzò le spalle, noncurante. Le prese il mento con le dita per sollevarle il viso e si piegò su di lei per poggiarle un bacio lieve sulle labbra. Frieda restò pietrificata, come anche Kaspar, Gilda ed Hildi. Poi l’amico scoppiò in una risata sguaiata. Conosceva Rukeli, poteva baciare chiunque e scamparla sempre, nessuna lo aveva mai rifiutato. Nemmeno Frieda fu in grado di respingerlo. Il bacio, comunque, durò un secondo. Quando si allontanò le regalò un sorriso dei suoi, da divo. Lei era ancora impietrita, poi si riprese sfarfallando le ciglia e gli mollò un colpo alla pancia con il dorso della mano, scatenando una risata generale. «Più serio di così, cosa volevi? Una proposta di matrimonio?» Frieda non gli rispose neanche, grugnì e si allontanò verso un banco di zucchero filato. Voleva solo ingurgitare dolci e affogare il nervoso nel cibo. «Hai lasciato qui il tuo premio, Frieda!» le gridò, ma vedendo che non era aria, riprovò «Hai una mira incredibile, non me l’aspettavo! Dai, ora non tenermi il muso tutta la sera!» Seduta sulla panchina a divorare zucchero filato a una quindicina di metri di distanza da lui, alzò il dito medio nella sua direzione. Johann scoppiò a ridere, e si avvicinò. «Non tenermi il muso, andiamo» «Sei uno stronzo» brontolò senza guardarlo. «Come la fai tragica per un bacino. Era anche senza lingua» la provocò, sollevando un sopracciglio. Frieda avvampò, imbronciandosi ancora di più. «Smettila» Johann sospirò, decise di ricominciare. Si voltò col corpo verso di lei, le prese le mani tra le sue. «Va bene, senti. Guarda dove siamo, ti sembra il posto giusto per stare imbronciata così? Avanti, bambina, fammi un sorriso e andiamo a giocare», inclinò la testa da un lato. Avrebbe voluto baciarla ancora, stavolta sul serio. Avrebbe voluto convincerla lasciandole baci sul viso e sul collo, accarezzandola, strofinandole la punta del naso sulla guancia. Trattenersi dal farlo, appellarsi a tutto il suo autocontrollo, si rivelò difficile. Quella sera avrebbe cambiato le cose, ne era certo, voleva dare una svolta al loro rapporto. Non ne poteva più di averla sempre così vicina, eppure non poterla avere come desiderava. Lei alla fine cedette e si sciolse in un sorrisetto timido. «E va bene. Sei un maledetto diavolo tentatore» Johann scattò in piedi, trascinandola con sé. «Vieni con me». Frieda non era mai stata in un luna park. Johann invece sì, e la trascinò ovunque. Si fermarono ad ogni stand per il cibo e i giochi, la portò su tutte le giostre. «Vieni, facciamo questo!» le urlava sopra il vociare della folla, la prendeva per mano e la faceva salire sul carosello. C’erano bambini, ma anche adulti. Tra i cavalli in plastica colorata e luci sgargianti, loro due giocavano come ragazzini rincorrendosi tra i cavallucci, i pali, oppure fingendo di star partecipando ad una gara equestre. «Lo stomaco ti regge?» le aveva chiesto poi. «Perché?» E lui non le aveva risposto, l’aveva trascinata sulle montagne russe. Erano così veloci, che se Frieda avesse voluto urlare, il grido le tornava in gola. L’unico momento in cui si lasciò andare uno strillo, fu quando i sedili si rivoltarono a testa in giù. Johann, d’altro canto, si divertiva come un matto e teneva le braccia in alto. Scesi dalle montagne russe, Frieda dovette allontanarsi dietro un cespuglio per vomitare. Il ragazzo le tenne i capelli, e le tamburellò la schiena con la mano. «Sii forte, si forte», beccandosi un’occhiataccia. Frieda si pulì i lati delle labbra. «Dio, che scena penosa» «Davvero vomitevole» «Sei pessimo, tu e le tue battute demenziali» Le pizzicò una guancia. «Non ti imbarazzare, dopotutto ti ho visto fare tante cose strane. Parlare con Buddha e Shiva, ad esempio. È andata meglio di quanto mi aspettassi» «Fanculo, Johann, non ti seguo più da nessuna parte» mugugnò, afflitta. Lui le rivolse un sorrisetto furbo e la bloccò passandole un braccio intorno alla spalle. La costrinse a voltarsi per indicarle la ruota panoramica. «Voglio regalarti Berlino di notte, che bella come lei ci sei solo tu». Frieda lo sguardò sfarfallando le ciglia, e arrossì. Si imbarazzò il doppio considerando che aveva appena vomitato di fronte a lui, dopo un misero giro di montagne russe. Johann ammiccò con le sopracciglia, e la trascinò in una delle cabine della ruota panoramica. Il giro procedeva flemmatico e in silenzio, c’erano tante coppie ma anche piccoli gruppi di amici. Da lassù, Frieda vide che Hildi si era messa a parlare con un gruppo di ragazzi mentre Kaspar e Gilda pagavano il biglietto per il prossimo giro di ruota. Arrivati sulla cima, la ragazza schiuse le labbra dallo stupore. Berlino di notte era incredibile e bellissima. Intravedeva la Porta di Brandeburgo, con il carro illuminato sulla cima; la cupola del Reichstag; la colonna della Vittoria al Tiergarten. «La Vittoria è un’amante pretenziosa. Chiede sempre qualcosa in cambio» sussurrò Johann. «Ad esempio?» «Ho sacrificato per lei tutte le possibili relazioni durature. Ho troncato tanti legami, inseguendo la vittoria» «E sei soddisfatto di questa scelta? Sacrificare affetti in nome della gloria?» Lui strinse impercettibilmente le labbra, lanciandole un’occhiata fugace prima di tornare a guardare la Vittoria. «C’è stato solo un legame, all’infuori della famiglia e del lavoro, che non ho saputo troncare. Non ce l’ho fatta, e nemmeno lo volevo» «Sono io» esalò Frieda, colta da un’intuizione improvvisa. Solo lei poteva essere. Non faceva parte della sua famiglia, nemmeno del suo ambiente lavorativo come Kaspar. Johann accennò un sorriso. «Non sono stato in grado di allontanarti. Ci ho pensato, sai? Le dico che deve girarmi alla larga o me la tengo stretta? In fondo, mi diverto da matti insieme a lei. Ma posso divertirmi anche con altri. Però lei ha quegli occhi, nessuno li ha come i suoi. E la sua risata? Dove la trovo una donna che ride come lei? E quando alza il dito medio in mezzo alla folla per mandarmici?» scosse la testa «Nessuno è come te. Non ce l’ho fatta a tenerti lontana da me, non volevo. Sei una persona speciale, e come tale volevo che mi rimanessi accanto». In realtà non sapeva bene perché avesse deciso di dirle quello che provava. Aveva deciso di dare una svolta perché non ne poteva più, era vero, ma la reazione al bacio che le aveva dato quella sera l’aveva spiazzato. Sperava che potesse fargli capire qualcosa sui suoi sentimenti, invece lei non sembrava ricambiare. Ma tutto ciò che faceva e aveva fatto in quei due anni contraddicevano questa tesi. Lei sembrava interessata a lui, ma poi lo rifiutava. Non riusciva a capire, non poteva aver travisato i suoi comportamenti. Forse per questo glielo stava dicendo. Mettendo in chiaro le cose per sentire la sua una volta per tutte. Nessuna delle donne incontrate era spiritosa come lei. Anzi, in generale nessuna era spiritosa. Ma amava sentir parlare lei. Era intelligente, divertente, gli parlava spesso di cose importanti e c’era sempre un confronto, una discussione attiva, tra loro due. Su qualsiasi argomento. Scambi di idee e di opinioni che contribuivano a renderla interessante ai suoi occhi. Non si limitava mai a dirgli “Decidi tu, fai come vuoi”, lo contraddiceva per il puro gusto di infastidirlo. E poi gli chiedeva spesso qualcosa sulla boxe e del suo allenamento, pur non capendoci nulla, si interessava a lui e non perché aveva un bel faccino. Forse era poco, ma a Johann sembrava tanto. Lo faceva ridere quando Frieda, in palestra dopo cena, si metteva sul ring e faceva l’imitazione dei suoi avversari con fare scimmiesco. Lo faceva ridere quando era quasi ubriaca e diceva d’aver parlato con Buddha o qualche divinità induista. Lo faceva ridere quando inciampava sulle briglie dei cavalli e finiva con la faccia nel fango del maneggio. Lo faceva ridere quando lui la prendeva in giro con sguardo serio, e lei ci cascava sempre. Lo faceva ridere quando si sdraiavano nell’erba la sera o nel pomeriggio, guardavano le stelle o le nuvole, e lei vedeva figure stranissime. Nessuna era come Frieda. La guardò con la testa bassa, da sotto le ciglia. Occhi negli occhi. La notte che abbracciava il giorno. Non erano che questo. «Mi piaci da matti, Frieda. Te lo giuro». Un senso di trionfo le riempì il cuore. Tutte quelle donne con cui se ne andava, erano più belle di lei. More, bionde, rosse. Agghindate, profumatissime, le labbra pitturate di rosso. Frieda non era niente di tutto ciò. Niente di particolare, il tipo di ragazza che non ti fermi a guardare per strada perché ordinaria e usuale. Eppure nonostante lui fosse andato a letto e baciato molte di quelle donne bellissime, preferiva sempre Frieda a loro. Quel ragazzo le era piaciuto da subito. Da quando l’aveva visto entrare nel pub la prima volta. Aveva persino pensato che avrebbero potuto scambiarsi promesse. Poi erano diventati amici, aveva imparato a conoscerlo. A conoscere la sua ironia pungente, era un ottimista, un giocherellone che pensava a divertirsi. Aveva un lato nascosto che mostrava a stento persino a lei: la sensibilità di Johann. Profonda. Era ben celata dietro sorrisi maliziosi e sguardi trionfali, dietro la boria e l’allegria. «…E non ho capito se per te è lo stesso» proseguì, parlando a raffica, «ma ho questa sensazione nel petto, e dovevo…» «Stai zitto». Lo interruppe bruscamente e fu un attimo. Frieda gli prese il volto tra le mani e lo aveva attirato a sé per fondere le loro labbra e trasformarle in un’unica cosa. Era un bacio leggero, ma al contempo audace e carico di passione. Carico di tutte le parole che non si erano detti, di tutte le emozioni che avevano respinto in due anni per il bene della loro preziosa amicizia. Intensità accorata. Fame insaziabile, sete inestinguibile. «Mi baci come se fossi un bravo ragazzo, ma sei pieno di cattive intenzioni» sussurrò Frieda, distaccandosi appena. Johann sorrise, la baciò di nuovo. «E tu mi baci come se volessi essere amata tutta la vita». La baciò ancora e ancora, con brevi pause in cui prendeva fiato e lo perdeva di nuovo mentre si smarriva nei suoi occhi infiniti, fino a farsi mancare il respiro. Fino ai sospiri, fino alle labbra arrossate, ai capelli scompigliati. Lei vuole un amante guerriero 3 giugno 1932 Birreria Bock. L’incontro con Erich Seeling, il campione tedesco dei pesi mediomassimi. Non era un incontro per spodestarlo, Johann lo vide più come un esame per verificare se avesse la stoffa del campione. Puntava al titolo nazionale di Seeling, lo bramava da quand’era alla Sparta Linden. Seeling era più basso di Trollmann, nettamente, ma pesava un paio di chili di più. Era più piccolo di due anni, ma sembrava più anziano. Aveva il naso grosso, le orecchie a sventola, i capelli mossi ben gelatinati ai lati della testa. Combatteva onesto, non cadeva alle trappole e trucchetti di Johann, non si lasciava distrarre da quelle sue danze gitane. Lo guardava passivo, paziente, sferrava colpi pesanti. Qualche round se lo aggiudicò Seeling, altri Trollmann. Seeling lo doveva inseguire, faceva il suo bravo combattimento, ma non riusciva a inquadrare del tutto lo zingaro: cambiava stile troppo spesso, lo disorientava, l’unico elemento che restava era la distanza che imponeva. Trollmann imponeva al campione il suo stile, lo dominava totalmente. Durante un round, il campione picchiò duro dimostrando di avere la mano pesante. Rukeli cedette un po’ di terreno, ma alla fine attaccò Seeling con una sequenza di colpi potenti, che sembravano voler dire: “Con te non ho ancora finito, io voglio vincere”. Dieci round. Alla fine vinse Seeling per un solo punto. Johann gli saltellò vicino, un gran sorriso sul viso. «Bel combattimento, mi sono divertito parecchio!» L’altro gli fece un sorriso pacato, poi si voltò a guardare il pubblico che sfumava. Rukeli sapeva cosa stava guardando il campione. Quella macchia di divise marroni che studiavano l’incontro dalla zona più marginale della sala. Un oscuro presagio. Li aveva notati anche lui, da qualche tempo si presentavano ai suoi incontri e assistevano in attesa. Non lo avevano turbato molto, ma a quanto pareva Seeling sembrava preoccupato. «Cambieranno molte cose per quelli come noi, Gipsy». Il ragazzo prese un asciugamano, passandoselo sulla nuca, seguì il campione giù dal ring. Lui parlava piano, si guardava intorno furtivo come se stesse dicendo una cosa proibita. «Quelli come noi?» «I non tedeschi» Johann alzò un sopracciglio. «Io sono tedesco» «Sai cosa intendo.» sospirò «Quelli diversi. Siamo gli unici due pugili “non tedeschi”, io ebreo e tu zingaro. Dovresti andartene finché puoi, ci sono tante opportunità anche fuori dalla Germania» Il sinti si strofinò il naso, largo e all’insù, con l’avambraccio. «Perché?» Lo sguardo di Johann. Innocente, infantile come quello di un bambino troppo cresciuto. «L’aria qui sta diventando irrespirabile. Dammi retta, vai via dalla Germania finché puoi». |
Capitolo 6
*** 1.06 - Buone intenzioni ***
6 - Gute intentionen
Box-Sport, edizione del 25 luglio 1932 – Trollmann contro Sabbotke, 23 luglio ‘32.
Sabbotke va in knock-down ma si rimette subito in piedi. Alla fine va in knock-out. Già dai primi minuti del match, era chiaro che sarebbe finito al tappeto.
Lo zingaro, dopo la vittoria, non ha rinunciato ad una fantasiosa danza sul ring, ed è stato festeggiato alla grande. Tutti i mediomassimi del Paese avranno il loro da fare con questo atleta imprevedibile! Box-Sport, edizione dell’8 agosto 1932 – Trollmann contro Ogren, 5 agosto ‘32.
Neanche Ogren, con la sua esperienza internazionale, riesce a venire a capo di uno stile pieno di trucchi. Nel secondo round lo svedese è riuscito a raggiungere il Troll solo con diretti e corti al mento, che però fa una smorfia e accusa senza conseguenze.
Anche Ogren ha subìto lo stile di Trollmann, che lo prende in giro e ogni volta che lo svedese crede di aver fermato il suo sfuggente avversario, quello spariva e ricominciava da capo. Per quanto riguarda la situazione dei pugili mediomassimi in Germania, […] tutti i veterani e aspiranti al titolo, non devono dimenticare che un bel giorno arriva Trollmann e manda al tappeto tutta la compagnia. Ne ha le capacità e ha già cominciato, a partire da Sabbotke. Box-Sport, edizione del 19 settembre 1932 – Trollmann contro Russo. Lo stile di Trollmann è tornato alla sua fase zingara. Contro Russo, che non aveva un buon gioco di gambe e riuscì a colpire Gipsy solo una volta, saltellava ovunque sul ring con quel suo fare spasmodico e imprevedibile.
I colpi erano scorretti, ma dal momento che Trollmann è ora il beniamino dei tedeschi può permettersi un tale modo di combattere. Poi fu la volta di Rienus De Boer il 7 ottobre 1932. Anche lui, il campione olandese dei mediomassimi, cadde sotto l’imprevedibilità di Rukeli. Johann aveva in serbo un truccaccio per non essere sopraffatto dalla differenza di peso di sette chili che aveva con De Boer. Nel mezzo del match, mentre si fronteggiavano, lanciò un’occhiata alle stringhe dei suoi scarponcini. Il campione si lasciò distrarre da quello sguardo, credendo di avere i lacci slacciati, e venne trafitto da un montante al plesso solare. Leyendecker amava e odiava il modo in cui combatteva Trollmann. Era corretto e rispettoso, ma per uno come l’allenatore, nella boxe non dovevano esistere certi trucchi. Non erano contro le regole, la boxe era anche un po’ d’inganno e un po’ di scena, ma Leyendecker era tutto d’un pezzo. La rivista che lo osannava, Box-Sport, però, da qualche tempo scriveva infamando il giovane pugile. Dopo il combattimento con De Boer, Trollmann fu assalito dai giornalisti. Era la seconda volta che lo zingaro sconfiggeva il campione nazionale di un altro Paese. Non solo li mandava al tappeto, ma sceglieva anche il round e lo comunicava alle prime file di spettatori durante il match. «Volete vedere che cade stecchito all’ottava ripresa?» confabulava, avvicinandosi alle corde durante l’incontro. E Johann non era un cialtrone, le sue promesse le manteneva tutte. Quel giorno alla fine di ottobre era stato invitato a parlare in radio. L’intervistatore si chiamava Walter Waltz, l’aveva intervistato altre volte. Era un uomo basso, tarchiato, con un eccentrico parrucchino biondo platino. Ma aveva la faccia grassa e simpatica, era la classica persona che piace prendere in giro con affetto. Si sedette dall’altro lato del tavolo in cui si trovava Waltz, il microfono rotondo di fronte al viso. Johann si era vestito di tutto punto. Un bell’abito scuro e una sgargiante cravatta verde smeraldo di velluto. I capelli erano stati pettinati alla bell’e meglio, era difficile gestire quei ricci neri. Un operatore fece un cenno, la lucina rossa si accese. Erano in onda, faccia a faccia in quella stanza insonorizzata. «Bentornati su Sportnachrichten. Il programma radio che fornisce notizie sportive e interviste esclusive agli atleti più in voga della Germania! Oggi con noi abbiamo il signor Gipsy Trollmann» «Buonasera, signori» salutò. «Di recente l’abbiamo vista confrontarsi con due campioni nazionali dei rispettivi Paesi, Ogren per la Svezia e De Boer per l’Olanda. Ancora prima ha tenuto testa a Seeling. Come la fa sentire?» «Non dico invincibile» sorrise, piegando la testa, «ma dà una bella carica di autostima. L’incontro con Seeling, in particolare, è stato onesto e divertente. È stato un onore combattere con lui, davvero. Lui è una brava persona, ha una bella tecnica. Poi ad ogni incontro si impara qualcosa di nuovo» «E che ci dici di Ogren e De Boer?» «Se sono campioni nazionali un motivo c’è» alzò le spalle, «ma mi aspettavo di dover faticare di più per buttarli giù, soprattutto De Boer che pesava molto più di me» «Immagino che non ci rivelerà mai il segreto per essere come lei, signor Trollmann. Posso chiamarti Gipsy?» «Chiamami come ti pare, ma soprattutto dammi del tu.» rise Johann «Comunque, è davvero banale: osservare. Sta tutto nella capacità d’osservazione. Ma stiamo parlando di pugilato, quindi bisogna metterci pure ottimi riflessi, fiato, velocità e potenza» «Credi di aver sviluppato queste abilità crescendo oppure per indole?» Lui ci pensò un momento. «Sono molto istintivo per indole. Ma certo acume, l’attenzione, la malizia… si sviluppano crescendo in strada, come di fatto sono cresciuto io. Quando ti abitui a girare in ambienti sgradevoli, come la città vecchia di Hannover, impari a guardarti le spalle e riconoscere le persone. Devi diventare smaliziato, altrimenti sei finito» «Era un ambiente tanto difficile?» «Duro da vivere per un ragazzino» «E dicci… punti a combattere per il titolo nazionale? In quale categoria, medi o mediomassimi?» «Prima si deve presentare l’occasione. Potrebbe accadere domani come no, io sto qui e continuerò a combattere» «Sai cosa dicono di te i giornali no? Che sei il pugile più veloce di Germania, nessuno riesce a prenderti. E che sei così abile che scegli persino il round in cui mandarli al tappeto. È vero?» «Non sempre.» sorrise, mesto «Durante il primo round capisco se posso mandare al tappeto o meno il mio avversario durante l’incontro. Se lo posso fare, mi do un tempo limite per farlo quindi sì, decido il round in cui deve cadere. Di solito va come previsto; altre volte capitano sorprese, o non cade oppure cade prima del tempo» Waltz si mosse leggermente sulla sedia, diede un’occhiata al foglio con le domande che aveva preparato. «È un po’ che non compari in cartelloni pubblicitari, è successo qualcosa?» «Se ci fai caso, ora richiedono i volti di donna» «A proposito di donne!» esclamò, in vena di pettegolezzi, senza seguire ancora il foglio con le domande preparate «Moltissime riviste femminili parlano di una donna in particolare, che pare averti rubato il cuore» «Anche la pazienza» scherzò Johann, con un sorriso affettuoso al pensiero di Frieda. «Con le donne è sempre difficile venirne a capo, non scervellarti troppo. Dalle foto che sono uscite sulle riviste, si capisce che si tratta di un prodigio sportivo di pochi anni fa, Olga Frieda Bilda.» Johann si mosse nervoso. «Sì, è lei» «Per i nostri spettatori, che non la ricordano o non la conoscono: Olga Bilda si qualificò come una delle migliori atlete regionali in diversi settori sportivi, ovvero atletica, ginnastica, tiro con l’arco ed equitazione. Nel 1928, a soli diciotto anni, è diventata campionessa nazionale di equitazione nel cross-country. Ma, ahimé, essendo una fanciulla e di origini straniere, non è stata neanche selezionata per partecipare alle Olimpiadi di Amsterdam e, nell’estate del 1929, le venne tolto il titolo». Mentre io firmavo il contratto per il professionismo e cominciavo la mia ascesa al successo, lei l’aveva già raggiunto e stava precipitando. Finirò anche io così? Toccherò l’apice e cadrò solo perché sono un diverso? «E dicci» continuò Waltz distogliendolo dai suoi pensieri, «hai un debole per la signorina Bilda, perché?» «È spontanea, sempre sé stessa, è semplice.» non gli andava di parlare pubblicamente del perché amasse tanto Frieda, dunque tagliò corto e si sbragò sulla sedia. – Tu invece? Tua moglie ti ha lasciato?» «No, Gipsy» ridacchiò Waltz. «L’altro giorno le ho chiesto perché continuava a farsi del male così» Gli operatori dietro il vetro della sala stavano ridendo a crepapelle, anche Waltz scoppiò a ridere. «Non ti agitare che altrimenti quel gatto che hai in testa mi morde» gli intimò. L’intervistatore si toccò il parrucchino. «Oh no, è buono e tranquillo» «Come l’hai chiamato? Figaro?» Waltz quando rideva sembrava un orsetto gommoso, la sua pancia si muoveva a ritmo della risata. Era più divertente vederlo ridere che la battuta in sé. «Caro Gipsy, ora dobbiamo proprio salutarci. È sempre divertente e piacevole averti con noi qui in studio. Ti ammiriamo tutti molto, ti auguriamo tutte le fortune del mondo» Johann sorrise, gli mollò una pacca sulla spalla. «Anche io le auguro a voi, grazie». Si alzò dalla sedia e salutò con la mano sia il conduttore che gli operatori, mentre Waltz continuava a leggere ultime notizie sportive dal giornale. Atletica, lancio del giavellotto, rugby. Firmò un autografo per il figlio di uno degli operatori, e strinse la cravatta uscendo dallo studio radio. Era già buio. Il cielo d’ottobre minacciava pioggia e soffiava un vento fastidioso, portando con sé foglie secche e polvere. Le auto sfrecciavano sull’asfalto. Johann avrebbe voluto portare a cena Frieda quella sera, dopo che finiva il turno al pub. Ma non era sicuro che lei volesse: quel periodo era stressante, mancava personale e faceva turni lunghissimi. Probabile che una volta finito neanche le andasse di stare in giro, tantomeno con quel tempaccio. Poteva portarla a casa sua, poteva passare la notte con lui. Gliel’avrebbe chiesto. Andò a prenderla, l’aspetto fuori il pub, appoggiato ad un palo della luce. Lei uscì con i consueti vestiti da uomo, era quasi più elegante di lui. Johann si chinò su Frieda per darle un bacio tra i capelli, poi le prese la mano intrecciando le dita alle sue. Amava tenerla per mano, la sua era così piccola che quasi spariva in quella di Rukeli, grande e dura. «Qualche idea per stasera? – le chiese. – Ti andrebbe di venire da me stanotte? Non sei ancora mai venuta a dormire a casa mia.» «È arrivato mio cugino Ivan. – gli rispose. – Tu, piuttosto, vuoi stare a cena da noi?» «Va bene. Ma poi torni a casa con me?» Lei annuì con un sorriso, portandosi la grossa mano di Johann alle labbra per baciargli le nocche. Per cena, Edmund Bilda aveva preparato un ottimo spezzatino di cinghiale con patate lesse e peperoni al forno, c’era l’insalata e una piccola torta che aveva tentato di fare Frieda. Ivan Bilda era un ragazzone di trent’anni, le spalle ampie e le braccia possenti. Aveva i capelli biondo cenere, a spazzola, e occhi malinconici di un profondo blu. La mascella squadrata, il naso bozzato. Alla comunità cosacca in Ucraina aveva un sacco di donne che lo desideravano in sposo. Ma c’era un problema, Ivan Bilda era fidanzato. Con un uomo otto anni più giovane, un soldato delle SS. Anche Ivan si era arruolato nelle SS, per questo era riuscito a raggiungere Berlino, grazie all’alleanza tra cosacchi ucraini e il partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi. In Ucraina stavano vivendo una situazione mortale, in cui si moriva di fame, eppure lui era rimasto un ragazzone possente. Era stato merito delle sue conoscenze nell’esercito sovietico. Ivan Bilda piaceva, a uomini e donne, e lo sapeva: non aveva esitato a sfoggiare un po’ di sé ai soldati sovietici segretamente omosessuali pur di mangiare e far mangiare qualcun altro. E nel periodo in cui Frieda ed Edmund erano andati fino a Kiev per riprenderlo, lui sembrava sparito nel nulla nell’ultimo periodo di permanenza. Nonostante ciò, non aveva movenze effemminate come qualche altro. Era estremamente maschio e virile. Gli uomini della famiglia Bilda erano colossi biondi, puri slavi forgiati dai venti delle steppe cosacche e dal calore dei cavalli che cavalcavano dall’alba dei tempi. «Anche io tiravo un po’ di boxe in Ucraina, prima del genocidio. Poi ho smesso» disse Ivan a Johann, divorando lo spezzatino. Ivan il tedesco lo parlava male. Un forte accento slavo deformava la maggior parte delle parole. Al ragazzo vennero i brividi quando parlò di genocidio. Capì che ciò che stava accadendo in Ucraina era più serio, era lo sterminio di un’intera etnia. Rukeli alzò gli occhi su di lui, inarcò le sopracciglia. «Un po’ si vede. Pesi massimi?» Ivan annuì, «Dilettante» «Peccato che hai smesso. Con la tua stazza avresti fatto strada» «Parlano molto bene di te, qui. Il pugile ballerino» sorrise, «ma poi stendi tutti questi pagliacci ingessati» «Sono avversari validi.» alzò le spalle «Se un giorno ti va, vieni a tirare due pugni alla palestra dove mi alleno. Mi fai sapere e ti vengo a prendere, okay, bisteccone?» Frieda tossì, per non scoppiare a ridere. «Siamo tutti un po’ appassionati di boxe qui.» intervenne Edmund, conciliante «Tranne Frieda. A Frieda non importa nulla, si interessa solo di un pugile» A quel punto Rukeli scoppiò a ridere, stringendo il ginocchio della ragazza sotto il tavolo. «Che sicuramente non è Johann Trollmann» chiarì lei con ironia, in imbarazzo, mettendosi a bere. «Stasera posso rubarvela?» domandò Johann. «Tienitela pure.» ghignò il signor Bilda «Ma ti avviso: disobbediente com’è, ti farà diventare matto» «Guarda che non sono così indisciplinata.» si difese Frieda «Lo mangiamo il mio dolce oppure no?» Tagliò a fette la torta con i frutti di bosco e panna. Aveva preparato tutto lei, e si era impegnata nel farlo. Non era male, al sapore un po’ acre ci si faceva l’abitudine. «Bambina, la pasticceria non è roba per te» le sussurrò Johann. Frieda, in tutta risposta, gli sporcò il naso con un po’ di panna. Lui si pulì senza che gli altri due se ne accorgessero e le lanciò un’occhiata famelica. A fior di labbra le disse che si stava arrabbiando, e sarebbe diventato cattivo. Lei gli fece una linguaccia e in risposta lui le strinse le dita sulla coscia. Ivan ed Edmund avevano praticamente divorato le loro porzioni. Finita la cena, Johann aspettò che Frieda recuperasse le sue cose e poi uscirono. Lui era ancora vestito elegante, lei invece aveva addosso ancora gli abiti maschili che indossava quand’era uscita dal pub, e i capelli legati. «Siamo una strana coppia» aveva riso lei, lungo la strada verso Schluterstaße. Quando entrarono, Johann accese la luce del salotto. Era abbastanza fiero della sua tana. Aveva un unico grande ambiente con angolo cottura e tavolo con le sedie, poi un piccolo corridoio conduceva alla camera da letto e al bagno con il lucernario. Non era una casa molto spaziosa, ma non doveva metterci niente. C’era un divano, una radio, qualche scaffale con dei libri, un tappeto con le frange tutto colorato. Le pareti erano bianche. C’era anche un balconcino rettangolare da cui si accedeva dalla cucina, che lui aveva decorato con un paio di piante… Quasi morte. Fece posare la sacca di Frieda in camera da letto. Era spaziosa, con un grande letto matrimoniale sfatto, un armadio a due ante e una scrivania vuota. Sulla sedia c’erano sparsi alcuni abiti di Johann. Si vedeva che Rukeli non passava molto tempo in casa, e che non ci prestasse neanche molta attenzione. Però ci teneva a tenerla pulita. Ordinata no, ma pulita sì. «Vuoi bere qualcosa? Ho la birra» fece oscillare una bottiglia di vetro con una certa fierezza. «Preparamene un bicchiere, vado a mettere il pigiama» «Quanti anni hai, novanta?» Dalla camera da letto, Frieda gli lanciò una pantofola, facendolo scoppiare a ridere. Il pigiama di Frieda: una camicia da notte di raso color perla, i riflessi rosati, con i bordi della scollatura in pizzo delicato. Stringeva leggermente il seno e il punto vita, scendeva morbida su fianchi. Quando lui la vide, alzò un sopracciglio e non commentò. Indugiò con gli occhi sulla scollatura, intravedeva l’incavo dei seni. Deglutì a vuoto. «Che fai qui quando sei solo?» gli chiese, appoggiandosi al muro. «Non sono quasi mai qui» replicò con un sorriso furbastro. «E dove sei?» indagò, quasi a volerlo sfidare. Assottigliò lo sguardo. «Con una dannata ragazza cosacca che fa la gelosa» «Mh, va bene.» esclamò, su di giri «Vuoi giocare a carte? È presto per dormire» si voltò per avviarsi verso la camera e prendere le carte da gioco. Johann la guardò sbigottito e si sentì preso in giro. Lo stava mettendo alla prova, voleva vedere quando avrebbe ceduto. Se non l’avesse desiderata così tanto in quel momento, avrebbe lottato un po’ di più per non dargliela vinta. Ma avrebbe ceduto lo stesso, lo sapeva, Frieda gli faceva crollare tutte le difese. In un attimo fu alle sue spalle. «Ho un’idea migliore.» le sussurrò, all’orecchio, facendola rabbrividire «Mia casa, mie regole. Sei qui con me, siamo soli, abbiamo una notte davanti, e tu indossi questa fastidiosa sottana che vorrei strapparti di dosso. Arrenditi». Le mani cercarono i fianchi, accarezzarono il tessuto liscio della camicia da notte, ricalcando le forme dolci della ragazza. Baci bollenti sulle spalle, sul collo. I corpi attaccati. «Da quanto tempo aspettavi questo momento, Gibsy?» sibilò con un sorriso dispettoso e sexy, le mani posate su quelle di lui. Un sorriso famelico gli increspò le labbra, passò la lingua sui denti come un predatore a caccia. Una mano le premeva delicatamente sul costato, appena sotto il seno, per tenerla attaccata e lui; con l’altra risaliva il fianco, portando con sé la camicia da notte e lasciando la pelle scoperta, con la punta delle dita le accarezzo la striscia di pelle appena sotto l’elastico della mutanda. Le labbra continuavano il loro percorso sulle spalle. Risalirono sul collo, raggiunsero l’orecchio. Le morse il lobo prima di parlare, in un sussurro, la voce calda ed erotica. Tutto il bassoventre di Frieda si contrasse a quelle attenzioni. «Ti voglio tutta, senza esclusione di colpi. Respiro affannato, guance rosse e camice da notte da strappare. Ho solo buone intenzioni con te, quelle cattive decidile tu». |
Capitolo 7
*** 1.07 - Schönower Heide ***
|
7 - Schönower Heide
Si svegliò riposato, ma in una posizione assolutamente inconsueta sul letto. Erano sdraiati ai piedi del letto, sul bordo, le gambe intrecciate. Completamente nudi. Ah già. Ricordò quella notte con un sorriso assonnato. Guardò la ragazza, dormiva serena accoccolata al suo petto. Le labbra arrossate dai baci di quella notte erano leggermente schiuse e mostravano il bianco dei denti. I capelli biondi arruffati e luminosi alla luce dei raggi solari che filtravano dalle tende bianche della stanza. Aveva una pelle meravigliosa: liscia e morbida, era porcellana preziosa. Era calda, gli scaldava l’anima e il corpo. Quella notte l’aveva vista nuda, l’aveva sentita, l’aveva toccata; il suo profumo di lavanda, la sua forma a clessidra, le natiche lisce e morbide, i seni rotondi e sodi, le sue gambe affusolate strette intorno a lui durante l’amplesso. La loro prima volta. Era quello fare l’amore. Con dolcezza e premura, mettere le anime a contatto ancora prima del corpo. Chiuse gli occhi riassaporando quel momento, mentre con la mano continuava a disegnare cerchi sulla spalla della ragazza accoccolata a sé. Aveva conosciuto moltissime donne, andato a letto con molte di loro. Ma Frieda era perfetta, era sua ed era una bambola di porcellana preziosa. Per troppo tempo aveva desiderato poterla toccare come quella notte. Era solo sua. Un angelo incarnato solo per lui. Nessuno avrebbe potuto portargliela via. Frieda mugugnò qualcosa e si stropicciò gli occhi. «Buongiorno, bambina» le sorrise, scoccandole un bacio tra i capelli. «Ehi» pigolò e si mise a sedere, allungando le braccia al soffitto per stiracchiarsi. Johann contemplò ancora una volta quel magnifico corpo nudo. La luce della mattina lo rendeva ancora più morbido, e la finezza che sfoggiava Frieda anche appena sveglia era rara. Altre donne, appena sveglie, erano volgari. Non nel parlare, ma nell’atteggiamento e nell’aspetto. Il trucco completamente distrutto, il corpo quasi grottesco. Belle, sì, ma solo se agghindate e in ordine. Lei non era così. Anche senza trucco e con i capelli arruffati, anche appena sveglia e assonnata, era fine. Il lenzuolo copriva elegantemente le nudità, e i seni ben rotondi e sodi non risultavano volgari come quelli estremamente prosperosi ma decadenti di altre. Amava guardarla. Poteva fissarla per ore e non stancarsi mai. «E ora come faccio, volevo arrivare vergine al matrimonio. Sei un tipo losco, Trollmann» Lui si mise a ridacchiare, tirandola per un braccio per farla stendere di nuovo vicino a sé. «Allora ti sposerò, un giorno, così non ti devi preoccupare» le stampò un bacio sulla punta del naso. «È una promessa?» domandò lei, con un sorrisetto sfottò. Johann arricciò il naso con un sorriso. «Se vuoi» «Io comunque scherzavo» gli morse piano la punta del naso. Lui inarcò le sopracciglia, con aria di sufficienza. «Lo so. Alla fine l’ho capito, comunque, che non era la tua prima volta» «Sei un grande esperto sul serio, allora» si appoggiò su un gomito, di fianco a lui. «Nemmeno ti rispondo, guarda» un sorriso sornione si aprì sul bel viso del sinti, come un gatto che fa le fusa. Se n’era accorto, ma aveva capito che la ragazza non doveva avere esperienza. Praticamente, era come se fosse stata la sua prima volta. Era ipersensibile agli stimoli e dolcemente inesperta, e l’aveva mandato in knock-out. Era audace e questo gli piaceva, non era passiva. Non ci aveva impiegato molto a prendere familiarità con il corpo di Johann. Tra cosacchi vivevano il sesso senza tabù. E poi, con un’amica come Hildi, un po’ di cose le sapeva in anteprima. Lei confidava tutto, ogni dettaglio. Tra una cosa e l’altra, Frieda aveva una mente molto aperta alla sessualità, non si scandalizzava come le sue coetanee e non era schizzinosa. La considerava una cosa assolutamente normale e naturale. Non esistevano tabù. La prima volta di Frieda era stata a diciassette anni, ed era stata la prima ed unica. Fu un disastro e non le piacque nemmeno, anche se il ragazzo le piaceva ed era un tipo apposto. Aveva capito lì che saper fare sesso era quasi un’arte, non tutti ne erano in grado. Ma Johann… Ci sapeva fare sul serio. Non era un cialtrone. «È stato fantastico» ammise timidamente, le guance rosse d’imbarazzo. Rukeli inghiottì l’azzurro cielo nel baratro del suo sguardo. Un breve silenzio, un lento sorriso sornione, lo sguardo di un lupo sul punto di saltare sul cerbiatto; la punta delle dita percorsero il fianco e la coscia della ragazza, fino a stringere sulla carne. «Facevi la preziosa, che a bordo ring non volevi urlare il mio nome come le altre. Alla fine però hai gridato per me.» sussurrò sfiorandole le labbra con le sue «Mi piace quando lo fai, mi piace quando gridi il mio nome». Avevano fatto colazione insieme. Johann non doveva allenarsi e lei aveva il turno al pub dopo cena, perciò avevano una giornata libera. La mattina avevano fatto un giro per Mitte, mano nella mano, e avevano spaventato bambini o comprato loro dei dolci come facevano di solito. Poi avevano fatto un salto al mercato ed erano tornati a casa. La neve era cominciata a scendere ma non attecchiva ancora. Pranzarono con uno stufato e poi andarono al maneggio. Frieda prese la macchina di suo padre senza chiedergli il permesso, gli lasciò solo un biglietto d’avviso nella cassetta della posta. Per metterla in moto collegò dei fili sotto al volante. Ricordava ancora la prima volta che l’aveva accompagnata al maneggio, che l’aveva vista guidare e mettere in moto l’auto. A volte con i fili sotto al volante, altre volte chiedendo le chiavi al padre. Ogni volta, appena saliva in macchina, c’era la routine: capelli dentro il borsalino, baffi finti e finti occhiali da vista dalla montatura enorme. «Le donne non potrebbero guidare, in teoria» osservò Johann, vagamente divertito. «Allora fallo tu, sei capace a guidare una macchina?» lo provocò, indossando il borsalino e nascondendoci dentro i capelli. «Beh, no.» ammise controvoglia «Chi ti ha insegnato?» «Mio padre, quando ha visto che tentavo di farlo da sola.» trafficò con uno scomparto dell’auto, estraendo un paio di biondi baffi finti che attaccò sopra il labbro «Però, come hai detto tu stesso, le donne non possono. È per questo che giro come Friedrich Bilda» disse orgogliosa, presentando il suo alter ego maschile con una carezza sui baffi. Non se l’aspettava. Ciò che stava facendo Frieda era praticamente illegale e non le importava nulla. La realtà era che in assenza del padre qualcuno doveva pur occuparsi dei cavalli, e chi meglio di lei? Non le interessava se la legge diceva che le donne non potevano guidare, le interessava dei suoi animali e della loro salute, e infrangere quelle sciocche regole era l’unico modo per prendersi cura di loro quando Edmund non poteva. «Non c’è il maschile di Olga?» sghignazzò. Lei ingranò la marcia. «Oleg. Un nome odioso come la sua controparte femminile. Frieda è il diminutivo di Friederike, perciò devo mettere al maschile Friederike» «Mia madre si chiama Friederike» Frieda gli strizzò l’occhio. «Sicuramente è una donna fantastica» «Egocentrica». La ragazza guidò sull’asfalto freddo seguendo le linee sinuose delle colline a nord di Berlino. Uscirono dalla regione, Frieda guidò a lungo. Arrivarono alle campagne di Schönower Heide[1]. Il fazzoletto di terra della famiglia Bilda era delimitato con una recinzione di legno e un cancello basso, era una porzione ampia che permetteva ai cavalli di girare liberamente. In fondo c’era un vecchio casale di piccole dimensioni che veniva usato per qualche rimpatriata ed era tenuto pulito, poi c’erano le stalle e il fienile, che era così grande che ci avevano persino messo dentro i trofei di Frieda e un tavolo con qualche sedia. C’era il tiro a bersaglio con le freccette nere e rosse, e i bersagli di fieno per il tiro con l’arco tra l’erba. Schönower Heide era quasi interamente coperta di fiori di lavanda e piccoli cespugli, e non c’erano molti alberi. Johann amava quel posto, profumava di natura e lo faceva sentire libero. Frieda scese per aprire il cancello di legno e rimontò sull’auto per entrare e parcheggiare dentro, vicino al fienile. Dovevano ripulire le stalle, rifornire con il fieno, rimettere l’acqua, coprire i cavalli e fargli fare un giro. Avevano il loro da fare, come sempre, ma in due si faceva prima. Johann adorava quel lato del carattere della ragazza: sempre pronta a rimboccarsi le maniche anche per fare lavori faticosi o non molto puliti come spalare via le feci dei cavalli, non si schifava e non era schizzinosa. Johann dal canto suo non aveva imparato un mestiere vero e proprio, eccetto magari fare il pane, e ogni tanto prendeva in giro scherzosamente Frieda dicendole che con lei stava imparando a fare lo stalliere. Mentre ripulivano il fienile, guardò le foto e i premi che la ragazza aveva vinto con il tiro con l’arco. Una meravigliosa amazzone con i capelli biondi e la mira micidiale di un cecchino. «Insegnami a tirare con l’arco o a freccette. Voglio migliorare la mia mira» le disse. Lei posò il grosso masso di fieno su una pila bassa, e lo guardò interrogativa. «D’accordo. Prima copriamo i cavalli, vieni». Edmund Bilda, scappato dall’Ucraina per via delle persecuzioni ai cosacchi e arrivato in Germania all’inizio del 1900, domava i cavalli per l’esercito tedesco. Viveva con Frieda e la moglie Agnes in una campagna grande il doppio di quella, ad ovest di Berlino. Perciò la ragazza era cresciuta in campagna, non aveva assistito neanche molto agli orrori della guerra. Ma la guerra le portò via sua madre nel 1917, un giorno che era a Berlino per comprare alcune stoffe. In concomitanza con il successo sportivo di Frieda, in ambito equestre, Edmund Bilda perse il lavoro e importanza, perché slavo, cadendo in miseria. Solo grazie all’aiuto di un amico ebreo, riuscì a tenere tre cavalli e prendere un pezzo di terra di modeste dimensioni, ed era quello. Ora gli restavano tre cavalli: Annika e Livia, due giumente, la prima grigia pezzata e l’altra color nocciola, e Alfie, lo stallone di razza gidran dal manto color castagna. La prima volta che Johann vide Alfie, così aggraziato e possente, era convinto che fosse il cavallo di Edmund Bilda. Alfie era stato prelevato dalle praterie dell’Ungheria, era un puledro selvaggio. Aveva pensato che fosse del signor Bilda perché era un grande esperto nella doma dei cavalli. Invece apparteneva a Frieda, lo cavalcava lei e avevano vinto insieme il titolo nazionale di cross-country. Alfie era addestrato alla perfezione ed abituato ai boschi. Gli gidran erano originari dall’Ungheria ed erano cavalli anglo-arabi perciò molto aggraziati, eleganti, ma forti e veloci. Dal temperamento vivace, energico, estremamente intelligente ed espressivo, erano molto poco inclini a lasciarsi domare e per questo non era semplice trovare gidran addestrati. Ma con una buona dose di comprensione ed empatia tra fantino e cavallo, si poteva arrivare ad un compromesso. Johann adorava quel cavallo, e quel cavallo sembrava apprezzare la sua scherzosa compagnia. Frieda gli aveva detto che se Johann fosse stato un cavallo, sarebbe stato un mustang selvaggio, dalle Americhe, per il suo temperamento indomito, indipendente, coraggioso, difficile da addestrare e dalla volontà impiegabile. Invece, secondo Johann, Frieda sarebbe stata proprio una gidran. Lui conosceva i cavalli. Durante la Guerra era andato a vivere nelle campagne dello zio, che domava quegli animali per l’esercito. Aveva imparato le diverse razze, le varie caratteristiche fisiche e caratteriali, e aveva imparato a cavalcare. D’altronde, lo zio Robert Weiss - fratello minore di sua madre - gli ripeteva sempre un proverbio gitano, aggiungendo: «I miei tesori non luccicano né tintinnano ma brillano nel sole e nitriscono nella notte. Questi animali sono con noi dall’alba dei tempi, senza di loro non saremmo qui. Sono il nostro tesoro più grande». Coperti i cavalli con dei teli pesanti, l’unica cosa che ai due restava da fare era tirare con l’arco. Frieda prese il suo arco, in legno chiaro e ricurvo sugli estremi, e la faretra. Si posizionò a diversi metri dal bersaglio, incoccò la freccia e tese la corda. Johann vide che quando la corda era tesa e arrivava al viso, Frieda fermava il respiro per una manciata di secondi. Tempo di prendere la mira. Espirava quando la freccia era già partita. Toccò a lui provare, lei non gli diede indicazioni né niente. Cercò di imitare la sua postura, l’incocco, il fiato. Non immaginava che anche nel tiro con l’arco fosse importante il respiro. Lei gli stava dietro. Gli alzò il gomito che teneva la corda tesa. «È la schiena che lavora, le scapole, le spalle. Non le braccia» gli disse. Lui seguì le indicazioni. Prese la mira. «Non mirare guardando la punta della freccia. Guarda dove vuoi colpire. I colpi vanno dove si posa lo sguardo». Era quello che gli diceva sempre anche Leyendecker, ma con il pugilato era diverso. «Fissa il punto, tieni il fiato. Quando sei pronto, lascia». I primi tentativi furono quasi disastrosi. Le frecce non prendevano il bersaglio oppure lo colpivano solo nei margini. Ma Frieda gli aveva detto che andava bene così, che era la prima volta e che era stato bravo. Gli aveva dato un bacio sulla guancia e lui aveva sorriso. Si sarebbe allenato meglio piano piano. Non doveva fare gare o combattere per il titolo nazionale di tiro con l’arco, aveva tutto il tempo. Ma si era impuntato che doveva imparare, e l’avrebbe fatto. Riuscirono a tornare a Berlino con il crepuscolo, tornarono a casa di Johann visto che Frieda aveva lasciato lì le sue cose. Si strappò via i baffi finti e li rimise a posto nel cruscotto, infine si tolse i capelli da sotto al borsalino. Quando entrarono nell’appartamento, doveva sbrigarsi a cenare per andare a lavorare puntuale. Ci pensò Johann a preparare la cena, mentre lei sistemava le sue cose. «Non sapevo che sapessi cucinare» commentò lei, la sacca appesa alla spalla. «Non sai tante cose di quello che so fare» replicò lui, lo sguardo furbo come quello di una volpe. «Ad esempio?» «So suonare il violino. Lo sapevi?» «Suonalo per me un giorno» «Te lo suonerei ogni sera per farti addormentare.» replicò, con un sorriso tenero «E farti chiudere quella bocca. Ché parli sempre» aggiunse, scherzoso. Tra uno sfottò e l’altro, si ritrovarono a parlare di loro. Cose che non si erano ancora mai detti. Cose che avrebbero voluto fare insieme come campeggi, viaggi, vacanze. Cosa sarebbero voluti diventare. Frieda voleva fare l’antropologa, Johann voleva diventare un campione di boxe. Sogni di due ragazzi che non volevano altro che divertirsi e andare avanti, trovare la loro strada. Progetti di gioventù destinati ad un boulevard di sogni infranti. Lui la accompagnò a casa a posare la sacca, e poi al Der Blume. «L’undici novembre c’è l’incontro di un mio amico ad Hannover.» le disse «Era mio compagno ai tempi della Sparta Linden. Andrò a vederlo, così saluto anche la mia famiglia. Ti va di venire?» Frieda ci pensò su. «Devo sentire se mi danno un paio di giorni di permesso.» indicò il pub «Se me li concedono, vengo volentieri» «Tanto staremo da qualche parte tipo un motel.» abbassò lo sguardo, imbarazzato «Casa mia è troppo piccola» Lei gli diede una pacca scherzosa. «Non importa. Io vado» si mise in punta di piedi e lo tirò verso il basso per ricevere un bacio. «Dopo ti riporto a casa io» le pizzicò il fianco scherzosamente e le strizzò l’occhio prima di voltarsi e andare. Lei entrò nel pub di fretta e furia, salutò tutti e si andò a cambiare. Da quando conobbe Rukeli, l’uomo molesto non si era più fatto vedere. [1] Schönower Heide Attualmente è una riserva naturale, ma fu proclamata tale dopo la Seconda Guerra Mondiale. |
Capitolo 8
*** 1.08 - Divergenze tra Trollmann ***
8 - Divergenzen zwischen Trollmann
11 novembre 1932 Un paio di giorni prima Johann aveva combattuto a Berlino contro Hein Domgoergen. Era un peso medio di settantatré chilogrammi, una decina d’anni più grande di Rukeli. La foto che pubblicò Box-Sport dell’incontro inquadrava Trollmann con le gambe estremamente divaricate come era solito a metterle lui, il destro alto e il sinistro più basso, il busto leggermente spostato indietro per schivare il colpo dell’avversario. Il piede sinistro di Domgoergen pestava leggermente quello di Johann. A causa delle gambe divaricate di Johann in quella foto, Box-Sport non perse occasione di scrivere un articolo dal vago tono sfottò. L’incontro finì pare, e la rivista di settore sottolineò il fatto che era un esito ingiusto, che andava compresa l’età “avanzata” di Domgoergen e premiata. Trollmann contro Domogoergen, 9 novembre 1932, Berlino, Spinchernsaele. Frieda aveva avuto i suoi tre giorni di permesso e il giorno dell’incontro, l’undici novembre, aveva preso il treno all’alba con Johann fino ad Hannover. Si erano sistemati nella stanza di un albergo in centro e poi erano andati a Tiefenthal, a casa di Johann. Era un ambiente molto piccolo, c’era puzza di umido. Ma a Frieda non diede fastidio, era abituata all’odore di feci di cavallo, c’era poco da fare la schizzinosa. In casa c’erano Friederike Weiss che fumava il sigaro, Albert e Julius giocavano a carte. Carlo era con la famiglia, sua moglie Erna. Ferdinand con Mausi, la sua fidanzata. Le tre sorelle erano ognuna per conto proprio, con i mariti, i figli, da qualche parte ad Hannover. Stabeli era con suo padre Schnipplo, in giro per le strade a suonare il violino. «Sono tornato!» cantò Johann, aprendo la porta dell’appartamento con quel suo fare trionfale e teatrale. «Oh no» piagnucolò Mauso, prima di lanciargli un sorriso. Mauso veniva soprannominato così fin da bambino perché aveva il visetto da topo. Aveva ventidue anni, tre in meno di Johann, praticamente la stessa età di Frieda. Albert si accorse della ragazza dietro Rukeli, «C’è una signorina!» Lui, invece, aveva diciannove anni. Si allenava come pugile alla Sparta Linden. Aveva successo con le donne, pur non essendo bello come Rukeli, Stabeli o Carlo. Aveva talento, fin da quando era bambino. Friederike aveva cinquantotto anni. Una rete fitta di rughe le circondava gli occhi e sembrava più anziana di quanto non fosse. I capelli, neri e legati, non avevano segni di vecchiaia. Gli occhi erano neri, infossati, e portava grandi orecchini d’oro. Si sporse per vedere la ragazza, che Johann aveva circondato con un braccio e trascinato dentro. «Vi presento Frieda, la mia fidanzata» «È biondissima!» commentò Benni. «Sì, sì. Non guardarla troppo che la sciupi» gli fece un cenno con la mano, prima di scompigliargli i capelli neri. Poi indicò a Frieda i suoi fratelli e sua madre, presentandoglieli. Lei li guardava, era così diversa da loro, selvaggi e tenebrosi. Friederike aveva una punta di severità nello sguardo, ma i fratelli di Johann la guardavano con curiosità e simpatia. «Ragazza mia» si avvicinò Julius, «devi odiarti proprio tanto per stare con uno come Rukeli. Sei ancora in tempo. A meno che non sei mezza matta pure tu, s’intende» Johann alzò gli occhi al cielo, «Mi fai cattiva pubblicità» «Quanti anni hai, cara?» le domandò Friederike, un sorriso conciliante. «Ventidue compiuti a settembre, Frau Trollmann» rispose Frieda, ricambiando il sorriso. «Ah, come Mauso.» indicò il figlio che poco prima stava parlando con lei «Tre anni meno di Johann» «Sì, ma lei sembra una bambina» giocò Rukeli, appoggiandosi alla testa di Frieda col braccio, come a voler marcare l’elevata differenza d’altezza. «Lei sembra, tu lo sei.» Friederike lo colpì con un giornale sulla testa riccioluta, lui scoppiò a ridere «Bambinone» «Chi è giovane nello spirito non invecchia, io non invecchierò mai» si difese, gonfiando il petto con orgoglio. La madre non gli rispose. Con i tumulti che stavano avvenendo in Germania, cominciavano a crollare le sicurezze. E loro erano zingari. Lui non voleva invecchiare, ma d’altronde invecchiare significava aver vissuta la propria vita per intero. Pregò che quel suo figliolo scapestrato sarebbe invecchiato, un giorno. «Frieda è cosacca» informò sua madre, sedendosi su una delle sedie. La ragazza restò in piedi, si appollaiò sulla schiena leggermente curvata di Johann, appoggiato con i gomiti sul tavolo. «Russia?» le domandò la donna, incuriosita. «Ucraina» le sorrise l’altra. «Ah, i cosacchi che non si piegano a Stalin. Siete un popolo fiero». Rukeli guardò la ragazza, intuendo i suoi pensieri. La mente di lei era corsa al genocidio che proseguiva indisturbato in Ucraina. I cosacchi stavano venendo sterminati proprio perché non volevano piegarsi a Stalin. Il loro orgoglio, la loro dignità e il loro onore era diventato la loro morte. «Ho sentito dire» indagò Mauso, «che avete una lingua vostra» «Beh, di solito parliamo la lingua del Paese in cui siamo stanziati.» rispose Frieda «Nel caso della mia famiglia parliamo l’ucraino e un po’ di russo per via dell’Unione Sovietica. Io, mio padre e mio cugino anche il tedesco, io soprattutto perché sono nata e cresciuta in Germania. Tra i cosacchi però si parla il cosacco, sì, ovvero il kazako» «Parli quattro lingue, maledizione. Non me l’hai mai detto» brontolò Johann. «In realtà il russo non lo conosco. Solo qualche parola.» gli diede un bacio tra i capelli «Il kazako può essere scritto sia con l’alfabeto cirillico, che latino, che arabo. Ma in realtà è una lingua turca con varie influenze. Vi confesso che io non so scrivere né in ucraino né in kazako, solo in tedesco» «È un po’ come noi» commentò Albert, «che parliamo la lingua del Paese che ci ospita ma tra noi parliamo il romanì». Friederike la guardò a lungo. Il visetto di quella ragazza era sui giornali nel ’28 e nel ’29. La campionessa d’equitazione a cui avevano tolto il titolo perché cosacca. Una fanciulla apparentemente ariana che condivideva lo stesso destino degli zingari, un fato comune riservato ai nomadi e ai reietti. Avrebbe preferito una ragazza sinti per il suo bambino, però lei apparteneva agli “zingari” dell’est Europa. Condividevano, se non altro, un cuore libero. I cosacchi erano gente fiera: “Famiglia, libertà, onore” era il loro motto. La famiglia posta persino prima della libertà e dell’onore, i bambini venivano educati secondo quel concetto. Erano più vicini ai sinti di quanto non fossero altri. I loro cuori e la loro stazza erano forgiate dai venti delle steppe, dal calore dei cavalli. Duri e glaciali solo all’apparenza; un fuoco sotto la cenere ribolliva nelle loro vene. A pranzo, Frieda fece la conoscenza del resto della famiglia Trollmann. Tutti volevano conoscere la fidanzata di Johann. Conoscevano il ragazzo, sapevano che era un farfallone con le donne, ma solo perché non aveva trovato quella giusta. Che, a quanto pareva, sembrava essere Frieda. Gli si leggeva negli occhi, nessuno l’aveva mai preso così tanto. Nel pomeriggio, andarono a passeggio con quasi tutti i fratelli e le loro fidanzate. Johann teneva Frieda a braccetto, gli piaceva mostrarsi con lei. La gente di Hannover lo riconosceva, lo salutava, lo osannava, gli faceva i complimenti. E lui si fermava volentieri a scambiare due parole con chiunque gli capitasse a tiro, si fermava per dare due calci ai palloni con cui giocavano i bambini in strada e poi si metteva a ridere con loro. Qualcuno di loro lo riconosceva e gli chiedeva di farsi insegnare due mosse di boxe, allora lui si improvvisava allenatore. A Frieda raccontò delle sue prime volte in cui tirava di boxe, quando ancora non aveva messo piede in una palestra. Aveva cominciato per gioco, un suo amico più grande gliene aveva solo parlato. «Andavo nelle campagne sul Leine, che ci stavano le fattorie» le disse, seduto su un muretto con le mani nelle tasche, «e cominciavo a fare la lotta con gli animali. Nel mentre facevo anche il cronista. “Rukeli è implacabile, sta combattendo contro tre temibili avversari! La capretta sta cercando di incornarlo ma lui è più veloce, e la mette al tappeto. La gallina prova un assurdo attacco d’ali ma anche lei viene messa fuori gioco. Ed infine ecco il tacchino, è cattivo, pronto a colpire Rukeli. Ma va giù anche lui!”.» simulò grida mute, come una platea invisibile che lo acclamava «“Rukeli Trollmann vince l’incontro!” E nella mia testa partivano gli applausi scroscianti. Poi l’allevatore mi vedeva e mi rincorreva con un forcone. Fine della magia». Solo più avanti avrebbe scoperto il mondo del pugilato, nel fango tra le strade della città vecchia. Era molto popolare tra i bambini e i ragazzi zingari, che però avevano una versione tutta loro: infatti usavano anche le gambe. Proprio ciò che Johann faceva sul ring. Le danze gitane portate sul quadrato. Frieda scoppiò a ridere gettando la testa indietro e aggrappandosi al suo braccio. Johann la guardò con un sorriso divertito, poi le comprò un po’ di zucchero filato. Le altre donne erano Erna, Mausi e Franziska, rispettivamente le fidanzate di Carlo, Ferdinand e Julius. Carlo ed Erna si erano sposati, Ferdinand e Mausi avevano in programma di farlo a luglio dell’anno successivo, Julius e Franziska non ci pensavano neanche. Le donne camminavano a braccetto davanti ai loro rispettivi compagni, ridevano e chiacchieravano di tutto. C’era Frieda, la più piccola d’età e di statura, che camminava più esterna perché doveva divorare il suo zucchero filato; Erna aveva le mani piccole e la braccia paffutelle, con lunghi capelli nocciola; Mausi era eterea, sottile come una spiga di grano, i capelli neri e ricci tagliati fin sotto le orecchie, ancora seguace della moda americana flapper; Franziska camminava esterna come Frieda, era alta e un tantino tarchiata, i capelli castano scuro di lunghezza media e il cappellino. Tra le chiacchiere, l’unica risata che si distingueva era quella di Frieda. La più squillante e vistosa. Le altre ragazze le facevano segno di fare più piano, non era carino attirare l’attenzione. Ma puntualmente, la ragazza rideva a crepapelle. Johann non riusciva a smettere di guardarla. Non le staccava gli occhi di dosso. Julius gli mollò una gomitata. «Accidenti, Rukeli, te la stai mangiando!» «Se ti fa stare meglio mi metto a guardare gli uomini» «Che intenzioni hai con lei?» gli domandò Carlo, le mani in tasca e una sigaretta penzolante tra le labbra. Carlo era votato allo studio, al matrimonio, al lavoro, alle regole. Erano cose a cui teneva. «Non corriamo troppo, stiamo insieme da giugno ed è novembre. Una cosa per volta» Johann alzò le mani, come a difendersi. «Metterai mai la testa a posto?» domanda retorica. «Ho ventiquattro anni» lo disse con un tono esasperato, «non voglio mettermi a pensare che devo mettere su famiglia ad ogni costo. C’è tempo, prima voglio divertirmi» «È questo il tuo problema, Rukeli. Tu vuoi solo divertirti. Comincia a prendere qualche responsabilità, non l’hai mai fatto. Tutti noi abbiamo cominciato a lavorare presto per aiutare la famiglia, tu no. Tu hai sempre fatto come volevi, non hai lavorato e ti sei messo a tirare pugni ad un sacco appeso ad un gancio». Carlo era implacabile. Lolo e Mauso si scambiarono un’occhiata, fu Julius a cercare di rabbonire gli animi. «Dai Carlo, non te la prendere così. È la sua vita e ne fa ciò che vuole». Gli occhi neri del maggiore trafissero il più piccolo, che tornò da Ferdinand in silenzio. Rukeli lanciò un’occhiata in tralice al fratello maggiore. L’aria di sfida. «Ho vinto quattro campionati da dilettante, ho portato dei soldi alla famiglia. Non significa che io abbia faticato meno di voi» «Noi eravamo in strada a prenderci gli insulti della gente. Io ero sui libri da mattina a sera per prendere un pezzo di carta che mi avrebbe permesso di tirarmi su da questa poltiglia. Tu neanche quello hai voluto fare, neanche il diploma!» «Quindi per te questo è il problema? Gli insulti della gente? Credi che io non li abbia mai presi solo perché tiro di boxe?» erano domande che suonavano come esclamazioni sgomente «Per quanto riguarda lo studio, sei l’unico che ha dei titoli». Johann vide Frieda voltarsi, attirata dai toni di voce agitati. Erna vicino a lei la costrinse a voltarsi di nuovo: una donna non doveva impicciarsi quando due uomini discutevano. «Rukeli sto solo dicendo che è ora che tu la smetta di far finta di essere solo al mondo, seguendo puramente l’istinto. Cerca di essere più razionale, prendendo responsabilità. Comincia sposando quella ragazza» «Non ci voglio pensare ora. Mi piace così la mia vita. Quando e se mi sposerò sarà perché lo voglio io, non perché lo vuoi tu» archiviò, e la discussione cadde. Carlo sapeva che non poteva insistere con Johann se aveva già preso una decisione. Ma la testardaggine era una prerogativa di tutti i Trollmann, quindi di tanto in tanto ci riprovava a fargli capire l’importanza delle responsabilità e del mettere su famiglia. Rukeli aveva lanciato un’occhiata al cielo che cominciava ad assumere tinture rosse e arancio, alle loro spalle era già quasi nero. Controllò l’ora sull’orologio da polso. Avevano poco tempo per mangiare e andare alla Sparta Linden per il combattimento di Paul Schubert. Johann si fermò in mezzo al marciapiede, infilò una mano in tasca. «Frieda» la chiamò, senza alzare la voce. Lei si voltò per guardarlo e senza che lui le dicesse niente la ragazza salutò tutti gli altri con strette di mano e baci sulle guance, e lo raggiunse prendendogli la mano che non aveva infilato in tasca. Si fermarono a mangiare uno spuntino veloce in un bar. Johann durante la cena era scuro in volto, non gli andava di parlare e assecondare il buon umore di Frieda. Rimuginava sulle parole del fratello. Poi, dopo essere usciti, lei lo costrinse a fermarsi e gli si piazzò di fronte. Affondò gli occhi di cielo in quelli neri di Rukeli, prendendogli il volto tra le mani. «Non tenermi il broncio» gli sorrise, conciliante, «fammi un sorriso dei tuoi» gli tirò le guance cercando di farlo sorridere un po’. «Non mi va, bambina» le mise le mani sui polsi sottili. «Metti da parte la discussione con Carlo. Per il momento non stare imbronciato, godiamoci la serata e l’incontro del tuo amico». Lui sospirò dal naso, alla fine le diede un bacio sulla fronte. Frieda aveva ragione. Perché se la prendeva tanto per Carlo? Lui non condivideva le sue scelte di vita ma mica gli diceva niente. C’erano sempre state un po’ di divergenze tra i due, per via delle personalità profondamente diverse. Johann era più libero, faceva scelte in base a ciò che prevedeva per il suo futuro, e si comportava in base a quanto gli comunicava il suo istinto. Carlo era attaccato a regole e dettami, dogmi che sarebbero dovuti essere presenti e radicati anche in Rukeli, ma che non avevano attecchito sullo spirito libero del ragazzo. Per questo, agli occhi del fratello maggiore, era un irresponsabile. Alla palestra della Sparta Linden c’erano tutti i suoi vecchi compagni e l’allenatore che a lungo aveva seguito Rukeli, cercando di inculcargli nella testa una tecnica che non gli apparteneva. Alla fine aveva rinunciato e aveva imparato ad apprezzare lo stile leggero e imprevedibile del ragazzo. Tutti si complimentarono con Johann, visti gli ultimi risultati. Ma lui scartava i discorsi come vento tra le fessure, la stella della serata era Paul. Prese posto alle prime file con Frieda ed Albert, ma era già pronto a scattare di nuovo in piedi ed andare all’angolo dell’amico. Come sempre. Quando Frieda vide Paul, inarcò le sopracciglia. Era un tipo magrolino, neanche molto alto, i capelli biondi ben pettinati. «Prevedo uno zigomo rotto, come minimo» mormorò. Johann alzò un sopracciglio, si avvicinò con le labbra al suo orecchio, «Schiva colpi come niente fosse, ha un busto molto elastico» «Menomale» si limitò a dire. Il suo avversario era un po’ più piazzato. Ma si parlava sempre di un incontro dilettantistico nella categoria leggeri. Il ragazzo si scusò, e si alzò per andare all’angolo dell’amico, accanto al suo secondo; prese il suo posto, mettendosi l’asciugamano intorno al collo, sopra la camicia. Arrotolò le maniche fin sopra il gomito e infilò le mani nelle tasche dei pantaloni grigi, osservando il ragazzo che combatteva. Ogni tanto gli urlava un consiglio e alla fine di ogni round, quando Paul si sedeva al suo angolo, Johann gli stava accanto asciugandogli il sudore dal viso, facendolo bere e massaggiandogli le spalle. Poi lo rilanciava al centro del ring. Dopo sei riprese, dichiararono Paul vincitore ai punti. Sul ring si riversarono gli amici e i sostenitori del ragazzo, per abbracciarlo. Qualcuno aveva preparato una tavolata di birre per festeggiare la vittoria – non importava di chi. Johann abbracciò l’amico, dandogli pacche sulla schiena. Si scostò tenendo il braccio sulle sue spalle e chiamò l’attenzione di qualcuno vicino alle birre. «Amico, porta qui un boccale per il campione!» E quello aveva obbedito. Sciolse l’abbraccio e prese il bicchiere che veniva passato tra le corde del quadrato. Paul aveva ancora i guantoni, aveva la faccia sudata e sorridente. «T’aiuto io» se n’era uscito Trollmann e tenne il boccale di birra aiutando l’amico a bere, visto che la mano era ancora infilata nel guanto. La differenza fisica tra Johann e Paul era notevole. Il sinti superava di almeno due spalle il ragazzo tedesco, era più massiccio. Rukeli fece un cenno a Frieda ed Albert, invitandoli a raggiungerli sul ring. «E lei?» domandò Paul, alzando un sopracciglio. «È la ragazza che ti dicevo tempo fa, Frieda» sorrise «Solo che prima era mia amica, ora è la mia donna» L’amico gli scoccò un’occhiata, notando il modo in cui Johann guardava quella ragazza. Lo conosceva da tanto tempo, ma non aveva mai visto quello sguardo. «Accidenti, e quello sguardo? Non dirmi che ti sei innamorato!» Rukeli abbozzò un sorriso, «Può darsi». Albert aiutò Frieda a salire sul ring, impedita dalla gonna. La ragazza imprecò a denti stretti, ma Benni la sentì e scoppiò a ridere. Johann tese una mano alla ragazza, attirandola poi a sé, mentre il fratello salutava Paul e si congratulava per la vittoria. «Paul, ti presento Frieda» la presentò come se fosse un bene preziosissimo da non toccare per nessun motivo. La ragazza strinse la mano del giovane pugile, che si era tolto i guanti e gli restavano le dita fasciate. Gli bastò sentire la stretta di Frieda, salda e sicura, per capire che tipa doveva essere. «È un piacere. Mi ha parlato di te» le indicò Johann con un cenno del capo. «Anche a me ha parlato di te.» gli strizzò l’occhio «Complimenti per la vittoria!» «Ti ringrazio. Felice che vi siate divertiti, io sono un po’ ammaccato. La vittoria fa male a volte.» sorrise «Vado a salutare gli altri. Vogliamo andare a mangiare qualcosa appena ho finito qui?» «Muoviti che ho così fame che potrei mangiarmi una vacca. Ti aspettiamo fuori» rispose Johann, gli occhi che brillavano di divertimento. Albert seguì Paul per salutare i loro amici. La ragazza si voltò verso Rukeli, e gli tolse l’asciugamano dalle spalle gettandolo sulle corde. «Ti sei fatto prendere, guarda come hai ridotta la tua povera camicia» gli sistemò il colletto, con un sorriso da furfante. Lui non le rispose, si limitò a sbuffare un sorriso e lasciarsi sistemare, posandole le mani sui fianchi. «Sono Johann Trollmann e mi agito solo guardando i miei amici» gli fece il verso, modificando la voce per renderla più profonda, mentre stringeva il nodo della cravatta di Johann. Le afferrò delicatamente il mento tra le dita per sollevarle il viso, «Ti butto giù dal ring» le intimò, alzando il sopracciglio destro, tagliato da una cicatrice pallida. Frieda lo tirò per la cravatta, costringendolo ad abbassarsi per arrivare alle sue labbra. «Buttati giù tu, zingaro» gli sussurrò, facendolo scoppiare a ridere. Johann Trollmann e Paul Schubert, Hannover 1932. |
Capitolo 9
*** 1.09 - Io non gioco ***
9. Ich spiele nicht
Frieda si era definitivamente trasferita da Johann, subito dopo il ritorno da Hannover. Johann la mattina si dedicava a Frieda e alle faccende varie, pranzava, e subito dopo pranzo partiva con l’allenamento in palestra. Tornava per l’ora di cena e la sera di nuovo con la fidanzata. La ragazza, dal canto suo, lavorava al pub, faceva visita a suo padre e si occupava del maneggio; appena aveva un buco di tempo libero, si dedicava alla sistemazione della casa. Aveva decorato il balconcino con piante, aveva portato lì tutte le cose che teneva quando abitava con il padre ed era riuscita a trovare una poltrona ed una libreria. Era diventata la loro tana, il loro nido, il loro posto nel mondo. Con Johann avevano promesso di trovare del tempo per dipingere le pareti, ma era difficile ritagliarsi una giornata per un lavoro così impegnativo. Box-Sport, da un po’ di tempo, cominciava a chiamare Trollmann “Heinrich”. Il pugile, che non leggeva la rivista per non essere influenzato dai giudizi quasi sempre negativi della redazione, prese evidentemente visione di quegli articoli che riportavano un nome errato. Zirzow gli disse che Box-Sport storpiava i nomi di tutti i pugili, persino Schmeling fu deformato in tutti i modi possibili, tra il 1923 e il 1924. Lo zingaro però si era accorto che non si trattava di deformare, in questo caso, ma di modificare radicalmente. Perciò scrisse una lettera di protesta, dove chiedeva di essere chiamato con il suo vero nome. Box-Sport, edizione del 21 novembre 1932. Quella di Trollmann è una pretesa ingiustificata: ritiene importante venir chiamato con il suo nome di battesimo, ma non dà peso a tutti i nomignoli che gli vengono affibbiati. Troll, Gipsy, Hurrikan… Io da qualche parte ho letto che si chiama Heinrich Trollmann, e non Johann. Le sue prestazioni sono alterne come il suo record. Gli avversari che – diciamolo una buona volta – si sottomettono al suo personale stile di combattimento, non hanno nulla da offrire contro di lui. I pugili che combattono in modo corretto diventano matti quando si trovano in queste esibizioni da circo. Trollmann fa smorfie, gioca, si intrattiene con il pubblico durante i match, bleffa con naturalezza inaudita. Poi, quando l’avversario non si fa abbindolare dai suoi giochetti, sale sul ring un pugile eccellente, completamente diverso, trasformato. Boxa con superiorità, con buona scuola, accetta lo scambio corretto, determina il tempo, dà lezione, dimentica i trucchi, combatte alla grande e con significativo successo. Lo zingaro con tutti i suoi lati oscuri si è visto contro Russo, per citarne uno. Invece un Trollmann impeccabile lo si è visto contro Seeling, ad esempio. -Punch Tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, Johann aveva disputato due incontri con un colosso sette chili più pesante, ad Amburgo. La ragazza non era andata con lui. Si era un po’ preoccupata, il suo avversario era Adolf Witt e dicevano fosse un picchiatore, una specie di torre irremovibile. Ma lei sapeva che il suo campione, seppur più leggero, era alto e maestoso. Capitava che perdeva, anche se da quando si erano fidanzati non era successo, ma anche nella sconfitta il ragazzo non si perdeva d’animo anzi. Era un tipo sportivo, si complimentava sempre con l’avversario a prescindere dall’esito e ci scambiava volentieri due parole in veste di uomo, non di avversario. Johann non dimenticò il primo incontro con lui, del 27 novembre 1932, al Teatro Flora di Amburgo. Percorse i metri che lo separavano dal ring a modo suo: testa bassa, cappuccio sugli occhi. Saltò le corde del ring come un acrobata e arrivato al suo angolo si tolse l’accappatoio. La sua tipica entrata in scena, teatrale. La folla era già in delirio, soprattutto grida di donne. Qualcuno stava persino piangendo. Johann salutò il pubblico con un gesto della mano e un sorriso da divo da cinema americano. A qualcuna piaceva quell’aspetto selvatico e tenebroso, unito ad una buona dose di ironia e solarità. Però c’erano le camice brune in cima agli spalti, come all’incontro con Seeling. Come ad ogni altro incontro dello zingaro. Witt grugnì con il suo allenatore. «Questo stronzo crede di essere il migliore. Pensa che nessuno lo possa colpire.» Johann lo sentì, ammiccò nella sua direzione. Ma sì, in fondo… perché prendersi sul serio? Era sport, bisognava divertirsi innanzitutto. Suonò il gong. Cominciò l’incontro. Rukeli schivava con facilità tutti i colpi dell’avversario, rotazioni minime, rapidi movimenti di gambe e di busto. Gli girava un po’ intorno, lo faceva stancare, e poi lo colpiva che neanche lo vedevi. Colpi qua e là, per infastidirlo e innervosirlo, fargli sprecare energie. Mentre lo zingaro si limitava a non accanirsi troppo, anche se i suoi colpi erano rapidi e duri, Witt si muoveva con ferocia. In ogni colpo c’era una forza bestiale, violenta e piena d’odio. Alla sesta ripresa, l’incontro si concluse. Parità. Johann sorrise all’avversario. «Bell’incontro comunque! Complimenti.» L’altro non ricambiò né il sorriso, né ringraziò, si limitò a guardarlo con disprezzo, e il ragazzo non osò avvicinarsi per scambiare le consuete chiacchiere che tanto amava fare. Non se la prese, comunque. Non posso mica piacere a tutti. Poi, nello spogliatoio, Leyendecker prese a togliergli le bende dalle braccia. Gli occhi preoccupati. «Non prendertela per Witt. Non puoi capire.» gli mormorò. Il ragazzo alzò un sopracciglio, quasi offeso. Con la mano libera afferrò una mela e la morse. «E cosa dovrei capire? Che gli ho tenuto testa pur pesando sette chili di meno?» replicò, aspro. Si passò la lingua sui denti. A Leyendecker quel gesto sembrò la minaccia di un predatore a caccia. «Quelli non giocano, Johann.» Gli occhi del lupo fulminarono l’allenatore. «Nemmeno io.» «Sono filo-nazisti.» Rukeli sospirò dal naso. Improvvisamente, la mela non gli andava più. «Non ha niente a che fare con noi, è solo politica e noi facciamo sport.» «Promettimi che quando sarà il momento te ne andrai dalla Germania.» «Perché?» «Perché sei uno zingaro.» L’incontro dell’11 dicembre 1932, sempre contro Adolf Witt al Teatro Flora di Amburgo, fu perso da Rukeli ai punti, al decimo round. Anche in quell’occasione c’erano le camice brune che scrutavano dall’alto come avvoltoi. La verità era che Johann quell’incontro non doveva disputarlo. Era stato chiamato all’ultimo momento perché Kaspar, il reale avversario di Witt, si era fatto male e non poteva combattere. Era toccato a Trollmann sostituirlo, come aveva sostituito molti altri colleghi nel corso di quell’anno. Fatto sta che non era preparato, non gli andava neanche quella sera, e perse l’incontro ai punti. Witt era carico di una rinnovata energia, rinnovata sicurezza. Johann sospettò che fosse per via delle camice brune e del fatto che lo zingaro non era affatto pronto per quella serata. Box-Sport non aveva perso occasione per schierarsi dalla parte del vincitore, sottolineando il temperamento di Trollmann: “T. ha buone capacità e fa belle prestazioni, ma è un pugile instabile e imprevedibile, troppo influenzato dal suo stato d’animo. Contro Witt si è dimostrato un grande sconfitto, senza venir sminuito dai trucchi e le piccolezze che fanno parte di “Gipsy”.” Di ritorno a Berlino, Leyendecker impose a Trollmann estenuanti addestramenti di vuoto. Come se lo volesse punire di una sua mancanza. Ma in realtà Leyendecker ogni tanto lo faceva con tutti, perché un pugile spesso aveva bisogno di ricostruirsi, di tornare sui propri passi e ricominciare dalle basi. E per Rukeli, la base della sua boxe era il vuoto. Era un maestro nel combattere con le ombre, ovvero “fare il vuoto”. Lo faceva da sempre. Era uno degli allenamenti base di un pugile, aiutava a rendere più rapido e preciso il movimento, e a ricordare che l’avversario più importante da abbattere era sé stesso e le proprie paure. Passò i giorni che seguirono ad allenarsi duramente. Un giorno portò con sé Ivan Bilda, facendogli provare l’addestramento da professionista e usandolo come sparring partner. Fu ottimo allenarsi con il colosso cosacco. Gli ricordava Witt nello stile di combattimento e faceva sempre bene allenarsi con avversari del genere. Sia Leyendecker che Zirzow furono felici di avere Ivan alla palestra per gli allenamenti, lo usavano come sparring partner un po’ con tutti ma, per la maggiore, con Johann. Sperando che gli mettesse a posto quella testa dura. * * *
Quando aprì gli occhi, le tende erano aperte e il sole baciava la camera. Sulla soglia della porta c’era Frieda, con la sua camicia da notte color perla e un vassoio della colazione in mano. Johann mugugnò qualcosa e prima che potesse alzarsi, Frieda gli piazzò sulle gambe la colazione. Gli schioccò un bacio sulle labbra. «Buongiorno, campione. Ti sei riposato?» Il giorno prima l’aveva passato in palestra, l’aveva vista solo la sera. Si era stancato parecchio, e si era addormentato subito accoccolato a lei. Non riusciva a staccarle gli occhi di dosso: gli sembrava bella più che mai, illuminata così dai raggi del sole i capelli le brillavano come oro; poi amava come le calzava quella camicia da notte, riusciva a intravedere l’incavo tra i seni, il punto vita. Si morse il labbro. «Sì.» «Bene, perché non voglio sentire scuse. Oggi pitturiamo le pareti.» incrociò le braccia al petto, decisa. «Niente cavalli?» domandò distratto, mentre spostava il vassoio sul comodino. Lei scosse il capo, facendo oscillare la chioma. Le mani dietro la schiena come una bambina, il sorriso di chi aveva appena fatto una marachella. «Ho già preso la pittura, i teli e i pennelli. Consolati. – si avvicinò come una pantera, a carponi sulle lenzuola, fino a sfiorargli le labbra con le sue. – Domani non ci sono, lavoro quasi tutto il giorno, hai la giornata libera per fare lo scapolo a zonzo.» «Fantastico, almeno non ti ho tra i piedi.» mugugnò ironico, e si leccò il labbro inferiore con un sorrisetto. Lei non fece in tempo a replicare che Johann le saltò addosso, bloccandola sotto di sé. Frieda scoppiò a ridere e lui le sorrise, furbescamente. Johann ricoprì tutti i mobili con i teli, mentre Frieda sistemò i fogli di giornale sul pavimento per non sporcare tutto. Riuscirono a rimediare una scala dai vicini per arrivare ai punti più alti. Dopo un’ora e mezza passata con i preparativi, finalmente aprirono i barattoli di vernice. Il sinti lanciò un’occhiata critica ai colori scelti dalla ragazza, che sembrava piuttosto fiera delle sue compere. Aveva scelto un verde brillante per le pareti della cucina, un giallo canarino per il salotto, un azzurro cielo per il bagno. La camera da letto voleva lasciarla bianca. «La carta da parati non ti piaceva?» le domandò, alzando un sopracciglio. «Non mi piace quella roba, si scrosta. E dipingere è divertente.» replicò impegnandosi per aprire il primo barattolo di vernice senza troppo successo. Johann le scoccò un’occhiata divertita. «Ti serve un piede di porco per aprire quell’affare?» «Cosa fai lo spiritoso? Dammi una mano invece di stare lì a gongolare, accidenti a te!» Si spartirono i lavori: Frieda la cucina, Johann il salotto. La scala l’aveva lui, perciò quando la ragazza terminò la sua zona di lavoro, Rukeli dovette andare fino in cucina per pitturare la parte alta delle pareti dove lei non era riuscita ad arrivare. Si beccò anche gli sfottò per questo. «Certo.. – cominciò, dipingendo con il pennello a rullo. – Che sei davvero una gnoma.» La schizzò con la vernice verde del pennello e scoppiò a ridere. Frieda stava appostata sotto la scala, le mani piazzate sui fianchi e la faccia contrariata… e sporca di vernice. Lei mosse leggermente la scala, facendolo traballare. «Fai la brava.» «Hai cominciato tu!» «Gne gne gne.» Toccò a lei sporcarlo con il pennello sporco di giallo. A causa dell’altezza di lui, sulla scala, il massimo che riuscì a sporcare fu all’altezza delle cosce e fondoschiena. Johann sbuffò dal naso, come un toro. «Sei un concentrato di malvagità.» «Zitto, Trollmann, lavora!» gli gridò, dileguandosi verso il bagno per cominciare a dipingerlo. Finirono nel tardo pomeriggio. Sporchi dalla punta dei capelli alla suola delle scarpe di polvere e colori. Tra il lavoro vero e proprio, si erano anche messi a giocare a schizzarsi con la vernice e si erano sporcati tutti. Erano macchiati di colori brillanti. I teli sui mobili e i fogli di giornale erano rimasti vittime della loro guerra colorata. Il divano e il tavolo si erano trasformati in trincee per un momento del loro gioco. Frieda si strofinò il naso con il dorso della mano, perché aveva le dita tutte sporche d’azzurro. «Ma guarda che hai combinato.» «Io?! ─ esclamò Johann, si indicò le natiche sporche di giallo. – Sembra che mi sia seduto su un canarino!» In realtà aveva anche un segno azzurro su una delle natiche, perché Frieda non aveva resistito e gli aveva dato un pizzicotto con le mani sporche. Lei scoppiò a ridere e lo pungolò sulla guancia, sporcando la sua pelle nocciola di celeste. «Poteva andarti peggio, potevi sederti su un folletto.» E stavolta fu lei ad indicarsi il fondoschiena, dove tra i segni di vernice spiccava una manata gialla, dove lui le aveva dato una palpatina di rimando al pizzicotto. Johann sorrise, divertito. «Diamoci una ripulita. Poi andiamo a mangiare fuori, ti va?» * * *
Si era fatto Natale, infine. Era ancora il 1932. Avevano occupato il casale nella campagna di Frieda a Schönower Heide. Fuori c’era la neve che copriva i fiori di lavanda e i tetti delle stalle e del fienile. L’interno del casale era spazioso, quasi totalmente privo di mobilia. C’era una grande sala con solo un tavolo lungo, un vecchio pianoforte e una libreria. Poi c’erano altre quattro stanze molto piccole: la cucina, il bagno, un magazzino, e una stanza con la rete di un letto appoggiata al muro. Nei giorni precedenti, la famiglia Bilda aiutata talvolta da Johann, avevano sgomberato e ripulito il casale. Il ragazzo avrebbe combattuto il 20 gennaio, poteva stare un mese tranquillo. D’altronde quell’anno aveva disputato diciotto incontri classificandosi come il pugile più indaffarato di Germania. Nessun boxeur aveva combattuto così tanti incontri in un solo anno. Effettivamente, Johann sentiva un po’ la fatica e i ritmi serrati cominciavano a pesargli sulle spalle, ma da una parte gli piacevano anche. Si sentiva importante. Nello scenario pugilistico di quegli ultimi anni, e in particolare del ’32, Rukeli era diventato l’atleta più temuto dei pesi medi e mediomassimi. Gli altri pugili cercavano di girargli alla larga, ma non potevano evitarlo. E lui conquistava il ring. Quella sera della vigilia di Natale, al casale c’erano Frieda, Johann, Edmund e Ivan Bilda, Hildi e il suo nuovo fidanzato Bruno, Kaspar e Gilda, Hans e la sua fidanzata Margarete, Ferdinand e Mausi, Julius e Franziska. Erano tutti vestiti eleganti e se la stavano spassando. La cena, la birra in abbondanza, i dolci che aveva portato Hildi. «Fortuna che non li ha fatti Frieda.» commentò Ivan, sperando di non farsi sentire dalla cugina. In tutta risposta, la ragazza alzò il dito medio nella sua direzione dall’altra parte del tavolo provocando le risate generali. Hildi era davvero brava a fare i dolci. Inoltre sembrava innamorata e felice con Bruno. Era la prima volta che Frieda la vedeva così presa da qualcuno. Era raggiante. Si erano conosciuti nella gioielleria gestita dalla famiglia di Bruno, si erano innamorati subito. Lui era ebreo. Aveva i capelli neri, corti sulla testa, gli occhi azzurri e le labbra sottili, il naso un po’ aquilino. Ma aveva un bel sorriso, Hildi era perduta. Kaspar tirò fuori da una busta di cartone alcuni giochi da tavola e delle carte. «Strip poker?» propose. «C’è una sala di là, se ci tieni tanto.» lo rimbeccò Johann, indicando la stanza, stringendo gelosamente il braccio intorno al corpo di Frieda. Vestiva con un completo bianco e una cravatta rossa per “mostrare il suo spirito natalizio”. Era seduto a capotavola, le gambe divaricate e la schiena appoggiata allo schiena della sedia. Seduta in braccio a lui c’era Frieda, avvolta nel suo abito lungo e aderente, rosso, con lo scollo a barca. «Io conosco un gioco più carino.» cominciò Mausi. «Il gioco del silenzio. Preghiamo il santo Natale e Santa Klaus e pure Gesù appena nato.» Johann non perse occasione di fare la sua battuta, rivolgendo i palmi delle mani al cielo e guardando il soffitto come illuminato dall’ispirazione divina. Tutti scoppiarono a ridere. «Tecnicamente deve ancora nascere.» precisò Franziska, accomodante. «Insomma, ‘sto gioco?» Lolo incalzò Mausi accarezzandole l’orecchio. «Ognuno di noi scrive su un foglietto qualcosa. Un personaggio di film, un personaggio famoso, un oggetto, qualsiasi parola. Ci scambiamo i foglietti e ce li mettiamo sulla testa. Chi ha il foglio sulla testa non deve sapere cosa c’è scritto, gli altri devono farglielo indovinare.» «Bellissimo questo gioco!» esclamò Hildi, improvvisamente su di giri. Fecero come aveva indicato Mausi e alla fine ognuno di loro si ritrovò brillo e con un foglio appiccicato sulla fronte. Johann aveva il biglietto di Ivan, con su scritto “Mercurio”. Aveva indovinato subito, quasi non c’era gusto a giocare con lui. A Frieda era toccato il biglietto di Kaspar, che aveva scritto “Johann Trollmann”. Era stato deciso che se si scriveva il nome di qualcuno presente in sala, non bisognava indicarlo ma cercare di fare indovinare il malcapitato attraverso gesti o indizi confusi. Per complicare la cosa. «È una scimmia.» aveva tentato Hans. «Un cespuglio!» fece Kaspar. «Beh no, non proprio…» cercò di difendersi Johann appoggiando il mento sul pugno chiuso. «Gambe!» «Ha un sinistro micidiale.» «Non sta fermo un secondo.» «Rompe le palle in modo spropositato.» aggiunse Mauso, dall’altro capo del tavolo. «Non si è mai spaccato il naso in quasi vent’anni di atti brutali.» le suggerì Johann, lo sguardo eloquente. «Johann!» indovinò Frieda con un sorriso fino alle orecchie. «Ah, ce l’hai fatta. – le tolse il foglio dalla fronte. – Stavo per offendermi.» «Avevo capito quando Hans ha detto “scimmia”, ma volevo divertirmi.» «Sei un concentrato di malvagità.» |
Capitolo 10
*** 1.10 - Figlio della guerra ***
10. Sohn des Krieges
Sarebbe dovuto andare a vedere l’incontro di Hans contro Domgoergen alla Spinchernsaele. Invece ci aveva combattuto lui, contro Domgoergen, proprio il giorno del suo venticinquesimo compleanno. Due giorni prima, il collega aveva quaranta di febbre. Zirzow aveva detto a Trollmann di pensarci lui a Domgoergen, visto che l’aveva sempre battuto e conosceva il suo stile meglio di altri alla palestra. Ma a Rukeli non andava proprio di combattere il giorno del suo compleanno, tantomeno per sostituire qualcuno. Durante l’incontro non si impegnò per niente. Si limitò a girargli intorno per non essere colpito, fargli qualche trucchetto per intrattenere il pubblico, dare un po’ di spettacolo. Alla fine aveva perso ai punti all’ottavo round. Tornato al suo angolo, sputò il paradenti nel secchio con la spugna di Leyendecker. «Diciannove incontri solo quest’anno. Volete farmi sputare sangue?» aveva lanciato i guantoni, ma senza la gioia di quando vinceva. Cominciò ad avvicinarsi al corridoio per lo spogliatoio, senza aspettare una loro risposta. «È il tuo maledetto lavoro!» gli urlò Leyendecker. «E per guadagnare devi vincere, testone.» aggiunse Zirzow. Trollmann si voltò, continuando a camminare all’indietro, l’accappatoio nero sulle spalle slacciato davanti, il cappuccio sulla testa. Alzò le braccia e il dito medio di entrambe le mani. Si era voltato di nuovo e aveva proseguito accompagnato da flash di macchine fotografiche e urla dei suoi sostenitori. Non si fece nemmeno la doccia. Infilò una giacca sportiva pesante, non cambiò nemmeno i pantaloni e non tolse neanche le fasce. Non era arrabbiato, Johann non si arrabbiava. Era infastidito. Tappare i buchi, sostituire, colmare le mancanze di altri, a lungo andare stancava. Perché facevano combattere sempre lui, per sostituire gli altri. Questo lo faceva sì sentire importante, ma i ritmi erano diventati stancanti. Lui combatteva anche con la febbre, anche a costo di perdere, non si era mai fatto sostituire. Perché gli altri non s’impegnavano allo stesso modo? Se si prende un impegno, bisogna portarlo a termine. Si diceva. E non capiva la facilità con cui i suoi colleghi, invece, rinunciavano alla prima difficoltà. Capiva Kaspar, quando si prese una storta. Ma l’amico in altre occasioni si era tirato indietro all’ultimo con scuse banali. Tornato a casa, trovò Frieda che stava leggendo sul divano. Aveva la camicia da notte e una coperta di lana sopra. Quando lo vide rientrare così presto e così conciato, non le servirono tante domande per capire che era nervoso e non aveva vinto. Non poteva biasimarlo. Lo seguì in bagno per togliergli le fasce. Lui si sedette sullo sgabello sotto la finestra, lei si appostò davanti a lui. Gli prese la mano. «Il prossimo anno più allenamento e meno incontri.» si promise a bassa voce. Frieda lo guardò da sotto le ciglia, senza alzare la testa. Gli aveva tastato l’avambraccio in cerca del punto in cui srotolare le fasciature. Lui se le legava sempre fino a poco più su del polso, si intravedevano sempre sotto il guantone. «Buffo sentirtelo dire. Adori gli incontri.» Gli davano un colpo di adrenalina impagabile. Gli permettevano di divertirsi, di mettersi alla prova, di avere la gloria. «Perché vuoi farne meno?» gli chiese. «Penso sia giusto darmi una calmata. – sospirò, passandole l’altra mano. – Sono un po’ nervoso.» Le camice brune cominciavano a renderlo nervoso, la loro presenza iniziava a dargli fastidio e un senso di oppressione gli pesava sul cuore quando c’erano loro. Non riusciva più a divertirsi quando li vedeva sugli spalti a fissarlo. Come una bestia selvatica in una gabbia, come un cavallo selvaggio improvvisamente chiuso in un maneggio. Un animale selvatico in uno zoo, sotto stretta sorveglianza, ecco come si sentiva. «Fatti una bella doccia. – lei finì di togliergli le bende, gli prese il viso fra le mani. – Poi vengo a pettinarti i capelli e ti faccio un po’ di camomilla così ti rilassi.» Per un attimo tutti pensieri si volatilizzarono. Strofinò una guancia sulla mano di lei, come un gatto che vuole essere accarezzato. «Grazie, bambina.» Frieda gli fece un sorriso tenero, gli stampò un bacio sulla fronte. Lui si fece una lunga doccia calda, lavando via il sudore e il nervoso. La ragazza gli pettinò i capelli neri e bagnati, come faceva sempre. Amava farlo, e anche a lui piaceva pettinarle i suoi e farle le trecce. Gliel’avevano insegnato le sue sorelle. Poi lo aiutò ad ammorbidire la pelle delle mani e delle braccia con un leggero stato di grasso di vaselina. Più la pelle era morbida e idratata, e meno c’erano le possibilità che si spaccasse con gli incontri e gli allenamenti. Kaspar odiava mettere la vaselina e aveva le mani sempre screpolate: in molti incontri si era trovato male perché la pelle sotto le fasciature si era lacerata per la secchezza e non riusciva più a colpire. Johann, invece, non li faceva questi errori banali. Sul tavolo della cucina, una tazza di camomilla bollente e qualche biscotto da sgranocchiare. Il nervoso scivolava via poco a poco, fino a scomparire completamente tra le lenzuola del letto, tra le braccia di Frieda. * * *
26 febbraio 1933 A gennaio, era ricominciata l’ondata di richieste pubblicitarie. Johann aveva posato per servizi fotografici di riviste, come la Zworf uhr Blatt, e aveva prestato il suo viso per il manifesto pubblicitario di una panetteria di Berlino. L’estate prima l’avevano fermato mentre pescava sullo Sprea, chiedendogli un paio di mosse di boxe e farsi fotografare per il giornale. Anche se, set fotografico o no, la sua faccia era su tutte le prime pagine dei quotidiani dal ’29 fino ad allora. Teatro Flora, Amburgo. Incontro contro Fred Boelck. Quando combatteva ad Amburgo, di solito non c’erano le divise brune. Quel giorno non c’erano. Si era sentito libero, senza un peso. Boelck era diventato professionista a marzo del ’32. Quello era il suo dodicesimo incontro, aveva perso solo una volta ai punti. Boelck era alto, magro e con pochi muscoli, però sapeva dove colpire e vinceva per questo. Era un buon pugile. La fronte sporgente, i capelli neri gelatinati indietro, il naso bozzato. Quando gli era stato organizzato l’incontro con il fantomatico Gipsy Trollmann, uno dei candidati per il titolo dei pesi mediomassimi di Germania, si era quasi spaventato. Tutti conoscevano la fama del pugile sinti, era un atleta temuto. Era imprevedibile e difficile da inquadrare o anticipare: al primo round aveva un certo stile e al secondo poteva cambiarlo completamente, rifilava truccacci durante i match. Era abile, troppo abile: si muoveva molto bene con le distanze, ma anche durante i corpo a corpo era forte, il suo sinistro era terribile. Metteva a nudo tutti i punti deboli dell’avversario. E agli altri non piaceva quando qualcuno smascherava quei punti che avevano nascosto accuratamente. Ti guardava negli occhi e ti interpretava, guardava ogni angolo del corpo dell’avversario e capiva cosa stavi per fare. Spesso sapeva cosa stava per fare l’avversario ancora prima che quello lo sapesse. Dunque si muoveva rapido, o schivava come un gatto o ti entrava nella guardia mettendoti al tappeto. Boelck aveva avuto paura. E ora che lo stava fronteggiando sul ring, si sentiva quasi una vittima. Trollmann lo fissava dritto negli occhi, interpretandogli l’anima. Si sentì messo a nudo, i suoi segreti allo scoperto, come se Gipsy si fosse accorto del bambino che Fred era stato. Gli occhi neri, intensi, del pugile sinti, con quel suo taglio da lupo, sembravano quelli di un predatore. E non importava se ogni tanto gli accennava un sorriso, quello sguardo selvaggio sfavillava e incuteva timore. La sensazione di una preda di fronte al lupo che la studia prima di addentarla. Trollmann teneva il mento incassato, i muscoli sulla nuca e degli addominali erano tesi. Teneva le gambe larghe, pronto agli spostamenti rapidi. Durante il primo round, aveva giocato. Aveva fatto il giullare. Si allontanava da Boelck con rapidi movimenti di gambe e si avvicinava alle corde, parlava con le prime file. «Ora gli mollo un gancio destro.» Oppure: «Alla settima ripresa lo butto giù.» Poi lanciava baci alle signorine. La prima ripresa andò a lui. «Stai giocando, smettila di giocare. Vuoi passare tutti gli otto round previsti a fare il buffone?» lo rimbeccò Zirzow. «Naah, ho in programma di buttarlo giù al settimo round. Nel frattempo gioco un po’.» gli aveva rivolto uno dei suoi sorrisi migliori. «Smettila, conserva quel sorriso per i fotografi. Lo stai spaventando a morte. Dagli il colpo della buonanotte e via.» era Leyendecker, controllandogli guantoni e paradenti. Il ragazzo non aveva nemmeno un po’ di sudore da asciugare. Johann sputò nel secchio. «Ho capito, mi sbrigo a mandarlo giù. – si alzò in piedi, suonò il gong. – Però siete noiosi, fatemi divertire.» «Come se mandare al tappeto quel povero agnellino di Boelck non lo facesse divertire.» commentò Zirzow, una volta che il ragazzo fu di nuovo al centro del ring. In fondo, tutti si divertivano quando combatteva Trollmann. Il suono del gong sembrava più il sipario che si apriva per dare inizio allo spettacolo teatrale. Durante il secondo round, Rukeli aveva smesso di giocare. Boelck glielo lesse negli occhi. Lo zingaro non si stava impegnando, non lo faceva quasi mai, però i suoi colpi si erano fatti più duri. Non riusciva a vedere i colpi arrivare, non riusciva a difendersi. Era troppo veloce. «Boelck cerca di intercettare Trollmann, ma lo zingaro si muove troppo rapido, sembra invisibile! Oh! Incredibile Gipsy Trollmann che si accanisce con rinnovata potenza su Boelck! Una grandine di colpi! – dicevano i cronisti. – Boelck tenta un jab destro. Gipsy lo schiva, ne approfitta per entrargli nella guardia. Esplode in una sequenza micidiale di montanti al plesso solare e conclude in bellezza con un colpo al volto dall’alto in basso mentre Boelck è piegato per il dolore! L’arbitro segna la fine del round. Boelck non smette di sanguinare dal naso e dalle ferite sotto l’occhio. Gipsy Trollmann, al suo angolo, si sta solo strofinando il naso con l’avambraccio. Non vedo sudore!» Johann, seduto sullo sgabello a gambe divaricate, teneva le braccia appoggiate alle corde, il mento incassato. Lo sguardo puntava all’angolo opposto, predatorio. Sciolse il collo. Leyendecker gli passò un po’ d’acqua. Zirzow fissava Boelck e il suo allenatore. Stavano cercando di fermare l’emorragia dal naso rotto e dalle borse di sangue sotto l’occhio. Il medico di gara li avvisò che se continuava a sanguinare non poteva continuare a combattere. L’allenatore chiese altri due minuti di tempo, l’arbitro glieli concesse. Ma in due minuti non riuscirono a fermare le emorragie. «Un attimo prima Boelck era sul quadrato, in piedi e con la faccia intatta. Un attimo dopo, è tutto finito! La vittoria va a Gipsy Trollmann per knock-out tecnico al secondo round, signori e signore!» Ulularono i cronisti al tavolo vicino al ring. L’arbitro alzò il braccio al vincitore. Una pioggia di fiori cadde sul ring, come la maggior parte delle volte che vinceva Johann. Il ragazzo s’inchinò teatralmente, salutò il pubblico. Si tolse i guantoni e li lanciò a Leyendecker. Rukeli si avvicinò a Boelck, ancora sanguinante. «È stato un bell’incontro.» gli disse l’altro. Gli sorrise. «Mi spiace, amico. Però sei in gamba. Farai strada. – lanciò un’occhiata critica al lavoro del suo allenatore. – Cosa stai facendo? Pensi che così smetterà di sanguinare?» «Guarda che non c’è modo, ha il naso rotto. Deve andare in infermeria.» replicò quello. «Vuoi scommettere?» Si fece passare una spugna e un paio di bastoncini di ovatta. Passò uno degli asciugamani a Boelck. «Mordi questa.» L’altro obbedì. Johann gli prese il naso tra le mani, inquadrò la posizione originale. Lo sistemò con un movimento secco che fece quasi urlare di dolore l’altro. Dopodiché prese i bastoncini cotonati, ne infilò uno per ogni narice del pugile sanguinante. «Trattieni il respiro.» Li spinse a fondo, mentre Boelck batteva i piedi a terra e martoriava l’asciugamano con i denti per il dolore. Ma un attimo dopo era tutto finito. Il naso era sistemato e non sanguinava più. Per la sacca di sangue sotto l’occhio invece dovette spremere via con i bastoncini tutto il sangue depositato lì dalla piccola ferita sullo zigomo. Fece comunque meno male del naso, e la sacca si sgonfiò in fretta sporcando un panno – prontamente afferrato dal secondo – quasi completamente. Johann gettò i bastoncini sporchi dentro il secchio, gli tolse l’asciugamano dalla bocca e ci gettò dentro pure quello. Si tirò su, sotto gli sguardi attoniti dell’allenatore e del pugile. Allargò le braccia. «Ci voleva tanto? Persino io, che non mi sono mai rotto il naso, ho saputo sistemarlo. Ci si vede, Boelck.» Attraversò il ring per ricongiungersi con Leyendecker e Zirzow. I due lo riempirono di pacche sulle spalle e complimenti mentre lo riaccompagnavano. Il manager allontanava prontamente tutti i giornalisti. Tanto avrebbero fatto le solite domande. Box-Sport, edizione del 27 febbraio 1933 – Trollmann contro Boelck, 26 febbraio ’33. Boelck è un promettente peso medio, si è ritrovato di fronte un Gipsy Trollmann come ce lo si augurerebbe sempre. Boelck, che ha perso per knock-out tecnico, avrà di certo molto da imparare da questo incontro… Trollmann, salito sul ring ben allenato e con una per lui rara determinazione combattiva e con una varietà di colpi uniti alla forza, ha giocato un ruolo eccellente ed è stato meritamente festeggiato. Fu mentre Johann leggeva quell’articolo, che udì una potente esplosione. Corse fuori il balcone e s’inorridì vedendo che una pesante cappa di fumo si levava verso il cielo. La sirena dei pompieri gli arrivava lontana, dove era scoppiato l’incendio? Frieda non era in casa, e questo lo fece allarmare. C’era stato un imprevisto, suo padre si era fatto male e lei era dovuta correre alla prima farmacia aperta per un disinfettante e antidolorifici, anche se erano le dieci di sera. Johann scattò a prendere il cappotto e il cappello, indossò la sciarpa e un paio di guanti prima di uscire nel gelido freddo invernale. Le strade erano innevate, c’erano poche persone che giravano sui marciapiedi e tutti erano fermi col naso all’insù per guardare quel fumo sinistro che oscurava le stelle e la luna. «Cos’è successo?» domandò a qualcuno. Il ragazzo, un adolescente a braccetto con la fidanzata, balbettò colto alla sprovvista. Non immaginava di vedersi il pugile davanti agli occhi in quella tragica serata. La ragazza si morse il labbro. «C’è stata un’esplosione a Mitte. – spiegò lui. – Un incendio. Non ho capito bene dove.» Johann annuì appena e li oltrepassò camminando a passo svelto. Loro erano nella zona di Charlottenburg sul confine con Mitte. Arrivò a Zillestraße e vide in fondo alla strada la figura infagottata di Frieda che si avvicinava velocemente con una busta di cartone in mano. Johann tirò un sospiro di sollievo e le andò incontro. La afferrò per le braccia, controllando che stesse bene. Lei si aggrappò a lui con occhi stralunati. «Non dirmi che sei stata a Mitte.» «Sono stata a Mitte.» «Cos’è successo? Sei rimasta ferita? Ho sentito un’esplosione, sono andato nel panico.» «Hanno incendiato il Reichstag, hanno già preso il colpevole. – sussurrò, senza voce. – Ho visto la cupola che cadeva divorata dalle fiamme, i camion dei pompieri sfrecciarmi accanto. Ho avuto paura, non mi era mai successo di trovarmi nella zona di un attentato.» Johann l’attirò a sé, la strinse forte tra le braccia mentre con una mano le accarezzava la schiena. Frieda affondò il viso sul suo petto, ancora sconvolta. La strinse dolcemente, lasciandole un bacio sui capelli. «Non aver paura, ci sono io.» * * *
12 marzo 1933 Teatro Flora, Amburgo. L’incontro con Helmut Hartkopp. Settantotto chili contro i settantuno di Johann. Era un pugile strano, secondo Trollmann. Perché vinceva spesso, ma altrettanto spesso perdeva. C’era uno strano equilibrio. Non sapeva se definirlo un buon pugile. Nel dubbio, lo trovava insolito. Alcune delle sue sconfitte era per squalifica, altre per forfait ovvero il ritiro. Però si muoveva bene, gli sembrava corretto e onesto. Inoltre era uno dei candidati al titolo nazionale dei mediomassimi. Le prime due riprese andarono a Trollmann. Alla terza, dopo aver assestato un montante al plesso solare di Hartkopp, l’avversario sembrò fumare di rabbia. Niente di insolito. Ma reagì veramente male. Fu fulmineo e lapidario. Colpì Gipsy sotto la cintura con un montante basso. Per fortuna lui fu abbastanza veloce da spostarsi e non farsi troppo male, ma il colpo gli arrivò comunque e si ritrovò in ginocchio sul quadrato, agonizzante. La schiena dritta, dignitosa, gli occhi chiusi con forza e una smorfia dal dolore. «Arbitro! – urlò Leyendecker. – Fa’ il tuo cazzo di lavoro, maledizione!» L’arbitro sembrò tornare dal paese delle meraviglie. Guardò Trollmann, che non riusciva a muoversi. Hartkopp stava per assestargli un gancio dall’alto verso il basso, lo fermò mentre caricava il colpo. I giudici erano in piedi, indignati. «Torna al tuo angolo!» La folla protestò contro Hartkopp e per il colpaccio che aveva rifilato al loro beniamino. Quello sputò nel secchio, guardando Rukeli in cagnesco. Nel frattempo, lo zingaro si stava tirando di nuovo su con calma. Imprecò a denti stretti mentre si allontanava verso il suo angolo, da Zirzow e Leyendecker. Il medico di gara gli disse di battere i talloni. Nel frattempo l’arbitro emise il suo verdetto. «Squalificato.» Di conseguenza, vittoria a Trollmann al terzo round. Seguì il medico di gara nello spogliatoio. Si sedette sul lettino e quello controllò che fosse tutto apposto. «Quello mi ha colpito le palle con un montate, maledizione.» ringhiò, guardandosi il punto dolorante. «Sì, Hartkopp ha questa fama di colpire dove non deve. – sospirò il medico. – Ma tu hai avuto la prontezza di spostarti un minimo. Poteva farti male molto più seriamente se tu non ti fossi spostato un po’. Menomale che sei veloce, ragazzo.» «Sì, ma che cazzo, dai! Proprio le palle doveva colpirmi?» «Dai, come sei melodrammatico, soffri in silenzio. – lo prese in giro Leyendecker, con un sorriso bonario. – Speriamo che non ti venga il livido. Brutta storia.» Johann guardò il medico, allarmato. Quello lanciò un’occhiata all’allenatore, che sembrava spassarsela a canzonare il suo pugile. «Nessun livido. Tieni un po’ di ghiaccio per i prossimi due o tre giorni, non si sa mai.» Box-Sport, edizione del 13 marzo 1933 – Trollmann contro Hartkopp, 12 marzo ’33. Ieri lo zingaro è stato effettivamente colpito pesantemente ma dieci centimetri sopra l’inguine, da un sinistro di Hartkopp, nel quale non c’era certamente l’effetto che Trollmann voleva farci credere rotolandosi sul pavimento. Tornato all’angolo continuava a lamentarsi, piegarsi, ed era orrendo da vedere. Il medico che l’ha visitato più tardi ha negato la presenza di tracce esterne di un colpo sotto la cintura. È incredibile ciò che il manager Zirzow abbia raccontato al suo protetto durante le riprese. È stato Zirzow per primo a confermare il colpo sotto la cintura, solo dopo Trollmann è andato al tappeto lamentando grandi dolori, quando invece il colpo che ha subìto l’avrebbe lasciato tranquillamente in piedi. -Punch Da quel momento Box-Sport, l’Autorità tedesca del pugilato (BBD) e la Federazione dei pugili tedeschi (VDF) raccomandarono caldamente ad arbitri e giudici di non lasciare impunite le presunte scorrettezze di Trollmann, di punirlo con borse più basse e bacchettarlo. Dall’altro lato, raccomandarono altrettanto caldamente di non punire in alcun modo chi commetteva le scorrettezze contro il pugile sinti. In altre parole, venne detto loro che contro Gipsy tutti i falli erano ammessi. Trollmann venne dichiarato selvaggina di libera caccia. * * *
Il 31 marzo 1933 era previsto l’incontro tra Seeling e Seifried a Neue Welt. Johann lo andò a vedere con Leyendecker e Kaspar, per studiare le strategie dei due pugili e per imparare qualcosa. La serata procedette come previsto ma poco prima dell’incontro, lo speaker annunciò che Seeling non si era presentato e che pertanto sarebbe dovuto subentrare qualcun altro. L’arbitro domandò a Gipsy se fosse disposto a combattere, quella sera. Accettò riluttante, e dopo essersi cambiato e preparato, saltò sul ring. Trollmann aggredì Seifried a sorpresa e con velocità disarmante. Il “vecchio e nodoso” veterano del pugilato tedesco, non riuscì a venire a capo dello stile di Gipsy. Rendendosi conto che non aveva molte possibilità di vincere ai punti, tentò un colpo decisivo. Portò di fatto un colpo duro che fece vacillare Johann, ma senza farlo cadere. Nell’ultima ripresa Trollmann tornò alla carica portando una serie di ganci al busto di Seifried. Nonostante la superiorità dimostrata dallo zingaro, il match venne giudicato pari e questo fece infuriare la folla. Il verdetto però non venne cambiato. Box-Sport, edizione del 4 aprile 1933 – Trollmann contro Seifried, 31 marzo ’33. Trollmann ha cominciato il primo round più giocherellando che combattendo seriamente. Un paio di fischi di avvertimento dalla galleria gli fanno rapidamente capire che ci sono occhi attenti che lo osservano. * * *
12 aprile 1933 «Mro vòci. Tra una settimana devo combattere in una città stupenda. E tu verrai con me, non mi interessa, ci parlo io col tuo capo.» Le aveva detto così, una settimana prima, tornando a casa dagli allenamenti. E non le aveva rivelato la località fino a quando non arrivarono all’aeroporto di Berlino. L’aereo era un mezzo di trasporto costoso, negli anni ’30, che solo da una decina d’anni veniva visto anche a scopo civile. Non potevano portare più di trenta o quaranta persone. Ma Johann con le borse dei combattimenti aveva guadagnato abbastanza marchi da potersi permettere un volo andata e ritorno per due persone. Zirzow e Leyendecker avevano speso da sé e avevano pagato anche le camere d’albergo. Grazie ai combattimenti di Gipsy, facevano la bella vita. Per Johann e Frieda era la prima volta su un aereo, lui pensava che lei l’avesse già preso per andare in Ucraina visto che era davvero lontana dalla Germania. Quando lei con le dita gli fece il gesto dei soldi, capì che tra Edmund e Frieda non guadagnavano mai abbastanza per permettersi un paio di biglietti. Era rimasto stupefatto, lui da solo guadagnava molto. Loro in due no. Il 1932 aveva fruttato a Johann davvero molti soldi, per tutti quei diciannove combattimenti disputati e la maggior parte dei quali vinti. Erano arrivati a Vienna, in Austria, la sera di due giorni prima così la mattina appresso erano usciti per fare un giro della città, restando a mangiare spuntini nei bar o in pub fino a sera. Leyendecker non voleva farlo stancare troppo, e lo lasciò libero. Erano andati al cinema a vedere un film in lingua bavarese di cui non capivano una parola, ma si erano divertiti a inventarsi dialoghi improbabili sul momento in base alle espressioni degli attori; andarono a ballare il jazz in un locale in centro, avevano giocato a biliardo, bevuto birra, fumato, e fatto l’amore tra lenzuola profumate. La mattina dell’incontro, il 12 aprile, Frieda si svegliò con l’odore di caffelatte nel naso. Si stropicciò gli occhi e si mise a sedere, tirando il lenzuolo al petto fino a coprire il corpo nudo. Johann non era vicino a lei, pensò che doveva trovarsi nell’altra stanza. Lo chiamò, e lui subito fece capolino dalla porta armato di vassoio con caffelatte e cornetto con marmellata, e un mazzo di rose. Era vestito con un paio di bei pantaloni grigio antracite, una camicia con le maniche arrotolate fin sopra i gomiti, le bretelle, e il colletto in disordine. «E quelle per cosa sono?» Lui le posò il vassoio sulle gambe. «Era da tanto tempo che non ti compravo dei fiori.» «Tu mi vizi.» mormorò annusando i petali rossi. «Anche tu mi vizi. – le rispose, mettendole una ciocca di capelli dietro l’orecchio. – E poi mi piace viziarti, mro vòci.» «Che cosa significa?» addentò il cornetto, guardandolo con i suoi occhioni di cerbiatto. «Ti ho chiamato in certo modo in lingua sinti. Ma non te lo dico cosa significa.» «Mi hai insultata, Trollmann?» esclamò, portandosi una mano al cuore, teatralmente offesa. Lui sbuffò un sorriso e le rubò un morso dal cornetto. «Secondo te cosa ti ho detto?» «Mi hai chiamata bambina? Lo fai sempre.» «No. Bambina si dice ciaiori.» «Un sinti che insegna la lingua ad una gagé. Insolito.» lo sfidò. «Non ti sto insegnando proprio niente, non farti strane idee.» replicò con un sorriso. Lei bevve il suo caffelatte senza distogliere lo sguardo. Dopodiché posò il vassoio sul comodino. «Da che parte vengono i sinti?» «In che senso?» «Da qualche parte dovrete pur essere partiti no?» «Ah. – capì, con un sorriso, e si sdraiò vicino a lei tenendosi su col gomito. – Qualcuno dice India. Ma non è corretto. I sinti vengono dalla valle del Sindh in Pakistan.» «Parlano l’arabo in Pakistan?» Le accarezzò teneramente il fianco, ancora avvolto nel lenzuolo bianco. «L’urdu. Scritto in alfabeto arabo. A Sindh parlano il sindhi, sempre scritto come l’arabo. Ma tra i sinti parliamo il romanì e la lingua del Paese in cui siamo, l’urdu o il sindhi non li conosciamo.» «Hai mai pensato di impararli?» «E cosa me ne faccio? Quelle lingue le parlano solo lì, mica devo trasferirmi in Pakistan. – le sorrise, divertito. – I cosacchi, invece, sono nativi della Russia?» Lei sorrise. «No. Turchia, oppure dall’antica Scizia, non ho ben chiaro. Da lì, comunque, si sono stanziati nelle steppe tra la Russia e l’Ucraina, nel corso dei secoli. Ma per noi non vale lo stesso discorso degli zingari, noi ci siamo mischiati molto di più con i popoli incontrati. Di fatto siamo slavi puri, se veniamo davvero dalla Scizia, siamo i discendenti delle Amazzoni! Voi sembrate indiani, arabi.» «In effetti mi hai scambiato per un arabo quando ci siamo conosciuti. – ghignò. – Parli il kazako?» «Sì, ma non so scriverlo nemmeno in alfabeto latino. Non so scrivere nemmeno il russo e l’ucraino, li parlo solamente. Il russo poco e niente.» «Dimmi qualcosa in kazako.» le sussurrò strofinandole il naso col suo. Lei si sciolse. «Meniñ ömir maxabbat.» «Come ti permetti? Guarda che mi offendo.» Frieda scoppiò a ridere, si mise carponi per poterlo baciare con dolcezza. Lui si lasciò consumare le labbra. «Ti ho chiamato amore della mia esistenza, traduzione letterale. Troppo sdolcinata per te?» Johann si sciolse in un sorriso sornione. Le circondò il corpo con le braccia, facendola stendere vicino a lui. La baciò lentamente. «Sei melensa.» Per il resto del giorno, Johann si allenò in una palestra con Leyendecker. Nessun allenamento pesante, si trattava solo di pensare a qualche strategia, provarla, definire la traiettoria dei colpi. Zirzow si trascinò Frieda per finire di sistemare tutto per l’incontro di quella sera. Tutti lo trattarono meglio, con una ragazza così carina vicino. Quando la bionda entrò nella sala grande della Kozerthaus di Vienna, restò a bocca aperta. Era un edificio elegante e meraviglioso, e l’interno in cui stavano montando il ring era raffinato. Per un momento le sembrò di essere tornata nel Settecento. La sala era più lunga che larga, in fondo era stato allestito il ring, nella rientranza bombata del muro. C’erano tantissimi posti a sedere, e anche una platea sopraelevata. Meravigliosi lampadari di cristallo pendevano dal soffitto e illuminavano piacevolmente quella stanza. Zirzow non le parlò più di tanto, era molto impegnato a organizzare al meglio ogni cosa. Frieda pensò che Johann fosse fortunato ad avere un manager come lui: era un uomo capace, d’affari, era furbo e aveva occhio per situazioni interessanti, non si lasciava sfuggire le opportunità. Stando un pomeriggio con Zirzow, si fece un quadro generale di come andavano le cose nel mondo degli affari e come muoversi nel migliore dei modi. Era un buon maestro, anche se lui non sapeva di esserlo. Non uscirono dalla Kozerthaus per tutto il giorno, solo lei era uscita un paio di volte per andare a mangiare qualcosa nel bar dall’altro lato della strada. In serata, arrivarono fotografi e giornalisti. Poi i giudici e gli arbitri. Infine il pubblico, che cominciò a prendere posto. Davanti al ring era montato il tavolo dei giudici e due bilance per l’operazione del peso. L’incontro sarebbe cominciato alle 21:00. Alle 20:30 si presentarono Johann e Leyendecker. Il pugile si era lavato e dato una sistemata, aveva scambiato due chiacchiere con i giornalisti di fuori. Poi era entrato nello spogliatoio, dove l’aspettavano Zirzow e Frieda. «Profumi, che strano.» commentò dopo aver dato un bacio al suo cavaliere nero. «Hai visto che posto? Da re.» i suoi occhi brillavano come quelli di un bambino al luna park la prima volta. «Operazione del peso, Trollmann, scattare!» gli urlò Leyendecker battendo le mani. Johann alzò gli occhi al cielo, ed uscì. Percorse il corridoio centrale della sala grande con l’accappatoio slacciato, mimando un paio di diretti al vuoto. In Austria non era così conosciuto, ma senz’altro in quel momento le donne austriache cominciarono ad amarlo. Hans Fraberger fece il suo ingresso, scatenando l’applauso generale dei suoi sostenitori. Cioè tutta la platea. Era il campione austriaco dei pesi welter. Nonostante ciò, all’operazione del peso, uscì fuori che pesava praticamente quanto Johann che era un peso mediomassimo. Fraberger era biondo, i capelli più lunghi sopra e rasati ai lati, perfettamente ordinati e gelatinati. Più basso di Gipsy Trollmann. Qualche donna in platea commentava le differenze tra i due. Il primo era ordinario, niente di particolare. Lo zingaro invece era tenebroso, selvaggio. Un figlio della guerra e delle gioie violente. E piaceva, Rukeli, piaceva a tutti. L’incontro cominciò che Fraberger era spavaldo. Sicuro di sé perché campione nazionale. Aveva quasi la stessa vena giocosa di Johann, sul ring, e questo fece divertire parecchio il pugile sinti. L’incontro era diventato quasi uno spettacolo teatrale, tra i due era nata una certa complicità scenica che rese piacevole e leggera la serata. Spesso nella sala si sollevavano risate ai teatrini comici di Johann, più ironico e melodrammatico rispetto a Fraberger. Questa complicità però venne presa sottogamba dal pugile austriaco, che credeva di finire il match in parità visto che Johann sembrava non impegnarsi affatto nel combattimento ma solo nei suoi siparietti. L’ironia del sinti non gli impedì di suonargliele di santa ragione a Fraberger. L’austriaco non se l’aspettava. Negli ultimi round cercò di stargli al passo, di riprendere un ruolo in quella “coreografia” ma Rukeli glielo impediva. Gli impose il suo stile, dominò totalmente il ring. Al nono round, l’allenatore di Fraberger gettò la spugna. Trollmann vinse per knock-out tecnico, in quanto il suo avversario non ce la faceva più a continuare, era stato pestato troppo. Il pubblico austriaco applaudì vigorosamente alla vittoria di Gipsy che, seppur aveva sconfitto il loro beniamino, meritava comunque le lodi. A Frieda, Johann parve immortale. Mentre Rukeli vinceva, suo padre Schnipplo moriva di un tumore al pancreas. Nessuno si preoccupò di fornirgli le cure possibili, nessuno voleva uno zingaro in ospedale ad occupare il letto di eventuali pazienti tedeschi che meritavano sicuramente più attenzioni. Wilhelm Schnipplo Trollmann aveva settant’anni. Aveva lavorato come ombrellaio per la polizia fluviale, e poi aveva cominciato a suonare il violino per le strade di Hannover. Riparava ogni cosa e intagliava il legno divinamente. Insegnò molto ai suoi figli, in particolare al piccolo Stabeli, a cui insegnò a suonare il violino e lui ne fece una professione. Schnipplo non fece in tempo a vedere suo figlio Rukeli prendersi la rivincita di zingaro sul ring di giugno. |
Capitolo 11
*** 1.11 - Il culmine ***
11. Der Höhepunkt
Dopo Fraberger aveva combattuto contro i due fratelli Eggert. Walter era professionista dal ’24 e aveva disputato solo cinque incontri prima di Trollmann, di cui ne aveva vinto uno all’inizio della carriera. L’incontro con Gipsy finì in parità. Allora suo fratello Karl lanciò la sfida a Rukeli, organizzando l’incontro una settimana dopo. Se il pugile sinti non era riuscito a battere un pugile scadente come Walter Eggert, ma solo a pareggiare, allora Karl Eggert avrebbe potuto sconfiggerlo e far schizzare il suo nome alle stelle. D’altronde, lo zingaro aveva un’ottima fama e sconfiggerlo valeva più di una semplice vittoria. Karl era più in gamba di Walter. Era professionista dal ’31 e aveva disputato sedici incontri, di cui due persi e due pareggiati. Non male. Con Trollmann fu il diciassettesimo incontro e il terzo pareggio. Box-Sport criticò Trollmann perché “Un pugile del suo talento, avrebbe potuto facilmente mettere K.O. i fratelli Eggert nel giro di un paio di round, come fece con Boelck. Non si possono fare predizioni in un match di Trollmann a causa del suo essere così istintivo, animalesco, influenzabile, e anche per questo i suoi risultati toccano picchi incredibili con vittorie lampo, per knock-out, e poi lo fanno perdere in incontri di basso livello. Il grafico dei suoi risultati è una montagna russa.” Il problema di Rukeli era questo suo istinto animalesco, secondo Box-Sport. Ma Trollmann era una miscela efficace di istintività e razionalità, difficile da spiegare, perché sul ring non aveva una strategia particolare finché non inquadrava l’avversario. E lo inquadrava per istinto e capacità d’osservazione. Ripensò che era dovuto al suo segno zodiacale, secondo una vecchia storia.Una vecchia zingara una volta gli aveva calcolato le stelle. Segno zodiacale, ascendente, la carta natale. Aveva dodici anni. Col senno di poi Johann, ripensando a quelle parole, si accorse di quanto aveva ragione quella vecchia zingara mezza sdentata. Non ci aveva mai creduto alle stelle e a quelle cose astrologiche, ma nel suo caso si erano rivelate veritiere ed era rimasto colpito. Ci aveva creduto, perché a pensarci con il senno di poi… lui era così. * * *
2 maggio 1933 Gli aveva detto che secondo lui era presto per un passo del genere. Ma poi Kaspar gli disse che Gilda era rimasta incinta, e voleva sposarsi in quei mesi prima del parto. Voleva una famiglia. Johann ci era rimasto di sasso. Ma poi lui ed Hans erano esplosi in applausi e pacche sulle spalle, abbracci, auguri, sfottò di vario genere. Hans gli tirò un orecchio. «Ma come, e io che volevo provarci con te! Pensavo che fossi tu quello gravido ma che ti vergognavi a dircelo!» Johann gli passò il braccio intorno al collo e strofinò il pugno chiuso sulla sua testa rasata. «Sai invece cosa pensavo io? Siccome ogni volta che esci dallo spogliatoio c’è sempre un bel fetorino di piscio, è evidente che hai un problema di mira, fratello. Quindi dubitavo che avresti fatto centro con Gilda, quasi ci stavo per pensare io!» «Brutti stronzi!» «Dai, non t’incazzare che ti sposi! Condoglianze!» Persino Zirzow si era sbilanciato e gli aveva fatto gli auguri per il pargolo e il matrimonio. E così, dopo quei tre giorni che seguirono dall’incontro con Karl Eggert il 28 aprile, ecco arrivato il matrimonio di Kaspar. Gli invitati erano i ragazzi della palestra con le fidanzate, per chi le aveva, Leyendecker, e tutti gli altri amici e parenti della coppia di sposi. A fare da testimone a Kaspar fu suo fratello maggiore Joachim, la damigella di Gilda era la sua migliore amica Teresa. Si sposarono in una chiesa evangelica. Una di quelle classiche, con la rosa sulla facciata. Johann andava in chiesa con la famiglia solo nelle festività cristiane, come il Natale o la Pasqua. Ma solo quand'era bambino. Non credeva né all’inferno e né al paradiso, e nemmeno in Dio. Credeva nel destino, credeva nella reincarnazione. Non tutti i sinti credevano nell’anima che si reincarnava e in altri concetti simili, sulla linea della ruota karmica, l’eredità dalle terre dell’est. Nemmeno nella sua famiglia ci credevano. A lui ne aveva parlato un anziano sinti nell'accampamento nomade sulle rive del Leine, fuori Hannover, nelle campagne dove andava a giocare da bambino. Frieda invece veniva da una famiglia ortodossa, anche se non le era mai importato nulla della religione. A pensarci, Johann non sapeva in cosa credeva Frieda, ma non la trovava una cosa così importante. Non l’avrebbe amata di meno o di più per questo. Il ricevimento era in grande stile. Kaspar e Gilda avevano organizzato tutto alla Meistersaal, a Postdamer Platz. Era una sala magnifica, con lampadari di cristallo che pendevano dal soffitto e candelabri aggraziati ai tavoli rotondi. Il soffitto era in legno intagliato in figure geometriche. In fondo alla sala c’era un piccolo palco scenico con le tende rosse aperte e una banda che suonava musica da camera senza disturbare gli ospiti che chiacchieravano. La torta nuziale fatta con i frutti di bosco era deliziosa. Frieda osservò la panna, il pan di spagna, la assaggiò. Interrogandosi su quale fosse il segreto di tanta bontà e per quale motivo lei non riusciva a ottenere quei risultati. A metà serata aveva bevuto abbastanza champagne da essere brilla. Rideva a crepapelle e sprizzava allegria da tutti i pori. Sembrava più felice lei della sposa. Johann assecondava il suo buon umore, Frieda gli dava una carica positiva incredibile. E gli sembrava quasi una bambina nel paese dei balocchi. Kaspar fece sgomberare i tavoli dal centro della stanza, era il momento di ballare. I musicisti cominciarono a suonare melodie più allegre, danzabili. Johann tese la mano a Gilda. «Signora Kölher, vuole darmi l’onore?» Lei accettò di buon grado, con una risata squillante e frivola, l’invito del sinti. Solo dopo si ricordò di guardare il suo nuovo marito, come a chiedergli il permesso. Le donne sposate, devote o meno, avevano tutte quella reazione di fronte all’apollo dalla pelle d’ambra. Kaspar stava chiacchierando con Frieda, quando notò lo sguardo di Gilda le fece un sorriso. Guardò l’amico con un sopracciglio sollevato e un sorriso di sfida, afferrò la ragazza cosacca e la trascinò in pista. Dovevano giocare ad armi pari. Le due donne si ritrovarono l’una con le spalle verso l’altra, i loro compagni si fronteggiavano. Gli occhi neri di Rukeli brillavano di sfida e giocosità. Kaspar si tracciò il pollice sul collo, minacciandolo. Johann scoppiò a ridere, stretto alla moglie di un altro. Fecero volteggiare le signorine, ora si davano le spalle loro due. Johann piegò la testa verso di lui, sbuffò un sorriso. «Te le stacco quelle mani, stai attento a dove le metti.» gli sorrise, oltre la spalla. «Attento tu, quella è mia moglie, testina di cazzo.» Rukeli si bloccò di colpo, e costrinse anche Kaspar a voltarsi. Lo fissò negli occhi, intensamente, dall’alto al basso. Gilda e Frieda si scambiarono un’occhiata. Hans strillò un: «Bacio!» che fece scoppiare a ridere tutti. Johann era serio in volto. Gli occhi del lupo fecero indietreggiare Kaspar di un passo. Ma poi quel momento di tensione si sgretolò. Il giovane sinti si inchinò di fronte all’amico. «Balla con me.» glielo disse come se fosse una proposta di matrimonio. La sala scoppiò in una fragorosa risata. L’amico dalla testa rasata sfarfallò le ciglia come una signorina stupefatta e gli afferrò la mano con una delicatezza che non apparteneva ad un peso massimo. I due amici cominciarono a ballare e cantare, volteggiando e saltellando per la sala. Gilda guardò Frieda, ma la ragazza era tornata sul buffet per prendere dei pasticcini con la panna. Si era detta basta champagne. Non si era mai ubriacata totalmente, ma quasi. Johann le aveva detto che diceva cose strane quando era mezza ubriaca, come discussioni profonde con Buddha e qualche divinità indù. Perciò basta alcool. Sorrise divertita, invece, al ricordo di Johann totalmente sbronzo. A volte gli prendeva male, e si rattristiva senza motivo o per eventi della sua infanzia – come la carcassa di un topolino che aveva trovato in strada un giorno che aveva sette anni. A volte era in vena di fare cose pazze, spericolate e anche illegali. Tipo mettersi a correre nudo per il Tiergarten. Quella sera, probabilmente, non era ubriaco ma solo su di giri. Lo vide dare una pacca sul fondoschiena di Kaspar e allontanarsi. Cercò qualcuno tra i presenti, e quando incrociò gli occhi di Frieda le si avvicinò. Si passò una mano tra i capelli e si accovacciò di fronte a lei, seduta al tavolo dove avevano cenato. «Me lo concede un ballo, madame?» Si tirò su, le prese la mano e la portò in pista. Ballò con lei quella melodia allegra. Frieda, il peso di una farfalla. La faceva volteggiare e ogni tanto la faceva scendere con la schiena, tenendola saldamente mentre lei era a testa in giù e rideva come una bambina. Le fece fare un paio di giravolte. «Che fai, anticipi i miei passi? – le domandò con un sorriso. – Saresti un’ottima pugile.» «In un’altra vita, forse.» I suoi occhi neri s’illuminarono, come se si fosse ricordato di una cosa importantissima. «Ah, ecco! Devo dirti un paio di cose, non te l’ho ancora dette.» «Dimmi allora.» gli sorrise. Un’altra giravolta. «Il sedici maggio devo andare in Belgio, ad Anversa, per un combattimento. Devo affrontare un pugile granitico, e ti voglio con me.» «Ci sarò. ─ gli rispose, alzando un sopracciglio quasi a volerlo sfidare. – E la seconda cosa?» Lui la fece scendere con la schiena di nuovo, lei quasi a testa in giù che rideva. Johann si chinò su di lei, i visi talmente vicini che i respiri si mescolavano. «Ti amo da impazzire.» Una scarica di brividi percorse la schiena della ragazza. Lui la tirò su, attaccò il corpo al suo. «Sei ubriaco marcio.» rise, un po' in imbarazzo da quella confessione a bruciapelo. Era arrossita, sentiva le orecchie andare a fuoco. «Mai stato così lucido. – un sorriso da folletto. – Mi dispiace non avertelo detto prima. Davo per scontato che bastassero i gesti, ma le parole hanno la loro importanza. - le pungolò una guancia rossa. - Mi piace la tua sindrome da pesciolino rosso.» Gli occhi di Rukeli. Neri, bollenti, profondi come un baratro. Così intensi. Così magnetici. Per un attimo temette di perdersi in quella notte senza stelle. Si accorse di aver trattenuto il respiro, ed espirò lentamente. Meniñ ömir maxabbat. Lui sorrise, ricordando quelle parole e il loro significato. La fece volteggiare di nuovo. «Sai, bambina… tra di noi, l’amore dell’esistenza viene chiamato Jaaneman. È un amore a livello dell’esistenza dell’anima, dicono. Te lo spiegherò meglio, prima o poi. – la strinse dolcemente. – Tu sei Jaaneman.» * * *
16 maggio 1933 Anversa, Belgio. Gustav Roth era un professionista dal 1927. L’incontro con Trollmann era il suo cinquantasettesimo. Aveva perso solo tre volte, due per squalifica, e pareggiato otto volte. Lo zingaro era più alto, più agile e scattante, e più grande di due anni. Ma ancora una volta, con pugili più piccoli, era Rukeli a sembrare più giovane. Lo scorrere del tempo non si manifestava sul suo viso né sul fisico o nell’atteggiamento. Induriva i muscoli e migliorava la tecnica, invece. Roth pesava tra i sette e i dieci chili di più rispetto a Johann, macinava colpi senza stancarsi. Prima dell’incontro scattarono una foto ai due pugili e ai rispettivi manager. Zirzow aveva la faccia quasi seccata, le mani sui fianchi; Rukeli era eretto come il tronco di un albero, il viso rivolto dritto verso la fotocamera, era serio e lo sguardo penetrante. Roth si stringeva l’accappatoio, non guardava l’obbiettivo, e il suo allenatore e manager gli circondava le spalle con un braccio e l'aria trionfale. I primi round andarono a Trollmann, contava di buttarlo giù o resistere fino alla fine delle dieci riprese previste, quanto meno. Le ultime due furono difficili. Roth sembrava non schiodarsi, non barcollava e anche se aveva la faccia livida, non dava segno di cedimento. Trollmann aveva individuato tutti i suoi punti deboli e colpiti con forza, schivato le mosse meccaniche del picchiatore belga. Ma arrivò stanco al decimo round, non saltellava nemmeno più. L’ultima ripresa la passò a schivare e incassare quando doveva. Quello non si schiodava e continuava a macinare colpi. Johann era andato in knock-down qualche volta, approfittava della conta dell’arbitro per riprendere fiato, e all’ultimo si tirava in piedi con un balzo, dandosi lo slancio con le gambe. Gipsy Trollmann perse ai punti, ma almeno riuscì a finire tutti i round senza andare al tappeto. Riportava le sue ferite di guerra: una sacca di sangue sotto l’occhio, diversi tagli gli spezzavano il sopracciglio e aveva il labbro inferiore leggermente spaccato al lato. Al suo angolo, sputò il paradenti nel secchio che teneva Leyendecker. Attraversò il ring per complimentarsi con Roth. «Dannazione, nessuno mi aveva mai impegnato così.» gli sorrise. L’altro gli batté il guanto sul suo. «Mi hai dato un bel da fare, Gipsy Trollmann. Bell’incontro. Hai davvero talento, i giornali per una volta dicevano il vero.» «Ti ringrazio, ma sei tu ad aver vinto, dovrei farteli io i complimenti.» «Beh se vuoi farmeli, ascolterò! – amiccò, ridacchiando. – Farai tanta strada, amico. Buona fortuna e buon ritorno a Berlino.» gli strizzò l’occhio. Johann gli sorrise come un bambino sorride ad un nuovo giocattolo. Lo salutò e si addentrò nello spogliatoio per cambiarsi e farsi dare un’aggiustata alla faccia da Frieda. Lei gli fece un sorriso, vedendolo entrare, poi lo fece accomodare sul lettino dello spogliatoio. Prese due bastoncini cotonati. «Zirzow e Leyendecker sono fuori a fumare.» gli comunicò, distratta. Aveva preso un po’ di disinfettante e dei cerotti dall’armadietto. A Johann usciva un po’ di sangue dal naso, pur non essendoselo rotto aveva preso una bella botta. Si tamponò la narice con un fazzoletto. La ragazza fece uscire il sangue dalla sacca che si era formata sotto l’occhio, spremendo la pelle con i bastoncini all’altezza del taglio che si era procurato. Presto il suo volto si sgonfiò, restando arrossato. Gli disinfettò il taglio e ci applicò un cerotto. Disinfettò anche gli altri tagli minori sull’altro zigomo e sull’arcata sopraccigliare, prima di metterci piccoli cerotti a strisce. Per il labbro non poteva fare molto, quelle erano ferite che si rimarginavano presto. Johann le accarezzò i fianchi con le mani, affondando il viso sul suo petto. Era il suo modo di ringraziarla. Lei lo baciò tra i capelli ricci. «Sbrigati a farti la doccia così torniamo in albergo.» «Non vedo l’ora di mangiare e dormire.» «E datti una ripulita, mio focoso caprone.» «Nessuna donna mi ha mai chiamato così. Non capisco se sia un complimento.» ammiccò. Frieda scoppiò a ridere, scuotendo piano il capo e lasciandolo solo nello spogliatoio. Il giorno dopo dal ritorno a Berlino. Era il 18 maggio 1933. Aveva fatto una serie di flessioni e addominali, sollevato pesi, saltato la corda e ora si stava allenando al sacco veloce. Frieda era seduta su una delle panche dall’altro lato della palestra, leggeva una rivista di sartoria. La teneva aperta sulle gambe e tra le mani teneva una tazza di caffè che le aveva portato Gunter, il signore addetto al banco iscrizioni. Quella ragazza gli era sempre stata simpatica. Non veniva spesso, ma era gentile e non disturbava. Quando poteva dava una mano. Con i conti non era brava, ma aveva un ottimo modo di organizzare i vari documenti. Gli piaceva la solidarietà incrollabile che dimostrava verso Rukeli Trollmann, la diceva lunga sulla ragazza. E poi aveva quel cugino… l’orso ucraino. Ogni volta che entrava in palestra sembrava far tremare i pavimenti, tanto era possente. Il segretario ammirava il coraggio dei giovani pugili a confrontarsi con quel peso massimo alto e incrollabile. Quel giorno c’era anche lui. L’altro peso massimo, Kaspar Kölher, lo stava utilizzando come sparring partner, sotto stretta sorveglianza di Leyendecker. Se le suonavano e poi ridevano. Zirzow aveva fatto irruzione nella palestra con la rivista Box-Sport ed una raccomandata. Né Frieda né il segretario seppero dire se fosse contento o angosciato. «Trollmann!» urlò per farsi sentire dall’altro lato della palestra. Lo zingaro si fermò immediatamente, lasciando roteare a vuoto il sacco veloce. Si avvicinò in fretta, in una corsetta tra gli attrezzi, i sacchi e tra le corde dei ring allestiti in mezzo alla sala. La maglietta nera era infilata nei pantaloncini grigio scuro e c’era una piccola chiazza di sudore al centro del petto. Anche Leyendecker si avvicinò, interrompendo l’allenamento di Kaspar ed Ivan. In realtà, si fermarono un po’ tutti. Corpi fumanti in attesa. «Il 9 giugno 1933, alla Birreria Bock, Johann Gipsy Trollmann di Hannover disputerà l’incontro per il titolo nazionale dei pesi mediomassimi!» urlò Zirzow, in modo che l’intera palestra potesse sentirlo. Seguì un secondo di silenzio. Il tempo di metabolizzare la notizia. Comprendere appieno cosa significasse per tutti, per Johann in primis. I suoi occhi si sgranarono lentamente, un sorriso si fece largo sul suo bel viso selvaggio. Si tolse i guanti, li lanciò in aria. L'occasione attesa da una vita, finalmente eccola. La prima volta che salì su un ring aveva otto anni. La prima volta che vinse il campionato nazionale dei pesi medi dilettanti, aveva diciotto anni. Da allora, a Hannover, era considerato quasi un simbolo. E da allora, da quando vide la speranza di riscatto nei volti dei sinti, decise che avrebbe vinto un titolo da professionista e restituito dignità alla sua gente. Quella era la sua occasione, il suo momento. Aveva toccato l'apice, raggiunto il culmine. Doveva solo allungare la mano e prendersi la vittoria. Tutti i pugili della palestra si fecero intorno a lui, lo sollevarono di peso portandoselo in spalla. Cantavano canzoni in suo onore, gli davano pacche sulle spalle, si congratulavano. Leyendecker aveva le lacrime agli occhi. Seguiva quello zingaro indisciplinato dall’estate del 1929. Insieme ne avevano passate tante. Finalmente avevano raggiunto il traguardo a cui puntava di portarlo da quando aveva messo piede nella nuova palestra. «Leyendecker! – gli urlò, con quella sua voce roca. – Grazie di tutto! E grazie anche a te, Zirzow! Senza di voi sarei ancora ad Hannover, è merito vostro se sono qui e sono arrivato fino al titolo nazionale.» Non avrebbe mai potuto ringraziarli abbastanza. Zirzow ci aveva messo la faccia, il cervello per organizzare ogni incontro e costruire, mattone dopo mattone, il suo percorso verso il titolo nazionale. Zirzow gli aveva incastrato incontri con pesi medi, mediomassimi e massimi di tutta Germania, con campioni nazionali di altri Paesi. Grazie a Zirzow si era costruito una fama, incontro dopo incontro. Leyendecker ci aveva messo la pazienza, l’impegno, la perseveranza. Laddove tutti vedevano uno zingaro ballerino, miserabile figlio di musicanti, lui aveva visto il talento allo stato puro e aveva fatto in modo che uscisse fuori ed esplodesse in tutte le platee di Germania. Grazie a Leyendecker aveva imparato mosse e combinazioni efficaci, aveva indurito i muscoli, aveva imparato ad incassare, aveva imparato a gestire il fiato ed avere molto più occhio per le situazioni e per l’avversario. Leyendecker voleva portarlo a combattere per il titolo da quando arrivò a Berlino nel ’29. Aveva sempre reputato Johann Trollmann un campione. Ma non solo di boxe, era un campione nella vita, nel mondo. Il fatto che si fece cucire “zingaro” sui pantaloncini e che li sbandierava in ogni ring di Germania, la diceva lunga su di lui. Anche il suo complimentarsi sempre e comunque con l’avversario dopo il match, fermarsi e parlarci del più e del meno. Il suo non prendersi sul serio, il suo giocare con leggerezza e vincere. Era una ventata di rivoluzione. Ma non piaceva a tutti. La mattina del venti maggio, in casa Trollmann arrivò una lettera dalla Francia. Fu Frieda a recuperarla dalla cassetta della posta, leggendo che il mittente era Erich Seeling, si incupì. La portò a Johann, che stava bevendo il suo caffè. Mi spiace disturbarti e allarmarti così, ma purtroppo non c’è altro modo. Il momento è arrivato, i cambiamenti di cui parlavo stanno cominciando, Trollmann. Il 31 marzo so che sei stato tu a sostituirmi all’incontro con Seifriend, a Neue Welt. Mi spiace che te l’abbiano detto all’ultimo minuto. Immagino che nessuno ti abbia detto del perché. La versione ufficiale è che sono stato poco bene e non ho potuto combattere. La verità è un’altra e la devo dire a te, perché presto questa situazione toccherà anche te la tua gente e chi hai vicino. Prima dell’incontro, le camice brune sono venute da me. Mi hanno intimato che non mi sarei dovuto presentare in nessun modo all’incontro altrimenti avrebbero preso la mia famiglia e li avrebbero fucilati uno ad uno. Appena sono andati via, io e mia moglie abbiamo fatto i bagagli. Siamo partiti subito per la Francia. Ecco perché non ho combattuto, stavo scappando. Ero su un treno per la salvezza. Ho intenzione di raggiungere l’America e continuare lì la mia carriera, mi sono già messo in contatto con Schmeling e Machon. Mi hanno tolto il titolo e tu sei uno dei candidati. So che lo disputerai ad ogni costo. Sappi che ti metteranno contro uno dei campioni ariani scelti dal Reich. Sarà propaganda. Fai attenzione, io sono ebreo e guarda come sono finito per colpa dei Nazionalsocialisti. Tu sei un sinti, uno zingaro, e quelli sono fissati con la “pura razza”. Temo che tra non molto si accaniranno anche sulla tua gente, Trollmann, e su tutti coloro che sono diversi dal loro ideale malato e perfetto. Ti prego, vai via dalla Germania. Sei ancora in tempo. Raggiugi me e Schmeling in America, ci saranno tante opportunità. Vai via finché sei in tempo. E. Seeling Johann indurì la mascella, accartocciando la lettera nel palmo della mano. La boxe era uno sport da ariani. E chiedevano ad uno zingaro di disputare l’incontro proprio nell’anno dell’ascesa del nazionalsocialismo di Adolf Hitler. Johann sapeva che Hitler era un appassionato di pugilato. Johann aveva capito che la boxe sarebbe diventata il suo strumento più efficace per fare propaganda razziale e promuovere le sue ideologie sulla razza ariana. Gli ebrei erano stati cancellati dalle liste delle varie categorie della boxe, solo gli ariani potevano boxare. Lui era l’unico zingaro nello scenario pugilistico di Germania, ed era uno tra gli atleti più famosi e amati dal pubblico. Ma la boxe non era uno sport neanche per zingari: l’avevano mandato via dalle Olimpiadi del ’29 per un motivo preciso, cioè quello. Non si sarebbe tirato indietro, mai. Si sarebbe preparato ad affrontare tutte le ombre che erano in agguato. Bastava stringere le fasce più strette. «Che dice la lettera?» lo riscosse Frieda. Lo stava fissando, studiando. Johann conosceva quello sguardo. Gli occhi attenti di chi stava prendendo la mira. Gli occhi di un cecchino. Non poteva mentirle. Quegli occhi di cielo glielo impedivano. E poi, lei se ne era già accorta che qualcosa non andava. Si sarebbe accorta anche delle sue bugie. Sistemò la lettera, gliela mostrò. Lei lesse velocemente le parole di Seeling. I suoi occhi si indurirono. «Combatterai lo stesso?» gli chiese, semplicemente. «Combatterò, e quel titolo me lo prenderò pure.» |
Capitolo 12
*** 1.12 - Necrologio ***
12. Nachruf
Aveva parlato con Zirzow e Leyendecker riguardo la lettera di Seeling, nel pomeriggio. Entrambi erano rimasti sconcertati da come stavano andando le cose. Come ad intuire la situazione, il giorno dopo aver ricevuto la lettera dell’ex campione tedesco, una squadra di camice brune fece irruzione nella palestra. Controllarono un po’ ovunque, in caso fosse tutto a norma. Le Sturmabteilung (SA) erano il reparto d’assalto dei militari d’élite di Hitler. Avevano richiesto i fascicoli di tutti i pugili che si allenavano lì, Leyendecker glieli aveva passati senza troppe cerimonie. Passarono un’ora nell’ufficio dell’allenatore a studiare i fascicoli dei ragazzi, controllando che fosse tutto a norma. Quando uscirono, Leyendecker era scuro in viso. Fece alcuni nomi, tra cui quello di Hans Seekirchen. «Dovete andare via, ragazzi, non potete più stare qui.» aveva detto. Johann guardò l’amico e poi Kaspar. «Che cosa? E perché?» aveva protestato Hans. «Perché siete ebrei. Gli ebrei non possono più boxare, è contro la legge.» aveva risposto uno delle camice brune, rigido. Hans e gli altri ragazzi restarono impietriti. Non fecero in tempo a dire nient’altro, li avevano fatti uscire in fila dopo avergli fatto togliere i guantoni. Quello che doveva essere il capo delle camice brune lì presenti, si rivolse a Leyendecker dopo aver scoccato un’occhiata a Johann, che cercava di guardare fuori le finestre dove stessero portando i suoi amici. «Quel suo pugile, lì… Trollmann. Sappiamo che presto combatterà per il titolo. Contiamo di vedere un combattimento pulito e onesto, in pieno spirito del Faustkampf.» «State dicendo che Trollmann combatte slealmente? Trollmann?» «Quei suoi trucchetti non sono onesti, e il suo sgambettare ovunque sul ring è un modo scorretto di sottrarsi allo scontro, Herr Leyendecker, lei lo sa.» L’allenatore scosse il capo. «Johann si allena duramente, è una vita che tira di boxe. Ha un grande talento e…» «Talento? Quello zingaro lì? Noi abbiamo visto solo un clown del ring. – ridacchiò in modo composto. – Confidiamo nel suo buonsenso. A presto.» Quando le SA e i loro amici furono fuori, c’era il gelo nella palestra. Nessuno disse più nulla, qualcuno se ne andò a casa. Johann rimase. Leyendecker gli andò vicino. «Prima i comunisti, ora gli ebrei. Johann. – lo richiamò l’allenatore, il volto segnato dalla preoccupazione. – Devi andare via.» Le raccomandazioni di un padre al suo unico figlio. «Devo combattere per il titolo.» replicò, distratto. «E poi te ne devi andare. Mi hai capito, ragazzo? Vattene.» «È solo politica, vecchio. – mormorò lui, mollando un gancio rabbioso al sacco nonostante il tono calmo. – Non ci vorrà molto che tutta questa follia sarà acqua passata.» «Lo hai visto anche tu. Non è più politica, sta diventando una questione sociale. E tu sei uno zingaro.» Johann si fermò di colpo. I suoi occhi neri brillarono di rabbia, fulminarono l’allenatore. Leyendecker si sentì al cospetto di un lupo affamato, lo sguardo selvaggio. Quegli occhi. Il baratro più profondo non poteva essere scuro come le iridi di Rukeli. Inghiottivano la luce delle lampade sul soffitto come un buco nero. Indietreggiò di un passo. «Lo so che sono uno zingaro, me lo ricordate tutti da quando sono a Berlino. Non fate altro che riempirvi la bocca con questa parola. – un gancio al sacco, oscillò senza contegno. – Non ha niente a che fare con me tutta questa storia. Io faccio sport, sono un atleta. Solo perché sono zingaro non significa che io sia un delinquente o chissà cosa.» «Ma possibile che non lo capisci? Ha a che fare con te eccome! Nemmeno Hans e gli altri ragazzi erano delinquenti, ma erano ebrei, mi capisci? Gli zingari sono sempre stati una questione sociale, come lo è ora quella degli ebrei. A quella gente non interessa il caso singolo, ma l’insieme. Pensi che non verranno a bussare alla tua porta, un giorno? – ora Leyendecker urlava, disperato. – Te ne devi andare, Johann! Fa’ il tuo incontro, ma non ha valore per quella gente, sarà propaganda. Fa’ quello che devi. Ma poi vattene! Te ne devi andare!» Un montante sinistro fece traballare il sacco. Si sganciò dai cardini, cadde pesantemente sul pavimento della palestra. Non si curò di tirarlo su e rimetterlo a posto. I pochi pugili rimasti ad allenarsi si erano fermati di colpo. Si sfilò i guantoni, li lanciò addosso alla parete. Si voltò verso Leyendecker. «Io non me ne vado. Sono nato qui, cresciuto qui. Sono tedesco, ho il diritto di stare in Germania. Questa gente non è nessuno per dirmi come devo vivere, cosa devo e non devo fare, e come lo devo fare.» sputò a terra, come se il suo vero obbiettivo in realtà fosse il nazionalsocialismo. Si avviò verso l’uscita. «Ti farai ammazzare, Johann!» gli urlò l’allenatore, in un ultimo atto di disperazione per cercare di convincere il suo pugile. Il ragazzo si voltò, allargò le braccia. «Forse. Ma non mi piegheranno.» * * *
26 maggio 1933 Kozerthaus, Hannover. Otto Klockemann pesava otto chili in più rispetto a Johann Trollmann. «Respira, stancalo. Con lui non puoi giocare.» gli diceva Leyendecker al suo angolo. Erano previste otto riprese. Ma Rukeli aveva tanta di quella rabbia in corpo che si accanì sull’avversario come se fosse un nemico. Non l’aveva mai fatto. Klockemann si era spaventato, cedeva terreno, veniva divorato dal lupo. Al secondo round, Gipsy vinse per knock-out tecnico. La Kozerthaus esplose in urla di gioia. Era la voce della sua gente, della sua città. C’era tutta la sua famiglia a vederlo. Persino le sue sorelle con i mariti e i figli. Quando incrociò gli occhi di sua madre tra il pubblico, la rabbia abbandonò il suo corpo. Rilassò le spalle, si sciolse in un sorriso. Si avvicinò a Klockemann, gli strinse la mano con un sorriso di scuse ma non gli disse nulla. Johann per primo era rimasto sconcertato da sé stesso: mai si era accanito così con un avversario. Mai come se fosse un nemico. Non li aveva mai colpiti con odio, come loro colpivano lui. Stavolta si era lasciato andare a quel fuoco rabbioso. Non l’avrebbe più permesso. Rukeli si avvicinò alla platea, alla sua famiglia, prese in braccio la figlia di sua sorella Kerscher. Dorette, chiamata Goldi, aveva otto anni ed era una bomba di vivacità. Come sua madre da bambina, d’altronde. Johann ricordò quei giorni con un sorriso, mentre portava sua nipote in giro per il ring, tenendola su una spalla. E i sinti di Hannover ridevano, cantavano, battevano le mani mentre lui restava sul ring. Era giovane e immortale. Il giorno dopo tornò a Berlino. Non tornò a casa subito. Sentiva di voler parlare con Edmund Bilda. Di cosa esattamente, non sapeva dirlo. Ma la morte di Schnipplo, e la sua generale assenza nella vita del ragazzo, lo portarono a desiderare un padre. Leyendecker era stato suo padre in quegli anni, Zirzow uno zio severo. Ma nessuno dei due era padre sul serio. Suonò il citofono, gli aprirono subito. Edmund lo accolse con un gran sorriso confortevole. Ivan non c’era. «Johann! Posso offrirti qualcosa?» «Sono apposto, grazie.» Si sedette su una delle sedia della cucina. Il signor Bilda posò una scodella di ciliegie sul tavolo. Johann guardò le foto di Frieda e sua madre appese sulle pareti della cucina. Avevano molte foto insieme. C’erano anche le foto di Edmund e sua moglie da giovani, il giorno del loro matrimonio, in momenti galanti. «Si chiamava Agnes, era tedesca. ─ mormorò Edmund con un sorriso triste. – Non c’è giorno in cui io non pensi a lei.» Johann abbassò lo sguardo, non sapeva cosa dire. Sapeva della madre di Frieda. Sapeva che era tedesca, una pura “ariana” come sarebbe stata etichettata in quei giorni. «Frieda non ne parla mai volentieri, non credo che le manchi. – continuò l’altro. – Aveva sette anni quando è morta. Forse è bene così. Se un genitore lascia un figlio quando è ancora piccolo, forse è meglio: in futuro non sentirà la sua mancanza.» «Io… credo che a Frieda sia mancata una figura materna. Tutto ciò che sa fare, il suo stesso carattere, sono forgiati da personalità maschili.» commentò Johann, sommesso. «Hai ragione. Hildi l’ha aiutata molto in questo: le ha insegnato a truccarsi, a vestirsi, a cucire, a rapportarsi con i ragazzi. Le ha fatto scoprire il suo lato femminile. – sospirò. – Frieda è sempre stata così autentica, così libera. Mi ha fatto diventare matto, soprattutto durante l’adolescenza. Ma è dotata di una sensibilità molto particolare, Johann. Una sensibilità ed un’empatia molto profonde.» «Me ne sono accorto. – sorrise. – Dal semplice fatto che riesce ad entrare in empatia con il suo cavallo, Alfie.» «Non è solo questo. Si fa carico delle emozioni di chi ha intorno, non lo fa apposta, è troppo empatica. Tutta la positività che raccoglie da chi la circonda le fa bene, il problema è quando assorbe la negatività. Si autodistrugge senza accorgersene. Oh, e non parlerà mai delle sue sofferenze. Non ti dirà proprio niente, si autodistruggerà in silenzio piuttosto che dirti quanto soffre. Te lo sto dicendo perché sei molto vicino a lei, dovrai fare attenzione a queste cose. – prese una pausa, gli sorrise. ─ Sei un bravo ragazzo, e ti ama. Non le è mai importato niente dell’amore, poi sei arrivato tu.» Era tranquillo, perché non stavano vivendo alcuna brutta situazione. Sapeva del suo brutto difetto di non parlare di ciò che la angosciava, non lo dava neanche a vedere, ma dopo quasi cinque anni aveva imparato a conoscerla. Sorrise per l’ultima frase di Edmund. Nemmeno a lui era mai importato niente delle romanticherie, sapeva solo che piaceva alle donne e perché non divertirsi con loro, allora? Quando si sarebbe presentata quella giusta per lui, se ne sarebbe accorto, ma fino ad allora erano tutte sue. Poi aveva visto Frieda. Solo per i suoi occhi, le mostrò il suo cuore. «Ti ha mai detto come ci siamo conosciuti?» Edmund scoppiò a ridere, annuendo. «Quella ragazza… È tutta pepe, quando ci si mette.» «Maledizione, l’ho notato!» «So che combatterai per il titolo nazionale.» esordì l’uomo. Il signor Bilda stava andando a toccare un argomento delicato per Rukeli. Forse era per quello che sentiva il bisogno di parlare con lui. «Sì, è una grande opportunità.» sussurrò. «Ragazzo mio, qualsiasi cosa ti turba per quella serata, scacciala via. Devi concentrarti e far vedere ai tedeschi che i sinti non sono solo musicanti o circensi. – gli strinse la spalla. – Niente sarà come prima, comunque andrà quella serata. Ecco perché devi far in modo che vada bene.» «Signor Bilda… Sarà propaganda.» Gli occhi di Edmund si incollarono a quelli del pugile. Azzurri come il cielo, profondi, senza limiti. Ma era un cielo diverso da quello di Frieda. Mentre lei aveva lo sguardo limpido, leggero, frizzante… Suo padre aveva gli occhi antichi, provati, pesanti. Il peso degli anni e dell’esperienza, delle difficoltà superate. «Un motivo in più per virare la situazione a tuo favore. – lo fissò. – Ascoltami, ragazzo. Cercheranno di portarti via l’orgoglio, di portarti via l’anima, tenteranno di prendere il controllo. Credimi, ci proveranno. Quando tutto ti sembrerà cadere, fermati. Respira. Ascolta la tua testa, ascolta il tuo cuore. Ricordati chi sei e riprendi il controllo. È come la boxe: il più bravo resta in piedi. In quel ring intangibile combatterai una battaglia tremenda, ragazzo mio. Porta con te l’orgoglio del tuo intero popolo.» Nel match contro l’ingiustizia, il pregiudizio, nel match contro un governo ed un’ideologia razzista, chi era il più bravo? Chi restava in piedi? Johann avrebbe combattuto contro quella bestia nera fino alla fine della sua vita e oltre. Tornò a casa per pranzo. Un rinnovato spirito di libertà e di ribellione gli bolliva nelle vene. Piegarsi mai. Aprì la porta di casa e un profumo di spezzatino e patate gli invase le narici. Frieda fischiettava una canzone mai sentita prima, e andava di qua e di là per la cucina, roteando come una ballerina. La gonna che si gonfiava leggermente ad ogni piroetta. Assaggiò lo spezzatino e rifletté sul sapore. Non sapeva decidere se fosse buono o meno. La vide alzare le spalle senza particolare attenzione e afferrare la pentola dalle maniglie. Si voltò per fare i piatti. Incrociò lo sguardo divertito di Johann. Era appoggiato con la spalla sul muro, le mani nelle tasche dei pantaloni neri. «Bella coreografia.» le sorrise. Lei lasciò la pentola sul tavolo e andò ad abbracciarlo. Gli riempì il viso di baci. «Com’è andata? Mangiamo.» Si allentò il colletto della camicia, sbottonando un paio di bottoni. Si accomodarono a tavola e iniziò a raccontarle di Klockemann. Le disse di Goldi, delle sue sorelle. Non le disse di Edmund. A Johann piacque lo spezzatino di Frieda. Non era molto brava a cucinare, ma s’impegnava duramente per imparare. Quand’era sola studiava libri di ricette e dava inizio agli esperimenti. Stava migliorando, e quello spezzatino ne era la prova. «È buonissimo. Sei stata brava.» le sorrise, pulendosi i lati delle bocca. Un sorriso raggiante si aprì sul volto di Frieda. «Davvero? Non lo dici tanto per dire, vero?» «Se faceva schifo te l'avrei detto, lo sai. Andiamo al cinema stasera? – le chiese. – Voglio portarti all’Haus Vaterland. Voglio ballare con te tutta la notte e bere birra mentre facciamo i nostri discorsi mistici da ubriachi.» Lei scoppiò a ridere. «Tu sei matto, domani ho il turno di mattina! A bere birra ci vengo ma dovrai trovarti un’altra signorina con cui ballare tutta la notte.» lo sfidò. Johann assottigliò lo sguardo, si leccò il labbro. «Va bene, allora. Spero di trovarci Hildi, pronta per me.» «Non ti biasimo. Anch’io mi tradirei per lei.» scoppiò a ridere di nuovo. Frieda cominciò a sparecchiare, mise i piatti a mollo nell’acqua del lavandino. Lui arricciò il naso, con un sorriso. «Non mi piace questa cosa, io non ti tradirei mai. Nemmeno per Hedy Lamarr, e solo questo dovrebbe bastarti.» «Hedy Lamarr ha diciannove anni! Dicono sia ninfomane.» la buttò lì. «Ti assicuro che per me non è assolutamente un problema.» Frieda gli scoccò un’occhiata di divertito disappunto mentre si sciugava le mani su un panno. Johann sbuffò dal naso, sporgendo le labbra come se meditasse. «Va bene, biondina, non faremo tardi stasera. Dopo, invece, voglio andare a pescare.» «Hai voglia di fare tante cose oggi, eh? – gli arrivò dietro, gli passò le mani sul petto e lo strinse dolcemente in un abbraccio. – E io?» Gli sussurrò nell’orecchio. Le sue labbra sul lobo, il fiato fresco. Un brivido gli percorse il corpo. Si passò la lingua sui denti, le afferrò uno dei polsi. «Tu cosa?» «Non ci sono nei tuoi piani giornalieri?» lo provocò, la voce suadente. Le sue labbra premevano lente e sensuali sul collo del pugile. Fanculo Hedy Lamarr. Johann si alzò in piedi, la inchiodò al banco della cucina. La sollevò, la fece sedere lì, tra i fornelli e il lavandino. Le teneva le mani sui fianchi. «Tu ci sei in ogni progetto, in ogni sogno, in ogni intenzione.» * * *
Box-Sport, edizione del 6 giugno 1933 – Presentazione del match per il titolo nazionale categoria mediomassimi, Trollmann-Witt, 9 giugno ’33. I punti di attrazione di questo periodo sono chiaramente Adolf Witt di Kiel e Heinrich Trollmann di Hannover. Ognuno di loro ha un proprio seguito. Witt è sostenuto da coloro che vogliono vedere un picchiatore forte, coraggioso, sempre pericoloso. Trollmann aveva molti sostenitori, in particolare tra coloro che non riuscivano ad accettare le nuove direttive per combattere date dalla federazione, sostenitori che apprezzavano la teatralità del suo stile e la sua imprevedibilità zingaresca. Si divertivano per la sua originalità. Non hanno mai avuto la minima sensibilità per il grande istinto che Trollmann ha dimostrato come pugile e che consiste nella più preziosa qualità di questo combattente. Risulta quindi chiaro che il talento di Trollmann sia stato portato su binari deviati. Si voleva un clown del ring e si applaudiva quando Gipsy dava dimostrazioni che avevano poco a che fare con il pugilato. Al contrario non lo si accettava quando combatteva seriamente, lealmente e determinato come una furia a vincere. Il pubblico, non prendendolo seriamente, ha stracciato a questo giovane la possibilità di avere un’incredibile carriera sportiva. Trollmann aveva le carte in regola per diventare campione Europeo, probabilmente anche mondiale, ma il pubblico l’ha deviato. Leyendecker finì di leggere l’articolo e alzò gli occhi su Trollmann, le labbra serrate e le sopracciglia inarcate. «Beh, questa è… una capriola stravagante. Ti rappresentano come traviato dai tuoi stessi sostenitori.» Johann, che stava eseguendo una sessione di addominali disteso su un tappetino, si fermò e posò i gomiti sulle ginocchia divaricate. Dalla cute colò un rivolo di sudore ai lati del viso. «Parlano di me al passato, come se non ci fossi più o non fossi più un pugile. L’hai notato? Puzza di necrologio, e non si parla male di un morto.» «Tu dici?» Alzò le spalle, tornando ai suoi addominali. «Rileggilo e te ne accorgi. Di Witt parlano al presente, di me al passato. Questi mi stanno facendo le scarpe, prendono le misure per la bara.» A N G O L O A U T R I C E Ce l'ho fatta ad aggiornare. Amen. In questi giorni sto facendo una revisione alla storia perciò i capitoli già postati finora sono stati lievemente modificati. Per modificati intendo che qua e là potrebbero esserci piccole aggiunte, piccole modifiche, etc. L'aggiunta più importante che ho apportato, è stato inserire gli spezzoni di articoli di Box-Sport dell'epoca che parlano di Trollmann. Li ho presi dal libro di Roger Repplinger, Buttati giù, zingaro (edizioni UPRE ROMA), che ha fatto un'approfonditissima ricerca e ricostruzione della vita di Rukeli riportando, oltre a questi articoli, le testimonianze dei familiari in vita e gli aneddoti più famosi. Quegli articoli ho cercato di trovarli da me, ma purtroppo i miei unici mezzi sono internet e i libri, mentre Repplinger disponeva di tutta la Germania per cercare il "fantasma" di Rukeli HAHAH Ad ogni modo, consiglio di leggerli! Si trovano nei capitoli - cap. 6, Solo buone intenzioni - cap. 9, Io non gioco - cap. 10, Figlio della guerra Vi ricordo che Box-Sport era una rivista che andò ad "arianizzarsi" ed era da sempre abbastanza razzista, pertanto si schierava di solito dalla parte dell'avversario di Rukeli. Se si "complimentava" con Trollmann era perché cercava di dar vedere una certa neutralità. Non ricevo molti feedback e sto andando un po' alla cieca (?). Se leggete, mi farebbe piacere avere un'opinione ç__ç Alla prossima! ♥ |
Capitolo 13
*** 1.13 - Il riscatto di Rukeli: lo zingaro re di Germania ***
| L'Angolo autrice ve lo piazzo in alto oggi. Voglio precisare che non so se abbiano combattuto davvero all'aperto e sotto la pioggia, io dubito perché non credo che facciano combattere fuori con un tempaccio del genere. Però ho esageratamente romanzato questo aspetto. In secondo luogo spero di non deludere le vostre aspettative e di aver scritto, tutto sommato, un capitolo decente. Non è facile per me scrivere di pugilato per la poca familiarità che ho con il contesto, nonostante le ricerche, perché certe cose sono dell'idea che vadano vissute un po' per saperle raccontare. Per scrivere questo capitolo, ho ascoltato a repeat una canzone in particolare, ma vi farò comunque una lista anche delle altre che ho ascoltato. Magari vi va di leggerlo con una di queste canzoni nelle orecchie! 1. Sonne - Rammstein [il cui titolo originario era Der Boxer.] 2. Hall of Fame - The Script 3. Unstoppable - Sia 4. Never give up - Sia 5. The Greatest - Sia Vi lascio al capitolo e IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE una fotografia scattata durante l'incontro. Mi farebbe piacere sentire le vostre opinioni! A presto! ♥ _______________________________________
13. Rücknahme von Rukeli Gipsy König von Deutschland 9 giugno 1933 Berlino. Birreria Bock. Kreuzberg Fidicinstrasse, monte Tempelhof. Ore 21:00. Era stata una bella giornata. Verso le 19:00 cominciò ad infuriare una tempesta e siccome l’incontro si sarebbe tenuto all’aperto, nel giardino della birreria, vennero “solo” millecinquecento persone. Era solo nello spogliatoio. Stava finendo di fasciarsi le mani. Non voleva nessuno. Conosceva il significato della parola propaganda. Avevano preso il pugile zingaro di centocinquantasei libbre, che guarda caso era il più amato e famoso di Germania, e gli avevano messo contro un colosso di pura razza ariana di centosettanta libbre. Adolf Witt. Il campione scelto dal Reich contro un gitano. La differenza di peso era elevata, la differenza di altezza pure. Nessuno sapeva cosa aspettarsi da questo incontro. Contro Witt aveva vinto, perso e pareggiato. L’ariano fisicamente superiore al gitano: Gipsy Trollmann annientato, la razza zingara sopraffatta dalla superiorità ariana. Non l’avrebbe mai permesso. Quella sera avrebbe giocato il tutto per tutto, c’era in palio molto più di un titolo. Avrebbe vinto il riscatto. Non poteva darla vinta agli uomini del Reich. La folla, là fuori, batteva i piedi e faceva tremare il pavimento. Chiamavano il nome di Gipsy. Lo volevano campione di Germania. Chiuse gli occhi, rilassò i muscoli. Gli tornò in mente sua madre Friederike. «Come ti chiami?» «Johann.» «No, il tuo nome sinti. Qual è?» «Rukeli.» «E cosa significa “rukeli”?» «Albero.» Glielo faceva ripetere. Ripeteva “albero” finché non sentiva il coraggio montare, si sentiva invincibile, impiegabile. «Un albero non cade se ha radici profonde.» Era diventato il suo mantra. Non era altro che questo, non era altro che il suo nome. «Quando tutto ti sembrerà cadere fermati. Ricordati chi sei, riprendi il controllo. Su quel ring combatterai una battaglia tremenda. Porta con te l’orgoglio del tuo popolo intero.» Riaprì gli occhi, respirò. I pantaloncini bianchi su cui era scritto Gibsy. Fuori il Reich voleva vedere lo zingaro cadere sul ring, sotto i colpi dell’ariano. Rukeli avrebbe dato loro lo zingaro. Ma l’avrebbero visto danzare. L’avrebbero visto vincere. Leyendecker bussò alla porta dello spogliatoio. Gli fece un cenno con la testa. Johann si alzò in piedi, tirò il cappuccio dell’accappatoio nero fino agli occhi lasciandolo aperto davanti. Con l’allenatore non avevano più parlato di niente. Lui sembrava essersi passivamente arreso all’ostinatezza di Trollmann. Non pioveva più. Johann poteva sentire l’odore della pioggia, della terra bagnata. Intorno al ring erano stati messi i gazebi per proteggere il pubblico in caso di pioggia e garantire una buona visuale dell’incontro. C’erano le camice brune che avevano occupato due interi tendoni. Fotografi e giornalisti sotto un altro tendone. I giudici sotto un altro ancora. Il resto del pubblico era sotto i restanti gazebi. Flash di macchine fotografiche, scommesse sottobanco, rumore di macchine da scrivere. Lo accompagnavano verso il quadrato. Il ring era stato asciugato. Era ben illuminato dai lampioni del giardino della birreria, quasi si trovassero dentro, sotto i fari. Witt era al suo angolo, provava alcuni montanti bassi, i pantaloncini azzurri. Otto Griese, l’arbitro, discuteva delle ultime cose con i giudici. Rukeli piantò la mano sul palo dell’angolo. Si diede lo slancio con le gambe, piegandole da un lato facendo lavorare i muscoli laterali della schiena e gli addominali, mentre saltava le corde alte un metro e mezzo a piedi pari. La folla in delirio. Lasciò scivolare via l’accappatoio, esibendo la pelle nocciola con una certa sfrontatezza di fronte al desiderio negli occhi delle donne e l’odio negli sguardi delle camice brune. Salutò il pubblico con le mani e lanciò baci qua e là. Incrociò lo sguardo di Edmund ed Ivan Bilda, fece loro un cenno col capo. Con gli occhi cercò Frieda nel pubblico, ma lei si era materializzata al suo angolo e lo guardava con le braccia incrociate e un sorrisetto da furba. Aveva fiducia nel suo campione, tuttavia Witt era carico di una sicurezza e spavalderia inusuale, e qualsiasi esito avrebbe avuto quella serata… niente sarebbe stato come prima. Nel bene e nel male. Si chinò su di lei, sporgendosi dalle corde per darle un bacio. «Un albero non cade se ha radici profonde.» le disse sottovoce. «All’angolo destro, in calzoncini azzurri. Il campione di Kiel. Ventuno incontri dal ’32, di cui quattordici vinti. Adooolf Witt!» Annunciò lo speaker, con un grosso microfono in mano. La folla applaudì, anche Witt era bravo. Le camice brune si alzarono in piedi. Poi lo speaker si rivolse a Johann, incapace di contenere l’ammirazione. «All’angolo sinistro, in calzoncini bianchi. Il campione di Hannover. Cinquantadue incontri dal ’29. Il pugile con il più alto record di incontri in un anno, diciannove solo nel ‘32. Johaaann Giiipsy Trollmaaaann!» Il pubblico esplose. Urla di devozione, dichiarazioni d’amore, incitamenti, applausi scroscianti per il beniamino di Germania. Rukeli si inchinò teatralmente a quell’accoglienza. Il titolo me lo prendo. Si voltò verso Leyendecker per farsi aiutare a mettere i guantoni. Zirzow fumava la sua fedele pipa, guardava in cagnesco le camice brune. «Mettigli una museruola.» ammiccò Johann all’allenatore, facendo un cenno col capo per indicare il manager. Quello sorrise divertito. Gli mise il paradenti. Rukeli provò un paio di colpi, le vene delle braccia inspessite ed evidenti sotto la pelle d’ambra. Sciolse il collo, le spalle. Riconoscere i propri limiti, rispettarli, ma non fermarsi. Andare avanti sempre, senza dimenticare mai la strada percorsa e da dove si è partiti. I sobborghi poveri di Hannover. Le scarpe bucate che si riempivano d’acqua quando saltava nelle pozzanghere dopo la pioggia. I cappotti tre volte la sua taglia. Le lotte con gli animali nelle fattorie. I pugni con Ferdinand nel fango delle strade. Friederike che imprecava e li divideva. Schnipplo che cercava di rifilargli un buffetto sull’orecchio. Johann che rideva e scappava, nessuno che riusciva a prenderlo. Si voltò verso Witt. Occhi azzurri, pieni d’odio. L’arbitro chiamò i guantoni. «Boxe!» Il gong nelle orecchie. Il gigante ariano tentò di colpire la faccia dello zingaro. I suoi occhi brillavano di disprezzo. Tirò una serie di colpi diretti al viso di Rukeli. Risposta: lievi rotazioni del busto, lievi spostamenti del capo. Witt caricò un gancio. Trollmann spostò indietro una gamba, bilanciando il peso su entrambi i piedi, piegò indietro il tronco, incredibilmente elastico. Il gancio sinistro andò a vuoto. In quel momento, mentre il colosso veniva trascinato dal colpo, scoprì tutta la guardia sul corpo. I piedi messi male rischiavano di sbilanciarlo. Gipsy esplose in una raffica di colpi al plesso solare e al costato nel frammento di tempo in cui Witt era scoperto. Il gigante non vide partire i pugni. Cadde a terra, i colpi l’avevano sbilanciato. Fine della prima ripresa. Ognuno ai propri angoli. Leyendecker massaggiò le spalle di Trollmann, Frieda gli tolse il paradenti e lo fece bere. «È meccanico. – commentò il pugile. – Statico, granitico.» «Non ti abbiamo ancora visto danzare, Gipsy.» commentò Zirzow. «Mancano undici round. Vedrai se non mi metto a ballare sotto la pioggia.» «Fuori i secondi!» l’arbitro chiamò. Nelle riprese che seguirono, Trollmann teneva Witt sistematicamente lontano impedendogli di entrare puntandolo col sinistro. Witt che tentava di colpire con diretti pesanti, ma non trovava niente. Le sue gambe veloci lo portavano lontano dalla zona di pericolo. Witt si disperava: colpiva nel vuoto, Trollmann rendeva evidenti i suoi limiti. Non aveva i mezzi pugilistici per fermarlo. Quando cercava di prenderlo doveva pagare un prezzo, molto maggiore rispetto al dono che Johann offriva. Prima che Witt arrivasse a segno, Trollmann lo aveva già colpito. E prima che ci riprovasse, Gipsy non c’era più. In compenso riconobbe che Witt non si lasciava ingannare dai truccacci che gli rifilava di tanto in tanto. Smise di cercare di fregarlo. In ogni colpo che l’ariano cercava di sferrargli, vedeva l’odio. Lo zingaro che gli rifilava colpi di disturbo, colpi che pungevano. Adolf Witt si innervosiva ad ogni schivata e ad ogni fastidio di Trollmann. Finiva col mettere più forza nei suoi pugni, spingendosi ai limiti, perché sia mai che lo colpiva, almeno lo prendeva per bene e mandava al tappeto quello zingaro ballerino. Ad ogni diretto furioso che l’ariano gli lanciava, Johann vedeva la frustrazione nel suo sguardo, i rivoli di sudore scendere lungo il viso, percepiva il fiato corto. Si stava stancando. Witt, il toro scatenato; Trollmann, il torero che sventolava il drappo cremisi. Witt combatteva onestamente, si impegnava per il bene del Reich e della razza, ma non aveva possibilità. Questo risultò chiaro a tutto il pubblico fin dai primi minuti. Trollmann era più veloce, sempre un passo avanti a lui: portare il colpo, andare a segno, poi sparire. Witt non riusciva a rispondere a questo, ci provava ma senza successo. Tra le camice brune c’era agitazione. Uno di loro, aveva scambiato qualche parola con l’arbitro e i giudici. Si era piazzato davanti alle corde. I suoi occhi facevano pressione su Rukeli. Cominciava a pioviccicare. Trollmann al suo angolo. Il corpo coperto da un sottile strato di sudore e ora umido dalla pioggia. Piccole gocce d’acqua incastrate tra i ricci neri. «Chi è quello?» indicò col mento l’SA a bordo ring. Le gambe divaricate, seduto sullo sgabello, le braccia distese sulle corde, il mento incassato. Gli occhi del lupo che guardavano l’omino con la camicia marrone all’angolo di Witt. Confabulava con il suo allenatore e con l’arbitro. «Nessuno.» rispose Zirzow, sbrigativo. Johann alzò lo sguardo sul manager, senza scomporsi. «Chi è?» «George Radamm. Presidente della Federazione dei Pugili Tedeschi.» «È venuto per guardarmi mentre butto giù il suo campione e vinco il titolo? Gentile da parte sua.» L’allenatore gli mollò un buffetto dietro la testa. «Falla finita, maledetto sbruffone.» L’arbitro richiamò i pugili. Suonò il gong. Decimo round. Leyendecker teneva gli occhi fissi su Witt. «Incassa il mento. Sta mirando al K.O.» Johann masticò il paradenti. «Anche io.» La pioggia si fece più fitta all’undicesimo round. Witt barcollava, ma alla fine aveva colpito Trollmann al lato del viso. Ora lo zingaro aveva un bel livido al lato della faccia, tra la tempia e lo zigomo. Ma Witt era ridotto peggio. Sanguinava dal sopracciglio, aveva un occhio nero, le labbra gonfie, una sacca di sangue sotto l’altro occhio, il naso rotto. La storia di Davide e Golia che si ripeteva su un ring. Leyendecker, Zirzow e Frieda si erano bagnati come pulcini. I pugili sul quadrato avevano i corpi scintillanti, le donne nel pubblico apprezzarono di più quello spettacolo ora che quegli Adoni di marmo erano bagnati addosso. I ricci di Rukeli gli si erano attaccati alla cute, un ricciolo ribelle scendeva tra gli occhi. L’acqua gli scendeva sul viso, gocciolando dal naso e dal mento, scivolando sul corpo e intrappolandosi nei pantaloncini attaccati alla pelle delle cosce. La cintura del campione, sul tavolo dei giudici, era stata portata via. Radamm aveva già capito chi avrebbe vinto, la superiorità di Trollmann era evidente. Doveva comunque tentare di non farlo vincere. Era indiavolato: non con l’avversario, ma con il Reich. Witt era suo avversario ma il Reich il suo nemico, mai dimenticarsi la distinzione tra queste due parole apparentemente simili. C’era un baratro di differenza tra nemico ed avversario, e Johann non colpiva questi ultimi come se fossero nemici. Non li colpiva come gli altri facevano con lui. Era un uomo paziente, con pazienza stava portando avanti da undici round la sua opera di smantellamento del colosso. Non aveva alcuna intenzione di perdere e dargliela vinta alle SS. Questa era la sua occasione per riscattarsi come zingaro, come pugile “ballerino”, e restituire un po’ di dignità al suo popolo. Trollmann al suo angolo, prima del dodicesimo round. «Come va col fiato, ragazzo?» chiese Leyendecker, allargandogli le narici per far passare più aria. «Non sono più il ghepardo di una volta.» ghignò. «Avessi io venticinque anni, il tuo fisico e il tuo talento, farei tremare il mondo.» borbottò Zirzow. «Sì, e magari di nome faresti Johann Trollmann?» lo canzonò Leyendecker, mentre asciugava il viso di Johann con un asciugamano. Rukeli sorrise, guardò Frieda. Era zuppa dalla testa ai piedi. Il trucco delle ciglia si era sciolto, lei l’aveva pulito via. I suoi occhi indugiarono sulla camicia fradicia che le si era attaccata alla pelle, lasciando poco spazio all’immaginazione. Di nuovo, il knock-out di Trollmann. «Ora puoi assestargli il colpo della buonanotte, se vuoi.» gli fece Leyendecker, riportandolo alla realtà. «Gliene avrò assestati un migliaio, quello non cade. È una torre.» sputò nel secchio. «Fuori i secondi!» urlò l’arbitro Griese. «E date una coperta, un ombrello, o qualcosa, alla mia ragazza. Se si ammala me la prendo con voi.» «Non ha voluto niente, quella è più testarda di te.» replicò Zirzow, strizzando via l’acqua dai bordi della giacca. Leyendecker lo lanciò sul ring prima che potesse replicare. «L’ultimo sforzo. Sei stato incredibile, finisci il round e prenditi questo maledetto titolo. E attento a non scivolare.» Dodicesima ripresa. L’ultima fatica di Ercole. La pioggia era fitta ora, ma almeno non pioveva a vento. Quelli sotto al gazebo stavano all’asciutto. I pugili sul ring avevano le ciglia zuppe, non inquadravano l’obbiettivo. Witt, col volto gonfio, tentò qualche colpo. L’ostinatezza di chi sa che non può perdere, per il bene della razza. Per il bene del Reich. Johann schivò spostando il tronco, elastico. Sgrullò la testa, allontanando il ricciolo ribelle tra gli occhi. Ora inquadrava Witt. Sembrava un cieco, il sangue rappreso sulle ciglia e l’acqua lì incastrata non gli facevano vedere bene la situazione. Solo movimenti. Ma l’incontro era quasi finito, mancavano una manciata di secondi. Gipsy lo colpì con una grandinata di colpi. Zingaro campagnolo. Miserabile figlio di circensi e giostrai, di musicanti e nomadi. Pugile ballerino. Sporco zingaro. Ladro e mendicante. Fenomeno da baraccone. Scimmia. Ballerina. Un colpo per ogni insulto che aveva incassato nel corso della sua vita solo per le sue origini. Non aveva mai dovuto dimostrare niente a nessuno, ma quelle parole si attaccavano ai vestiti come polvere e il pensiero di uno diventava quello di molti. Gente che l’aveva giudicato ancora prima di cercare di conoscerlo. Gente che non guardava oltre il colore della pelle e dei lineamenti, non riuscivano a tagliare i confini della somiglianza. Gente che lo aveva giudicato solo a causa della sgradevole etichetta che si era ritrovato attaccato. Non aveva scelto lui di essere zingaro, non era colpa di nessuno. Lui aveva scelto di non essere come quelli che rubavano, aveva scelto di diventare pugile e uscire allo scoperto dalle ombre dei sobborghi. Alla fine Johann glielo assestò il colpo della buonanotte. Il montante sinistro, micidiale, lo mandò addosso alle corde, il gigante rimbalzò e cadde carponi. Il round era finito. I due pugili ai rispettivi angoli. «Bravo, hai vinto.» gli sorrise Leyendecker. Zuppo pure lui. I capelli grigi attaccati alla testa. Zirzow era una statua di sale. La cintura non c’era. I giudici, l’arbitro e quello delle camicie brune si confrontavano. Di solito in caso di vittoria schiacciante il verdetto non si faceva attendere. Eppure… Richiamarono gli atleti sul ring. Otto Griese al centro. «L’incontro è stato giudicato come no contest, il titolo non è assegnabile.» Il silenzio totale, interrotto solo dal ticchettare della pioggia incessante sui teli dei gazebi. L’occasione della vita, il titolo, il riscatto. Johann li vide scivolare via. No contest. L’incontro non era valido, come se non fosse stato disputato. Non contava niente. Non sarebbe apparso nei record. Il tempo sembrò fermarsi. Il mondo attorno a lui farsi offuscato. Conosceva la follia nazista, solo che non si aspettava che avrebbero negato l’evidenza di fronte a tutta quella gente. No contest. Trollmann con la bocca spalancata dallo stupore, Zirzow e Leyendecker paralizzati, Witt sorpreso da quel verdetto chiaramente disonesto, Frieda ammutolita. I pugili vennero mandati nei rispettivi spogliatoi. Zirzow faceva avanti e indietro per il ring, imprecava, urlava e minacciava, totalmente fuori di sé. Poi si fece mostrare i cartellini dei giudici, e tutti segnavano Trollmann come vincitore. Johann Trollmann, venticinque anni, pugile professionista, candidato al titolo nazionale per i pesi mediomassimi. Zingaro. Era nello spogliatoio, la faccia tra le mani e una coperta sulle spalle. I ricci che gocciavano acqua sul pavimento. Era solo. Piangeva sommessamente, le labbra umide erano ammorbidite dalle lacrime. Era la sua grande opportunità, il suo schiacciante riscatto. Aveva vinto e non volevano assegnargli il titolo. Si accorse che quella gente non si fermava davanti a nulla: regole, lealtà, giustizia, tutto calpestato. Non poteva diventare campione tedesco, pur avendo la stoffa per diventare campione d’Europa come dimostrò contro Roth. Alla porta bussò Frieda, timidamente. «Ehi.» sussurrò. Rukeli alzò gli occhi su di lei. Grondava d’acqua, era appena entrata all’asciutto. I capelli fradici, la camicia bagnata che si attaccava alla pelle. Si passò la mano sul viso, asciugandosi distrattamente le lacrime. «Vieni qui, per favore.» Si avvicinò titubante. L’avvolse nella sua coperta. Non era bagnata, si era asciugato prima di coprirsi. Si appostò dietro di lei. Prese un asciugamano dal suo borsone sportivo, lo avvolse intorno ai suoi capelli biondi e li tamponò. «Non ti hanno dato nemmeno un ombrello, mi fanno incazzare come una iena. Così ti ammalerai.» sussurrò, strofinando delicatamente quella chioma d’oro nell’asciugamano. La voce impastata dal pianto. «Johann, andiamo fuori.» mormorò. «E perché dovrei? L’incontro non è valido. Ho vinto e non mi assegnano il titolo. Sai perché? Sai che effetto farebbe se uno zingaro vincesse il titolo di campione di Germania nel pugilato, sport amato dal cancelliere?» Frieda non riuscì a dire nulla, sentendo che la voce di Johann veniva nuovamente spezzata da un singhiozzo. Lui si andò a sedere di nuovo sulle panche, il viso tra le mani e le spalle scosse dal pianto. Non l’aveva mai visto così. Il cuore le si strinse in una morsa di dolore. Lui che era sempre così ottimista e giocherellone, stava piangendo come un bambino e nonostante cercasse di mantenere una certa dignità, non riusciva a trattenersi. Una lacrima rigò il viso di Frieda, consapevole di quanto importante fosse per lui quel titolo e quella vittoria. Si avvicinò piano, gli passò le mani tra i capelli e lo strinse a sé. Johann affondò il viso nel petto della ragazza, e si lasciò andare alle sue lacrime senza più curarsi della dignità che tentava di esibire di fronte a lei. Doveva spurgare tutto la tensione del momento, tutte le cattiverie gratuite che aveva subìto nel corso degli anni solo per la sua etnia. «Io sono orgogliosa di te e di tutto quello che hai fatto.» Dopo interminabili momenti, Zirzow entrò furioso dentro lo spogliatoio. Fece allontanare Frieda con un’occhiata truce. Afferrò il pugile e fece uscire un Trollmann disperato, sotto la pioggia, e lo costrinse a salire di nuovo sul ring. Il manager aveva distribuito alla folla i cartellini dei giudici, che davano lo zingaro come vincitore. Il gerarca e presidente della Federazione Pugili Tedeschi, Georg Radamm, era rosso di rabbia. Era lui che aveva fatto portare via la cintura, lui aveva deciso il no contest. La folla era in rivolta: erano volate lattine, scatole di mentine per l’alito, persino una scarpa. Ma non tra di loro. Erano furiosi con i giudici e le camice brune, tutti gli oggetti che erano volati erano finiti su di loro. Johann lasciò il suo corpo fluttuare nelle onde di quel momento. Il tempo dilatato. Vedeva i volti, uno ad uno. Uomini furiosi che inveivano contro i truffatori, donne che si accanivano. Era per lui tutta quella solidarietà. Il pubblico, il suo pubblico, amava la boxe a prescindere dalle origini di chi saliva sul ring. Amavano lui, amavano lo zingaro. E non sopportavano le ingiustizie o gli incontri truccati. Qualcuno salì sul ring. Gente che lo abbracciava, che lo baciava, qualcuno gli alzò le braccia al cielo in segno di vittoria. La commissione sportiva si riunì e in fretta discussero di ciò che era meglio fare. Alla fine, George Radamm e i suoi si avviarono verso l’uscita, per evitare il linciaggio. Il presidente della federazione incrociò gli occhi di Rukeli per un momento, prima di dileguarsi. Griese salì sul quadrato scivoloso. Witt aveva messo l’accappatoio e il cappuccio sulla testa, il viso gonfio, irriconoscibile. Trollmann a petto nudo, i calzoncini bianchi attaccati alle cosce, i capelli ricci attaccati alla cute, il ricciolo ribelle tra gli occhi. La pelle nocciola lucida sotto i lampioni, bagnata dalla pioggia. Gocce d’acqua che scendevano dal naso, dal mento. «I giudici hanno sbagliato il verdetto finale. – annunciò Griese. – C’è stata un’incomprensione.» Il pubblico, che si era quietato, ruggì di nuovo. A bassa voce, battendo i piedi, era cominciato il coro. Ru-ke-li. Ru-ke-li. Ru-ke-li. «E vince il titolo di campione nazionale dei pesi mediomassimi… - marcò ogni parola, enfatizzandola al massimo. – JOHAAAAANN… RUKELIII… TROLLMANN!» Gli sollevò il braccio in aria. La folla esplose. Si riversò sul quadrato, sollevarono Johann tenendoselo in spalla e portandolo come se fosse su una portantina. Il pugile teneva le braccia in aria, il volto verso il cielo. Lacrime di gioia gli rigarono le guance, stavolta, e non sapeva se essere commosso per la vittoria o per la solidarietà e affetto dimostratogli. Lacrime calde come sangue, sofferte, agognate. Persino con la pioggia si poteva capire che il campione stava piangendo. Le donne gli lanciavano baci, qualcuna lo accarezzava mentre passava, gli uomini gli davano pacche sulle spalle e gli urlavano complimenti. Gli avevano lanciato una ghirlanda di fiori al collo, e altrettanti petali e fiori bagnati di pioggia venivano lanciati sul pugile per festeggiarlo alla grande. Gli avevano dato la cintura, il suo nome inciso sopra. Aveva avuto il suo riscatto, come gitano e come pugile “ballerino”. Aveva dimostrato una volta per tutte di valere qualcosa, di essere al pari dei pugili ariani. Era uscito dall’ombra dei sobborghi poveri e li aveva affrontati tutti guardandoli negli occhi, senza paura, da uomo. Aveva vinto. Johann Trollmann era immortale, in quel momento più che mai. Lo zingaro aveva vinto sul ring degli ariani. 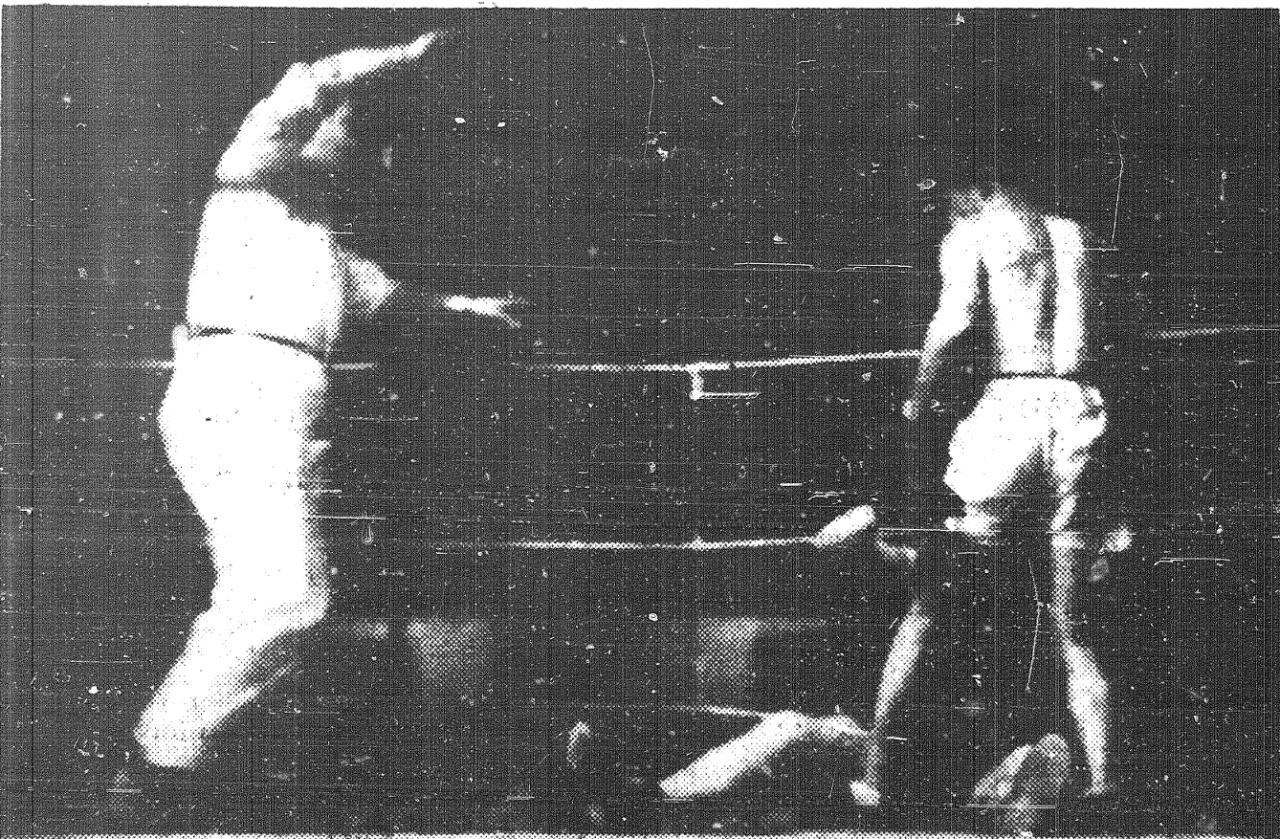 Otto Griese conta il knock-out. Johann Trollmann è in piedi, Adolf Witt a terra. 9 giugno 1933, Birreria Bock, Berlino. Incontro per il titolo nazionale, categoria mediomassimi. |
Capitolo 14
*** 1.14 - Icaro ***
14. Icarus
In un momento di calma prima dei festeggiamenti, Johann era risalito sul ring dove erano rimasti Leyendecker, Zirzow e Frieda. Dopo aver saltato le corde, aveva raggiunto la ragazza. L’aveva presa per i fianchi, le mani ancora fasciate, e l’aveva tirata su facendola girare. Lei aveva posato la fronte sulla sua, tenendogli il viso con le mani. «Sono così orgogliosa di te.» gli sussurrò. Lui aveva baciato avidamente quella ragazza che tanto lo amava, che tanto lo aveva supportato in ogni momento fino ad allora. Avrebbe voluto ripagarla in ogni modo possibile del suo amore e della sua solidarietà incrollabile. Avevano festeggiato alla birreria per il resto della serata. Scorrevano fiumi di birra, cibo a volontà. Johann andava a sedersi al tavolo con i suoi sostenitori, girando come una trottola per tutta la sala della birreria Bock. Stava un po’, parlava con loro, e poi passava al tavolo successivo. Alle tre del mattino, tutti tornarono a casa. Johann e Frieda si lavarono, lei gli pettinò i capelli umidi e si arrotolò le ciocche ricce intorno alle dita. Una volta in camera, la ragazza fece l’imitazione di Witt e di Radamm, poi la caricatura di Rukeli saltando sul materasso, mentre il campione batteva le mani e non aveva più fiato per le risate. «Avevi un futuro da comica e cabarettista!» Poi l’aveva attirata a sé. L’aveva baciata lentamente, accarezzata su tutto il corpo e spogliata con calma. Avevano fatto l’amore con tenerezza intensa e abbandono totale. A godere di lei e lasciarsi cullare dalla gioia del trionfo, dimenticando tra le sue braccia tutto il veleno che aveva ingoiato. Il giorno dopo, tutti si beccarono febbre ed influenza. «Alla fine ti sei ammalata pure tu, li prendo a schiaffi quei due.» aveva borbottato Johann, vedendo Frieda tossire e soffiarsi il naso. Lei gli aveva rivolto un’occhiata divertita e l’aveva rabbonito con un bacio tra i capelli. Una volta guarito, circa due giorni dopo, venne invitato in ogni dove. Programmi radiofonici, interviste per riviste, servizi fotografici, pubblicità, incontri galanti. Era un divo. Lo specchio gli restituiva finalmente l’immagine del campione. Si era sentito il re del mondo, gli sembrava d’aver toccato il cielo con un dito. Aveva raggiunto l’apice della sua carriera, del successo, della fama, della gioia. Non poteva saperlo che era il punto più alto di una discesa ripida. Perché così era: più si sta in alto, più la caduta fa male. Un martire divorato dalla bestia nera. Il ring sarebbe diventato la sua collina del Golgota[3]. * * *
Di recente era uscito con Kaspar. L’amico gli aveva chiesto di vedersi in un bar, dopo pranzo, per prendere un caffè. Quando era entrato, sembrava agitato. «Vuoi sposarmi e cercavi un posto tranquillo per dirmelo?» lo incalzò Johann, alzando un sopracciglio e il sorriso di sfida. Era seduto al bancone, la camicia bianca a maniche corte e i pantaloni beige. Il berretto piatto appoggiato alle gambe, una sigaretta che pendeva dalle labbra carnose. La cameriera che lo guardava di continuo, le guance rosse. Kaspar gli lanciò un’occhiataccia, si sedette vicino a lui e si accese una sigaretta. Non era aria di scherzi. Johann sbuffò il fumo dal naso, cercando di assecondare l’umore dell’amico. «D’accordo, ricominciamo. Come va?» «Hans se n’è andato.» «Dove?» Kaspar alzò le spalle possenti. «Immagino Francia. Forse Inghilterra. – lasciò cadere un cilindro di cenere nel piattino di vetro. – Non gli è rimasto più niente qui, da quando gli hanno proibito di boxare.» «E Margarete?» «Lo ha lasciato. Aveva paura che potessero farle qualcosa, visto che lui è ebreo. E l’ha lasciato.» Johann alzò le sopracciglia. «Come l’ha presa Hans? Hai avuto modo di parlarci?» «La capiva. Non la biasimava. – scosse il capo. – Conosco Hans da quando eravamo piccoli, Johann. È mio fratello. Fa male vederlo solo, che va via da solo e triste, privato di tutto. Gli hanno portato via la boxe, l’amore. Sta cercando di restare un uomo libero.» Gli tornarono in mente le parole di Leyendecker. Le parole di Seeling. Sentì montare la bile. Quella notte non riuscì a dormire. Era agitato. Hans. Seeling. Leyendecker che gli diceva di andarsene. Le nuove disposizioni per il pugilato, il Faustkampf. Il titolo. Non sarebbe durato molto. Gliel’avrebbero tolto. Lo sapeva. Cosa ne sarebbe stato di lui, dopo? Era rimasto solo per quello. Lui era solo quello. Sapeva fare solo questo. Frieda, vicino a lui, dormiva sulla schiena e il volto girato dall’altro lato. I piedi che si sfioravano. La guardò. Come avrebbe potuto renderla felice se non rendeva felice nemmeno sé stesso? In quella Germania che si divideva e sbriciolava, come avrebbero fatto loro due a sopravvivere? Erano due diversi. Voleva accarezzarla, ma per la prima volta ebbe paura di toccarla. Il tempo. Avrebbe estirpato anche il ricordo del suo viso. * * *
17 giugno 1933 Era in palestra quel giorno. Paul Schubert era andato a trovarlo a Berlino. Johann lo aveva portato al Der Blume per fargli conoscere qualcuna delle graziose cameriere, colleghe di Frieda. Erano tutte belle, deliziose, con gli occhi truccati e i sorrisi gentili. Non aveva trovato nessuna che gli piacesse, aveva arricciato il naso. Il campione l’aveva guardato come si guarda un folle. Il giorno dopo erano andati in palestra e si allenavano come sparring partner. Leyendecker e Zirzow che bevevano i loro caffè seduti su una panca. Ivan che si allenava al sacco, Kaspar al sacco veloce. Frieda e Gilda sedute ad una delle panche vicino la segreteria, parlavano. A Frieda piaceva Gilda, era una ragazza per bene. Con i suoi capelli biondissimi, corti fin sotto le orecchie, le labbra carnose, il mento piccolo, gli occhioni marroni che sembravano spaventati da tutto. Era ingenua, innocente, una ragazza devota, l’anima delicata. Le stava raccontando come si era conosciuta con Kaspar. Lui era il suo vicino di casa. La notte che aveva sfuriato, il motivo per il quale la porta sul retro della palestra restava aperta di notte, lei si era indispettita. Gli aveva bussato alla porta, gli aveva detto di smetterla perché voleva dormire. Lui le aveva urlato contro così forte d’averla spaventata. Era rientrata in casa si era messa a piangere. Poco dopo, lui aveva smesso di fare baccano ed era andato a chiederle scusa. «Ma pensa, che carino.» aveva commentato Frieda senza particolare trasporto. Gilda, innamorata persa, aveva sospirato con aria sognante. L’addetto alla segreteria si chiamava Gunter. Era appena rientrato nella palestra. Era uscito per raccogliere delle lettere. La maggior parte erano per Zirzow, qualcuna per Leyendecker. I due si avvicinarono alla segreteria per dare un’occhiata, ognuno alle sue. Una, però, era indirizzata a Johann Trollmann. Dalla Federazione Pugilistica Tedesca. Il vecchio allenatore sentì un peso nello stomaco. Chiamò il suo campione. Rukeli si avvicinò. Alto, maestoso. Il sudore a rendere lucida la pelle d’ambra. Rivoli di sudore che percorrevano gli addominali, la schiena, e finivano nell’elastico dei pantaloncini blu perfettamente tesi sui fianchi. Strappò la busta della lettera, estrasse il foglio. Tirò forte su col naso, espirando dalle labbra. Quasi a riprendere fiato. “Con la presente, si informa che il titolo di campione nazionale dei pesi medio-massimi disputato alla birreria Bock il giorno 9 giugno 1933 alle ore 21:00 tra i pugili professionisti Adolf Witt di Kiel e Johann Trollmann di Hannover, e consegnato a quest’ultimo, è stato revocato.
La revoca è dovuta alla condotta anti-sportiva tenuta dal pugile Trollmann durante l’incontro e dall’insufficienza di prestazioni da parte di entrambi. Pertanto, il titolo resterà vacante fino a data da destinarsi.” Lo sapeva. Se lo aspettava. Solo che non pensava così presto. Erano passati solo otto giorni. Passava gli occhi torbidi sui contorni delle lettere scritte a macchina. Revocato. Non sapeva bene come reagire. Emozioni forti, che chiedevano reazioni contrastanti. Non staccava gli occhi dalla lettera. Le sopracciglia aggrottate, come se fosse concentrato, le labbra strette. Leyendecker vide i muscoli tesi sotto la pelle, la mascella serrata. Gli occhi del lupo. Li conosceva bene, ormai. Qualcosa non andava. «Cosa dice?» domandò Zirzow, accendendosi la pipa. «Leggi tu stesso.» Era così orribile che non voleva nemmeno crederci. Conosceva la follia nazista, ma non credeva che sarebbero arrivati a tal punto. Il Reich, con quella revoca, stava dimostrando solo un assaggio di tutto il suo potere. Lo zingaro cercò gli occhi dei tre presenti, ma solo quelli di Frieda erano lì per lui, lucidi per le lacrime. Non voleva crederci nemmeno lei. Gli occhi di Zirzow e di Leyendecker si aprirono poco a poco, man mano che le parole si susseguivano nella lettura. Non dissero niente. «Cosa vuoi fare ora?» gli chiese il manager, alla fine. Johann accennò a un sorriso amaro. «Cosa mi rimane da fare?» «Io.. Io cercherò qualcosa, mi darò da fare, smuoverò un po’ le acque. Potresti avere un’altra occasione in futuro.» Non riuscì ad apprezzare la buona volontà e l’ottimismo di Zirzow. Gli saltarono i nervi. Tutta la calma che aveva tenuto fino a quel momento, precaria, esplose. Lo sguardo nero mutò d’improvviso. Non c’era più niente di umano in quegli occhi profondi. Brillavano selvaggi e pericolosi, un predatore a caccia. Il naso arricciato, come quello dei lupi quando ringhiano. Il mento incassato. Zirzow indietreggiò, una mano avanti come a volersi proteggere. «Hanno mandato via Hans, hanno mandato via Seeling. – ringhiò. – Non me la darà nessuno una cazzo di altra occasione, perché se non l’hai notato sono uno sporco zingaro. Non c’è posto per gli zingari nella boxe, nel Faustkampf.» sputò quel nome come se fosse veleno. Appallottolò la lettera della Federazione, la lanciò dall’altro lato della palestra in un moto furibondo. «Me l’hanno fatto capire in mille modi. Uno zingaro non può boxare. Vogliono vedermi rinunciare al mio stile, perché gli dà fastidio. “Troppo veloce, Trollmann, troppo danzante, prendili due pugni qualche volta”. Vogliono vedere uno zingaro combattere come un ariano, che equivale a stare piantato in mezzo al ring come un idiota e farmi prendere a pugni. E mi chiamano ballerino! – mollò un pugno al muro, qualcuno trasalì. – Era il mio sogno, maledizione. Il mio riscatto. Come zingaro, come “ballerino”. Lo guardo scivolare via, ed è orribile perché non posso farci niente per fermarlo, non è neanche colpa mia.» Non ho scelto io di essere zingaro. Mi sono ritrovato addosso quest’etichetta che non ha fatto altro che farmi terra bruciata intorno. Kaspar gli si era fatto vicino, gli aveva dato una pacca sulla schiena. Gilda gli aveva accarezzato un braccio per supportarlo. Leyendecker gli strinse una spalla, un padre che si accinge a raccogliere i cocci rotti del proprio figlio. Come Dedalo, che pazientemente aveva sopportato l’ambizione di Icaro, e infine ne aveva raccolto il corpo bruciato dal sole. Johann aveva giocato col fuoco. Si era bruciato. La sua ambizione, il suo sogno, troppo alto. Fattibile. Ma non nella Germania di Hitler. Fattibile. Ma non se eri uno zingaro. Rukeli non aveva guardato Frieda. Guardava a terra. Ma lei li vedeva, i suoi occhi. Lei lo sentiva. La potenza di quelle emozioni la travolse come un’onda anomala. Sentiva la bile nello stomaco, la saliva farsi acida. Le mancò il respiro. Non riusciva a sorreggerle, erano un fardello pesante che lei si era involontariamente caricata sulle spalle. Lei e la sua maledetta empatia. Respiri profondi per far tornare a circolare l’ossigeno. La palestra avvolta nel silenzio. Poi Johann se n’era andato passando dal retro, senza aspettarla. Leyendecker lo vide andare via. La ragazza con gli occhi di cielo era impietrita, lo sguardo fisso al pavimento. La boxe è magia, pensava l’allenatore. La magia di rischiare il tutto per tutto per un sogno che vedi solo tu, pur sapendo che ti verrà strappato via e ti lascerà sanguinante, senza più niente. I campioni si formano da dentro, da questi sogni e da questi progetti. Senza di essi, non si è più campioni. Cosa ne sarà di te ora, ragazzo mio? Il mondo gli era caduto addosso. Era tornato a casa solo per cena. Frieda dormiva sul divano, si era addormentata mentre leggeva un libro. Dall’aspetto della cucina, intatto, Johann dedusse che la ragazza non aveva nemmeno mangiato. Non c’erano piatti nel lavandino, né pentole sul fuoco, né la tovaglia ad apparecchiare. Solo lei distesa sul divano, piccola e addormentata, con un libro sul petto. Le guance lucide, rigate di lacrime. I dolori del giovane Werther. Johann Wolfgang von Goethe. Il preferito dello Johann pugile. Si era seduto su una delle sedie intorno al tavolo, il mento poggiato sul pugno serrato. Le nocche ferite dai pugni al muro, ai tronchi degli alberi. Ferite che non voleva veder rimarginate. Così, ogni volta che si guardava quelle maledette mani capaci solo di dare pugni, si ricordava che non doveva più volare in alto. Aveva fatto la fine di Icaro. Così imparava la lezione: uno zingaro non poteva essere ambizioso, non poteva volare. Forse era la volta buona che qualcuno gli aveva messo apposto quella testa dura. Solo pochi giorni prima era invitato in ogni dove: galà, servizi fotografici, pubblicità, programmi radiofonici. Era il campione. Era il re di Germania. Il re del ring ariano. Ora gli restavano solo mani ferite e occhi vuoti, senza ambizione. Rassegnati alla consapevolezza di appartenere ad un’etnia senza vincenti, consacrata ad una vita da vinti. Non avere ambizioni e il cuore colmo di passiva rassegnazione. Era quello morire. «Dovremmo fare qualcosa per quella mano.» mugugnò la voce di Frieda. Si stropicciò gli occhi, asciugandosi le guance umide. Il viso fra le mani. «Sto bene.» «Potremmo aprire un dibattito in merito.» replicò, atona. «Ti preparo qualcosa da mangiare?» «No.» Quand’era tornata a casa aveva infilato la testa nel gabinetto e aveva rigettato tutta la negatività. Non se la sentiva di mettere qualcosa nello stomaco. La bile minacciava di risalire. Si era messa a leggere sperando che questo la distraesse. E si era attivato un altro meccanismo di difesa: il sonno. Ogni volta che “assorbiva” la negatività da qualcuno, stava malissimo: pianti disperati, poi vomito e infine cercava di difendere sé stessa con il sonno. Lui lo sapeva che lei reagiva male alla negatività, conosceva la sua empatia quasi medianica. Johann aveva fatto un cenno d’assenso col capo. Si era alzato e si era andato a fare una doccia. Lei era rimasta lì, seduta. I piedi sul pavimento fresco, il libro chiuso sulle gambe, la faccia tra le mani. Poco prima che Johann uscisse dalla doccia, lei si era infilata sotto le coperte e si era addormentata di nuovo, sdraiata su un fianco. La schiena rivolta alla zona del letto destinata al suo campione. Rukeli era entrato nella stanza in penombra, illuminata solo dalla lampada sul comodino. L’asciugamano avvolto intorno alla vita, un altro sulla testa. Infilò i pantaloncini vecchi che usava come pigiama e una canottiera bianca. Si strofinò la testa per asciugare quei ricci, non ci prestò molta attenzione. Dietro e ai lati i capelli erano tagliati leggermente più corti. Sopra restarono umidi, ma non gli importava. Si infilò sotto le lenzuola, sdraiato di schiena. Frieda che gli dava le spalle. Il respiro leggero. Non riusciva a pensare a niente. Quella notte il suo sonno fu tormentato. Infestato da incubi. Johann che combatteva le ombre, loro che vincevano. Lui che si contorceva sul ring insanguinato. Poi un campo spoglio, circondato da filo spinato. Neve che si andava a sciogliere, l’aria frizzante di primavera che puzzava di carne bruciata e morte. Le ossa sporgenti che graffiavano la pelle, scapole fuori dalla schiena come ali d’angelo mozzate. Cadaveri accatastati, putrefatti o quasi. Neuengamme. Wittenberg. Quel sogno puzzava come una premonizione. Puzzava di futuro. «Johann!» Mani che lo afferravano e lo trascinavano nel ventre della terra. «Johann! Svegliati!» Frieda che lo scuoteva per le spalle. Johann prese fiato, scattando a sedere. Il sudore che lo ricopriva come una patina lucida. Gli occhi della donna che amava. Il cielo infinito. «Era solo un incubo.» sospirò, piano. Ma non ci credeva fino in fondo. Quel sogno… era una premonizione, non era solo un incubo. Se lo sentiva nelle ossa. Lei annuì, lentamente. Le dita stringevano le lenzuola bianche. Lui si accorse che c’era la luce del comodino accesa. Guardò la sua Frieda. Gli sembrò un cerbiatto perso nel bosco del lupo. Spaesata e spaventata. Era solo un incubo. Solo uno stupido incubo. «Sto bene, sul serio. Era solo un incubo.» mormorò, più dolce. Accennò un sorriso stanco, si sdraiò di nuovo, cercando di rilassare i muscoli. «Johann.» «Dimmi.» “Sto bene”. «Non mentirmi.» Lui restò in silenzio. Frieda gli si avvicinò, titubante. Per la prima volta, non sapeva come avesse reagito il campione ad un contatto con lei. Si teneva su con il gomito. Gli posò una mano sulla guancia, lo vide chiudere gli occhi come se gli facesse male. Lacrime calde gli rigarono il viso. Lei le baciò via. «Ti amo, Johann. – gli confessò per la prima volta, il cuore in mano, la fronte posata sulla sua. – Ti amo da morire. Voglio che tu lo sappia, e voglio che tu sappia che non ho intenzione di abbandonarti perché sei un sinti o chissà cosa. Non ti amerò di meno per le tue origini o per la tua carriera. Resterò al tuo fianco fino a che vorrai.» Non le rispose, non le disse niente. Aveva aggrottato le sopracciglia, le labbra strette. Come se soffrisse. E le lacrime continuavano a scendere copiose, senza che lui emise un solo singhiozzo. Frieda si sdraiò, lo attirò a sé. Johann affondò il viso nel suo petto. Lei che gli accarezzava i ricci neri, lui che la stringeva come se tutto il mondo stesse per scomparire tranne la ragazza. La sua ancora di salvezza. Il suo unico punto fermo in quell’uragano che gli stava portando via ogni certezza. Si addormentò. Non sognò nient’altro. Dormì sereno e profondamente per il resto della notte tra le sue braccia. * * * Box-Sport, edizione del 19 giugno 1933 – Trollmann contro Witt, 9 giugno ’33. Gli amici di Trollmann, che ritenevano le corse sul ring e i punti del loro uomo, degne di un campione, hanno mostrato un’enorme resistenza e hanno torturato le loro corde vocali in maniera mostruosa. Zirzow, il manager di Trollmann, sfrecciava come un piccolo razzo intorno al ring, parlava con labbra tremanti, era una volta qui e una lì, poi improvvisamente appariva riportando dallo spogliatoio Trollmann che piangeva. La commissione sportiva ha rovesciato la decisione dei giudici e dell’arbitro, e proclamato Trollmann nuovo campione tedesco dei mediomassimi! Purtroppo non ci si può far nulla! Se si giudicava Trollmann qualificato da un punto di vista puramente sportivo per un incontro di campionato, si doveva sapere che con Trollmann sono sempre possibili sorprese sia dal lato positivo sia dal lato negativo. Lo zingaro è un pugile istintivo, che segue il suo stato d’animo, e che con il suo saltellare sul ring alle volte devia fortemente da una linea sportiva. Spesso si può anche passar sopra alle mancanze di serietà nella sua boxe. Ma se in gioco c’è un incontro per il titolo, allora si corre il pericolo che il valore intrinseco di un titolo venga sminuito dallo stile particolare di questo pugile istintivo. La Federazione pare aver compreso il rischio corso a lasciare il titolo a Trollmann. Il verdetto dell’incontro Heinrich Trollmann-Adolf Witt del 9 giugno nella Bockbierbrauerei per il titolo di campione tedesco dei pesi mediomassimi viene sospeso e il combattimento viene dichiarato no-contest a causa delle prestazioni insufficienti dei due pugili. Il titolo è di conseguenza libero. La commissione annuncerà la data del prossimo incontro. Johann l’aveva strappato a metà e aveva lanciato le pagine trinciate in mezzo alla strada. Si era andato ad allenare al sacco veloce, sfogando la tensione. Si era chiesto cosa ci facesse ancora lì, in quella palestra, se ormai non valeva più la pena di combattere. Non aveva più niente da inseguire. Era un ragazzo zingaro che tirava pugni ad un sacco veloce senza nessun tipo di ambizione. Leyendecker gli era andato vicino, non si erano detti niente. Si erano guardati negli occhi per interminabili momenti, la mano dell’allenatore stretta sulla spalla del suo campione. Gli aveva fatto da padre in quegli anni, lo aveva costruito mattone dopo mattone. Aveva fatto uscire il talento, facendolo esplodere come dinamite. Aveva fatto della promessa vacua, un campione. E ora vedeva il suo operato sgretolarsi. Il lavoro di quasi cinque anni cadere in pezzi sotto i colpi di un avversario incrollabile. Il campione che aveva costruito incassava i colpi bassi di un nemico intangibile e troppo potente. Era stato difficile per Johann tanto quanto per Leyendecker. Quello sguardo e quella mano stretta sulla spalla ne erano la prova. Solidarietà ed empatia. Come era venuto, se n’era andato. Volatilizzato verso alcuni nuovi arrivi. Poi era entrato quell’omino panciuto. La faccia grassa, rotonda, il parrucchino nero perfettamente gelatinato alla moda dei nazionalsocialisti. I guanti bianchi sulle mani paffute, gli occhietti piccoli e neri come biglie. Si era rivolto al buon vecchio Gunter, alla segreteria, e aveva chiesto di Zirzow e Leyendecker. Il manager si era materializzato lì vicino, come sbucato dalle assi del pavimento. La pipa tra le labbra, le mani sui fianchi. Aveva urlato all’amico allenatore di raggiungerlo. Johann si era fermato, interessato. Aveva guardato la situazione da lontano. Poi loro gli erano passati davanti. L’omino panciuto guardò lo zingaro. Si bloccò di colpo. «Lei deve essere Gipsy Trollmann!» Johann alzò un sopracciglio, squadrandolo dall’alto in basso. Era l’unico pugile zingaro della Germania. Chi altro poteva essere? «Giusto di lei dobbiamo parlare. – continuò. – Credo sia giusto che lei venga con noi.» Afferrò un asciugamano e se lo passò sul petto, sulla nuca, sulle spalle. Li seguì nell’ufficio malandato di Leyendecker. L’omino panciuto si accomodò sulla sedia lì di fronte alla scrivania. Zirzow a braccia incrociate vicino a lui, l’allenatore dietro il tavolo con i fogli sparsi e calendari segnati da tratti di matita. Alle pareti, le foto del pugile che era stato. E qualche foto con Zirzow da giovani. L’omino panciuto era uno delle camice brune. Avvocato e notaio di Berlino, si chiamava Hans-Joachim Heyl. Nello specifico, era il nuovo presidente della commissione ed era lo Sturmbannführer delle SA, le squadre d’assalto che fissavano muti gli incontri di Rukeli, e delle Waffen-SS. Le SS combattenti. Era questo ciò che adombrava lo sguardo di Zirzow. «Possiamo fare qualcosa per lei, signor Heyl?» «Ci saranno diverse sanzioni per voi che avete sostenuto la vittoria del pugile, ma verranno ufficializzate a luglio. – andò dritto al punto. ─ Si è discusso molto del ragazzo, in questi giorni. La revoca del titolo resterà tale, su questo ci siamo trovati tutti d’accordo. Ma pensavamo che fosse il caso di farlo combattere di nuovo.» Leyendecker e Trollmann si scambiarono un’occhiata fugace. Zirzow sbuffò il fumo della pipa, lo sguardo sottile, indagatore, come quello di un rapace. «Cosa propone la Federazione?» «Un incontro per risollevare il morale dell’ex campione, spronarlo a continuare. Mi spiego? L’incontro non varrà per il titolo.» «Quando? Contro chi?» «Quando c’è da deciderlo, Herr Zirzow. Dipende se il ragazzo accetta o meno. – un sorriso affabile che nascondeva le zanne. – Contro Gustav Eder.» Eder era un peso welter, campione nazionale di quella categoria. Era un osso duro, e questo Trollmann lo sapeva. Facendo un rapido calcolo, tra un peso welter come Eder e un mediomassimo come Trollmann, dovevano correre circa otto chilogrammi. Non solo, l’avversario non vantava particolare altezza. Probabilmente, la differenza era di una decina di centimetri. Per questo Eder era un pugile che boxava secondo lo stile dell’aggressore, nella guardia, entrava da sotto. Era pericoloso, ma poteva gestirlo. «Per amor dell’onestà, dovrò far presente al ragazzo che sono state stabilite alcune regole che dovrà seguire durante il corso del match.» Johann arricciò il naso, poteva già immaginare a quali regole si riferisse. Non gli piaceva come quel tale parlava di lui. Non lo chiamava neanche per nome, come se fosse peccato e gli si bruciasse la lingua solo pronunciandolo. «Non dovrà accennare alle sue… “danze”. Non dovrà in alcun modo muovere le gambe, né abbandonare il centro del ring. Per ultimo, dovrà tenere la guardia bassa.» «Credo d’aver capito. – annuì. – Devo combattere da vero tedesco, giusto? E nel farlo devo perdere. A questo punto non preferireste un sacco da boxe?» si lasciò sfuggire il diretto interessato, con acidità. Zirzow lo fulminò con un’occhiata truce. Heyl scoppiò in una risata controllata, il retrogusto astioso. «Mi creda, Trollmann, il pubblico la adora. Non lo deluda un’altra volta. – si schiarì la voce. – L’avviso che se solo accennerà ad infrangere una di queste regole, saremo costretti a ritirarle la licenza di pugile professionista. E se queste motivazioni non dovessero bastarle… lo faccia per la sua famiglia.» [3] Collina del Golgota. Il luogo fuori Gerusalemme su cui, secondo la Bibbia, fu crocifisso Gesù Cristo. _______________________________ Eccoci qui! Quattordicesimo capitolo. Per chi è Cristiano, vorrei avvisarvi che farò alcuni riferimenti biblici, come la collina del Golgota, nel corso della storia. Non voglio risultare blasfema, e mi scuso, ma i sinti di Germania (in particolare quelli di Hannover) videro in Rukeli una sorta di angelo, di vittima sacrificale sul'altare del Nazismo. Per loro il suo gesto di ribellione (che vedremo presto) e la sua figura in sé, hanno assunto un che di religioso. Poi i sinti, così come altre etnie rom, sono molto religiosi. Tengo a ricordare che Box-Sport storpiava tutti i nomi, e quindi Johann divenne "Heinrich", così come altri pugili come Schmeling si ritrovarono il nome storpiato. Fatemi sapere cosa ne pensate, che mi fa piacere ♥ Alla prossima! ♥ |
Capitolo 15
*** 1.15 - Il lupo tra i leoni ***
15. Der Wolf unter den Löwen
Johann che sfuriava in palestra. Che prendeva a pugni il muro senza fasce e senza guanti. Johann che spaccava l’intonaco e sbriciolava i mattoni della parete. Kaspar che lo teneva fermo cercando di bloccargli le braccia. Lo zingaro che se l’era sgrullato di dosso come se fosse polvere. Un ultimo pugno al muro, messo male, gli fece prendere una storta al polso. Le nocche livide, rosse di sangue, la pelle squarciata. Leyendecker che gli portava un secchio col ghiaccio e bende per medicare le nocche. Zirzow spiegò la situazione a Kaspar, che si era visto l’amico sfuriare e prendersela con le pareti della palestra dopo che l’omino panciuto era uscito. Johann con le mani infilate nel ghiaccio, rossastro dal sangue. La testa china, il secchio tra le gambe divaricate. «Non ci devi andare, Johann.» gli disse Zirzow. «Sarà umiliante. – aggiunse Leyendecker. – Ritirati, non lasciarti umiliare così, ragazzo. Puoi andare via dalla Germania, come hanno fatto Hans, Schmeling, Seeling. Costruirti una nuova carriera all’estero.» Ci stava riprovando. Lo doveva salvare. «No.» rispose, inflessibile. «È una trappola, ma possibile che non lo capisci?» «No, sei tu che non capisci. – alzò gli occhi su di lui. – Io ci voglio cascare in questa trappola. Ma non come dicono loro. Ci cadrò, ma come dico io.» Gli occhi di Johann. Brillavano di rabbia, selvaggi e indomabili. Leyendecker riusciva a percepire il battito del suo cuore sinti, il fuoco scorrergli nelle vene sotto la pelle d’ambra. Vedeva in lui la determinazione di un uomo che non riusciva a sottostare alle regole dei gagé, di un uomo che portava sul ring l’orgoglio di un popolo intero; un uomo fiero, che restava stoico in ogni situazione… come un albero. Lo capì: capì che Rukeli non si sarebbe piegato ai nazisti, che avrebbe sempre trovato un modo di protestare o ribellarsi se gli si fosse presentata l’occasione. Anche se ha torto marcio, anche se sa che insistere lo porterà alla rovina, se non tiene il punto fino alla fine… si sente perduto. Aveva lasciato appesa la discussione a questa promessa. Nessuno cercò di convincerlo a non salire sul ring di Eder. Con Witt avevano cercato di fare propaganda sfruttando la differenza elevata tra peso e altezza dei due. I lineamenti nordici di Witt, da puro ariano, con le sue caratteristiche da vero pugile tedesco. Uno dei migliori che meglio incarnava l’ideale del Deutscher Faustkampf. Stavolta puntavano ad altro. Puntavano a dimostrare in modo più evidente l’inferiorità dello zingaro. Gli mettevano contro un peso welter: sessantasei chili, sei in meno di Johann; centosettanta centimetri, tredici in meno dello zingaro. Ma avrebbe vinto, era una sconfitta organizzata a tavolino. Un peso mediomassimo più alto della media dei pugili della sua categoria, che si faceva stracciare da un peso welter notevolmente più basso. Una propaganda migliore, per promuovere la pura razza, non esisteva. Sarebbe filato tutto liscio. Rukeli Trollmann cancellato dai cuori della gente e dalle pagine di giornale, la razza zingara messa a tacere di nuovo, ricordando qual è il loro posto. Ai margini. Alla fine avevano chiamato il numero che Heyl aveva lasciato: lo zingaro accettava l’incontro. L’avevano fissato per il 21 luglio, alla birreria Bock. Dove tutto era cominciato. Dove tutto sarebbe finito. Era tornato a casa nel pomeriggio. Da Frieda. In realtà, l’aveva incontrata sotto il portone. Era appena tornata anche lei. Gli aveva fatto un gran sorriso, che lui non era stato in grado di non ricambiare nonostante il pessimo umore. «Dove sei stata?» le chiese, appendendo il cappello sull’attaccapanni. Lei indicò il sacchetto della spesa con la testa. «Al mercato.» Cominciò a sistemare il contenuto del sacchetto. Lui l’aiutò, mettendo a posto le cose nei punti più alti della dispensa. Fu allora che la ragazza notò le mani di Rukeli. Le nocche fasciate. «Non hai niente da dirmi?» «No, perché?» Conosceva Frieda. Si sarebbe caricata le sue emozioni sulle spalle. Sarebbe stata male per lui. Doveva provarci a salvarla. «Ah no? – gli afferrò il polso, tirando su la mano, le sopracciglia inarcate. – Niente?» «Sono caduto, ho strusciato le mani per non sbattere la faccia. – alzò le spalle. – Mi sono anche slogato un polso per questo.» «Sei caduto.» ripeté lei, scettica, le braccia incrociate al petto. Un sopracciglio alzato. Era la prima volta che le mentiva. Come aveva fatto a dire una bugia di fronte a quegli occhi? Si dicono le bugie per proteggere chi si ama. Lui la stava proteggendo da sé stessa, dai suoi crolli emotivi, dalla sua auto distruzione. Annuì, convinto. Lei storse le labbra, squadrandolo. Non indagò oltre, Johann si lasciò andare ad un sospiro di sollievo. Si era accorta che mentiva, conosceva il suo cavaliere nero, e lui lo sapeva. Ma ormai il danno era fatto. Frieda si chiuse in un ermetismo esemplare mentre massaggiava l’impasto del pane sul tavolino. Aveva imparato a farlo. Gliel’aveva insegnato Johann. Lui lo faceva più buono, ma quello della ragazza non era male. Le veniva morbido, la crosta croccante. Rukeli, invece, si era messo a raccogliere i panni stesi fuori dal balcone. Le lanciava occhiate, la studiava da lontano. Era di pessimo umore, ma in qualche modo il mutismo in cui si era chiusa la ragazza lo faceva distrarre. Pensava a come attirare la sua attenzione. Si avvicinò come una pantera al tavolo. «È pronto per essere infornato?» Le chiese, cercando di attaccare bottone. Lei affondò la punta del dito, poi lo portò alla bocca succhiando via i rimasugli d’impasto che le erano rimasti attaccati. «Sì, penso di sì. Opinioni dell’esperto?» lo incalzò, acida. «Anche secondo me è pronto.» «Bene.» «Molto bene.» «Benissimo.» «Ottimo.» Frieda gli lanciò un’occhiata di traverso. Si chinò, mise nel forno la teglia col pane. Poi cominciò a ripulire il tavolo dalla farina e i pezzi d’impasto appiccicati sul legno lucido, sotto gli occhi attenti di Johann. «Che fai, mi tieni il broncio?» «Non ci parlo con i bugiardi.» replicò, distratta. «Non ti fidi di me?» Lei gli lanciò un’occhiata di fuoco. «Non osare rigirarti la frittata come ti pare, Johann Trollmann. Non sono stupida, lo so quando dici le bugie.» sventolava l’indice all’altezza del suo sguardo. Rukeli alzò un sopracciglio. L’afferrò per i fianchi, se la caricò su una spalla come un sacco di patate. «Mettimi giù!» «No.» Le tolse il grembiule di dosso, gettandolo davanti la porta della camera. Scoppiò a ridere alle proteste di Frieda. «Non farmi resistenza.» Tutti i muscoli sul basso ventre della ragazza si contorsero in un formicolio, a quelle parole. «Io non ci parlo con te.» provò a dire. Ma quando lui l’adagiò sul letto, tutte le sue difese crollarono. «Per favore, sii sincero. Cosa è successo?» gli sfiorò le mani, le nocche. Johann, a carponi su di lei. Un ciuffo riccio che scendeva, i muscoli delle braccia tesi, gli occhi improvvisamente cupi e torbidi come petrolio. «Non mi va di parlarne ora.» Anche le sue difese crollarono di fronte allo sguardo di Frieda. Così innocente, così limpido. Knock-out. «Ti fanno male?» «Non quanto vorrei. Ci sono ferite che fanno più male.» «È per questo che non vuoi dirmi niente?» «Anche. – la baciò con dolcezza. – Perdonami.» Lei sorrise, come un gatto che fa le fusa prima di sfoderare gli artigli. «Non capisco il tuo umore. – mormorò, alzando le mani verso il suo viso per accarezzarlo. – Sei triste e arrabbiato, oppure su di giri? Con me sei giocherellone, ma non ti senti allegro.» «Sei pericolosa, amore mio, mi senti troppo.» Si sedette sul bordo del letto, la fece accomodare sulle sue gambe come una bambina a cui bisogna raccontare una storia. Ma Johann non voleva dirle nulla. Le infilò una mano sotto la camicetta, dietro, e le accarezzò la schiena con la punta delle dita. Un tocco rovente, carezze lente, che la facevano impazzire. Sotto i polpastrelli sentiva la sua pelle liscia, la linea della spina dorsale che curvava armoniosa, il solco. Sulla parte bassa della schiena, le fossette di Venere. «Non dovrei?» «Forse no. – ammise lui. – Non in questo periodo. Stai male, ti fai carico di un peso troppo grande. Hai già le tue emozioni, le tue sofferenze, non puoi prenderti anche il mio fardello. Resterai schiacciata.» «Non lo faccio apposta.» sussurrò, accoccolandosi sulla sua spalla. Johann la strinse a sé. «Se potessi comandare questa dote… lo faresti? Ti prenderesti il mio fardello lo stesso? Perché io vorrei non permettertelo.» «Solo se poi tu non lo avresti più.» Lui si mosse nervosamente, senza ben sapere cosa rispondere. «Mi faranno combattere di nuovo.» le confessò, di getto. «Quando?» «Presto. Contro un peso welter.» Frieda lo scrutò attentamente. «E perché la cosa ti preoccupa? Hai abbattuto pesi massimi che pesavano anche quindici chili più di te. Perché un peso welter ti spaventa?» «Perché devo combattere come un cazzo di ariano. – brontolò. – Non posso boxare secondo il mio stile: fermo in mezzo al ring, con la guardia bassa. E quell’Eder è un picchiatore. Chiedono allo zingaro di boxare come un ariano, e perdere pure nel farlo.» Frieda gli si accoccolò con la testa tra la spalla e il collo, toccandogli la schiena poté sentire tutti i suoi muscoli tesi dal nervoso. «Stanno chiedendo ad un’aquila di combattere contro il coccodrillo, ad un lupo di combattere nella gabbia dei leoni.» Johann si morse il labbro inferiore, abbozzando un sorriso amaro. «I leoni saranno pure grossi e pericolosi, ma sono loro che si esibiscono nei circhi, non i lupi. Sono loro i clown del ring, non io.» * * *
Con l’avvicinarsi della data dell’incontro, Johann si era chiuso in sé stesso. Nulla traspariva dagli occhi neri, non una parola di troppo veniva pronunciata. Le discussioni erano diventate monosillabiche, atone. Chi era più vicino al pugile, faticava a riconoscerlo. Lui sempre così allegro, ottimista e chiacchierone. L’allenatore Walter Leyendecker aveva tentato un’ultima volta di far ragionare il campione. Non doveva andare, sarebbe stato umiliante, era una trappola. Johann Rukeli Trollmann aveva ribadito che voleva cadere in quella trappola, gli stava bene. Avrebbe affrontato quelle ombre. Ma a modo suo, come diceva lui. In palestra non si era più allenato, si limitava a scaricare la tensione su un sacco veloce e saltare la corda dietro uno dei piloni centrali. Leyendecker si era chiesto come avesse intenzione di affrontare il match, quello sgangherato d’uno zingaro. Non aveva infierito. Nessuno aveva detto più niente. Chi cercava di affrontare questo argomento, veniva sistematicamente ignorato. Con Kaspar non parlava. Ma neanche con Frieda. L’aveva tagliata quasi totalmente fuori dalla sua sfera emotiva. Le uniche volte che le mostrava un filo d’emozione, era quando i loro occhi si incontravano e lui non riusciva a fare a meno di farle un sorriso. Oppure quando facevano l’amore. Ma non era più un’esperienza così piacevole. In quel frangente, Johann tirava fuori una rabbia repressa che a volte la spaventava. Johann non era abituato a non esternare niente. Ma era come se qualcosa in lui si fosse spezzato, come se le fiamme che gli bruciavano le vene si fossero estinte, come se fosse morto. Qualsiasi emozioni che s’insinuava nel suo cuore, la seppelliva prontamente. Per sé stesso, soprattutto, ma anche per Frieda. Non le avrebbe caricato addosso la sua negatività, era stata già male abbastanza anche sul piano fisico. Con il vomito, sonni profondi e continui, singhiozzi sommessi e disperati nel cuore della notte. La sentiva quando piangeva. Sentiva quei respiri strozzati e tremanti, nel tentativo di riprendere fiato e non svegliarlo al tempo stesso. La sentiva, ma non la toccava. Non ce la faceva. Sapeva d’averle fatto male, sapeva che lei era diventata restia a toccarlo anche solo per dargli un bacio. Aveva paura del lupo che le dormiva vicino la notte. Per la prima volta in quegli anni, erano distanti. _________________________ NOTE Mi dispiace di rifilarvi questo capitolo GNE. È di passaggio, nel prossimo ci sarà il match Trollmann-Eder. A proposito, il prossimo capitolo potrebbe tardare un po' ad arrivare, come questo alla fine.Ma semplicemente perché devo praticamente riscriverlo daccapo: non mi piaceva già prima della revisione generale che ho fatto fino ad ora, quindi va cambiato. Io scappo, perché in questi giorni sto davvero a pezzi e ho il cervello che è tutto un "Error 404", per capirci. Cercherò di farmi viva al più presto. Alla prossima! ♥ |
Capitolo 16
*** 1.16 - L'orgoglio di Rukeli ***
| Avevo detto che ci avrei messo un po' di più per questo capitolo, mi sbagliavo hahaha. In realtà, è complice il fatto che non l'ho riscritto di sana pianta, avevo una base su cui lavorare e apportare modifiche. Non è un capitolo molto descrittivo come altri, perché è stato un combattimento molto statico e non c'era molto da scrivere... MI scuso se questo può causare delusione. Come ho fatto anche con un paio di capitoli fa, ho una piccola "playlist" che mi ha dato la carica per scrivere questo capitolo (già i titoli fanno molto Rukeli HAHAH) : - Guts over fear, Eminem ft Sia - Paid my dues, Anastacia - I will not bow, Breaking Benjamin - I'm not afraid, Eminem - Kings never die, Eminem ft Gwen Stephani - Elastic heart, Sia - Unbreakable heart, Three days grace Fun fact: è stato proprio questo episodio a farmi appassionare alla storia di Johann Trollmann! _____________________________
16. Der Stolz von Rukeli Box-Sport, edizione del 17 luglio 1933 – Presentazione dell’incontro Eder-Trollmann.
Se si fa partecipare Trollmann ad un incontro principale, esiste la possibilità – anzi, la probabilità – che fornisca una prova estremamente deludente. Si pensi a come si è comportato nel match contro Witt per il titolo di campione dei pesi mediomassimi. Non solo ha umiliato lo sport e sé stesso, con quel piagnisteo, ma ha anche privato il suo avversario del prestigio che si era guadagnato nel suo ultimo match contro Hower. Era penoso assistere ad un simile match e le conseguenze sono evidenti a tutti. […] Ma d’altro canto occorre obbiettivamente dire che Trollmann ha disputato dei grandi combattimenti. Contro Ogren, Seeling, Domogoergen, ad esempio. In queste occasioni è stato un grandioso combattente. Questo ragazzo ha commesso molti peccati. Quand’era dilettante i dirigenti sportivi non hanno apprezzato i suoi trucchetti, da professionista gli è mancata la mano forte che avrebbe potuto metterlo sulla retta via. Gli manca l’educazione sportiva. Una testa matta come Trollmann va costantemente gestita, non si può abbassare la guardia perché tornerebbe alla carica con i suoi dispetti. [...] Se consideriamo l’aspetto sportivo, allora dobbiamo pretendere da Trollmann che risarcisca con un match combattivo e senza tregua il grande danno provocato al pugilato tedesco nell’ultimo match di Berlino. Non è accettabile che un pugile con licenza dia sul ring una prova della sua condotta sportiva che porti danni anziché aiuto allo sviluppo del nostro sport. A Trollmann si deve dire che una sconfitta non è dannosa se sopportata con dignità. * * *
21 luglio 1933 Berlino. Birreria Bock. Dove tutto era cominciato, dove tutto sarebbe finito. L’ascesa e la caduta. Uno scontro dettato da regole ariane, su un ring ariano, con un avversario ariano. Trollmann non si presentò alla cerimonia del peso. Leyendecker e Zirzow ci fecero una pessima figura, e tentarono di tappare questa mancanza dichiarando che il pugile pesava settantadue chilogrammi circa. «Ma come? Quel gran fenomeno di Gipsy Trollmann che non si presenta? È proprio uno zingaro, buono solo a scappare» aveva ululato Eder, sguaiato, generando le risate composte delle SA lì presenti. Quel peso welter, campione nazionale della sua categoria, era un concentrato di cattiveria. Capelli neri e folti, ordinati e ben gelatinati indietro, occhi neri, labbra prominenti, pelle bianca come latte. Un corpo magro e muscoloso, un fascio di nervi, e un ciuffo di peli neri sul petto. Aspettava al suo angolo del ring il suo avversario. Era nato nello stesso anno di Trollmann, Eder era più grande di soli due giorni. Era professionista dal 1928 e quello sarebbe stato il suo cinquantesimo incontro, mentre per Rukeli che era professionista dal 1929 sarebbe stato il cinquantaquattresimo. Erano due campioni delle rispettive categorie, gli stili di combattimento molto diversi. Era uno di quei pugili che boxavano secondo lo stile, cosiddetto, dell’aggressore perché combatteva nella guardia dell’avversario. Era statico, violento, granitico, una macchina da guerra perfettamente addestrata secondo le regole del Faustkampf. «Quel maledetto zingaro che fa? Dà forfait?» borbottava con il manager e l’allenatore. Effettivamente, Johann Trollmann era in ritardo di ben tre ore. Si sarebbe beccato una multa di dieci marchi. L’arbitro incalzò Leyendecker e Zirzow, ma nemmeno loro sapevano dove si trovasse Rukeli. Avevano chiesto a Frieda, che quella sera se ne voleva restare in platea, ma non lo sapeva neanche lei. Il pubblico aveva cominciato a parlare, ironizzare, additando lo zingaro come vigliacco e sgangherato. «Ormai conosciamo Trollmann, si sarà dimenticato» Diceva qualcuno. I giornalisti scrivevano per il loro articolo di giornale, smaniosi di darlo per vinto. Le donne si agitavano sulle sedie, bramose di rivedere quel dio della guerra dalla pelle ambrata. Gli uomini ridevano, commentavano cattivi, inveivano a voce alta anche contro Zirzow e Leyendecker. Alle prime file, c’erano gli alti funzionari del Reich, i gerarchi nazisti, e i capostipite della Federazione. Dietro, tutta l’ondata delle camice brune. Heyl e Radamm erano seduti vicini. Improvvisamente, tutto si quietò. Ad interrompere il silenzio mortale, solo lo sfrigolare delle luci sopra il ring. Rukeli Trollmann era arrivato. Pronto a sottostare alle regole che gli erano state imposte. Aveva attraversato i quindici metri che lo separavano dal ring, le spalle dritte e il mento sollevato. Niente accappatoio. Era passato sotto le corde, entrato nel quadrato di luce. Aveva guardato i volti delle camice brune e degli alti funzionari, le facce sconvolte del pubblico debolmente illuminate. Li perdonò tutti. Perdonò quel pubblico che fino a un mese prima lo osannava e che ora gli sputava addosso. Era sempre stato uno zingaro, solo ora se ne ricordavano? Perdonò quei funzionari che avevano sottratto ad un uomo come lui, tutta la sua ambizione. Incrociò lo sguardo di Heyl e di Radamm. Allargò le braccia, come a dire: “Così vado bene? Sono abbastanza ariano per voi?”. Nessuno fiatava. Erano tutti sconvolti, dal primo all’ultimo. Lo zingaro: ricci neri, indomabili, la pelle calda color nocciola. Ora il suo corpo era cosparso di talco, i suoi capelli dipinti di biondo e gelatinati indietro, ordinati, alla moda del Reich. Un angelo, una vittima sacrificale, come se fosse lì ad espiare tutti i peccati della Terra. Il ring tanto amato, il suo Golgota. I guantoni, la sua croce. Il tragitto dagli spogliatoi fino a lì, la via Crucis. Gli occhi neri erano l’unica cosa che restava di Rukeli. Sul ring non avrebbero visto Johann Rukeli Trollmann, detto Gipsy, ma un ariano qualunque che combatteva come un ariano qualunque. Che avrebbe perso come un ariano qualunque. Qualcuno comprese l’ironia, ma l‘indignazione per tale affronto lasciò molti fanatici disgustati. A Zirzow si gelò il sangue nelle vene a vederlo così, nella sua perfetta caricatura di un ariano. In prima fila, le camice brune e i loro capi erano ammutoliti di disprezzo. Come si permetteva, quel maledetto zingaro, a sbeffeggiare così la pura razza? «La ballerina ha finito di incipriarsi il naso, finalmente!» proruppe Eder, cattivo, sciogliendo i muscoli del collo. Rukeli gli lanciò un’occhiata indecifrabile. «Johann. – era Zirzow, la faccia livida. – Che cosa credi di fare? Non è uno spettacolo di circo, maledizione.» «Ah, davvero?» inarcò le sopracciglia, l’espressione eloquente, poi si voltò. Leyendecker si massaggiò la mascella, senza sapere bene cosa pensare del suo pupillo. Eppure una cosa la sapeva: i veri combattenti non temevano la loro ultima battaglia, e se c’era una cosa che Gipsy aveva sempre fatto, era dimostrare di non temere neppure il Diavolo. E in quel momento fu chiaro a tutti, in caso avessero avuto ancora dubbi. Johann sapeva che stava rischiando moltissimo con quel gesto ribelle davanti ai funzionari del Reich. Lo sapeva che erano folli, che bastava premere un dito sul grilletto per mettere a tacere quell’anima in rivolta che gridava per la libertà. Sapeva che quella sera avrebbe rischiato la vita. Ma che importava ormai? Se combatteva con il suo stile avrebbe vinto ma avrebbe perso la licenza e messo in pericolo la sua famiglia; se combatteva come volevano loro avrebbe perso il match e il tenore di vita, e sarebbe stato costretto a sparire dalla circolazione. Non aveva vie di scampo, era stato messo all’angolo. Eppure era dell’idea che non poteva abbassare la testa, a qualunque prezzo. Non avrebbe permesso a quella gente di incatenare la sua anima. Suonò il gong. Erano previsti otto round. Rukeli non si limitò ai simboli come i capelli pitturati e il talco sul corpo, accettò lo scontro alla tedesca. Il primo round fu statico, un incontro tra picchiatori. Violento, furioso e brutale come piaceva al pubblico, si pestò con Eder senza fare un solo passo indietro ma limitandosi a pesanti passi sul tappeto del ring, a enfatizzare l’assenza dei suoi saltelli. Alla seconda ripresa, Eder sfoderò i suoi colpi migliori. Trollmann si mise sulla difensiva: i gomiti chiusi sul corpo, il mento incassato. Le lezioni sull’imparare a incassare di Leyendecker davano i suoi frutti. Non indietreggiò mai, restò piantato al centro del ring a farsi martellare di colpi. Alla fine del secondo round sanguinava da una ferita al sopracciglio. Al terzo round Trollmann strinse Eder all’angolo e lo colpì con un furioso diretto che gli spaccò il naso. I suoi sostenitori nel pubblico trattennero il fiato, fiutando il caso eccezionale e il ritorno di Gipsy. Eder si liberò a fatica dall’angolo e colpì Trollmann al plesso solare. Al quarto round, Eder aprì un vero e proprio fuoco di fila di annientamento sullo zingaro. I pugni arrivavano da ogni direzione: al corpo, al volto, ai fianchi. E poi ancora, in un limbo ripetitivo, l’ariano colpiva lo stereotipo dell’ariano. Lo colpiva con cattiveria, con tutta la potenza e la ferocia che avrebbe riservato ad uno zingaro o ad un ebreo. Negli occhi di Eder, ora Rukeli vedeva la rabbia cieca, la frustrazione, perché lo zingaro non cadeva. Ma non poteva resistere per sempre, piantato in mezzo al ring a farsi martellare. Era come prendere a pugni un sacco in palestra. Vittoria facile, scontata. Il talco sul viso si era sciolto a causa del sangue delle ferite e del sudore, era diventato una maschera drammatica. Nessuno riuscì a fermare quel sanguinamento. In cuor suo, Johann ne era anche felice. C’era l’ariano sul quadrato, non Gipsy, e l’ariano doveva perdere. Era stanco, non ce la faceva più. Metà della sesta ripresa: in una nuvola bianca, cadde. Alla fine, tutto ciò che era accaduto, è che non era morto. Ricordava poco, della sera precedente. Ricordava di essersi alzato ed essere andato da Eder per fargli i complimenti della vittoria. Un po’ troppo sarcasmo gli aveva incrinato la voce. L’altro l’aveva guardato in cagnesco, in risposta gli aveva sputato sulla faccia. «Prendi per il culo qualcun altro, sporco zingaro.» Poi era tornato nello spogliatoio. Il sangue scendeva a fiotti da tutte le ferite sul volto tumefatto. Era svenuto. Si era appena risvegliato dentro una camera d’ospedale, la luce del mattino che filtrava dalle tende bianche. Il volto fasciato quasi totalmente, anche il corpo. Gli faceva male tutto, non riusciva neanche a muovere le sopracciglia. L’occhio destro era così gonfio che era costretto a tenerlo chiuso. Si guardò le mani, i lividi neri sulle nocche. Lo avevano lavato, la sua pelle era tornata quella di uno zingaro, i capelli di nuovo come la notte. Tossì, si schiarì la voce. Aveva la gola secca, doveva assolutamente bere. Nella stanza entrò di fretta un’infermiera, lui riconobbe Gilda. «Johann!» «Acqua.» biascicò, la voce impastata. Lei si affrettò a versarla nel bicchiere e lo aiutò a bere. Lo guardò, gli occhi dolci pieni di compassione. «Mi dispiace per quello che è successo, Johann, tu…» cercò di dire. Lui alzò leggermente una mano. «Dimmi solo se sono ridotto tanto male» «Direi di sì. Hai tre costole incrinate, una in modo grave che ha quasi rischiato di lacerare il polmone. Potresti restare cieco dall’occhio destro e hai rischiato di farti fracassare la milza. Oh, inoltre abbiamo dovuto tagliarti via un piccolo pezzo d’orecchio perché era tumefatto.» «Non male, insomma. – commentò, sarcastico. ─ C’è qualcuno qui fuori per me?» «Ci sono tutti.» «Frieda?» «Sì, ma sta dormendo. È qui da ieri sera, da quando ti hanno portato. Si è messa a dormire solo quando le abbiamo detto che eri fuori pericolo.» Johann non rispose, lasciò cadere la conversazione, e Gilda uscì. Lui lo sapeva che da quel momento in poi la sua vita non sarebbe più stata la stessa: sentiva di star cadendo, sentiva che la follia nazista lo stava per travolgere come una mandria imbufalita. Ma non voleva abbandonare il pugilato, non voleva rinunciare alla sua carriera e nemmeno a Frieda. Perché se le cose si mettevano male, sapeva che avrebbe dovuto lasciarsi qualcosa indietro. O la boxe, o l’amore. Tra le due cose avrebbe lasciato andare lei: se le cose si mettevano male, Frieda non doveva rischiare. Non meritava una vita di sofferenze al fianco di uno zingaro che non aveva più niente da offrirle. Nella camera entrarono Leyendecker, Zirzow e Kaspar. Si accomodarono ai lati del suo letto. Avrebbero voluto rimproverarlo, piangere, emozioni contrastanti che cozzavano tra di loro. L’allenatore sentiva le lacrime pungere dietro gli occhi. Prese la mano del suo pugile. L’affetto di un padre, di nuovo Dedalo che raccoglieva ciò che restava di Icaro. «Sto bene, vecchio. Non farmi quella faccia.» cercò di fargli un sorriso. «Dicono che potresti restare cieco da un occhio. Io non direi che stai messo tanto bene.» commentò Zirzow. «Ho sempre l’altro.» «Non sai cosa hai combinato, ragazzo.» mormorò Leyendecker scuotendo piano la testa. «Sono salito sul ring e ho seguito le loro regole. Non possono farmi niente, ho ancora la mia licenza. Posso ancora combattere.» «Hai affrontato il Reich a viso aperto. Ti sei preso gioco di loro davanti a duemilacinquecento persone, tra cui i più alti funzionari del governo e i capostipite della Federazione. Capisci? Uno zingaro che li sbeffeggia.» «Sei completamente fuori di testa, Rukeli.» sorrise, tristemente, Kaspar. «Non ti renderanno la vita semplice, anche se hai ancora la licenza.» Johann sospirò dal naso. «Non c’è problema. Vorrà dire che finché mi lasceranno la licenza e combatterò, perderò sempre.» I suoi occhi brillarono di una luce che tutti lì conoscevano bene: la sfida. Il puro gusto di provocare. Trollmann si divertiva a provocare i suoi avversari sul ring, e ora anche quelli fuori. Si divertiva a vederli perdere le staffe, la falsa compostezza, si divertiva a guardarli rivelarsi per ciò che erano. Mostri. «Non giocare, Johann. – gli intimò l’allenatore. – Quelli non giocheranno con te. Ti farai ammazzare se continui a provocarli.» «Non ho detto che continuerò a provocarli. – si difese. – Ho detto che ogni incontro che verrà organizzato, lo perderò.» «Ritirati allora, e sparisci dalla circolazione.» replicò Zirzow. «Non gli darò questa soddisfazione.» Leyendecker scattò in piedi, esasperato. «Basta, Johann! Non so più come dirtelo, perché non lo vuoi capire? Ti stai rovinando la vita per questo tuo esasperante orgoglio! C’è un labile confine tra stupidità e dignità, te ne rendi conto? E lo stai oltrepassando. Quelli non si dimenticheranno di te e del tuo affronto, vedrai l’inferno se continuerai così» Johann si rifiutò di rispondere ancora alle solite prediche del suo allenatore. Dal suo punto di vista, era lui che non voleva capire. O forse aveva capito, ma come gli altri cercava di cambiarlo – in buona fede, certo, ma la testardaggine e l’ottuso orgoglio erano più forti del buonsenso. Leyendecker uscì senza fare un altro fiato, sbattendo la porta alle sue spalle. Dopo nessuno parlò più. Zirzow si congedò per secondo. Kaspar guardava l’amico senza sapere bene cosa provare per lui. Nel dubbio non gli aveva detto nulla, e se n’era andato. Anche lui. Era di nuovo solo. Sperò non per molto. Si era riposato ancora un po’, poi Gilda l’aveva aiutato a mangiare. Infine aveva dormito di nuovo. Si svegliò al tramonto. La luce arancione e rosa del sole che filtrava dalle tende chiuse. Seduta vicino al letto, con la testa sul materasso, c’era Frieda. Da quanto tempo era lì? Aveva passato la notte e la giornata in ospedale? Voleva accarezzarle i capelli, ma lei era lontana e lui troppo dolorante. La guardava riposare, accoccolata vicino a lui ai piedi del letto. Johann aveva dormito molto perché era stanco, ferito. Ma sapeva che Frieda aveva dormito tanto perché doveva mettere a tacere il dolore, le sofferenze. Era uno dei suoi meccanismi di difesa d’altronde. Era così bella. Una bambola di porcellana preziosa. Sul collo intravide i succhiotti violacei che le aveva lasciato l’ultima volta che avevano fatto l’amore. Aveva lividi, non particolarmente marcati, anche sui polsi e sotto il gomito. Punti dove lui l’aveva afferrata. Si adombrò, i sensi di colpa a mordere il cuore. Aveva pensato a quello che gli aveva detto Leyendecker in ogni momento di veglia, e le sue preoccupazioni erano tutte rivolte a Frieda. L’aveva coinvolta in una situazione che si prospettava drammatica e lei, confusa e trascurata, non sapeva più cosa fare con quel ragazzo indisciplinato. Ormai aveva capito che avrebbe dovuto lasciarla andare. Avrebbe fatto male come una pugnalata in pieno cuore, ma l'amava troppo per metterla in pericolo con i nazisti. Non seppe dire quanto rimase a contemplarla, lei si svegliò con un mugolio. Si stropicciò gli occhi come una bambina, si stiracchiò alzando le braccia verso il soffitto. Rimase qualche momento con la faccia tra le mani, per cercare di svegliarsi del tutto. Infine alzò il viso su Johann. «Sei sveglio» disse solamente. Si avvicinò fino ad arrivare vicino al suo viso e gli fece una carezza tra i capelli. Il labbro stretto tra i denti e le sopracciglia aggrottate. Quanto dolore nel vederlo così ridotto. Quanta sofferenza nel guardarlo e vedere tutta l’umiliazione, il peso schiacciante delle sue emozioni, il suo prezioso cuore infranto. «Non credevo che il giallo del salotto ti sarebbe tornato utile» sussurrò, cercando di scacciare la bile che aveva ricominciato a salire. Johann si lasciò andare in un sorriso. «Per la prossima volta pensavo di farli verdi folletto, come la cucina. Che ne dici?» «Dico che sei pazzo» «Freud stesso non disse qualcosa tipo “Un pazzo è un sognatore sveglio”?» replicò l’altro, tamburellandosi il mento con un dito. Frieda sospirò, alzando gli occhi al cielo. «Dicono che tra due o tre settimane ti fanno tornare a piede libero.» gli accarezzò il viso. Lui si sciolse sotto le sue mani fresche. Chiuse gli occhi. Restarono in silenzio a lungo. Frieda decise di riprendere parola. «Andiamo via, Johann. Andiamo via dalla Germania. Anche Leyendecker ti ha detto che...» Sapeva perché glielo stava dicendo. Ora non aveva più niente da perdere. Ma sapeva che questo pensiero aleggiava nella testa della ragazza già da un po’, dalla lettera di Seeling. «Leyendecker non ha vincoli qui, io sì. – replicò, fulminandola con un’occhiata. – Tu vuoi andartene?» «I miei non sono capricci. – sibilò. – Ho paura per te. Tu vuoi rimanere, e questo mi spaventa.» «Tu vuoi andartene?» ripeté, serio. «Non voglio andarmene senza di te, non voglio lasciarti solo ad affron-» «Molto carino da parte tua, ma voglio che te ne vai. Devi sparire. – la interruppe, il tono di voce e lo sguardo erano duri, severi, gli occhi glaciali. ─ Vattene, io non ti fermerò. Ma adesso, mi hai capito? Devi uscire da questo ospedale, fare una valigia, e andartene lontano. Devi dimenticarti tutto di questo posto, dimenticati di me e di noi. Non ti voglio più vedere in giro per Berlino. Sparisci. Ricomincia da capo da un’altra parte, lontana dalla Germania.» Lontana da me. Doveva salvarla. Lui non se ne voleva andare, la sua ottusa dignità glielo impediva. Ma lei non poteva restare per il suo orgoglio ed egoismo, non poteva pagare per gli errori che Johann aveva deciso di commettere. Aveva già capito che piega avrebbero preso le cose dopo quel match, e non poteva permettere che Frieda soffrisse per la situazione. Sapeva che non l’avrebbe mai lasciato di sua spontanea volontà, doveva fare in modo che lei se ne andasse da quella pericolosa Germania o che, almeno, si allontanasse da lui. Si sarebbero ritrovati un giorno, in tempi migliori, ma Frieda doveva salvarsi da quella vita al suo fianco che si prospettava piena di sofferenze, dalle scelte pericolose che Johann avrebbe fatto. Doveva andare via da lui e da quella Germania dilaniata. La ragazza aveva gli occhi pieni di lacrime, lo sguardo fiero di chi però non si sarebbe messo a piangere. L’aureola si era spezzata, c’era la guerra nei suoi occhi. Solo poco tempo prima si erano scambiati promesse. Lo guardò senza riconoscerlo, senza sapere come replicare. Ma forse non c’era niente da dire, ormai. Lui aveva fatto la sua scelta. Scattò in piedi e si chiuse la porta alle spalle senza sbatterla. Passi silenziosi che si allontanavano dalla vita di Johann. |
Capitolo 17
*** 2.17 - Perdere il controllo ***
Seconda parte
L'uomo Mesi al tappeto anche Adolf Witt l'ariano, ma la Federazione rese quel trionfo vano. M'impose la sconfitta nell'incontro successivo, poi la deportazione mi rese inoffensivo. C.F.F. ─ Come fiori ______________________________________________________ 17. Kontrolle verlieren Box-Sport, edizione del 24 luglio 1933 – Incontro Eder-Trollmann, 21 luglio 1933.
Eder ha offerto un match fantastico e correttezza vuole che si riconosca che Trollmann si sia impegnato a fondo presentandosi sul ring come un vero combattente per far dimenticare la catastrofica prestazione fornita contro Witt nel cosiddetto incontro per il titolo dei mediomassimi. Il ragazzo di Hannover, che come al solito non ha saputo rinunciare a portare sul ring una nota di colore presentandosi con i capelli tinti di biondo, ha iniziato a percorrere un nuovo cammino. Ogni sua superficialità viene dimenticata di fronte alla prestazione di Trollmann. Usciva dall’angolo per combattere. Sapeva che con questa impostazione sarebbe stato severamente punito. E tuttavia lo ha fatto, seguendo le istruzioni ufficiali. Trollmann affondava a bandiere spiegate. Nell’apoteosi finale tuttavia tornava il vero Trollmann, perché la pretesa sua e di Zirzow che gli ultimi due colpi al corpo che lo hanno mandato al tappeto fossero stati portati sotto la cintura, gli ha procurato fischi in quantità. Tuttavia ha saputo riparare al danno congratulandosi con grande sportività con Eder per la vittoria e riconoscendo così con chiarezza la sconfitta. Molti hanno giudicato la teatralità di Trollmann, nel suo presentarsi con i capelli tinti, come una pagliacciata grottesca e di cattivo gusto. A tal proposito, vi riportiamo qui una breve poesia scritta da Fritz Hoffmann e dedicata appunto a Trollmann: Il “biondo” Gipsy, una volta era uno zingaro. Nessuno era bello come lui! Ricci neri come la notte, non arricciati dal parrucchiere, gli stanno bene, a pennello. Non era proprio un eroe, sospiravano quelle dame che venivano per lui. Ha una brutta ciocca - e intendevano la sua criniera, che gli sta ricciuta sulla testa. Oddio, com’è interessante! Una volta c’era uno zingaro. Nessuno era furbo come lui! Un geniale apprendista stregone pieno di magica strategia. Un demonio che andando a zig zag strisciava sempre lungo il muro. Una volpe, super astuta, che si allargava come un pavone, con soffi e nitriti da stallone selvaggio. Poi di colpo come un cavatappi Si divincola tra le corde con arte. Oddio com’è interessante! C’era una volta uno zingaro. Adesso non è più nessuno! Perché a forza di colpi di sole si è esposto troppo a lungo. Come si è rovinato, persino la sua arte è scolorita. Ciò che una volta era geniale, è oro finto e apparenza senza sostanza. Della volpe resta solo l’ombra del colore, troppo bello per essere vero. Così “una” piena di rabbia lo sgridò, e di interessante solo Eder trovò. Mah, c’era una volta uno zingaro? * * * *
Frieda non si era più fatta vedere in ospedale. Aveva tagliato i contatti con tutti, persino con Gilda. Le due settimane e mezzo in cui Johann era in ospedale, non fece altro che pensare a lei. Chissà se n’era andata, chissà se l’avrebbe dimenticato. Chissà se era al sicuro, ora. Il lupo che proteggeva la sua compagna, il suo piccolo branco. Aveva raccontato a Gilda di ciò che le aveva detto, lei aveva pianto e lo aveva abbracciato, comprendendo il gesto e le sue parole, comprendendo l’amore che Johann provava per la sua amica. I sensi di colpa e il dolore che gli avevano provocato quegli occhi, quello sguardo… aveva il cuore stretto in una morsa. Aveva perso la boxe, aveva lasciato andare l’amore. Gli restavano gli amici, ma per quanto? Gli restavano le sue radici, ma per quanto? Avrebbe perso ogni cosa, e lo sapeva. La sensazione di essere stato inghiottito da un ciclone, ti essere in balìa delle rapide che inevitabilmente l’avrebbero fatto scontrare su scogli acuminati. Sentiva di star perdendo il controllo della sua vita e questo, più di tutto, lo mandava nel panico. Passava le giornate con Kaspar e Ivan. Il ragazzone non parlava della cugina, e Johann non faceva domande. I due lo scorrazzavano in giro per il giardino dell’ospedale con la sedia a rotelle. Le costole non riuscivano ancora a sostenere il peso del corpo. Si divertiva con loro, lo facevano ridere e lui faceva ridere loro nonostante tutto. Si stava riprendendo bene. L’occhio era fuori pericolo, ci vedeva ancora bene come prima. Gli erano rimaste piccoli cicatrici bianche sul volto. Un sopracciglio aveva la coda spezzettata dalle cicatrici che lo tagliavano, altre due erano sotto l’occhio destro, un’altra sotto quello sinistro, un’altra ancora tagliava orizzontalmente il naso, un’altra sulla guancia destra, vicino al lato della bocca. Ogni tanto gli arrivavano dei fiori con delle dediche da parte di coloro che erano rimasti fedele alla leggenda di Gipsy e amici. Da parte di Hans, da parte di Edmund Bilda, da parte di Paul e Max, da parte dei suoi fratelli, persino da parte di Seeling e Schmeling. Con tanto di biglietti. “Al campione, al pugile più grande di sempre” quello del signor Bilda. “Rimettiti in fretta, testardo d’uno zingaro” quello di Max e Paul. “Vediamoci su un altro ring. Che ne dici, oltreoceano?” da Seeling e Schmeling. «Manco fossi morto.» aveva commentato, con un sorriso. Ma da Frieda niente. Uscito dall’ospedale dopo il periodo di ricovero, era tornato a casa. Non c’era odore di lavanda. I vestiti di Frieda nell’armadio erano spariti, così come tutte le sue cose. Non c’era più traccia di lei. Come se non fosse mai stata lì. Come se non fosse mai esistita, mai entrata nella vita di Johann. Né un oggetto dimenticato, né un vago profumo di lei, né un biglietto. Niente. Quello che era stato il loro nido, il loro posto nel mondo, ora sembrava vuoto e privo di ogni ricordo. Era andato a cercarla al Der Blume. Hildi gli aveva detto che aveva lasciato il posto da circa due settimane e mezzo, e anche lei. I nazionalsocialisti se la prendevano con comunisti ed ebrei, e quello era un pub pieno di manifesti marxisti. Chi ci lavorava rischiava parecchio. Le chiese se sapesse qualcosa, ma lei aveva detto di no. Frieda aveva tagliato i rapporti anche con Hildi. Era andato a cercarla al maneggio. Non l’aveva trovata. Poi era andato a casa sua. Edmund Bilda l’aveva accolto calorosamente. «Io so perché l’hai fatto, ragazzo mio, e credimi se ti dico che avrei fatto la stessa cosa al tuo posto. Amare è proteggere. Ma lei... Non l’ha presa molto bene.» Il padre ricordava bene il giorno in cui la sua unica e amata figlia era tornata a casa. Il cuore infranto e pioggia che scendeva dagli occhi di cielo. Aveva lanciato al muro un paio di vasi, rovesciato il tavolo della cucina. Quando i due uomini erano tornati, avevano trovato la casa a soqquadro, una valigia davanti alla porta di casa, e la ragazza sdraiata sul sofà. Una sigaretta accesa tra le dita, gli occhi gonfi di lacrime, arrossati, le guance umide, il trucco colato. Era partita la mattina dopo, senza dormire né mangiare. Senza dire una parola a nessuno, né un cenno, né un saluto, né la vaga promessa di rivedersi un giorno. Aveva telefonato dopo una settimana, lasciando l’indirizzo a cui inviare le lettere e scusandosi. «Dove è andata?» chiese Johann, riscuotendo il signor Bilda dal ricordo. «A Praga. Dalla sorella di Agnes, sua zia Rosa.» Si era sentito morire. Era così lontana dalle sue braccia. Frieda aveva scritto una lettera a suo padre. Un foglio di carta con alcune righe scritte a matita, la calligrafia rotonda ma disordinata. Informazioni brevi ed essenziali. Lo informava dicendogli della zia, della casa, del lavoro che aveva trovato. Johann si era sentito sereno, perché lei era al sicuro. Si era trascritto l’indirizzo. Non era certo di volerle scrivere, avrebbe voluto che lei si dimenticasse di lui. Ma sarebbe stata l’unica cosa che gli restava di Frieda. * * * *
Box-Sport, edizione del 4 settembre 1933 – Incontro Trollmann-Sabbotke, 1° settembre 1933. A ravvivare la serata con una sorpresa ci ha pensato Gipsy Trollmann! Lo zingaro contro Sabbotke, cominciò con lo stile consueto: finte, schivate, colpi fulminei da ogni direzione. Per la delusione del pubblico e dello stesso Trollmann, Sabbotke accusava anche i colpi più leggeri così fino al quarto round si è sviluppato uno dei soliti combattimenti di Trollmann in cui sembra una bestia che gioca con la preda prima di massacrarla, in cui non si sa se ci si deve arrabbiare, ridere oppure ammirare la sua istintiva ed abile boxe. Nel quinto round Sabbotke sferrò un pesante colpo a Trollmann, mandandolo al tappeto, e così un paio di volte, ma presto l’uomo colpito tornò con una scarica violenta di pugni. I pugni che si abbatterono su Sabbotke erano così tanti, così vari, e così veloci, che quello non poté farci niente. Trollmann dominò il ring per i round successivi, poi Sabbotke rispose di nuovo, Trollmann era intontito ma poi ebbe un ritorno di fiamma. Infine Sabbotke, raccogliendo tutte le sue energie, riesce ad arrivare al round conclusivo, ed entrambi ricevono ovazioni dal pubblico di Berlino. Forse ora Trollmann ha capito che deve combattere per avere successo. Il più bel record non conta niente se dalla propria parte non si ha il pubblico. Box-Sport, edizione del 9 ottobre 1933 – Incontro Trollmann-Boelck, 8 ottobre 1933. A guardare l’aspetto e il peso di Trollmann, sembra che l’aria di Berlino non gli faccia granché bene. Ma anche un Trollmann in una forma diversa (anche se non ha avuto occasione di dimostrare quale) non avrebbe avuto molto da offrire contro questo Boelck. Box-Sport, edizione del 30 ottobre 1933 – Incontro Trollmann-Boja, 27 ottobre 1933. Poi il match conclusivo, grottesco, più un finale allegro che un match sportivamente apprezzabile. Trollmann (71,2) entrato nel parterre in uniforme da SA, saltava, ballava, impegnava l’avversario, fintava come al solito, il vecchio Boja (71,7) spigoloso e legnoso nei movimenti, l’esatto contrario dell’imprevedibile Trollmann, colpiva con movimenti rigidi e lenti ma pesanti. E l’incredibile accadde. Trollmann andò al tappeto fino al “nove” del knock-down, poi scapò così in fretta che quasi travolse l’arbitro e si assistette ad abbracci, trattenute, “cravatte” da lotta più che un pugilato accettabile. Boja ottenne la vittoria ai punti e il pubblico applaudì per la grottesca esibizione finale. Box-Sport, edizione del 6 novembre 1933 – Incontro Trollmann-Eybel, campionato dei pesi medi Domogoergen-Boelck, 5 novembre 1933. Nell’incontro conclusivo Trollmann (Berlino, 71,3) ha dimostrato di essere almeno un po’ allenato. Eybel non si è lasciato influenzare dal famoso teatro di Trollmann, ma dalla terza ripresa ha dovuto incassare colpi pesantissimi che lo hanno costretto ad arrancare sanguinante verso la sconfitta. Trollmann immaginava questo incontro più difficile, probabilmente. Ha di nuovo usato i suoi trucchi, le sue meschinità cambiando l’abito come il colore dei capelli, inseguendo il suo avversario come un gatto fa col topo, giravolte, colpi dati e ricevuti, carezze derisorie e colpi portati con sapienza e incredibile potenza. Era una tipica rappresentazione alla Trollmann e il suono del gong faceva l’effetto del sipario di una rappresentazione teatrale. Lo scontro con Eybel fu l’ultima vittoria di Trollmann, e fu segnata da urla provenienti dal pubblico. «Bisogna fare uno spezzatino con questo ceffo zingaro!» «Trollmann buttati giù altrimenti ti veniamo a prendere!» «Porco zingaro, vattene in Valacchia!» Parole che pesavano nell’animo già devastato di Johann. Ormai non si arrabbiava neanche più. Era sconsolato, amareggiato. Alla premiazione gettò la corona d’alloro in un angolo, sotto lo sguardo mortificato di Zirzow e Leyendecker che non lo riconoscevano più. Nonostante l’allegria e l’ironia che portava sul ring, Johann non era più niente di tutto ciò. Si era spento come una candela. Se fino a quella sera aveva ancora dubbi, ora non ne aveva più: vincere era ormai sinonimo di pericolo. Era uno sportivo a cui avevano ormai precluso la possibilità di dimostrare quanto valeva, perciò non gli restava che fare show e indicare con decoro che sarebbe stato in grado di dimostrare il suo valore se solo glielo avessero permesso. Trollmann aveva capito che doveva solo perdere se non voleva essere poi multato dalle SA – o addirittura bastonato. Ma nonostante la paura e l’insicurezza, non rinunciò alla sua satira e al suo spettacolo sul ring: combatteva vestito con una divisa delle SA a noleggio, salutava la folla con il gesto del profeta, si tinse di biondo per un periodo e si truccava il viso col talco per schiarire la carnagione. I suoi avversari non erano quelli sul ring, erano quelli fuori. Appostati sugli spalti, come una bestia nera, pronti a deriderlo ed insultarlo ad ogni incontro. Istigavano la folla, alimentavano un odio irrazionale nei confronti dello zingaro. Il pubblico invadeva il ring, lo aggrediva, gli lanciava oggetti di ogni sorta e lui tornava sempre a casa ferito dalle bottiglie di vetro che gli lanciavano contro e sporco di cibo, salse e uova. Era difficile concludere un incontro, e concluderlo senza andare al tappeto, in quelle condizioni. A volte si buttava giù volontariamente. Venne sconfitto anche da avversari che aveva abbattuto più di una volta. I suoi incontri diventarono match marginali, non più principali e fulcri delle serate; le notizie sul giornale che lo riguardavano erano brevi, mere curiosità. Johann Rukeli Trollmann, probabilmente l’uomo e il pugile mediomassimo più apprezzato e temuto della Germania ora non era altro che uno zingaro qualsiasi, un fenomeno da baraccone. Persino Ernst Zirzow era stato costretto ad abbandonare Rukeli, nell’inverno del ’33. Leyendecker continuò a seguirlo fino a quando non ritirarono la licenza al ragazzo e venne intimato al vecchio di girargli alla larga se ci teneva alla vita. A marzo del ’34 terminarono definitivamente i suoi incontri ufficiali, e fino ad aprile, per arrivare a fine mese, prese parte a incontri di pugilato nel luna park al mercato Pötte di Hannover. Rischiava di perdere la licenza, ma che differenza faceva ormai? Una settimana prima, uno di questi suoi incontri venne annunciato platealmente. Ciò attirò suoi sostenitori, ma anche suoi nemici che interruppero l’incontro lanciandogli bottiglie e cibi vari. Chi non aveva smesso di apprezzare Gipsy Trollmann si schierò in sua difesa, provocando una rissa. Il 24 maggio 1934, gli ritirarono definitivamente la licenza di pugile professionista. Scriveva lettere che avrebbe voluto inviare a Frieda, ma non se la sentiva. Le teneva nascoste in una scatola in fondo all’armadio della sua nuova casa a Hannover. Era stato costretto a vendere quella a Berlino. Un trio di studenti universitari erano andati ad abitare lì. Lui si era spostato ad Hannover, portandosi dietro solo vestiti, libri e sofferenze, stava in affitto a casa di una signora anziana a cieca, ma con la voglia di vivere di un ragazzino di tredici anni. La signora Berger aveva ottantadue anni, era vedova e affetta da diabete, una volta era una maestra di una scuola elementare. Aveva folti capelli bianchi sulla testa, ricci, era magra e ricurva, sempre appoggiata al suo fedele bastone che le faceva da guida. Aveva anche un cane, un pastore tedesco di nome Ulma. La signora Berger aveva dei figli, ma erano morti durante la Grande Guerra e i suoi nipoti ora vivevano a Parigi. Qualche volta l’andavano a trovare. La sua badante era una ragazza di trentacinque anni austriaca, Clara, che abitava porta a porta; capelli biondi e occhi verdi, paffuta. A Johann ricordava una ciambella ricoperta di zucchero sia per la corporatura e sia per la sua dolcezza. «A me non frega niente se eri un campione, ragazzo. – gli aveva detto la signora Berger quando era arrivato. – Ora che vivi qui, dovrai fare la tua parte. E anche un po’ quella di Clara. Lei si occuperà di cambiarmi il pannolone ma tu dovrai almeno pensare alle faccende domestiche!» «Sfida accettata.» «Che sfida e sfida! Non farmi arrabbiare!» E aveva agitato il bastone. Johann, ridotto ai lavori forzati, spalava carbone ad Hainholz, il quartiere settentrionale della città, e puliva aeroplani all’aeroporto di Vahrenheide. La paga era misera, bastava a malapena per il sussidio. La signora Berger gli disse di non preoccuparsi di questo, alla spesa ci avrebbe pensato lei con i suoi soldi. Ma lo stipendio di Johann non gli permetteva nemmeno di pagarle l’affitto. Anche in questo, la signora Berger gli aveva detto che non c’era problema, si era affezionata al ragazzo. Lui cercava di pagare in tempo comunque. Per questo la notte aveva cominciato a lavorare come cameriere nelle bettole della città vecchia, a Kreuzklappe. «Dai, muoviti, campione! Veloce come quando scappavi sul ring!» Gli urlavano. Lui non fiatava e faceva il suo lavoro. Con tutte le umiliazioni che aveva subìto, si aggrappava ancora alla sua dignità e al suo orgoglio. Al suo datore di lavoro piaceva Johann, era un bravo ragazzo e buon lavoratore, e gli dava sempre qualche soldo in più nella busta paga. Era mansueto, docile. Sorrideva ai clienti e si muoveva come un gatto tra i tavoli. Era veloce con le ordinazioni e cordiale in ogni circostanza. E poi, nonostante tutto, continuava a piacere le donne, che da quando lui lavorava lì, erano sempre più presenti nel locale. Giusto per vedere Gipsy Trollmann ancora una volta e parlarci con la scusa di prendere ordinazioni. Si svegliava all’alba, lavava aeroplani, pranzava in una mensa pubblica per senzatetto, poi spalava carbone ad Hainholz fino al tramonto. Tornava a casa, si dava una ripulita, cenava, e dopo andava a Kreuzklappe fino alle tre del mattino. E di nuovo ricominciava il giro. Aveva solo un giorno libero, la domenica, e lo passava a casa per aiutare Clara e la signora Berger. Qualche volta faceva un giro in città, giocava a calcio con i ragazzini per strada, andava a salutare sua madre. Friederike pensava che Johann avesse una casa tutta sua. Nessuno sapeva che era in affitto da una signora anziana e cieca. Non aveva detto niente, non voleva che i suoi fratelli cercassero di tappare i buchi della vita di Rukeli. Ce la faceva da solo, era l’arte dell’arrangiarsi e gli veniva piuttosto bene, munito anche di una certa dose di fortuna e carisma. E poi si divertiva dalla signora Berger. «Secondo me tu sei finta cieca.» la provocò Johann una sera. «Secondo me tu ti diverti a prendere le mazzate, invece.» replicò. Ogni volta che il ragazzo scherzava, lei si divertiva a dargli leggere bastonate sulle gambe. Lui si faceva sempre trovare, non ci provava a schivarle. Una volta, la signora Berger gli chiese se poteva “guardarlo”. Con le mani antiche, passò le dita sul suo viso. Il mento squadrato, gli zigomi alti, i lineamenti duri, il naso all’insù, le labbra carnose. Le sopracciglia ben disegnate, la palpebra che calava leggermente e gli conferiva quel taglio da lupo. I bei riccioli neri, folti, tagliati più corti dietro e ai lati. L’orecchio a cui mancava quel pezzo di cartilagine, le cicatrici sul viso sparse e leggermente in rilievo. «Ragazzi belli come te sono difficili da trovare. - aveva sussurrato, accasciandosi sulla poltrona. – Ci credo che le donne fanno ancora a gara per averti. Tu e la tua testa ricciuta strappate ancora sottovesti in quantità. Scommetto che la signorina media si presterebbe volentieri agli esperimenti sull’ibridazione della razza.» Johann strabuzzò gli occhi alle parole della signora Berger, e poi scoppiò in una risata prorompente, delle sue. «Ma dai! Ma come ti vengono! Non ci faccio più molto caso ormai.» «Tu eri Gipsy Trollmann. Il divo. Le donne ti venivano dietro e tu non ne rifiutavi neanche una, me lo ricordo sai, e lo fanno ancora. Ma non eri fidanzato?» Clara notò lo sguardo di Johann passare dall’ilarità alla malinconia, mentre accarezzava la testa di Ulma. «Signora Berger, non credo sia un tasto da toccare.» provò a dire la domestica, conciliante. «Se n’è andata vero? Se ne vanno tutti, ragazzo. Chi per scelta, chi no.» «Lei aveva paura qui in Germania, mi aveva chiesto di andare via insieme. Le ho detto di no, le ho detto che doveva andarsene da sola e che non l’avrei fermata.» spiegò lui, lentamente. Quanto tempo era passato? Da quanto tempo non vedeva Frieda? Gli mancava da impazzire. Gli mancava parlare di cose importanti e fare progetti insieme a lei, sembrava tutto più cupo e più pesante senza la sua presenza frizzantina. Si stava dimenticando della sua voce, della sua risata, delle sue espressioni e dei suoi sorrisi. Stava dimenticando la sua pelle, le sue abitudini, il suo essere così piccola tra le sue braccia. L’unica foto di lei che aveva la ritraeva da lontano, ed era praticamente nascosta dietro il suo cavallo. Gli piaceva pensare che lei fosse dietro Alfie, gli piaceva ricordarla così: al maneggio, tra la paglia e i suoi animali. Sentì lo stomaco rigirarsi, la bile salire. Neanche c’era stato un addio. Il tempo stava estirpando il suo ricordo, non voleva. «Ora è a Praga.» sussurrò. «Ti manca?» Johann sentì lacrime bollenti riempirgli gli occhi. Clara lo guardava con la fronte aggrottata, gli fece una carezza affettuosa sulla spalla. «Che importanza ha? È al sicuro, lontana dalla Germania. È l’unica cosa che conta.» La signora Berger lo scimmiottò ripetendo le sue parole. «Ma sentilo. Per un titolo diventi una belva, ma quando si tratta di combattere per amore sembri un pesce. Maledizione, quanto costa un biglietto per Praga?» ____________________________ Okay allora questo capitolo è lunghissimo. Ho sfoltito, ma più di così non ho voluto perché è un po' un riepilogo di quello che successe da luglio 1933 all'estate seguente. Ho usato gli articoli di Box-Sport per scandire il tempo che passa, nella mia testa sono come quei spezzoni di film con le pagine di giornale per legare due periodi distinti, non so se mi spiego hahah |
Capitolo 18
*** 2.18 - Lo stilista di Ostrava ***
18. Der Modedesigner aus Ostrava
Praga, Repubblica Ceca. Rosa Vowe era la sorella maggiore di Agnes. Aveva quasi sessant’anni, e non aveva figli. Era fidanzata con un pilota dell’aeronautica militare ma con lo scoppio della Grande Guerra lui non tornò da lei. Poco tempo dopo la fine, scoprì che era a Parigi a fare la bella vita con una donna dieci anni più giovane. Rosa, già provata dalla perdita della sorella nel 1917, se ne andò dalla Germania per ricominciare da capo. Si stabilì a Vienna, infine a Praga. In pochi anni aprì una boutique prestigiosa in tutta la città. Vestiti esclusivi, all’ultima moda. Zia Rosa era una sarta e una stilista con una creatività strabiliante e le mani d’oro. Era una donna con i capelli bianchi, folti e sempre acconciati in modo eccentrico, gli occhi castano scuro. Non dimostrava la sua età, era vivace e piena di cose da fare. Aveva polsi, mani, caviglie e piedi piccoli ma era paffuta come un bignè pieno di panna. Qualsiasi cosa dovesse fare, si vestiva elegante. Abbinamenti impeccabili, prestigiose pellicce. Aveva l’abitudine di fumare la sigaretta da un lungo bocchino nero. Abitava in un enorme appartamento, sopra la sua boutique Lesk, nel centro di Praga. Era un appartamento così grande da avere anche un piano superiore. Rosa Vowe era stata davvero felice di accogliere la sua cara nipotina. Erano quindici anni che non la vedeva. Ora aveva ventitré anni, l’ultima volta che l’aveva vista ne aveva otto. Appena la vide dalla finestra che scendeva dal taxi che l’aveva accompagnata, le era balzato il cuore in gola. Sua nipote vestiva con abiti scialbi, ma li sfoggiava con un’eleganza innata che le avrebbero permesso di rendere aggraziata persino una busta dell’immondizia. Quando poi era salita, rivide nei suoi lineamenti la sua cara sorella Agnes. Era bella come lei. Aggraziata e fine come lei. Anche il fisico atletico e minuto l’aveva ereditato dalla sorella. Era la sua fotocopia. Ma gli occhi di cielo e i capelli d’oro erano senza dubbio del buon vecchio Edmund. Da quando era arrivata, l’aveva messa sotto a cucire abiti, occuparsi della boutique come commessa, sistemare gli abiti sui manichini, farle da modella per i suoi esperimenti di sartoria. «Bisognerà mettere in risalto questo bel seno, signorinella, non durerà mica per sempre! E questo punto vita lo vuoi valorizzare oppure vuoi buttare tutte queste qualità nella pattumiera?» urlava continuamente, quando vedeva i vestiti di Frieda, oppure le faceva mettere addosso i modelli che cuciva. Era così bella che non c’era da stupirsi dei ragazzi che si voltavano in strada a guardarla, da quando indossava gli abiti giusti. Finalmente Rosa Vowe aveva portato un po’ di buongusto nel vestiario della nipote. «Olga, tesoro. – le mormorò quel giorno, la ragazza era alla cassa della boutique. – Sono arrivate delle lettere per te.» La ragazza si era avvicinata, le aveva prese tra le mani controllando il mittente. Suo padre, Hildi, Gilda. Johann. La sua lettera fu semplicemente lasciata cadere a terra. Rosa piazzò le mani sui fianchi. «Non la leggi neanche? E se ci fosse scritto qualcosa di importante?» Sorrise, sardonica. «Ho dei dubbi» «Chi era il mittente?» «Nessuno. Un ragazzo che non è nessuno» «Però ti provoca un certo effetto, anche se è un signor nessuno» la incalzò Rosa, recuperando la lettera. Frieda strinse le dita sulle altre buste candide. «Era il mio fidanzato quando ero a Berlino» Rosa si addolcì e la nipote le raccontò della loro storia. Nei suoi occhi, la zia vide l’emozione nel rivivere quei momenti. Sentiva la dolcezza dell’amore che la ragazza provava per quel pugile. La sofferenza che le stringeva il cuore in una morsa ogni volta che lo ricordava. La nostalgia di quei giorni con lui. Era passato un anno da quando si erano visti l’ultima volta. Non c’era giorno in cui Frieda non lo pensasse, ma era troppo arrabbiata e orgogliosa per scrivergli. In ospedale le aveva chiesto di dimenticarsi della Germania, di lui, di loro. Probabilmente era quello che anche Johann avrebbe voluto fare ma che non riusciva, per questo le aveva scritto. La ragazza mostrò alla zia una foto di Johann, che teneva gelosamente nel portafogli. Era la foto stampata e ritagliata che gli avevano scattato a marzo del 1933, ad Anversa, prima dell’incontro con Roth. Lo trovava bellissimo. Un figlio della guerra e delle passioni violente. La zia Rosa aveva strabuzzato gli occhi. «Tu eri la sua fidanzata?» Frieda scoppiò a ridere, si morse il labbro guardando la stampa con affetto. «Mi è piaciuto da subito. – sussurrò. – Ci siamo divertiti tanto insieme, era giocherellone e spassoso. Ci siamo scambiati promesse e segreti. Ma nell’ultimo periodo… non lo conoscevo. Non sapevo più chi fosse. Non riuscivo più a sentirlo, era lontano. E io capisco come doveva sentirsi, ma volevo solo stargli accanto e mi ha mandata via come un cane» «Non essere infantile, tesoro. Stava passando un momento difficile. Probabilmente anche lui avrebbe voluto averti accanto ma ha preferito mandarti via per proteggerti. Forse è il caso che tu metta da parte l’orgoglio. Lui lo sta facendo per te» alzò le sopracciglia, eloquente, mentre le porgeva la lettera di Johann. La ragazza si adombrò, non prese la busta. Gli occhi indagarono sulla sua scrittura disordinata, ma lo ignorò. «Devo finire di vestire dei manichini, zia. Ci vediamo a cena.» * * *
25 giugno 1934. Hannover, Germania.
Ti ho scritto tante lettere durante il corso dell’ultimo anno, ma non ho avuto il coraggio di inviartene nemmeno una. Buffo, eh? Io che non ho coraggio. Ma stavolta è diverso, perché esiste la possibilità per me di raggiungerti a Praga, per alcuni giorni almeno. Se mi vorrai resterò, altrimenti accetterò la tua decisione e tornerò in Germania. Ma è una cosa che voglio fare, perché come dice un’anziana signora a me molto cara: “Non esistono amori impossibili ma solo amanti codardi”. E io sono stato un codardo troppo a lungo con te. Rosa non si era trattenuta dal leggere la lettera che il ragazzo aveva mandato a quella disgraziata, tanto quanto adorata, nipote. La lettera di Johann era stata breve, senza parole dolci. Ma le intenzioni e le emozioni che trasudavano da quella lettera erano più che chiare. Rosa Vowe aveva le lacrime agli occhi. La sua nipotina non poteva desiderare di più, ed era sicura che non lo faceva. Scrisse lei una risposta a quel ragazzo. 2 luglio 1934. Praga, Repubblica Ceca.
Caro Johann, Mi chiamo Rosa. Sono la zia di Olga, lei alloggia da me, come forse sai. Mia nipote è testarda come un mulo e più orgogliosa di Napoleone Bonaparte, ma ho visto i suoi occhi quando mi ha parlato di te e sono abbastanza vecchia da riconoscere l’amore. Facciamo così. Ti lascio il numero di casa a cui rispondo solo io, e quando partirai mi chiamerai. Io preparerò ogni cosa per il tuo arrivo. A presto, Johann Trollmann. Zia Rosa. Sorrise alle parole della donna, lo rincuoravano. C’era qualcuno che lo supportava. Al telefono pubblico della stazione, compose il numero che c’era segnato sulla lettera. Dopo qualche squillo, gli rispose una voce dolce. «Pronto, signora Rosa?» La donna, dall’altro capo del telefono, sentì questa voce calda e profonda. «Johann? Stai partendo?» «Sì. Tra dieci minuti arriva il mio treno» controllò sull’orologio da polso. «Ottimo, sai tra quanto arriverai?» Fece un rapido calcolo mentale. «Quasi otto ore. Dovrei arrivare per l’ora di cena» «Ti farò avere un taxi fuori la stazione. Buon viaggio, ragazzo mio» Era partito sul primo treno di mezzogiorno. Sarebbe stato un lungo viaggio. Si era portato un bagaglio con un bel po’ di abiti e un paio di libri, giusto i suoi preferiti. La signora Berger era stata gentilissima e disponibile, con la sua aria frizzante. Gli aveva dato qualche soldo in più, per le spese extra. Grazie alle conoscenze poco raccomandabili della signora Berger, era riuscito a procurarsi dei certificati medici che dichiaravano l’impossibilità di lavorare per circa venti giorni. Li aveva presentati alla centrale a carbone di Hainholz, all’aeroporto di Vahrenheide e alla bettola di Kreuzklappe. Non aveva fatto domande alla Berger, sul perché conoscesse certi individui, ma ormai si aspettava di tutto da lei. Davanti a sé aveva venti giorni a Praga con Frieda. E se lei non l’avesse voluto, sarebbe tornato ad Hannover e si sarebbe goduto i giorni di riposo. Quel giorno Frieda era alla boutique. C’era una ragazzina ceca che l’aiutava con i manichini e la sistemazione degli abiti, ma non parlava molto. Le chiacchiere che scambiavano erano essenziali. Verso l’orario di chiusura, una cliente disposta a pagare fior di quattrini per un pezzo unico di zia Rosa si stava facendo prendere le misure dalla ragazza cosacca. Con un laccio millimetrato e alcune spille da balia, cingeva il girovita della signora, la circonferenza del petto e dei fianchi per prendere le misure necessarie e apportare le dovute modifiche all’abito. E la signora parlava e parlava, senza sosta. Era una cliente abituale. In un anno che Frieda era a Praga, l’aveva vista spessissimo alla boutique. «Mia figlia si sposerà e devo prendere un abito adatto. Dimmi tesoro, secondo te questo mi valorizza?» Frieda l’aveva squadrata con un sopracciglio alzato e diverse spille da balia tra le labbra. Annuì con un’alzata di spalle, come a voler dire che secondo lei sì ma non era un’esperta. «Ahio!» esclamò, quando la ragazza la punse per sbaglio. «Fcufi» rispose prontamente, con le labbra serrate per tenere le spille da balia. Rosa fece il suo ingresso trionfale dal retro della boutique, dove c’erano le scale che conducevano all’appartamento. Aveva una pelliccia di volpe sulle spalle, un cappellino con una lunga piuma viola ed un fiore. «Olga, mia cara. – cinguettò svolazzandole accanto. – Abbiamo un ospite a cena. Vai a darti una sistemata» Frieda alzò un sopracciglio, la zia le tolse le spille dalle labbra. «Un ospite?» «Ahio! Ma insomma!» esclamò la cliente, di nuovo. Rosa la zittì con un cenno. «Viene da Ostrava. Ha fatto un lungo viaggio, arriverà per cena» «Oh. Chi è?» «Un collega stilista. Parleremo di lavoro. Tu faresti bene ad ascoltare, signorinella. Se un giorno vorrai, questa boutique sarà tua e dovrai ereditare il mio buon gusto e le mie conoscenze, tesoro» Frieda aveva già pensato di svignarsela e cenare in camera sua. La zia sembrò leggerle nel pensiero, e lei fu costretta ad annuire. «Ho capito» Lasciò il metro, gli spilli e le gli aghi vari alla zia, e lei si ritirò nel retro della boutique. Salì le scale a chiocciola, di legno pitturato in verde pastello, fino a sbucare nello stanzino della cucina dell’appartamento. Era una sorta di passaggio segreto. La cucina era spaziosa, i mobili di legno color avorio e un’isola col piano di marmo nero al centro. C’erano grandi finestre alle pareti che illuminavano l’ambiente. I fornelli e il forno erano in una rientranza del muro. Una delle due domestiche, quella addetta alla preparazione dei pasti, volteggiava come una farfalla da una parte all’altra della cucina. Si avvicinava l’ora di cena e il loro ospite stava arrivando. Stava preparando una serie di delizie e squisitezze da leccarsi i baffi. Frieda le passò dietro senza essere notata, arraffò una mela dal cesto di vimini sull’isola e si dileguò. Passò dalla sala da pranzo. Anche in essa dominava l’avorio. Il pavimento in parquet, sotto il tavolo, era coperto da un tappeto azzurro. Il tavolo era in legno pregiato, le sedie intorno bianche e imbottite, con lo scheletro dello stesso legno liscio del tavolo. Sopra, c’era un mazzo di fiori coloratissimi. Grandi porte finestre illuminavano l’ambiente e si affacciavano su un lungo balcone. Le pareti decorate da quadri di paesaggi dai colori chiari. La sala da pranzo era accessibile dall’ingresso attraverso una grande arcata. In fondo all’ingresso, c’erano le scale per il piano di sopra. Frieda le salì due a due, ritrovandosi nel salottino del primo piano. Era come un altro micro appartamento, con solo camere e due bagni. Qui l’attendeva Hedy, la domestica che si occupava di tutto ciò che non riguardava la cucina. Faceva un lavoraccio, ma era ben retribuito ed era affezionata alla signora Rosa. Praticamente, quella palazzina nel centro di Praga era abitata da tutto ciò che circondava Rosa Vowe. La boutique al piano terra, due appartamenti piccoli per le domestiche, e l’appartamento enorme della zia. Non si faceva mancare niente, solo un animale domestico o un giardino. E Rosa non aveva intenzione di avere nessuna delle due cose. «Signorina Olga, è pronto il bagno caldo. Nella sua stanza ho già appeso l’abito che sua zia desidererebbe vederla indossare» Frieda alzò gli occhi al cielo. «Grazie Hedy, ma ti ho già detto di chiamarmi solo Frieda, senza tutte queste formalità. Accidenti, siamo coetanee! E in ogni caso, ti prego, non chiamarmi Olga» «Va bene, signorina Olga. Cioè, uhm… Frieda» La camera da letto che Rosa aveva dato alla nipote, era piccola e spaziosa. Essenziale. C’era un letto con le lenzuola blu e bianche e grandi cuscini rotondi, la struttura era in ferro battuto nero; una cassettiera di legno, una scrivania con uno specchio ovale, e una poltrona all’angolo della stanza. Sulla parete dietro il letto, c’erano diverse mensole piene di libri. L’intera parete opposta al letto era occupata da vetrate, ai cui lati c’erano morbide tende avorio. Quella stanza le era piaciuta subito. E poi, da lì, Rosa non poteva sbirciare cosa facesse Frieda in camera sua quando aveva la porta aperta, e non vedeva il suo lato di corridoio. Non che avesse i segreti, ma a volte sgattaiolava fuori senza che la zia lo sapesse. E le cameriere erano brave a tenere i segreti. C’erano altre due stanze degli ospiti. Ma in realtà si era ridotta ad una. La prima era davanti alla camera di Frieda, ed era sempre chiusa a chiave perché tanto non ci doveva stare nessuno. Le domestiche l’aprivano solo per far prendere aria e pulire via la polvere. L’altra era davanti alla camera di Rosa, ed era stata svuotata per creare la fabbrica personale della sarta con macchine da cucire, manichini, tessuti, disegni di abiti appesi alle pareti. Lì faceva i suoi esperimenti. Il primo bagno era diventato monopolio di Frieda, e infatti si trovava vicino alla sua camera. L’altro bagno era personale di Rosa, anch’esso vicino alla stanza della proprietaria di casa. Al piano terra c’era anche un altro bagno, ma era riservato a tutti. La ragazza si spogliò, s’immerse nella vasca ovale affondando fino al naso. Rimuginava sul restare a Praga o tornare a Berlino. In realtà, il suo cuore le stava dicendo di tornare in Germania. C’erano suo padre e suo cugino lì, i suoi amici, i suoi cavalli, Johann… tutta la sua vita. Ma la Germania stava diventando pericolosa per chi non era puro ariano. Forse sarebbe potuta tornare per salutare, uno di quei giorni. I soldi a zia Rosa non mancavano per un biglietto del treno Praga-Berlino. Soffiò, producendo una serie di bollicine. La luce e il cielo cominciavano a tingersi di rosso e d’arancio. L’orologio appeso il muro ticchettava, segnando l’ora di cena. Si alzò e si avvolse un asciugamano intorno al corpo, un altro sulla testa. Si asciugò alla bell’e meglio, spazzolando poi i capelli per renderli ordinati. Ma erano sempre la solita criniera di ondulati fili d’oro. Si addentrò nella sua camera, profumata di vaniglia e lavanda. Sul letto, era posato un abito corto. Era sbarazzino, lo scollo a barca e le maniche corte. Era stretto sul busto e la gonna svolazzante che arrivava alle ginocchia. Bianco, con un motivo nero simile all’ombra delle foglie. Sul girovita si stringeva un laccetto nero. Era uno degli abiti che zia Rosa aveva cucito appositamente per Frieda. Il tessuto liscio al tatto. Se non altro, non era troppo elegante. «È solo una stupida cena» mormorò per infondersi coraggio. Ripensò alle parole della zia riguardo l’ereditare la boutique. Il tipo da Ostrava poteva essere un buon alleato, per quando sarebbe arrivato il momento. Forse era meglio fare colpo. Un minimo, insomma. Doveva dimostrare di avere ereditato un minimo di buongusto dalla zia, anche se quell’abito l’aveva scelto Rosa. Percepì il forte tonfo dell’entrata principale. L’ospite era arrivato, avrebbero cominciato a mangiare. «Hedy! Ho urgente bisogno di te!» Hedy fece irruzione nella camera pronta ai soccorsi. Trovò Frieda con il braccio incastrato, il viso contrariato. Cercò di aiutarla senza strappare nulla. Alla fine riuscirono nel loro intento. «L’ospite è arrivato. F-farebbe meglio a sbrigarsi a scendere, mentre la aspettano per la cena, la signora Rosa potrebbe finire il vino e…» Hedy era su di giri. Frieda la studiò con un sopracciglio alzato, e la interruppe. «Sei in iperventilazione. È così bello questo stilista di Ostrava?» «Oh, signorina, lo è davvero.» «E mia zia, che fa?» indagò assottigliando lo sguardo. «B-beh… ride alle sue battute, gli versa il vino… Cosa dovrebbe fare, signorina?» Frieda sbuffò un sorriso divertito, arricciando il naso. «Quella vecchia marpiona, me l’aspettavo!» Al piano di sotto, Rosa rideva di cuore alle battute di Johann. Se fosse stata giovane come lui, come la sua Olga… Sarebbe entrata in competizione con la nipote per lui. Nemmeno Rosa, nella sua lunga e avventurosa vita, aveva mai conosciuto un uomo così. C’erano molti uomini belli in giro per la Germania, a Vienna, e a Praga. Ma erano accumunati dalla solita bellezza nordica. Se avesse dovuto assegnargli un elemento, sarebbe stato senza dubbio il ghiaccio. Quel Johann, invece, gli ricordava il fuoco. L’incendio. Ogni dettaglio emanava calore, a partire dal colore della pelle fino agli occhi, quel nero così profondo sembrava cioccolato fondente fuso. Lo sguardo era caloroso e buono, solo da quello Rosa capì che era un bravo ragazzo. Il corpo era fasciato da una camicia con le maniche arrotolate fin sopra i gomiti mostravano gli avambracci allenati, al polso un orologio rotondo, i pantaloni blu scuro, il colletto disordinato ad arte. All’attaccapanni aveva appeso una giacca nera, con i bottoni in pelle, e un cappello piatto. Rosa pensò che con un viso del genere, era un peccato che non fosse diventato un attore o un modello. Ma d’altra parte, senza la boxe, quel fisico non sarebbe uscito fuori a dovere. «Quanto vuoi stare?» gli chiese, servendogli del vino bianco. Lui stava con un braccio poggiato al tavolo, tra le dita una sigaretta consumata a metà. «Quanto posso stare, magari» «Per me puoi stare quanto vuoi. Per Olga, invece… Non saprei. Non sa che sei qui. Le ho detto che sarebbe stata una cena di lavoro con uno stilista di Ostrava» «Io ho venti giorni di malattia dal lavoro. Se Frieda mi vorrà, resterò. Altrimenti tornerò ad Hannover e mi riposerò con la mia famiglia» Rosa gli chiese del lavoro, della famiglia, della carriera di pugile. Johann le raccontò tutto in modo sbrigativo, senza dilungarsi troppo. La zia rimase colpita dalla fatica del ragazzo a racimolare i soldi fino a Praga, dal momento che aveva uno stipendio misero ed era costretto a lavorare anche di notte. E aveva faticato tanto solo per vedere quella sua nipotina disgraziata, senza neppure sapere se sarebbe rimasto o meno. Frieda fece capolino dall’arcata della sala da pranzo, avvolta nel suo abito sbarazzino. I capelli lunghi fino alle scapole ricadevano sulle spalle ed erano tenuti lontano dal viso da delicate mollette senza fronzoli. Alle orecchie portava due pendenti di perla. Una linea di eyeliner sulle palpebre la facevano sembrare un’attrice di Hollywood. L’espressione di Johann mutò lentamente. Dalla sorpresa, alla gioia. Gli occhi spalancati e le labbra leggermente schiuse, a lasciar intravedere il bianco dei denti. L’espressione di Frieda era pressoché la medesima. Era come uno specchio. Solo che lei, subito dopo, arrossì. Il cuore le fece una capriola nel petto e schizzò fino alla gola, ingoiò un groppo. Le tremavano le gambe dall’emozione di rivederlo. Segretamente, aveva fantasticato molte volte sul loro possibile incontro. C’erano diverse versioni: quella in cui lei s’infuriava di nuovo, quella in cui lui si infuriava, oppure quella in cui si lasciavano andare ad un lungo e sofferto bacio. Ma quel momento era diverso da ogni versione che aveva immaginato. Johann aveva lasciato cadere la sigaretta nel posacenere, era scattato in piedi come una molla e si era avvicinato con le mani in tasca. «Non so il tuo nome» le disse con un’occhiata di sottecchi. In quegli occhi neri, la ragazza riconobbe una sfumatura di divertimento. «Nemmeno io so il tuo» sussurrò, senza voce. «Mi chiamo Johann» Si schiarì la voce, cercando di darsi un contegno. «Io sono Frieda» Come la prima volta che si erano conosciuti. Ricordavano quel momento come fosse il giorno prima. Si strinsero la mano. Lui ebbe un fremito quando toccò di nuovo la pelle di Frieda. La sua mano piccola, delicata. «È un piacere conoscerti. Non vedo l’ora di lavorare a nuove linee di moda con te» ammiccò strizzandole l’occhio, con il suo solito sorrisetto furbastro. La cicatrice al lato della bocca sembrava una fossetta, quando sorrideva. Frieda si sciolse in un sorriso divertito, scuotendo appena la testa. «Oh, ma ti prego» Lui chinò appena il capo per esibire un delicato baciamano, mentre la guardava da sotto le ciglia. La ragazza si era incantata a guardare le sue labbra sfiorarle la pelle. Il respiro caldo, la bocca bollente. Il suo tocco gentile, la sua voce. I suoi occhi, lo sguardo profondo. Quanto gli era mancato. «Mangiamo!» li riscosse Rosa. Le era sembrato che nella stanza fosse divampato un incendio. Era fiera di sé. Aveva riunito quelle anime e la sua Olga non aveva sfuriato come pensava, ma anzi aveva accolto la novità di buon grado. Aveva persino sorriso. La cena passò in silenzio. Frieda spiluccava il cibo con la forchetta, lo stomaco chiuso. Lanciava continui sguardi a Johann. Era così strano rivederlo. Non aveva perso il suo tipico appetito, ma si manteneva in forma. Sembrava solo un po’ stanco. Non si sarebbe mai aspettata di trovarlo lì. Certo, era arrabbiata con lui, ma in quel momento non riusciva a pensare ad altro se non alla gioia di rivederlo. Non era riuscita a dimenticarlo. Sua zia doveva aver letto la lettera e si era organizzata con il ragazzo per farli rivedere. Doveva essere andata così. Aveva sentito che Johann si sarebbe trattenuto venti giorni, se Frieda avesse voluto, e poi sarebbe tornato ad Hannover. Nemmeno per un attimo dubitò su cosa fare. «Quindi ora Olga sa cucire, gestire un negozio, cucinare. Ha imparato persino il bon-ton» gli fece presente Rosa. Johann sollevò lo sguardo per rivolgerle un’occhiata interrogativa. «Il bon-ton?» «Sai, a rivolgersi ai clienti con garbo. Si spazientiva subito» «Oh. Che terribile vizio» commentò, lanciandole una frecciatina riguardo al gancio destro mollato al maniaco del pub la sera che si erano conosciuti. Frieda trattenne una risata, lui le fece un sorriso divertito mordendosi il labbro. Rosa non poté cogliere il riferimento e non colse le occhiate divertite che si erano lanciati i due. «Assolutamente. Ma alla fine ha imparato. Ora ha anche un po’ di buongusto nel vestirsi» «Qualità fondamentale se voglio stare al mondo, immagino» replicò la nipote. «Non sottovalutare la potenza dell’abito, signorinella. Diffida da chi ti dice che l’abito non fa il monaco» La ragazza roteò gli occhi. «Insomma, Johann, caro. – tornò a rivolgersi a lui. – Vorresti rimanere?» Frieda posò il mento sul palmo della mano, un lento sorriso si aprì sul viso angelico. «Magari per sempre» ___________________________
Era ovvio che si sarebbero incontrati di nuovo. Nelle mie intenzioni non così "presto", anche se è passato un anno. Per per una serie di tempistiche, dovevano ritrovarsi a luglio 1934 circa. PER FORZA. Ad ogni modo, come ho detto, tutta questa parte è romanzata. Johann non è mai stato a Praga. È un capitolo di passaggio, il prossimo sarà sentimentale ma ci sarà anche una parte con le battute alla Johann Trollmann. Diciamo che è già pronto perché sono stata a controllarlo fino a ieri sera, convintissima che dovevo postare quello anziché questo... ok. Alla prossima ♥ |
Capitolo 19
*** 2.19 - Ogni respiro è per te ***
19. Und jeder Atemzug für dich
Frieda gli fece fare un giro della casa, per fargli capire l’ambiente. Infine lo accompagnò alla sua stanza, quella degli ospiti di fronte alla sua. Aveva il soffitto spiovente, su cui era incastrata un’enorme finestra che dava sui tetti dei palazzi di Praga. Era essenziale, color beige per la maggior parte. C’erano un paio di poltrone, un letto grande con le lenzuola bianche, un cassettone, la moquette, scaffali con diversi libri. Profumava di vaniglia. Johann aveva seguito Frieda tenendosi a debita distanza, le mani in tasca, e la osservava con attenzione e curiosità. Gli sembrava più matura, persino meno sbarazzina. Lei si fermò di fronte alla porta della sua stanza, gli lasciò la chiave sul palmo della mano. Quelle grandi mani che colpivano duro, che accarezzavano dolcemente. Ebbe un fremito, al ricordo dolceamaro. «Questa è la chiave, in caso volessi uscire o desideri un po’ di pace senza Hedy che ti ronza intorno» mormorò. Si lasciò sfuggire un sorrisetto. «Va bene. Grazie» «Allora buonanotte» «Ci rivediamo dopo un anno e “Allora buonanotte”? Sul serio?» esclamò allargando le braccia. «Vuoi parlare? Vieni» aprì la porta della sua stanza e lo invitò ad entrare con un cenno del capo. Johann le passò davanti mimando un sarcastico “Grazie” con le labbra, e andò a sedersi sulla poltrona all’angolo della camera. Lei si accomodò sul bordo del letto. «E comunque, tanto per la cronaca, se mi dici “Vieni, parliamo”, e mi inviti in camera tua… Penso a tutto meno che al fatto che dobbiamo effettivamente parlare, biondina» sghignazzò. «Sembri un tredicenne» «L’età mentale è quella. – alzò le spalle con nonchalance, poi si fece più serio. – Dobbiamo davvero parlare. Ci sono delle cose che devo dirti» il tono di voce perse ogni traccia di simpatia, si fece serio e quasi perentorio. «Se sei venuto fino a Praga per farmi la predica, puoi benissimo tornartene da dove sei venuto. Tu mi hai detto “E allora vattene adesso!” e io me ne sono andata» replicò Frieda, mettendosi subito sulla difensiva. «Non fa una piega» commentò sarcastico, inarcando le sopracciglia con aria eloquente. «Io capisco qualsiasi cosa, lo so che era un brutto momento per te. Ma mi hai trattata come se non fossi niente, mi hai mandato via a calci. Io che volevo solo starti accanto, Johann» «Quello che tu non capisci, invece, è che non ti ho trattata così perché lo trovavo divertente. – si chinò appoggiando i gomiti alle ginocchia. – Ti ho lasciata andare e ti ho trattata male perché dovevo salvarti da me, dalle scelte che avevo preso e che avrei preso in futuro, e dalla Germania» «Tutto ciò che volevo era stare con te, non volevo abbandonarti in quel momento difficile» «Carino da parte tua, ma la vuoi sapere una cosa? – allargò le braccia. ─ Vuoi sapere come sarebbe stata la tua vita se fossi rimasta con me? Ecco un assaggino. Mi avresti visto combattere con una divisa a noleggio delle camice brune. Mi avresti visto tornare a casa pieno di ferite perché mi aggredivano e mi rompevano bottiglie di vetro addosso, mi avresti visto sporco di uova, salse e altri cibi unti. Mi avresti visto combattere in un mercato per racimolare qualche soldo, come un maledetto fenomeno da baraccone. Mi avresti visto quando venivo privato della licenza di pugile ed ero sull’orlo della disperazione. Quando venivo costretto ai lavori forzati. Non mi avresti visto per intere giornate, neanche la notte avresti dormito con me. Perché mi alzavo all’alba, andavo a lavare aeroplani fino a mezzogiorno; poi pranzavo ad una mensa per senzatetto per sbrigarmi. Andavo a spalare carbone fino al tramonto, cenavo, e dopo cena andavo a fare il cameriere fino alle tre del mattino. Per guadagnare due soldi che non mi permettevano nemmeno di fare una spesa decente. Saresti stata in una casa che non è neanche la tua, costretta a dividerla con una signora cieca, un cane, e me. Ti saresti sentita in colpa perché non avresti fatto in tempo a pagarle l’affitto tutti i mesi, nonostante la fatica del lavoro. Ti saresti sentita umiliata, piena di vergogna, l’esistenza ridotta ad una routine forzata e ad un’orribile quotidianità. Era questa la vita che volevi? Per cosa? Solo per stare accanto ad uno zingaro che non ha niente da offrirti?» Frieda aveva le lacrime agli occhi. Il suo Johann, quell’anima così preziosa, aveva vissuto tutto questo in solo un anno? Era questo quello che provava? Umiliazione, vergogna, sensi di colpa, il senso di panico e claustrofobia che gli serrava la gola a causa di quell’incubo che stava vivendo. Lui, che aveva sempre bisogno d’aria e di uscire dai confini imposti. Si era sentita un’egoista. Nonostante tutte le difficoltà, anche economiche, lui era lì. Aveva speso soldi tanto sudati per comprare un biglietto e andare da lei, in un altro Paese. Lei, che se n’era andata come il vento. Non aveva lottato neanche un po’. Johann si passò le dita tra i ricci neri. «Non guardarmi in quel modo. Non compatirmi, odio la sensazione di far pena a qualcuno» Frieda sfarfallò le ciglia. «Tu mi hai mandata via prima, non potevi sapere se le cose sarebbero andate così. Magari se fossi rimasta, sarebbero andate in modo diverso» provò a dire, le lacrime che pungevano dietro gli occhi solo immaginando la sofferenza del suo campione. «Non credo. Avevo già deciso di noleggiare una divisa delle SA per combattere, e sapevo che mi avrebbero tolto la licenza. Mi aspettavo le aggressioni, mi aspettavo persino i lavori forzati. Certe situazioni possono andare solo in una direzione per quelli come me, non era difficile immaginarlo» Per quelli come me c’è solo l’oblio. Fantasmi di una vittoria fatiscente. «Rimani qui» sussurrò, una lacrima che le rigava il viso. La guardò intensamente e infine strinse appena le labbra. «Non posso. Ho venti giorni di tempo per stare qui. Dopodiché metterei a rischio la signora Berger e la mia famiglia, se non torno» «Posso tornare in Germania insieme a te» provò a insistere. «Non voglio che torni, è pericoloso lì. Non posso darti una vita dignitosa e nemmeno dedicarti il mio tempo. Verrò a Praga quando tutto sarà sistemato. Non ho niente da offrirti, Frieda, niente» Il suo sguardo divenne cupo e quando incrociò gli occhi di lei, pieni di lacrime, gli fece come l’effetto della macchina della verità. Un pensiero oscuro, che forse lo tormentava da troppo tempo, si stava materializzando e prendendo forma con le parole e la voce. «A volte penso che non ho fatto altro che rovinarti la vita nell’ultimo periodo. – ammise. – E che tu non meriti una vita di sofferenze con uno zingaro che non ha nulla da offrirti, meriti un uomo tedesco che sia in grado di darti serenità. E mi sento in colpa per tutto il tempo che ti ho fatto sprecare, mi sono preso i tuoi migliori anni senza darti niente in cambio. Eppure non ce la faccio a lasciarti andare. Questa era una buona occasione per permetterti di avere la vita che meritavi, e invece non ce la faccio. Perché è vero che non ti merito, ma al contempo odio pensarti con un altro, e dopo tutto questo tempo non riesco più a immaginarmi senza di te. Ti guardo e non so se scoppiare a piangere dalla gioia di vederti o dal dolore che ti ho causato. Non hai idea di quello che mi fai» Frieda era rimasta interdetta da quelle parole. Tra tante cose, mai si sarebbe aspettata che lui si sentisse così in colpa nei suoi confronti. E forse, tra tutte le cose che le aveva detto quella sera, quella confessione era stata la più dolorosa per lei da ascoltare. «Come puoi pensare una cosa simile? – sussurrò, come colta da una mancanza di energie. – Come puoi credere di avermi fatto sprecare tempo o non avermi dato niente in cambio, Johann? A me non importa se sei zingaro, se non sei ricco. Mio dio, ma come ti viene in mente? – si sporse verso di lui, gli prese il viso fra le mani. – Tutto quello che voglio, tutto quello che merito, tutta la mia serenità, tutto quello che ricevo in cambio… sei tu, sei sempre stato tu. Non è vero che non hai niente da offrirmi, Johann, non è vero. Mi hai sempre dato tanto, più di quanto io abbia mai desiderato o immaginato, e non te ne rendi nemmeno conto. L’unico uomo che voglio è il mio amante guerriero col cuore da poeta, occhi selvaggi e mani capaci di colpi duri e carezze di seta. È il mio migliore amico, il mio complice, la parte combaciante» Una lacrima gli brillò tra le ciglia. Le prese una mano e se la portò alle labbra, baciandola e stringendola tra le sue, colto da un profondo senso di pace, un’emozione vibrante e bruciante che non credeva essere più in grado di provare. Capì che doveva smettere di pensare a cosa sarebbe stato meglio per lei, ci pensava da sola a fare una cernita di cosa era meglio e cosa no, cosa voleva e cosa no. E se Frieda voleva lui, allora andava bene, non si sarebbe negato. «Mia anima, ogni respiro è per te» Il mattino seguente, Frieda aprì gli occhi che il sole filtrava dalle tende avorio. Si stiracchiò, allungando le braccia al soffitto e si portò le mani agli occhi, stropicciandoli. Restò una manciata di secondi seduta sul letto, cercando di svegliarsi completamente, dopodiché scansò tutte le lenzuola e si alzò per aprire le tende e le finestre. L’aria era fresca, tirava un filo di vento piacevole, non c’erano nuvole. Era una giornata meravigliosa. Meravigliosa per stare dentro la boutique a combattere con la clientela esigente di Praga. Si guardò allo specchio, si diede una sistemata ai capelli. Si catapultò in sala da pranzo con una vestaglia da camera in seta, i piedi nudi. Da quando abitava con zia Rosa, indossava solo tessuti raffinati e indumenti eleganti, anche se si trattava solo di dormire. Si sentiva estranea alla vera sé, quella che passava il tempo libero in campagna, a ripulire le stalle dei cavalli e fare passeggiate nelle campagne di Berlino, quella che si vestiva da uomo e metteva baffi finti per poter guidare indisturbata fino al maneggio. Ora abitava nell’eleganza e raffinatezza di zia Rosa. La sua vita era cambiata radicalmente da quando era arrivata a Praga, si sentiva ancora un pesciolino fuor d’acqua. Con l’arrivo di Johann, si sentiva di nuovo a casa. Lui è casa mia. Si ritrovò a pensare. I suoi capelli, il suono della sua voce, la sua pelle, la morbidezza delle sue labbra. Non era un posto, casa sua. Era Johann. Non riusciva a togliersi dalla testa la discussione della sera precedente. Era stata intensa, profonda, a tratti terribile per le emozioni negative di Johann. E poi era tutto finito. Lui le aveva dato un bacio delicato ed era uscito dalla stanza augurandole sogni d’oro. Hedy volteggiava nella sala come una ballerina, intenta a spolverare. «Dov’è zia Rosa?» domandò. «Di sotto. Sta importunando l’ospite» Frieda alzò un sopracciglio e si fiondò di sotto, nel retrobottega della boutique. Sua zia aveva fatto provare al povero sinti tutti i capi maschili più pregiati e raffinati, e la dimostrazione erano quei completi abbandonati sul pavimento e sulle sedie. Ora indossava un completo blu scuro e posava davanti alla macchina fotografica della zia. «Buongiorno» esordì, appoggiandosi allo stipite della porta con la spalla, le braccia incrociate e un sorrisetto furbo. «Buongiorno, tesoro» la salutò distratta la zia. «Ehilà» lui le sorrise, mordendosi il labbro e alzando un sopracciglio. Gli occhi neri che la studiavano attento, senza girare la testa nella sua direzione. Rosa squittì. «Okay, ho finito. Olga, lascio a te il negozio. Ma prima datti una sistemata, tesoro. Vi saluto» Si fiondò fuori dalla boutique per far sviluppare quelle fotografie. Johann si tolse la giacca del completo blu, restando con la camicia e i pantaloni scuri. «Tua zia è…» «Impossibile?» Sorrise, mentre si arrotolava le maniche. «Volevo dire esuberante. Ha insistito per avermi come modello di punta per la sua nuova collezione. Mi sembra di essere tornato ai tempi di quando ero chiamato ovunque per fare pubblicità. Secondo lei nessuno di quegli abiti mi rendeva giustizia. – indicò col mento gli indumenti buttati a terra. – Mi ha preso qualche misura e ha detto che me ne avrebbe confezionato uno» «Qui puoi tornare ad essere un divo, devi solo rimanere. – sorrise incerta. ─ Le piace cucire abiti su misura, su corpi che secondo lei meritano. Lo ha fatto anche con me, l’abito di ieri sera, sai…» Si avvicinò come una pantera. Frieda si sentì piccola davanti a lui, si inchiodò appoggiando la schiena allo stipite della porta. Lui era di fronte a lei, non la toccava. Leggermente chino, il braccio posato sul legno dietro la ragazza a tagliarle le vie d’uscita. «Quell’abito… - sbuffò un sorriso. – Ho ancora una vecchia abitudine che non ho perso» «Chissà quante sottovesti avrai strappato, allora» replicò, incrociando le braccia al petto, falsamente gelosa. Johann capì l’antifona e inclinò la testa. «Nemmeno una, donna di poca fede, non ingelosirti. È passato un anno, sto impazzendo» Si sciolse, le era rimasto fedele, e quegli occhi erano terribilmente sinceri. Ma lei s’incupì. «Non ho un piacevole ricordo delle ultime volte che…» «Lo so. – la interruppe. – Dannazione, lo so, credimi» Ricordava i lividi sui polsi sottili, sull’avambraccio, i succhiotti violenti sul collo. Macchie violacee a sporcare la pelle di porcellana. Ma lei non temeva più il suo tocco, ora. Con la mano libera le carezzò il fianco, portando con sé la camicetta da notte e sfiorando con le dita la pelle nuda. Frieda si era irrigidita, ma non perché aveva paura. I suoi occhi brillavano di sorpresa e di malcelato desiderio. Johann le sorrise come un lupo. «Sei tremenda» «Cosa? Perché?» Le pungolò la punta del naso con il dito. «Conosco quello sguardo, biondina. Non posso soddisfarti qui» Lei arrossì di botto. «Tu sei tremendo! Vedi cose che non ci sono! A-adesso devo aprire la boutique, se non ti spiace. Fammi passare» Johann si allontanò di un passo, un sorriso di sfida sul volto. «D’accordo. Ci vediamo a pranzo, allora» * * *
Dieci giorni erano passati. Frieda cedeva terreno solo quando lo aveva pericolosamente vicino e quando lui la sfiorava. Johann la provocava, sotto il tavolo le accarezzava la coscia nuda fino all’orlo della gonna. Lei stringeva le gambe. La sera, che si aggirava con una camicia da notte, era il momento preferito del giovane: la guardava aggirarsi per la casa martoriandosi il labbro con i denti, bruciandole la pelle e i vestiti con lo sguardo. E adorava guardarla arrossire dall’imbarazzo. Durante il giorno lei si occupava della boutique, dei clienti. Lui girava per Praga senza allontanarsi troppo dal palazzo. I soldi extra della signora Berger li spese per comprare una collana a Frieda. Si era stancato di giocare. Altri dieci giorni e sarebbe dovuto tornare ad Hannover, anche se il tempo trascorso era stato piacevole e divertente, sentiva il bisogno fisico di averla addosso. Quella mattina le fece trovare un vassoio con dei pasticcini davanti alla porta della sua camera. E un biglietto. Lei ingurgitò i pasticcini come niente, godendosi la panna e la glassa di ognuno di loro. Johann fece capolino dal bagno, i capelli umidi. Un asciugamano sulle spalle e un paio di pantaloni scuri. Quando la vide, sorrise astuto come una volpe. «Potevi gustarteli dentro, invece che seduta lì» «Non ci ho penfato» rispose, le guance gonfie di pasticcini. Inghiottì tutto d’un fiato. Fece irruzione nella camera di Frieda, si chiuse la porta alle spalle. L’attirò a sé, accarezzandole la pelle dei fianchi sotto la sottana. Lei posò le mani sulle sue braccia, a volerlo respingere. «Ti alleni ancora o mangi chili spinaci? Hai le braccia forti, devo chiamarti Popeye?» «Ho altre cose non meno forti, nel caso te ne fossi dimenticata» Frieda scoppiò a ridere. «Più passa il tempo e più diventi sporcaccione, come funziona?» Johann la studiò con sguardo assottigliato, quasi le stesse leggendo l’anima. Le prese il mento tra le dita e le sollevò il viso per guardarla meglio. «Non voglio che pensi che mi sei mancata per quello. Ma a parole sono bravi tutti, e questo è solo il mio modo di mostrarti quello che provo. È poco gentiluomo e non molto romantico, lo so, ma se non altro è sincero. – abbozzò un sorrisetto cauto. ─ Mi dispiace, se vuoi ti porto a cena in un bel ristorante» e ammiccò, quasi la proposta allettasse anche lui. Frieda scosse appena la testa con un sorriso di divertita rassegnazione. «Quando mai le cene in bei ristoranti hanno fatto per noi?» Rosa non l’avrebbe saputo. Non sapeva delle provocazioni e dei dispetti che si erano fatti quei due, nei precedenti dieci giorni. Ai suoi occhi si tenevano a distanza di sicurezza. Forse qualcosa si era spezzato. Non poteva sapere che invece qualcosa li avrebbe legati in modo definitivo, quella notte. Quella sera, Johann avrebbe dormito nella camera di Frieda. Dopo cena, dopo che Rosa andò a dormire, bussò piano alla porta della ragazza. Lei gli aprì, invitandolo ad entrare. Rukeli si lasciò cadere sul letto a braccia aperte, come un bambino. Era a petto nudo, un paio di vecchi pantaloncini da boxe a fargli da pigiama. «Questo letto è comodissimo» sospirò, la faccia affondata nel materasso. Frieda lo guardava a braccia incrociate. Spense la luce e si sdraiò vicino a lui. La luce della luna piena, filtrata dalle tende, proiettava ombre morbide nella stanza, rendeva i loro corpi eterei. Eterni. Johann si girò sulla schiena, fissò il soffitto. Le braccia aperte: uno che penzolava fuori dal materasso, l’altro sul grembo di Frieda. «Ti manca Berlino?» le chiese, senza guardarla. Lei studiò il suo profilo: la sua fronte dritta, le sopracciglia disegnate, il naso all’insù, il profilo delle labbra carnose, il mento tondo. «A me manchi tu. – rispose in un sussurro. – Posso abbracciarmi a te stanotte?» Con le dita sfiorò le sue, titubante. Lui restò in silenzio a lungo poi si voltò a guardarla, anche lei si girò. Quegli occhi di cielo brillavano, Johann si accorse che erano lucidi per il pianto sommesso. La guardò intensamente. Gli mancava da morire la sua Frieda, la dispettosa ragazza cosacca. Gli mancavano i giorni passati, quelli in cui erano stati felici e si divertivano. Le chiacchierate, i progetti e i segreti confidati sotto le lenzuola, le promesse, i battibecchi e le discussioni. Lei lo aveva fatto crescere, gli aveva insegnato lo scontro con chi si ama. Ogni volta che la guardava, non importava quanto tempo era passato, sentiva sempre la stessa netta sensazione del sentimento puro, delicato e profondo che provava per lei. La voleva con sé, ma non poteva portarla in Germania. Doveva saperla al sicuro, lontano. Eppure era come perennemente calamitato verso di lei, e non era solo l’attrazione fisica a provocargli quell’effetto. Frieda lo appagava, calmava il suo animo irrequieto, gli donava quelle sensazioni di pace e calore che l’avevano portato a considerarla casa. D’altronde era sempre stato così, fin dai loro primi anni: lei era il suo unico punto fermo, l’unico pilastro incrollabile. Johann strinse la sua mano, intrecciando le dita a quelle di lei. Non spezzò il contatto visivo. «Posso avere te stanotte?» ___________________
(( la frase Ogni respiro è per te, l'ho gentilmente presa in prestito dal signor Goethe haha in realtà volevo imbucarci anche qualcosa di D'Annunzio ma al momento non mi veniva in mente niente di pertinente )) Sì aggiornamento rapido perché avevo ricontrollato questo capitolo come se fosse il diciottesimo, convinta che dovevo postarlo ieri. E quindi era pronto, perciò eccovelo. Non so, forse è un po' smielato, però cercavo di farvi capire la frustrazione di Johann, che non ha nulla ed è convinto di non poter offrire niente a Frieda, che non la merita, quando lei d'altro canto non è interessata a qualcosa di materiale ma a lui in sé. Frieda cerca di fargli capire che lui, offrendole la sua sola presenza e il suo affetto, le offre la cosa più preziosa. Ah e ovviamente le battute e la vena "sconcia" di Johann non potevano mancare. Povero ragazzo, dopo tutte le disgrazie che ha passato ora ha un momento di serenità a Praga... deve pure dare libero sfogo alla sua lingua biforcuta, no? HAHAHA Che ne pensate? Vi sono arrivate le emozioni di Johann? Fatemi sapere! ♥ Alla prossima ♥ |
Capitolo 20
*** 2.20 - Alla maniera di Johann Trollmann ***
20. In der Art von Johann Trollmann
Gli ultimi dieci giorni che seguirono, Rosa li vide riavvicinarsi. Forse si era sbagliata, non si era spezzato niente. Lui andava vicino alla ragazza e l’abbracciava teneramente, pensando di non essere visto da nessun altro. Le passava le braccia intorno ai fianchi mentre lei era di spalle, l’attirava a sé con una dolcezza che Rosa non aveva mai visto. Come se Frieda fosse la creatura più fragile e preziosa che Johann possedesse. Le baciava il collo, sotto l’orecchio, i capelli. Davanti alla zia, si prendevano in giro con frecciatine, scherzavano come due buoni amici. Johann le faceva sempre i dispetti, poi lei si vendicava. Frieda gli insegnò come sistemare giacche scucite, ricucire buchi sugli indumenti, piccole nozioni che gli sarebbero potute tornare utili. Si mettevano nel retrobottega e gli impartiva brevi lezioni. Rosa, dalla cassa della boutique, sentiva Johann che ogni tanto lanciava un: «Ahia, maledizione!» seguita dalla voce della nipote che scoppiava a ridere. Il giorno di riposo in cui la boutique era chiusa, Frieda lo portò in giro per Praga. Lui aveva fatto un giro da solo, qualche volta, ma non si allontanava molto. Con lei invece affittarono un paio di biciclette e fecero un lungo giro, tornando solo di sera a casa. Le aveva comprato zucchero filato e poi le aveva finalmente dato il regalo, la collanina. «Non sono molto bravo con queste cose» cercava di dire, grattandosi la testa imbarazzato. Lei si era voltata, dandogli le spalle e invitandolo a metterle la collana. Con le sue grosse dita, trafficò un po’ prima di riuscire ad aprire quel minuscolo gancetto, imprecò tra i denti facendola scoppiare a ridere. Quando ci riuscì, allontanò le mani accarezzandole i capelli. Era un sottile filo d’argento che terminava con la stampa un piccolo fiore metallico stilizzato, nel cui centro c’era un minuscolo brillante. Era fine, delicata, e le stava benissimo. Frieda l’aveva riempito di baci. Non l’avrebbe più tolta. La sera, ormai, non dormiva più nella camera che gli era stata assegnata. Dopo che zia Rosa si addormentava, e la sentiva perché russava, andava a bussare alla porta di Frieda. Si sdraiavano sul letto, le lenzuola blu. A volte parlavano tutta la notte, facendo progetti mentre si strofinavano i piedi e si pungolavano a vicenda. Con lei, Johann stava riscoprendo la dolcezza. L’amore. Tutto quello che gli era mancato durante quel drammatico anno trascorso senza di lei. Avevano parlato di loro, rivelandosi cose che non si erano ancora detti, si raccontavano della loro vita in quell’anno di lontananza. Le raccontava della signora Berger, di Clara, del cane Ulma, del lavoro e delle persone che aveva conosciuto, degli sprazzi d’allegria e del resto dei momenti tristi. Lei gli raccontava delle lezioni di cucito di Rosa, della zia, di Hedy, della sua crescita. Quanto rinnovato vigore c’era in lei, quanta speranza. In quegli ultimi dieci giorni, aveva trasmesso a Johann un carico di positività senza eguali. Facevano l’amore tutte le notti, in silenzio, dopo lunghe chiacchierate al buio. Come se il loro amore fosse un segreto, da custodire gelosamente. «Ce l’hai una casa dei sogni?» gli chiese lei, sdraiata su di lui, nella sua ultima notte a Praga. Johann teneva una mano dietro la testa, con l’altra le accarezzava la schiena con la punta delle dita. Il tessuto della sottana liscia al tatto, la curva della schiena sul suo corpo. Ogni tanto l’occhio gli cadeva sui seni di lei, schiacciati contro il suo petto. «No. Sono uno zingaro, è impensabile avere una dimora fissa» rispose ironico, facendole un sorriso. «Io ce l’ho» «Ah sì? Indovino: in campagna, magari a due piani e una soffitta, e un giardino così grande da tenerci una stalla con i cavalli» Frieda sorrise. «Beh, messa così è allettante. – gli disegnò un cerchio sotto la clavicola. – No, la mia casa dei sogni è con te» Lui abbozzò un sorrisetto timido. «Sei diventata romantica. Ma io sarò sempre con te, mro vòci, te lo giuro. – le accarezzò una guancia col pollice, il sorriso che gli aveva increspato le labbra sparì per lasciare spazio ad uno sguardo più serio. – È solo un brutto periodo. Quando le cose con il lavoro si sistemeranno, tornerò a Praga. Ci resterò insieme a te. Siamo insieme da troppi anni, ormai non vedo più un futuro dove non ci sei. Ti voglio con me per tutta la vita» Gli occhi di Johann affondarono in quelli di Frieda. Intensi, bollenti, simili a cioccolato fondente fuso. Terribilmente seri. Ebbe l’impressione che stesse cercando di comunicarle qualcosa con lo sguardo. Frieda si perse in quel baratro, non riuscendo neanche più a decifrare quell’occhiata, e si accorse di aver trattenuto il respiro. «È una specie di proposta?» sussurrò lei, riprendendo fiato. «Dipende. – un sorriso sornione. – Vale lo stesso anche se non sono in ginocchio, non ho fatto nessuna fatidica domanda e non ho un anello da farti vedere?» Lei fece scattare la testa verso di lui, per fissarlo negli occhi. «Vuoi sposarmi?» domandò, incredula. Alzò un sopracciglio, astuto e malizioso come una volpe. «Ma non ero io a dovertelo chiedere?» Frieda scoppiò a ridere, si tirò su per mettersi a cavalcioni su di lui, per guardarlo meglio con sopracciglio alzato e il sorriso di un folletto. Un dito che gli accarezzava il petto, scendendo fino agli addominali. Lui che fissava quel movimento banale, ipnotizzato, le labbra schiuse. «Proposte di matrimonio alla maniera di Johann Trollmann» mormorò, guardandolo da sotto le ciglia. «Già. – concordò, abbandonandosi a lei, le mani sui suoi fianchi. – Fatte senza stare in ginocchio, senza anello da mostrare, e senza nessuna domanda esplicita» «Detto così sembra che sia stata io a fraintendere le tue intenzioni. – gli fece un sorrisetto. ─ Va a finire che nemmeno all’altare mi darai l’anello» lo prese in giro pungolandogli il naso. Johann lo arricciò con un sorriso divertito. «Disgraziata, non sono così squattrinato. I soldi per le fedi posso trovarli» «Ah, le tue intenzioni sono serie, allora!» scoppiò a ridere. «Donna di poca fede, ne dubitavi, forse? Le intenzioni ci sono. – sospirò lui. – I soldi, l’organizzazione, il tempo. Quelle un po’ mancano, ma è solo questione di tempo» «Sono la fortunata vincitrice della proposta di matrimonio di Johann Trollmann. Credo che tutte le fanciulle di Berlino l’abbiano sognata almeno una volta» Lui sorrise astuto, mordendosi il labbro. «E tu?» «Io non ti sopporto per più di due ore, figuriamoci per tutta la vita!» «Neanche io ti sopporto. Però sto facendo un atto di bene nei confronti del popolo maschile, almeno qualche poveraccio non sarà costretto a sopportarti. Mi faccio carico di questo compito gravoso» si portò una mano sul cuore, con teatralità. «Johann Wilhelm Trollmann, il migliore amico dell’Uomo» «Olga Frieda Bilda, la mia Pandora, che fa uscire da questo scrigno – si indicò. – tutti i Mali del mondo lasciandoci solo la Speranza» Lei arrossì e sorrise timida, ma cercò di mascherarlo deviando il discorso. «Fai come ti pare anche con i miti greci, sei incredibile» «E tu non sei come le altre donne che ho conosciuto» replicò cercando il suo sguardo sfuggente. Sfarfallò le ciglia con fare angelico. «Ovviamente in senso positivo» «Ma sei matta? Mica sono il principe azzurro, che dico le cose in “senso positivo”» e le pizzicò una guancia. «Ah giusto, tu sei il lupo cattivo» «Sei tu che hai scelto il lupo. Perché lo sai che ti guardo e ti ascolto bene. Ma sai anche che ti mangio ancora meglio». Il giorno dopo, Johann partì a mezzogiorno per tornare ad Hannover.
Rosa l’aveva riempito di abiti che, a detta sua, valorizzavano il suo corpo statuario. Gli aveva fatto preparare qualcosa da mangiare da portarsi sul treno. Frieda l’aveva accompagnato fino alla stazione. Lei con il suo vestitino azzurro e un largo cappello di paglia e fiori. Johann sistemò la sua valigia nello scomparto sopra i sedili della terza classe. Scese sul marciapiede vicino al treno fermo, dove c’era Frieda. La guardò a lungo, impresse il suo viso nella sua mente. Non sapeva quando l’avrebbe rivista. Guardò le onde d’oro dei suoi capelli, che scendevano morbidi sulle spalle; gli occhi da cerbiatto che avevano rubato il colore al cielo d’estate; il naso a punta, le labbra delicate e morbide del colore delle ciliegie. Intrecciò le dita alle sue. «Ti chiamerò e ti scriverò, promesso» le disse, piano. «Sicuro che non vuoi che venga con te?» ci riprovò. «Non ci provare. – sorrise, pizzicandole la guancia. – Resta qui, ti raggiungerò appena possibile» l’attirò a sé per abbracciarla forte, le diede un bacio tra i capelli inspirando il profumo di lavanda. «In carrozza!» urlò il capotreno. Johann balzò sul treno, si sporse col corpo per baciarla un’ultima volta. Le sue labbra, il miele della saliva. Nell’ultimo anno l’aveva perduta, e perderla era come smarrire il suo unico punto fermo, il suo pilastro, la sua sicurezza. L’aveva ritrovata e, anche se doveva separarsene di nuovo, non era come prima. Ora non si sarebbe più sentito alla deriva. «A presto, signora Trollmann» le sussurrò strizzandole l’occhio, un sorriso sfacciato sul bel viso tenebroso, si sentiva così fiero di darle il suo cognome. Frieda avvampò. Lui scomparve e riapparve poco dopo facendo capolino da uno dei finestrini. La ragazza si portò la mano alla collana. «Ti aspetterò» Il treno partì. Si salutavano con la mano mentre il treno si allontanava. Lei restò con la mano sollevata finché non sparì alla sua vista. Gli occhi si riempirono di lacrime, il cielo minacciava pioggia. Era così doloroso. Si erano lasciati con una promessa senza tempo, ma quanto poteva passare prima che si sarebbero rivisti? * * * *
Passavano le ore, i giorni, i mesi. Da luglio era improvvisamente arrivato settembre. I sinti di Hannover cominciavano a sparire, soprattutto quelli che abitavano nelle campagne lungo il fiume Leine. Nessuno sapeva niente, nessuno tornava. E chi lo faceva, non parlava più per il trauma. Talvolta, chi tornava si lasciava morire dopo poco tempo. La famiglia Trollmann non veniva toccata, abitavano in città. Ancora a Tiefenthall numero cinque. Carlo Trollmann, divenuto il capofamiglia, esortava i fratelli a continuare a lavorare e non lasciarsi scoraggiare dalle scomparse dei loro compagni. Johann proseguiva con i lavori forzati, ma era stato congedato dall’aeroporto di Varheneide quindi aveva la mattinata libera. Scriveva a Frieda, a volte le telefonava. Faceva visita a Friederike, scherzava con la signora Berger, aiutava Clara con le faccende. La badante si occupava della signora, a Johann toccavano gli altri compiti: occuparsi del cane, fare la spesa, sistemare la casa. Gli veniva chiesto in cambio questo, piuttosto che i soldi dell’affitto. La signora Berger si era affezionata a quel ragazzo. Stava riscoprendo con lui tutto l’affetto di una madre verso il figlio, una nonna verso il nipote. «Quando morirò. – gli aveva detto un giorno. – Voglio che sia tu a prendere questa casa. E pure il cane visto che ti adora, non si sa perché» Johann aveva preso una boccata dalla sigaretta, era appoggiato alla finestra della cucina. «Ma che discorsi vai a fare? L’erba cattiva non muore mai, è risaputo» replicò, cercando di sdrammatizzare. Non gli piaceva prendere certi discorsi. Gli smuovevano le budella. «Non fare lo spiritoso. Lì fuori è pieno di erba cattiva. Quella gente ci seppellirà, altroché» Schiacciò la sigaretta nel posacenere sul tavolo, lanciò un’occhiata a Clara. «È solo politica, signora Berger. Il popolo continua a vivere anche se i leader cambiano, è sempre stato così» «Stanno sparendo i sinti, ragazzo. Alcune comunità con le carovane vengono attaccate la notte, vengono date alle fiamme e i malcapitati che escono per sfuggire all’incendio vengono brutalmente uccisi. Non sarei molto ottimista fossi in te. – sospirò. – Ho un po’ paura per te. Sei un sinti e sei lo stesso che si è preso gioco dell’ideologia nazista» Johann si adombrò. «È passato più di un anno» «Quella gente non dimentica di chi li ha sbeffeggiati e umiliati» «Li ho sbeffeggiati, ma non umiliati. – replicò. – Sono stato io a perdere quell’incontro, non loro» «No. È stato l’ariano a perderlo, non lo zingaro. Hai calpestato in ogni modo possibile il loro concetto razziale, e questo non lo dimenticheranno e non te lo perdoneranno mai, Johann» Quasi tutte le domeniche Johann andava a pranzo da suo fratello Carlo, con gli altri fratelli e sua madre. Non era una casa molto grande, ma c’erano pochi mobili e sembrava spaziosa. Aveva già tre figli, due femmine e un maschio, ma erano bambini. Con le recenti scomparse dei sinti, le cene di famiglia sembravano più riunioni per decidere il da farsi. Carlo incitava a continuare a lavorare, per quanto faticoso e duro fosse il mestiere. Friederike invece era pensierosa, sempre meditabonda. Si metteva sulla sedia a dondolo all’angolo del salotto del figlio e raccontava storie ai nipoti, oppure cuciva coi ferri. A Lolo, come al solito, scivolava sempre tutto addosso o comunque non dava a vedere le sue preoccupazioni; Mauso e Stabeli comprendevano la gravità del problema ed erano preoccupati per il mutare del corso degli eventi; Benny la prendeva con ottimismo, un po’ come Rukeli, e non credeva che potessero accadere cose terribili. «Sono le solite questioni razziali. – disse Benny. – Il governo non c’entra niente» «Il governo è complice. – ringhiò Carlo. – Lo sanno che i sinti stanno sparendo e non tornano, e non muovono un muscolo per difenderci. È sempre stato così» Johann si mosse a disagio sulla sedia, estrasse dalla tasca l’astuccio con il necessario per girare una sigaretta. Con estrema cura depositò il tabacco sulla cartina, cercando di concentrarsi su quello piuttosto che sui discorsi cupi dei fratelli. Lolo prese parola come se stesse sbadigliando. «Forse dovremmo solo smetterla di farci tanti complessi. Ci sono sempre stati casi del genere contro di noi, governo o no, e così come iniziavano finivano» «Il fatto che ne parli come se fosse normale, è disarmante» commentò Johann, senza guardarlo, mentre girava la cartina con il tabacco per formare la sigaretta. «Perché è normale. – replicò Ferdinand, aspro. – È la nostra realtà, Rukeli, quella che viviamo da sempre. Quella che il nostro popolo vive da sempre. Ormai rientra nella normalità. Se gli zingari spariscono non importa a nessuno, anzi è meglio, per quella gente! Meno gente che ruba, in fondo, no? Per la gente là fuori ce lo meritiamo» «Lolo» l’ammonì Carlo, lanciandogli un’occhiata di rimprovero. «È vero, Carlo! Lo sai che è così!» «Quindi se per quelli là fuori meritiamo una fine del genere, allora è così davvero?» lo incalzò Rukeli, senza batter ciglio. Parlava lentamente, con tutta la calma del mondo, mentre si accendeva la sigaretta. «Siamo un popolo di vinti. E poi, lasciatelo dire, ma sei davvero strano. Ti sei sempre sentito in imbarazzo ad essere uno zingaro, cerchi di comportarti come loro, e non credere che non l’abbiamo notato. Ti vergogni delle tue origini, ma poi ti fai cucire “Gibsy” sui pantaloncini da boxe e ti ergi a paladino. Non sei coerente» «Mi ergo a paladino? Eh? – sbuffò un sorrisetto divertito. ─ Non ti passa per la mente l’idea che per me non esiste la differenza e che ho sempre fatto quello che mi andava senza curarmi delle origini? So di essere uno zingaro, volente o nolente è ciò che sono, c’è poco da fare. Solo che non ho permesso a questo e ai pregiudizi di fermarmi, cosa che invece avete fatto voi. Vi siete fermati al primo insulto, al primo “sporco zingaro” vi siete andati a nascondere con la coda tra le gambe. Scusa, se non ho voluto fare lo stesso» Lolo aggrottò le sopracciglia, scoccandogli un’occhiata truce. «Adesso, per la prima volta nella tua vita, stai vivendo come noi. Come ci si sente a stare nella poltiglia?» «Mi prendi in giro? Tutta la mia infanzia, come voi, l’ho passata nella miseria. Dovresti imparare a contare prima di parlare, Lolo. E poi, non capisco quale sia il vostro problema con me, esattamente. – sbuffò il fumo. – Ogni volta avete qualcosa da ridire sulla mia vita. Non mi sembra che io mi metta a giudicare la vostra» «Rukeli. – Friederike intervenne, per la prima volta da quando erano cominciate le “riunioni di famiglia”. – Lolo sta solo cercando di dire che anche se non è giusta questa omertà del popolo nei nostri confronti, è la nostra normalità. A nessuno importa, la notizia non passa neanche sui giornali o alla radio, è sempre stato così in casi in cui siamo le vittime» «Sì, e poi ha cominciato a dire che mi vergogno delle mie origini e mi comporto da gagé. Ma che senso ha questa frase? Io mi comporto come voglio, da Johann Trollmann. Non lo zingaro, non il pugile, ma l’uomo» Friederike gli fece una carezza sul viso, gli passò la mano tra quei capelli neri e riccioluti. Fin da quando era bambino amava toccarli, arrotolarseli intorno alle dita e vedere come quelle molle scure si arricciassero perfettamente, come cilindri. Non importava se era prossimo ai ventisette anni, se ormai era un uomo, la donna continuava a vedere il bambino che fu. Johann aggrottò impercettibilmente le sopracciglia, e le posò la mano sul polso. Sua madre non era la donna più affettuosa del mondo, anzi, ma l’amore si dimostrava in molti modi. Per Rukeli, il miglior regalo che i suoi genitori fecero a lui e ai suoi fratelli e sorelle, era la dignità: nonostante la loro povertà, Schnipplo e Friederike avevano sempre cresciuto i figli senza far mancare loro nulla. Dignità, sacrificio e famiglia. I tre valori fondamentali dei Trollmann. Rukeli sembrava aver assimilato solo la prima parte degli insegnamenti, con quel suo fare ribelle e fuori dagli schemi, un libero spirito flirtante che non si curava di metter su famiglia o trovare un lavoro fisso. Di fatto, tutti eccetto lui, Albert e Stabeli, avevano figli. E Rukeli era il terzogenito maschio, in totale era il sesto su nove. Un po’ insolito che alla sua età ancora non fosse nemmeno sposato, e questo aveva fatto mettere le mani nei capelli a Friederike, legata alle “regole” e princìpi della famiglia. «Forse è diversa dalla loro, ma questa è la tua vita. Non devi dare spiegazioni a nessuno sul come e sul perché la stai vivendo, Rukeli. Lascia che Lolo parli» Johann scoccò un’occhiata a Ferdinand, che incrociò le braccia al petto con uno sbuffo. Gli venne da ridere, perché quando Lolo faceva così era tale e quale a quando era bambino, che veniva rimproverato ma non replicava perché sapeva di stare nel torto. C’erano alcune cose che non erano cambiate. «Con me lo fa, mi lascia parlare da solo» borbottò Carlo, fingendosi offeso. Rukeli gli strizzò l’occhio. «Non sempre, a volte ti rispondo pure» «È quello che meritate, parlare da soli. – Friederike tornò alla carica con la sua severità. – Non v’impicciate di quello che fanno gli altri, guardate il vostro» Alle spalle della madre, Johann tirò fuori la lingua in una smorfia sfottò in direzione dei fratelli, con tanto di dito medio sollevato. Quando Friederike si voltò di nuovo per parlare con lui, il ragazzo unì le mani dietro la schiena, rapido. «Non importa cosa ne fai della tua vita, disgraziato che non sei altro. – gli diede un buffetto leggero sulla guancia. – Tut kamav, mro chavò» «I me, daju. – inghiottì un fiotto di saliva. – Ho una cosa da dirvi. Nessuna brutta notizia. O meglio, niente a che vedere con le sparizioni dei sinti» «Ora sgancia la bomba» ridacchiò Mauso. «Quella l’ho sganciata io» replicò Albert, impassibile. Il maggiore si voltò a guardarlo. «Sei uno schifo» «Ma cosa vuoi, anche tu le fai» Rukeli schioccò le dita. «Ehi ehi, scorreggioni, un attimo d’attenzione. Ho un annuncio importante» «Due marchi che si sposa» propose Albert a Stabeli, a bassa voce. «Tre se ha messo incinta Frieda» contrattò, e alla fine si strinsero la mano. «Ho intenzione di sposarmi» annunciò Johann, tutto d’un fiato. Tra i fratelli calò il silenzio. Solo Benny mollò una ginocchiata a Stabeli da sotto il tavolo, per farsi passare i soldi della scommessa vinta. «In che senso?» fece Mauso. Lolo scoppiò a ridere. «Porca vacca, Rukeli! E perché non ce l’hai detto prima? Quando?» Lolo si era sposato l’anno prima con Mausi, agli inizi di luglio, praticamente pochi giorni prima dell’incontro tra Johann ed Eder. Era andato al matrimonio con Frieda, aveva rivisto le sue sorelle dopo tanto tempo. A parte Maria, la più grande, le altre due se n’erano andate dalla Germania: Anna era in Svizzera, Wilhelmine in Francia. «Non lo so quando, c’è solo l’intenzione» «È pur sempre un punto di partenza, no? – gli sorrise Carlo. – Ne hai già parlato con lei?» «Sì, certo» «E…?» «Ovviamente ha detto sì, ti pare che mi rifiuta» sollevò un sopracciglio, in un teatrale atteggiamento da divo. In realtà non gli aveva dato una risposta esplicita, ma non ce n’era bisogno. «E come farete, poi?» domandò Lolo. «Andrò da lei, a Praga» «Era ora. – sospirò Friederike. – Mi chiedevo giusto quando avrei potuto ufficialmente definirla nuora. Poi, finalmente, un nipotino da te» «Minimo ci farà aspettare altri dieci anni per quello» sghignazzò Lolo. Rukeli scoppiò a ridere e le diede un bacio tra i capelli. «Ti prego, mamma, una cosa per volta!» _____________________________ Piccoli appunti TADANNN. E insomma, Johann (alla sua maniera) ha chiesto a Frieda di sposarlo e lei (alla sua maniera) ha detto sì. Ma non si sa quando e dove, perché lui deve tornare ad Hannover. Fosse stato per me, e il mio terrificante sadismo di questo periodo, non li avrei più fatti incontrare. Ma ho una biografia da tenere in considerazione, quindi si rivedranno presto hahaha Detto ciò battete un colpo se ci siete e se vi va fatemi sapere cosa ne pensate! Ci sentiamo nel prossimo capitolo! |
Capitolo 21
*** 2.21 - Facciamo un gioco ***
21. Lass uns ein Spiel machen
Praga. I mesi erano passati veloci da quando Johann era tornato in Germania. Frieda aveva continuato a lavorare alla boutique. Dopo quasi quattro settimane dalla partenza del ragazzo, aveva cominciato ad avere fastidiose nausee mattutine. La situazione si fece seria quando divennero più forti e la costringevano ad infilare la testa nel gabinetto per rigettare. All’inizio solo Hedy sapeva e l’aiutava preparandole tisane. Dopo tre mesi, Frieda ne parlò alla zia Rosa. Le disse delle nausee, del ritardo delle mestruazioni. Si era messa a piangere, non sapeva come far fronte alla gravidanza. Non sapeva cosa fare, come comportarsi, non aveva idea di niente che riguardasse la maternità. Solo pian piano aveva cominciato a metabolizzare questa novità, l’aveva accettata. Sua zia la istruì come se fosse sua madre, facendole presente i rischi e le situazioni in cui si sarebbe ritrovata con l’avanzare dei mesi. Frieda aveva cucito dei vestitini da neonato che andavano bene per entrambi i sessi. La sera si metteva di fronte allo specchio, le mani sulla pancia ancora poco vistosa e la cullava. Ci metteva sopra i vestitini. Dopo metà del terzo mese, cominciò a sentire vaghi movimenti. Arrivò gennaio. Quasi sei mesi di gravidanza. Aveva deciso di tornare in Germania. Forse non avrebbe potuto vivere con Johann, come una famiglia normale, ma lì c’erano suo padre, suo cugino, i suoi amici. Zia Rosa l’avrebbe raggiunta a marzo. «Olga, tesoro, sei sicura di voler partire da sola? Te la senti?» si era preoccupata prima che il treno partisse. Frieda aveva sorriso, le aveva strizzato l’occhio. «Tranquilla, zia, so ancora mollare un gancio destro. Posso farcela» Arrivò a Berlino dopo cena. Il grosso bagaglio che si era portata dietro pesava più del previsto. Lo trascinò, tra sbuffi seccati, fino all’esterno della stazione di Alexanderplatz e pagò un taxi per farsi portare fino a Zillestraße, a casa del padre. Sarebbe stata dura dirglielo. Avrebbe significato vedere la sua bambina crescere, diventare una donna. Si trascinò dietro quella maledetta valigia per tre rampe di scale e fece il suo ingresso nella casa in cui aveva passato gli ultimi anni non sentendola più sua. All’appendiabiti era appesa una giacca da militare ed un cappello. Al tavolo c’era Ivan. L’avevano espulso dalle Waffen-SS perché non rispettava alcuni requisiti, come l’avere quattro figli. Himmler aveva deciso determinati parametri per la squadra d’élite del cancelliere. Ma era comunque stato spostato nella Wehrmacht, reparto di fanteria. «Bentornata a casa» l’orso ucraino l’abbracciò stretta, con affetto. «Mi sei mancato, pezzo da novanta. – gli mollò un pugnetto, facendosi male lei. – Papà?» «Dovrebbe tornare a breve. Insomma, cosa ti riporta a Berlino? Hai messo su qualche chilo vedo» «Non è grasso, però» sospirò, lasciandosi cadere sulla poltrona del salotto. Ivan ci mise un po’ a capire, poi strabuzzò gli occhi. «E quando..?» «A luglio Johann è venuto venti giorni a Praga. È successo» si strinse nelle spalle. «Lo sa?» «No. Non so come dirglielo. – mormorò. – Non se la passa bene, ed è tanto che non ricevo sue notizie. Quando nascerà non potremo stare insieme. Lui è ad Hannover, non ha una casa, e nemmeno io. Non mi sembra il caso di stare qui» «No, no, certo. – annuì Ivan, accarezzandole la mano. – Johann non è ad Hannover, però. È qui a Berlino, ogni tanto viene a trovarci, sai. Ha trovato lavoro qui, a tempo determinato. Si trova a Rummelsburg, sotto l’ala della casa sicura del lavoro, fa il panettiere. Quindi potete stare insieme, magari al casale» Frieda fece scattare la testa nella sua direzione, gli occhi che brillavano. «Certo! Non ci avevo pensato» «E come lo dirai a zio?» « “Ehi papà, sono incinta” » «Veloce e indolore» «Non mi piace girare intorno alle questioni importanti» Si accucciò di fronte a lei, carezzandole i capelli e il viso, con un sorriso carico della tipica dolcezza di Ivan. «Io ti sono vicino, lyal’ka» Suo padre aveva pianto, la sua bambina stava crescendo. Certo, era rimasta incinta un po’ più tardi rispetto alla media delle ragazze di quei tempi. Aveva ventiquattro anni, le altre ragazze già tra i diciannove e i ventidue anni si erano sposate e messo su una famiglia. Era felice che la sua Frieda, però, si fosse presa il suo tempo. Ed era felice che ci sarebbe stato quel ragazzo a prendersi cura di lei: Edmund voleva bene a Rukeli, come ne voleva ad un figlio, conosceva i suoi sacrifici e l’affetto che provava per sua figlia. E quella era la cosa più importante, quel sentimento che li teneva uniti. Sarebbe andata a vivere al casale del maneggio, con o senza Johann, l’auto sarebbe servita più a lei che ai due uomini. In mattinata del giorno dopo il suo arrivo, Ivan ed Edmund caricarono il letto matrimoniale del signor Bilda su un camioncino affittato e lo portarono al casale. Lo ripulirono, aggiustarono ciò che non andava bene, portarono qualche stoviglia e altri oggetti per la quotidianità: asciugamani, sapone, coperte, cuscini, pentole. Lo stretto indispensabile. Per il resto, il casale era pulito e sistemato a dovere. Mentre i due uomini si occupavano di queste faccende, Frieda telefonò a Hildi e Gilda, dando loro la lieta notizia. L’amica baciata dal fuoco aveva pianto al telefono, l’altra aveva cinguettato i suoi migliori auguri. Gilda aveva una figlia piccola, Teresa, di quasi un anno. Ricordava quand’era rimasta incita lei. Hildi si era sposata con Bruno, vivevano nella villa che apparteneva alla famiglia della ragazza, fuori città. Sembravano tutti essersi sistemati e felici. Dopo pranzo, andò alla panetteria dove lavorava Johann, quartiere di Rummelsburg, distretto di Lichtenberg. Lo intravide dalla finestrella dietro il bancone, un cappello bianco sulla testa e un camice da cui sbucava la cravatta e il colletto della camicia, intento a impastare il pane. Lo guardò ancora un po’. Il volto concentrato, il naso all’insù, una guancia sporca di farina. «Posso passare?» domandò al cassiere. Johann fece scattare la testa nella sua direzione, udendo la sua voce. Sollevò le sopracciglia, confuso e piacevolmente sorpreso. «Falla passare, Bob!» «Te l’ho già detto, non mi chiamo Bob» sospirò il cassiere alzando gli occhi al cielo, e fece un cenno a Frieda di andare. Lei gli girò intorno e raggiunse la cucina come un lampo. Johann tenne le mani sull’impasto, un sorriso beato gli increspava le labbra. «Ehi» sussurrò abbassandosi per baciarla, senza toccarla per non sporcarla di farina, lei in punta di piedi per raggiungere le sue labbra. «Mi sei mancato» rispose mordendosi il labbro con un sorriso. «Anche tu, mro vòci. Quanto starai?» «Sono tornata definitivamente» Le lanciò un’occhiata di vago rimprovero. «Sarebbe stato meglio di no, ti avevo detto che sarei tornato io a Praga» «Stavo bene da zia Rosa. Ma mi mancavi. Mi mancava mio padre, Ivan, Gilda, Hildi, i cavalli. Starò nel casale, in campagna. Vuoi venire con me?» «Tuo padre ti lascia la macchina?» «Sì» «Vengo con te solo se mi insegni a portarla» «Ma tu hai la moto!» replicò piccata. «Prendere o lasciare, biondina» Alzò gli occhi al cielo, con un sorriso divertito. «E va bene» «Sempre un piacere fare affari con lei, signora Trollmann» Erano a Schönower Heide. Avevano cenato con Ivan ed Edmund, avevano portato loro qualcosa da mangiare, ma erano andati via presto. Johann era davvero felice di rivedere Frieda, gli era mancata in quei sei mesi. La trovava piacevolmente più tonda, il seno più prosperoso. Doveva aver messo su qualche chilo, comunque era difficile da dire con tutti quei fastidiosi vestiti addosso. Lei teneva le gambe incrociate sul letto, prima di andare a dormire. Johann era appena tornato dal bagno dopo essersi lavato i denti, le aveva spazzolato i capelli, come amava fare, e fatto una treccia morbida che terminava sotto le scapole. Era seduto dietro di lei, stavano giocando: dovevano tracciarsi disegni o frasi sulla schiena a vicenda e indovinare. Johann le aveva disegnato un fiore, ma lei non aveva tentato di indovinare. «Facciamo un altro gioco?» gli chiese Frieda. «A quest’ora? È tardi, bambina» le disse dolcemente, baciandole le spalle. «Sarà veloce, lo giuro. – gli sorrise, voltandosi contenta. – Ti spiego le regole. A turno chiudiamo gli occhi, chi rimane con gli occhi aperti deve posare il dito o la mano del partner in un punto a caso del proprio corpo e quello deve indovinare che punto è» Johann le rivolse un sorriso tenebroso. «Conosco a memoria ogni parte del tuo corpo» pregustava già il modo in cui sarebbe finito quel gioco. «Vedrai che è difficile» si impuntò. Lui si mise a gambe incrociate di fronte a lei, alzando le spalle e il mento. «Va bene, però chiudi gli occhi tu per prima» Frieda obbedì e Rukeli le prese il dito per puntarselo nella fossetta della clavicola. Lei arricciò il naso e pensò si trattasse dell’incavo del collo. «Quasi. Apri gli occhi» quando li aprì, le mostrò il punto. «Tocca a te ora» Johann chiuse gli occhi e Frieda guidò la sua mano aperta sulla pancia gonfia. Lui fece scattare le testa, perplesso. «Coscia?» La ragazza scoppiò a ridere. «Ritenta» «Non è giusto, io al tuo primo errore ti ho mostrato subito qual era!» «Io non lo farò. Riprova dai!» «Non lo so, mi arrendo» E aprì gli occhi. Quando vide la sua mano poggiata sul ventre di Frieda ci mise un secondo a realizzare cosa lei cercasse di dirgli. Sfarfallò le ciglia, incapace di mettere insieme una frase di senso compiuto. I suoi occhi saettavano dalla pancia gonfia della fidanzata al suo viso sorridente, gli occhi umidi per l’emozione. «Tu…» sussurrò Johann, incapace di parlare. Aveva le lacrime agli occhi. Finalmente quei deliziosi chili che sembrava aver preso, il seno florido, e le nausee di cui gli aveva parlato avevano un senso. Frieda poggiò la sua mano su quella di lui. Un sorriso, mentre una lacrima le rigava la guancia. L’emozione nello sguardo del suo Johann non aveva prezzo. Con la mano libera, Rukeli si strofinò gli occhi e il viso. Quasi non riusciva a crederci. Lei era stata sei mesi da sola, la maggior parte della gravidanza l’aveva passata da sola. Si era sentito un idiota. Doveva immaginarselo, viste le nottate a Praga. Non riusciva a crederci, doveva metabolizzare questa novità. Padre. Sarebbe diventato padre. Ed era proprio Frieda che gli avrebbe dato un figlio, o una figlia. «Quando piangerà, la notte, non mi alzerò solo io. Sappilo» lo avvertì con un sorriso, il labbro stretto tra i denti. «I-io… non so che dire, te lo giuro. Sono del tutto impreparato. Sono mortificato che sei stata sola sei mesi, avrei voluto starti accanto, mi vergogno da morire ora, per le mie mancanze» Si sentiva terribilmente in colpa, si vergognava di sé stesso e all’improvviso era impacciato di fronte a lei e alla sua meravigliosa pancia. Lei gli si avvicinò col viso, prendendo il suo tra le mani. «Ehi… - gli sussurrò, dolcemente. – Non ti dannare l’anima. Hai avuto i tuoi problemi e le tue motivazione per venire in Germania. Io me la sono cavata, zia Rosa ed Hedy mi hanno aiutata, e anche il medico di fiducia di zia» «Ci sono stati problemi?» «No, no. – gli sorrise, dandogli un bacio sullo zigomo. – Dice che a giudicare dalla forma delle pancia, potrebbe essere una femmina. Non ci credo molto a queste cose. In ogni caso ha detto che è una gravidanza sana e forte, senza pericoli di alcun genere» Le sfiorò il viso con i pollici, gli occhi emozionati. «Sei una roccia, bambina» Un figlio era la cosa migliore che potesse capitargli. Aveva tutto ciò che desiderava nella sfera riguardante l’amore: una ragazza che lo amava, presto un figlio, una famiglia. Gli sarebbe piaciuto vivere questo sogno in contemporanea con una brillante carriera di pugile, ma uno o l’altro andava bene, si accontentava. Sdraiato sul letto, con Frieda accanto, si erano messo a fantasticare sulla loro vita familiare. Johann non aveva idea se sarebbe stato un buon padre, ma avrebbe lottato con unghie e denti per dare al figlio una vita dignitosa e farlo sentire amato incondizionatamente. Immaginava di portare suo figlio a giocare al parco, a cavallo, a pescare, al luna park; fantasticò sul fatto che in futuro avrebbe potuto insegnargli un po’ di boxe, cose da uomini. E perché no, se Frieda era d’accordo, avere un secondo figlio. Si ritrovò a fantasticare sul possibile volto del bambino o della bambina. Voleva che prendesse gli occhi di cielo della madre, che avrebbero brillato come zaffiri sulla pelle ambrata ereditata dal padre; le labbra carnose come il papà oppure delicate come la mamma? E i capelli? Ricci e biondi oppure mossi e neri? Il corpo? Statuario come Rukeli o dalle curve dolci come Frieda? Ogni combinazione, ogni possibile momento d’affetto in famiglia, gli passò per la testa finché non crollò addormentato con piccole lacrime ai lati degli occhi ed un sorriso beato sulle labbra. * * * *
È stato un capitolo un po' difficile da scrivere perché la maternità è un argomento che nelle mie storie, finora, non avevo mai toccato. Non sapevo come far reagire Johann nel modo più verosimile possibile, oppure come gestire in generale la situazione. Ero zingaro, venivo da Hannover
Ero zingaro e discriminato Esponente del popolo impuro Non degno nemmeno di vivere. Ero zingaro, venivo da Hannover Ero zingaro e determinato Mi avrebbero visto quei bastardi Mi avrebbero visto brillare. Ero zingaro, venivo da Hannover Ero zingaro e tormentato Avevo ombre e terrore negli occhi Vedevo il mio popolo sterminato. Ero zingaro, venivo da Hannover Ero zingaro e nulla più Spero che i nazisti siano contenti Ora che me ne sono andato. Ero zingaro, venivo da Hannover Ero zingaro e ora anche un sogno Sono il sogno, la speranza La luce che sempre spenderà. Ero zingaro, venivo da Hannover Ero zingaro, bruciato nel vento Ricordami tu nuova vita Così che io possa vivere eternamente. Spero vi sia piaciuta come è piaciuta a me, che mi sono commossa! HAHAH Ad ogni modo, fatemi sapere cosa ne pensate se vi va, se avete domande, consigli, o non so! Alla prossima, un besito ♥ |
Capitolo 22
*** 2.22 - Nessuno è come Gipsy ***
22. Niemand ist wie Gipsy
Johann apprezzava le rotondità che aveva assunto il corpo di Frieda e la sicurezza con cui le sfoggiava. La trovava sensuale, dolce. Kaspar e Gilda erano andati a trovarli, avevano un lettino come regalo. L’amico pugile gli raccontò di Leyendecker, della palestra, degli allenamenti: «È invecchiato. – aveva sorriso. – Ci fa sputare sangue, più di prima. Gli manchi, ma le camice brune gli hanno intimato di non farti entrare in palestra» Anche Hildi e Bruno avevano fatto visita al maneggio e avevano portato un passeggino. Johann si era fatto mettere il turno fisso in panetteria, perciò lavorava dall’alba all’ora di pranzo. Quando tornava a casa, trovava Frieda che armeggiava con pentole e stoviglie. Aveva davvero imparato a cucinare, in quell’anno e mezzo trascorso a Praga. Era diventata brava. Aveva imparato a cucire bene, tanto che per la figlia di Kaspar e Gilda, o per i nipoti di Johann, cuciva sempre qualcosa da regalare loro. Dopo pranzo riposavano insieme. Poi pala alla mano, e si occupavano delle stalle dei cavalli. Lui stava sempre un po’ in pensiero, non voleva far sforzare Frieda. Lei non sembrava accusare la fatica o il peso della pancia, era ancora sostenibile. Quando Alfie l’aveva rivista, le aveva leccato la faccia e poi aveva avvicinato il muso al grembo della sua compagna d’avventure. Era montata in sella con l’aiuto di Johann, ed aveva fatto un giro per il campo innevato. Il bambino cullato dai movimenti ondeggianti del cavallo. La sera dopo cena scendevano in città, si sedevano in un bar e Johann ordinava due limonate lisce. Parlavano a lungo passeggiando mano nella mano, discorsi importanti oppure solo dispetti e frecciatine. Per strada, qualcuno riconosceva il pugile, lo guardava da lontano. Sguardi che Rukeli non aveva intenzione di incrociare ma che sentiva bruciare sulla pelle. A casa, tra le lenzuola, si discuteva di cose importanti. Del futuro, di progetti, mentre sgranocchiavano biscotti. Quando il bambino si muoveva, Johann appoggiava l’orecchio sulla pelle tesa della pancia. Gli piaceva e si rilassava, lasciava scie di baci sulla porcellana, a volte parlava con le labbra premute sulla pelle sperando che lo sentisse, e Frieda rideva perché gli faceva il solletico. Poi cominciò a scalciare, la pancia a pesare, le contrazioni a infastidirla. Frieda si ritrovò quasi impossibilitata ad occuparsi delle stalle. Ci pensava Johann, aiutato da Kaspar e Bruno quasi ogni giorno, mentre le ragazze erano dentro. Con l’aumentare della grandezza della pancia, Frieda non poté neanche più guidare: se prima poteva spacciarla per una pancia da bevitore o semplicemente grasso, ora si vedeva che non era niente di tutto ciò e i suoi travestimenti non avevano senso. Rukeli si fece insegnare da Kaspar, così quando divenne abbastanza bravo, cominciò a scendere in città più spesso per comprare cibo, vestitini da neonato, regali a Frieda, stoffe e libri. Certo, aveva la moto, ma con l’inverno o quando doveva fare spese, preferiva prendere la macchina. La quotidianità che stavano vivendo era diversa ora, rispetto alla convivenza a Schluterstraße. Si consideravano una famiglia anche prima, ma stavolta c’era un figlio ad unirli. Non avevano più parlato di matrimonio. Johann però, in segreto, stava mettendo da parte un quarto del suo stipendio da quando era arrivato a Berlino. Non aveva ancora racimolato molto, neanche i soldi per le fedi. Si ritrovò a vendere alcuni vecchi abiti ad un mercatino dell’usato. Non li indossava più, ma erano in ottimo stato ed erano di buona fattura. Durante i tempi d’oro del campione, quando vinceva borse molto alte, poteva permettersi certi lussi. Vendendo quegli abiti estirpava un altro pezzo del suo passato trionfale, ora doloroso. Quel pomeriggio Frieda era a casa con Hildi e Gilda. Johann si era sentito di troppo così aveva preso la macchina ed era sceso in città. Guidò fino a Charlottenburg, alla vecchia palestra. Bussò alla pesante porta principale di lamiera. Gunter, il vecchio segretario, si affacciò dai vetrini in alto per sbirciare. Da quando i nazisti erano al potere, bisognava stare attenti a tutto. Ma non riusciva a credere ai suoi occhi, urlò a Leyendecker. L’allenatore si fiondò fuori. L’ultima volta che l’aveva visto, Johann era solo un ragazzo sgangherato e senza un briciolo di buonsenso. Ora invece era un uomo. Un uomo sgangherato e privo di buonsenso. D’altronde il lupo perde il pelo ma non il vizio. Lo strinse per le spalle. Lo trovò ancora ben solido, nonostante non si allenasse da quasi due anni. L’aveva guardato con affetto, un padre che rivede suo figlio consapevole delle innumerevoli umiliazioni e sofferenze a cui aveva dovuto far fronte ma che, nonostante tutto, aveva ancora una dignità e un orgoglio saldi. Il solito sguardo di sfida, il solito atteggiamento borioso, il solito sorriso da latin lover. «Dovresti andare ad Hollywood. Li cercano, quelli con la faccia da stronzetto come la tua» gli disse. «Invierò il curriculum» replicò con sorrisetto strafottente. Leyendecker si era invecchiato. Aveva più rughe, i capelli bianchi. Non era passato molto tempo, ma lo stress che aveva vissuto anche lui dopo la caduta del suo campione era stato un brutto colpo. Gli diede una pacca sulla schiena, e andarono alla caffetteria vicino alla palestra. Si misero a chiacchierare davanti a tazzine di caffè fumante e sigarette accese. «Beh, insomma, come te la passi, ragazzo?» «Ci sono stati alti e bassi. Mi guardo indietro e vedo una montagna russa». Gli raccontò brevemente del lavoro forzato, di Kreuzklappe, della signora Berger. Gli parlò dei venti giorni a Praga, della nuova convivenza con Frieda in campagna. «Sono molto contento che sei riuscito a far pace con Frieda. Insomma, non riuscivo proprio a vederti senza di lei, dopo tutto quel tempo insieme!» Johann sorrise, sbuffando un po’ di fumo dalle narici. «Sto per diventare padre, vecchio». Leyendecker ammutolì. Fece un rapido conto dell’età del ragazzo. Ventisette anni, compiuti alla fine di dicembre. Erano a febbraio inoltrato. Sicuramente era in ritardo rispetto ad altri ragazzi della sua età, di solito mettevano su famiglia molto prima. Ma Johann era così, senza regole. Faceva le cose solo quando se lo sentiva, senza curarsi degli altri. «Frieda partorirà a marzo. Forse aprile. – prese una boccata dalla sigaretta. – Non ho idea se sarò un buon padre, ma il pupo verrà amato incondizionatamente». Persino quando fumava aveva quell’atteggiamento borioso. Leyendecker lo riscopriva ora. L’eterna fanciullezza dell’animo di Rukeli. Non era cambiato. Maturato, cresciuto, ma di fondo era sempre il solito. «E ti sei sposato?» Scosse la testa. «Non ancora» «Quando?» «Quando sarà tutto pronto» borbottò, spegnendo la sigaretta nel posacenere. Non aveva intenzione di dirgli che non aveva i soldi. «Certo. Non perché sei uno squattrinato» lo incalzò, eloquente. Johann roteò gli occhi. «E tu come te la passi? Chi vuoi portare al titolo?» Leyendecker si adombrò. «Nessuno. Sono tutti atleti validi, in palestra. Ma nessuno di loro è abbastanza in gamba da meritare il titolo. Nessuno là dentro ha il tuo talento, Gipsy» «Kaspar è un osso duro. Potresti concentrarti su di lui. Se lo alleni secondo il Faustkampf, creeresti un Eder dei pesi massimi» si rigirava la tazzina di caffè tra le dita. «L’avrei fatto. Ci sono diverse cose che a Kaspar mancano per diventare un pugile abbastanza valido da ottenere il titolo» «Non ti fossilizzare su quello che sono stato io, vecchio. – gli sorrise, dispettoso. – Lui ha il suo stile, potrebbe diventare campione». Quello che sono stato. Una morsa al cuore che riaprì le ferite di entrambi. Il passato glorioso di Gipsy Trollmann. Quello che era stato, e che mai sarebbe potuto tornare ad essere. «Non capisci. Tu potevi avere il suo stesso stile ma saresti riuscito ad arrivare al titolo, perché avevi altre cose che ti differenziano da lui. – si preparò all’elenco. – Tu sei furbo come una maledetta volpe, intelligente, capivi il pugile che avevi davanti, leggevi i loro corpi e le loro espressioni e ti muovevi di conseguenza. Hai sempre avuto un istinto incredibile e capacità d’osservazione senza eguali. Notavi tutto. Ogni dettaglio invisibile, ogni movimento impercettibile, capivi le situazioni e anticipavi. Dare pugni e non prenderli. Tu giocavi, ti divertivi, ma eri dannatamente bravo e vincevi. Non posso allenare un pugile per diventare campione se non ha le tue stesse capacità d’osservazione. Kaspar abbassa la testa e carica come un toro, non guarda. Per lui gli avversari sono tutti uguali, come i sacchi in palestra». Johann sorrise mestamente. Le parole del vecchio allenatore gli strinsero il cuore come una morsa. La boxe era la sua vita. La sua ambizione. A ventuno anni aveva abbandonato la sua famiglia e i vicoli della città che l’aveva visto crescere per raggiungere la grande città di Berlino, per inseguire il suo sogno che era la boxe, andando contro tutto e tutti. Per cinque intensi e faticosi anni, costellati di gloria, aveva vissuto il sogno, alla fine aveva toccato l’apice e il fondo. Ma ora… Si era ridotto ad un fantoccio senza ideali a causa del Reich. In cuor suo lo sapeva, sapeva che nessuno boxava come lui. Nessuno dei suoi compagni guardava l’avversario con l’attenzione con cui li guardava Johann. Nessuno di loro aveva il magnifico gioco di gambe di Gipsy, né la sua velocità, né la sua teatralità. Né tantomeno il suo carisma e il suo ascendente sulle masse: l’unico uomo che nonostante fosse zingaro sia stato amato dalle folle come un divo, in un Paese in cui il popolo si proclamava “razza superiore” già dagli inizi del Novecento. «E Zirzow?» chiese, alzando gli occhi su Leyendecker. «Se n’è andato. Non mi ha detto dove. “Lontano da questo posto di merda” è l’ultima cosa che gli ho sentito dire. È successo subito dopo che te l’hanno tolto come manager. Non vuole più organizzare gli incontri di nessuno, vuole stare lontano dalla boxe. La batosta che ha preso con te è stata dura. Si era affezionato troppo». Rovinando la vita a Rukeli, l’avevano rovinata anche ai pilastri della sua formazione professionale. Zirzow e Leyendecker facevano la bella vita con le borse dell’ex campione. Si erano ridotti in stracci anche loro. Distruggendo il campione, avevano distrutto molti altri. E sarebbe stato così anche in futuro. «È strano, è la prima volta che non sono con Zirzow. – aggiunse l’allenatore. – Ci conosciamo dai miei esordi. È stato il mio manager quando anch’io ero pugile. Era come un fratello» sorrise, malinconico. «Oddio, vecchio, sei diventato un sentimentale» «Ah, Gipsy, non hai idea. Più si invecchia e più è peggio, vedrai!» «Mi spiace, io non invecchierò. Non così almeno» allungò le gambe intorpidite. «Se non ti sbrighi ad andartene dalla Germania non invecchierai sul serio» «Quella gente non sarà al potere per sempre, il loro governo cadrà prima o poi» «Tu scherzi col fuoco, non impari mai. Quella gente fa sul serio» si era avvicinato col busto. Johann non si scomponeva. «Io non ho paura» «Lo so, lo so bene. – sospirò. ─ Ma ora non si tratta più solo di te, capito? Ora se non arrivano a te direttamente, potrebbero accanirsi sulla tua famiglia, Frieda e tuo figlio» Questo lo fece vacillare. «Loro non possono essere toccati più di tanto, Frieda è mezza ariana e il pupo sarà solo un neonato. Solo gli zingari che abitano nelle carovane vengono presi. La mia famiglia non è nemmeno stata minacciata o che so io, sono anni che abitano ad Hannover, non sono nomadi». Leyendecker lasciò cadere il discorso di fronte alla solita, ottusa testardaggine del ragazzo. No, non era cambiato affatto. Ma forse diventare padre avrebbe limato quella sfumatura del suo carattere. «Salutami Frieda» si limitò a dire, schiacciando ciò che restava della sua sigaretta nel posacenere. Il vecchio allenatore se ne andò, uscì dalla caffetteria, senza proferire più parola. Né un saluto, né la vacua promessa di rivedersi un giorno. Un pezzo del suo passato che se ne andava. Di Johann Rukeli Trollmann era rimasta solo l’ombra di ciò che fu. Non poteva farsi prendere dai ricordi ora. Facevano male, troppo, e la ferita nel cuore era ancora aperta. Era stata solo sedata. Ma ora lo attendeva un altro tipo di vita. La prospettiva della famiglia lo rendeva sereno, placava la sua anima nomade, irrequieta. * * * *
Capitolo breve ma che volevo postare al più presto.Johann tendeva a prendere sottogamba alcune situazioni, e questa in particolare forse perché si sentiva intoccabile: dopotutto era uno zingaro che per anni era stato perfettamente integrato nella società tedesca, ed era un campione. E cosa fatale: non credeva nella cattiveria umana, era molto ingenuo sotto questo punto di vista. Oggi rincontriamo Leyendecker che elogia Gipsy un'ultima volta e lo esorta ad andarsene, a fargli capire la situazione. Ma ormai lo conosciamo quel capoccione, e sappiamo che non muoverà un muscolo. Fatemi sapere cosa ne pensate se vi va eeee nel frattempo grazie a tutti per aver speso un po' del vostro tempo a leggere queste (dis)avventure e aver conosciuto Johann! Io come sempre spero di riuscirvi a fare entrare, almeno un po', in empatia con lui - in particolare. Alla prossima! ♥ |
Capitolo 23
*** 2.23 - Rita ***
23. Rita
18 marzo 1935
Berlino. L’ospedale sembrava un rifugio per nomadi. C’erano i fratelli di Johann con le fidanzate: Carlo ed Erna, Julius e Franziska, Ferdinand e Mausi, Albert, Stabeli. Friederike aveva liquidato la situazione con una mano: «Poi il pargolo me lo porterà a far vedere, io sono vecchia, non fatemi fare questi viaggi lunghissimi» A Rukeli era dispiaciuto non avere sua madre lì quel giorno, ma capiva la donna. C’erano i parenti di Frieda. Zia Rosa, Edmund ed Ivan, i due fratelli del signor Bilda e anche sua sorella: Vasilij, il padre di Ivan, Boris e Olga. Erano massicci, forgiati dai venti delle steppe e dal calore dei cavalli. Granitici. I capelli biondi e gli occhi azzurri erano un tratto comune ai Bilda. Nessuno di loro parlava il tedesco. Vasilij era il più anziano, i capelli e i baffi folti erano solo leggermente brizzolati. Era alto e imponente, come il figlio. Boris era il terzo dei tre fratelli, aveva perso i figli piccoli durante il genocidio, terminato solo nel 1933. Da quel momento si era chiuso in un mutismo ermetico quanto definitivo. Olga era l’ultima dei Bilda. Anche lei era alta, una donnona. Gli occhi miti, passivi e rassegnati allo scorrere degli eventi, un fazzoletto azzurro sui capelli biondi. Sinti e cosacchi, riuniti nella stessa sala d’aspetto. Non c’era nulla che li accumunava esteriormente. Dentro, invece, erano più simili di quanto si aspettassero. Lo stesso legame con i cavalli, con la famiglia. Lo stesso istinto migratorio, anime che seguivano i venti dell’est, attecchivano in una stagione e alla prossima non c’erano più. Lo stesso cuore libero, lo stesso orgoglio. I cosacchi d’Ucraina, però, non amavano vivere passivamente il susseguirsi degli eventi. Lottavano, facevano sentire la loro voce. Erano guerrieri, i discendenti delle Amazzoni e degli Sciti. I sinti non avevano questa caratteristica: il loro atteggiamento verso le prepotenze era più passivo, quasi come se lo meritassero. Ivan aveva raccontato, in kazako, a suo padre e agli zii stranieri dell’impresa di Rukeli, la sfida al nazismo. «Sığan jındı. Mağan unaydı» aveva commentato Vasilij con un sorriso. Zingaro pazzo. Mi piace. In effetti, uno zingaro che si ribellava al sistema non si era mai visto. Tantomeno così a viso aperto, guardandoli negli occhi uno ad uno. I Trollmann avevano capito che stavano parlando di loro fratello, anche se la “u” la pronunciavano “a” (“Rakeli”). Johann camminava avanti e indietro per il corridoio, si mordeva le unghie e passava le mani tra i capelli. Ogni tanto si fermava, si appoggiava alla parete, le braccia incrociate e la testa bassa. Carlo si era avvicinato a lui, gli aveva stretto la mano sulla spalla. Lui aveva tre figli, due femmine e un maschio, ed Erna era incinta di nuovo. L’ansia di Rukeli per il primo figlio ce l’aveva anche lui, in passato, e anche le seguenti due volte che Erna aveva partorito. «Ho l’ansia» ammise Johann, con un sorriso imbarazzato. «Sarebbe stato strano il contrario» «Carlo, io… Non so se sarò un buon padre» «Nessuno può saperlo. Nemmeno io so se sono un buon padre. Sono cose che puoi capire, in parte, solo quando i figli crescono. Vedi le scelte che fanno, le strade che prendono, come trattano gli altri… e capisci se hai fatto un buon lavoro. Dipende anche dal carattere, certo, ma l’impostazione che hai cercato di dargli si vedrà e capirai che tipo di padre sei stato» «Non so neanche come si prende un neonato in braccio» borbottò. Carlo scoppiò a ridere. Ogni volta che rideva, sembrava tornare adolescente. «Non sono cose che si imparano. Verrà naturale, non rimuginarci troppo su. Segui il corpo, sa cosa fare» Johann gli scoccò un’occhiata indecifrabile, in cui il fratello vi lesse incertezza. «Il mio corpo non è fatto per queste cose, è fatto per dare e prendere pugni» Gli diede una pacca sulla schiena. «Non è vero, vedrai. La famiglia è il bene più prezioso, Rukeli, e siamo uomini fortunati ad avere al nostro fianco donne straordinarie, che ci amano nonostante gli altri ci voltino le spalle» In quel momento, Hildi si affacciò da una porta in fondo al corridoio. Le guance rigate dalle lacrime, il sorriso ampio, la fronte imperlata di sudore. Era voluta entrare in sala con Frieda, non avrebbe abbandonato la sua amica più cara. Si avvicinò barcollando a Johann, e si appoggiò a lui. Lanciò un’occhiata alla sala d’aspetto gremita, gli sguardi su di lei in attesa. Hildi guardò l’amico. «Entra solo tu. – gli intimò. – È nata, ed è una bambina bellissima» Gli gettò le braccia al collo, abbracciandolo forte e facendogli i suoi più sinceri auguri. Johann ricambiò l’abbraccio, titubante. Era una statua di sale. Quando lei si scostò, lui si fiondò nella sala dove intanto avevano spostato la ragazza, con una veste pulita e un letto comodo. La faccia pallida come un cencio, gli occhi arrossati, la pelle imperlata di sudore e i capelli biondi appiccicati alla fronte. Il seno era abbondante sotto la veste, più dei giorni precedenti. Una minuscola creatura era tra le braccia di Frieda. I capelli neri, radi, la pelle rosea, le manine rugose, gli occhi chiusi. Era nata sana come un pesce, di due chili e mezzo. Frieda gli fece segno di fare silenzio. Lui si avvicinò piano, accovacciandosi vicino a lei, gli occhi neri pieni di lacrime. Allungò un dito per accarezzare il dorso della mano della bambina. «È così piccola» sussurrò, la voce tremante per l’emozione. Frieda gli asciugò le guance con il pollice. «Ha le tue labbra» «Riposati, mro vòci. – le scansò i capelli dalla fronte madida, ci poggiò un bacio. – Sei una tigre» «Prendila» Titubante, allungò le mani per prendere il fagottino che la ragazza gli stava passando. Era minuscola. Aveva quasi paura di tenerla, fragile come un colibrì. La posizionò con la testa nell’incavo del braccio, la schiena della piccola che si distendeva, il respiro impercettibile. La grossa mano di Johann si poggiò sul pancino molle, la cullava. Non riusciva ancora a credere di essere diventato padre. Aveva avuto circa due mesi e mezzo per realizzarlo ma ora che la teneva in braccio era tutto diverso. La chiamarono Rita Edith. Frieda e Rita restarono in ospedale altri tre giorni. Hildi, Gilda e Johann erano sempre vicino a lei. Hildi nel frattempo era riuscita a trovare una carrozzina e un lettino, con l’aiuto di Bruno ed Edmund Bilda l’avevano portato al casale in campagna. Zia Rosa aveva cucito un’infinità di vestitini per la piccola Rita e anche qualcuno che avrebbe messo quando sarebbe stata più grandicella. Quando madre e figlia furono dimesse dall’ospedale, la sera venne organizzata una grande cena al casale con i fratelli di Johann, i cosacchi, gli amici. C’era persino le sorelle di Johann, Friederike e suo fratello Robert, con il piccolo Edu. Clara aveva portato la signora Berger ed Ulma fino a Berlino dopo che Johann aveva dato loro la notizia. C’erano tutti, ma proprio tutti. Kaspar passò a Johann una lettera da parte di Hans, in cui gli faceva i suoi più sentiti auguri. Se n’era andato in Inghilterra, si era ricostruito una vita. Anche Leyendecker era andato alla cena al maneggio. La signora Berger toccò i volti di Frieda e Rita, per “guardarle”, e fece un sorriso furbetto. «Siete davvero due bamboline, proprio come aveva detto quel disgraziato» Frieda si era sgonfiata, tornando la minuta ragazza di sempre. Eccetto per il seno, l’allattamento la rendeva prosperosa. Hildi le aveva dato una strizzata: «Sfruttale finché le hai!» Leyendecker aveva voluto tenere in braccio la neonata, le faceva strane smorfie e le parlava come se potesse capire: «Spero che non diventerai come quel maledetto borioso di tuo padre, bambolina, altrimenti ci sarà da mettersi le mani nei capelli» Cenarono su un lungo tavolo allestito in giardino, alla brezza fresca di marzo. I corpi avvolti da golfini leggeri, mantelle, cappellini. E dopo, Stabeli cominciò a suonare il violino. Nessuno era bravo come lui. Kerscher accompagnò la melodia del fratello con il tamburello, sua figlia Goldi che le ballava intorno. Anna e Maria coinvolsero la zia Olga, la zia Rosa, le mogli dei loro fratelli, Gilda ed Hildi a ballare. Frieda batteva le mani a tempo, seduta su un ceppo vicino alla carrozzina con Rita che si guardava intorno. Friederike le andò vicino. «Aspettavo con ansia un figlio di Rukeli. Persino Mauso è diventato padre prima di lui. – sospirò, le fece un sorriso. – È proprio una bella bambina. E non lo dico mica perché sono la nonna!» La ragazza ridacchiò. «Spero che crescendo somiglierà di più a Johann» «Coraggioso da dire» E non seppe identificare quel tono di voce. Dopodiché si propose per far addormentare Rita, e Frieda gliela lasciò di buon grado. Friederike si allontanò verso l’entrata del casale, cantando una ninna nanna in lingua romanì. La stessa che cantava a Johann e agli altri fratelli, la stessa che Rukeli aveva cantato quei giorni alla figlia. Una nenia che viaggiava di generazione in generazione. Johann aveva afferrato il violino di Stabeli, cominciato a suonare. Non era bravo come il minore, ma era abbastanza capace da saper inventare e suonare sul momento. Suonava inginocchiato di fronte a Frieda, gli occhi negli occhi. Lei lo guardò sorridendo, osservava le dita forti premere sulle corde, il movimento armonioso del braccio che strofinava l’archetto e produceva quel suono soave, gli occhi torbidi che non si staccavano dai suoi. Per lei, non c’era nessun altro lì in quel momento. Nessun altro, nessun altro suono. Solo Johann con il violino e la sua musica. Se non fosse stato un campione di boxe, era sicura che avrebbe avuto un futuro da violinista. Magari in un’altra vita. Pensò, immaginando che quella sarebbe stata la risposta di Rukeli se gli avesse fatto quella considerazione. Finì di suonare, appoggiò il violino sull’erba. Infilò una mano in tasca e ne estrasse una scatoletta di velluto bianco. Brillò un anello. Un cerchio d’oro perfetto, sottile. Frieda era del tutto incapace di parlare. «Olga Frieda Bilda. – cominciò lui, solenne, scandendo ogni sillaba. – La luna e le stelle ne sono testimoni. I nostri amici e le nostre famiglie ne sono testimoni. Tu sei jaaneman. Ci riconosceremo in ogni vita che ci verrà regalata. Da grembo a tomba» Johann deglutì e incrociò di nuovo gli occhi febbrili di Frieda. «Ma non per questo motivo sono in ginocchio. Ti scelgo ogni giorno della mia vita, anche quando litighiamo che mi metti il broncio e voglio attirare la tua attenzione a tutti i costi; ti scelgo perché sorrido tutte le mattine, appena apro gli occhi e ti vedo vicino a me che ancora dormi. E io non so cosa ho fatto per meritare l'amore di una donna come te, che potrebbe avere chi vuole e invece ha scelto me. Sai che non ho molto da offrirti se non la mia compagnia e tutto l'amore che sono in grado di donarti, semplice e ingenuo lo so, ma se non altro è sincero. È tutto quello che ho, e voglio donarlo a te e a Rita. E ti chiedo oggi, di fronte al cielo… posso averti per tutta la durata di questa vita? Vuoi starmi tra i piedi finché non esaleremo l’ultimo respiro?» l’ultima frase l’aggiunse a bassa voce, il sorriso innamorato e scherzoso che le rivolgeva ogni volta che giocava con lei. Frieda si era messa a piangere, le mani sulla bocca. Fece di sì con la testa, totalmente incapace di parlare. E nel caos degli applausi per i futuri sposi, lui le sussurrò ancora: «Ora la proposta è valida, direi» ghignò, riferendosi alla notte a Praga. Johann infilò l’anello al dito di Frieda, minuscolo tra le sue, e la strinse forte a sé sussurrandole ancora e ancora quanto l’amasse. ECCO LA PUPAAAA♥ Il 18 marzo 1935 nasceva Rita Edith Trollmann, che quest'anno ha compiuto la bellezza di 82 anni! Io non conosco nulla di questa donna, vedo le sue foto ora che è anziana e cerco di immaginarla più giovane. Somiglia molto al padre: ha lo stesso taglio degli occhi, le stesse labbra e sorriso, lo stesso naso. Ora è anziana, quindi la pelle andando un po' a cadere ha "deformato" alcuni tratti. Da questo momento in poi la vedremo spesso e vi avviso: la sua personalità sarà del tutto inventata. Non so chi sia Rita Trollmann, come abbia affrontato la guerra etc, cercherò di fare una ricostruzione romanzata, per così dire, più verosimile possibile. Ora finalmente c'è un anello al dito, presto verrà ufficializzato tutto. Tecnicamente, Johann avrebbe riconosciuto Rita come propria figlia a dicembre del 1935. Ma non conoscendo il perché di tale scelta, ho evitato di inserire questa informazione. Se volete lasciatemi una recensione ♥ Buon inizio settimana, alla prossima! ♥ |
Capitolo 24
*** 2.24 - Tutto cominciò da uno sguardo ***
24. Alles begann mit einem Blick
1 giugno 1935 Il comune del distretto di Charlottenburg era sulla Otto-Suhr-Allee. Un imponente edificio in sfarzoso stile guglielmino per rappresentare al meglio la ricchezza dell’allora città borghese Charlottenburg, divenuta poi parte di Berlino come distretto e quartiere. L’aspetto cupo, alti finestroni, la torre era persino più alta del castello del quartiere e misurava ottantasei metri. Il 1 giugno 1932, Johann e Frieda si baciarono per la prima volta sulla ruota panoramica al luna park del Tiergarten, come testimone l’angelo sulla cima della colonna della Vittoria. Quello stesso giorno, a distanza di tre anni, si sposavano. La sala si chiamava Cielo Floreale (Blümchenhimmel). Era tondeggiante, il soffitto a cupola con un motivo floreale appunto, le pareti bianche e rifiniture in legno di noce. Corridoi in alto, sopraelevati. Gli sposi sotto l’arcata in fondo alla stanza, le panche con gli invitati intorno. La cerimonia in comune prevedeva semplicemente una firma, pochi preamboli e poco romanticismo. Ciò non impedì a Rosa Vowe di cucire un abito da sposa per sua nipote e nemmeno a confezionarne uno per Johann. Frieda vestiva con un abito che lasciava le spalle scoperte, si allacciava dietro il collo. Il corsetto in pizzo elaborato, un laccio sul girovita, la gonna ampia in tulle con ricami di pizzo a decorarla. I capelli tirati su sulla testa, due ciocche ondulate a incorniciarne il viso, un diadema delicato dal motivo floreale sul capo. Bracciali di perle, orecchini in argento, la collana che le aveva regalato Johann al collo. Si era rifiutata categoricamente di indossare il velo: «Non ti azzardare a mettermi quell’affare sulla testa». Johann invece aveva un completo elegante, in grigio scuro e non in nero perché: «Ti sposi, mica vai ad un funerale» aveva spiegato zia Rosa. La giacca era più lunga dietro, si allacciava con solo un bottone all’altezza del diaframma. La camicia bianca sotto, niente cravatta, e nel taschino all’altezza del petto, il ragazzo si era preso la libertà di infilarci un fazzoletto blu. «Non sembri uno sposo!» aveva Carlo, guardandolo. Johann stava finendo di abbottonare i gemelli sui polsini della camicia, aveva sorriso. «La fede al dito me la guadagno lo stesso, l’abito non fa il monaco» e lo disse semplicemente per provocare la signora Vowe, che credeva fermamente nel contrario. Rosa gli aveva mollato una pacca sul braccio: «Eh, ma allora non hai capito niente! Sei come quell’altra testona di tua moglie!» «Se fa il monaco, allora avrei dovuto vestirmi di nero» la provocava con un sorriso dispettoso. C’erano tutti. Persino gli amici da Hannover. Paul e Max, Hildi e Bruno, Kaspar e Gilda, erano in prima fila. Le ragazze tenevano la piccola Rita. Johann fu accompagnato all’altare da Friederike, Frieda da suo padre. Il buon vecchio Edmund piangeva come un bambino, ma cercava di non darlo a vedere. In realtà piangevano tutti. Rukeli si passò il pollice sugli occhi, scacciando le lacrime. Man mano che lei avanzava tra le panche, gli tornavano in mente tutti i momenti con la sua Frieda. Il primo sguardo, il suo primo knock-out. Il primo bacio. I loro sguardi, i loro baci, i loro discorsi, i loro sogni di gioventù, gli occhi negli occhi; ogni momento insieme, ogni parola pronunciata, ogni carezza sfiorata. Tutti i ricordi, dal principio a ciò che stavano per diventare, la loro evoluzione. Amici, fidanzati, genitori, ora coniugi. Erano ragazzini quando s’innamorarono, non sapevano nemmeno cosa fosse quel sentimento che bruciava le vene. E sotto certi aspetti, erano ancora ragazzini, ma il sentimento non era cambiato ed erano pronti a combattere contro ogni disuguaglianza. E Frieda era lì, sempre più vicina, sempre più bella. Il sorriso ampio di chi aveva gli stessi pensieri. Il nero degli occhi di Johann accolse il cielo di quelli di lei, come la notte che abbraccia il giorno. Non erano che questo. Sguardi emozionati e cuori frenetici. Le prese il mento tra le dita, posò le labbra su quelle della donna che gli aveva riconsegnato dignità e gioia, la donna che gli stava dando di nuovo un posto nel mondo senza neanche accorgersene. Il ricevimento si tenne a Schönower Heide, al maneggio. Non avevano abbastanza soldi per farne uno con i fiocchi e avevano Rita a cui pensare. Era più comodo tornare a casa e organizzare qualcosa lì, con una bambina così piccola. Mangiarono a volontà, risero, bevvero, cantarono. C’erano tutti. La signora Berger con Clara ed Ulma, Leyendecker e persino Zirzow era tornato apposta. Kaspar, Gilda e loro figlia Teresa. Hildi e Bruno. Max e Paul. Gli zii di Frieda, Vasilij, Boris ed Olga. Zia Rosa ed Hedy. Ferdinand e Mausi, Julius e Franziska con i loro tre figli, Carlo ed Erna e i loro figli, Albert, Stabeli e la fidanzatina. Anna, Maria e Wilhelmine con i loro mariti e i loro bambini. Friederike e suo fratello Robert, il piccolo Edu Weiss, e il nonno Papo. Ivan voleva portare il suo fidanzato, presentandolo come un amico, ma questo non volle saperne niente quando seppe che c’erano gli zingari. L’orso ucraino ci era rimasto male: «Quegli zingari sono parte della mia famiglia, che ti piaccia o no». Tra danze, musiche, cibi tipici ucraini e zingari, si fece il tramonto. In entrambe le tradizioni sinti e cosacche, il rituale di matrimonio prevedeva una fuga degli sposi. Di solito di qualche giorno, ma dal momento che avevano una bambina molto piccola, solo qualche ora. Per consolidare il matrimonio e per buon auspicio. Lo zio Robert consegnò le briglie del cavallo al nipote. Edmund consegnò le briglie di Alfie a Frieda. La ragazza fece una carezza sul muso del suo amato cavallo. Partirono al galoppo a nord di Schönower Heide, verso la boscaglia. «È qui che allenavo Alfie» mormorò Frieda, mentre i cavalli procedevano senza problemi tra gli alberi sottili, i tronchi chiari, le fronde leggere. L’aria estiva profumava di boccioli, foglie fresche, frutti di bosco, legno vivo. Johann guardò Frieda. Così vestita sembrava una regina elfica a cavallo in boschi fatati. E lui un cavaliere nero pronto a dare tutto per la sua sovrana. Legarono i cavalli ad un tronco sottile e li lasciarono lì vicino a pascolare. Stesero il telo a quadri sull’erba appiattita di una radura tra i tronchi, tra piccoli fiori gialli e viola, e steli sottili. Vi si sdraiarono. Gli occhi al cielo. «Mi spiace che ti tocca camminare tra le fratte con questo bel vestito» ghignò Johann. «Oh, non importa. In fondo, si usa solo per un’occasione, non dovrò metterlo di nuovo» Lungo silenzio, interrotto dal cinguettio degli uccelli e i rumori del sottobosco. «Com’è non essere più scapolo?» gli lanciò un’occhiata maliziosa, il sorriso di un gatto che fa le fusa prima di sfoderare gli artigli. «Sono almeno tre anni che non mi sento più scapolo. Nella mia testa, eri la signora Trollmann anche prima di oggi e anche senza un anello al dito. Sono terribilmente fiero di averti dato il mio cognome. È una cosa che mi rasserena, perché ti voglio per me. Sei mia, e io sono tuo, ufficialmente» «Nessuno potrebbe mai portarmi via da te, e nessuno potrebbe mai portarti via da me» gli baciò il naso. Le prese la mano, con l’intenzione di intrecciare le loro dita. Restò, invece, a contemplare la differenza. La mano di Frieda, piccola, arrivava a malapena a metà della seconda falange delle dita di Johann. La porcellana che creava quel contrasto di colore sul bronzo. «Sei così piccola» sussurrò, portandosela alle labbra per baciare ogni sottile dito di lei. «Sei tu che hai le mani enormi. – sorrise. – Guarda che ditone che hai» «Sono le mani di un pugile, che ti aspettavi?» sbuffò un sorriso divertito, alzando gli occhi al cielo. «Ti manca?» Lui si adombrò. «Avevo otto anni quando cominciai. Mi sono allenato ogni giorno da quel momento. La boxe non era la mia passione, era la mia vita. È strano non farlo più, sento i muscoli afflosciarsi, non era mai successo». Frieda abbassò lo sguardo, senza sapere bene cosa dire. Ne aveva passate tante, ingoiato troppi bocconi amari e subìto troppe ingiustizie. Non poteva limitarsi ad un semplice “mi dispiace”. Preferì tacere, e lui interpretò bene quel silenzio. Le sfiorò una guancia con la punta delle dita, il sorriso dolce e rassicurante: «Ma ora è tutto diverso. Ci sei tu, c’è Rita. Ci siamo noi e questo mi basta». Prima di congedare tutti gli invitati, aveva bevuto ancora. Era terribilmente su di giri, ma non era chiaro se fosse brillo. Rita si era addormentata attaccata al seno di Frieda, e la ragazza l’aveva poi messa nel suo lettino in casa. Aveva avuto il tempo di lavarsi e mettersi addosso la sua sottana color perla, poi si era messa a sistemare i piatti – già lavati dalle sue amiche. Johann era andato a farsi una doccia, lo sentì trafficare con le ante degli armadi in cerca di qualcosa. Si presentò in cucina con un pigiama enorme su cui erano stampati asinelli. Frieda gli lanciò un’occhiata, strabuzzando gli occhi, prima di scoppiare a ridere. Era ancora ubriaco. «Non ci credo!» «Me lo ha fatto la mia nonnina, volevo fartelo vedere» fece una giravolta e se ne andò di nuovo. Poco dopo, tornò in cucina. Frieda alzò gli occhi al cielo, con un sorriso. «Serve qualcosa?» Lui si aggirava dietro di lei, aprendo la dispensa in cerca di qualcosa. «Ho fame». Frieda si voltò a guardarlo. Non aveva i pantaloni. Non aveva le mutande. Il barattolo di biscotti aperto era posto proprio davanti al pube. Lei lo fissò sfarfallando le ciglia, e quando sollevò lo sguardo fino ad incontrare i suoi occhi, lui le regalò un sorriso da cattivo ragazzo. «Vuoi un biscotto?» la incalzò, malizioso, ammiccando con le sopracciglia mentre masticava. Lei scoppiò a ridere gettando la testa indietro. «Oh, Signore. Sei ubriaco!» «Per niente. – replicò alzando il mento. ─ Ma se vuoi un biscotto, sai dove trovarlo. Per te ce n’è uno bello gros--» «Forse è il caso che tu vada a dormire» «Non riesco se non ci sei tu, biondina» sussurrò, baciandole la guancia. Sembrava un bimbo in cerca di attenzioni. Lei si sciolse, teneva le mani sul suo petto. «Senti, tra poco arrivo. Voglio finire di sistemare qui. Non fare rumore, che sennò Rita si sveglia» «Ho capito, vado. Addio», e si allontanò. Frieda si morse il labbro, abbassando lo sguardo. Tornò sui piatti, sui bicchieri e sulle posate da asciugare e mettere apposto. Ripensò alla sua vita. L’infanzia nelle campagne, la Guerra, la perdita di sua madre, l’equitazione, i campionati, le estati alla comunità cosacca in Ucraina, la caccia nei boschi con Ivan ed Edmund. Il titolo, la crisi del padre, il ritiro, i suoi sogni, i suoi progetti. La sua fatica per racimolare i soldi per l’università e scoprire di non potersi più iscrivere perché donna. E poi era arrivato Johann. Era entrato in quel locale, aveva bevuto, l’aveva difesa dal maniaco. Aveva scoperto che era un pugile. L’aveva guardata con i suoi intensi occhi neri, i suoi bollenti occhi da lupo così intelligenti, ed era rimasta sopraffatta. Era cominciato tutto da lì. Da un pugno e da uno sguardo. Da una cucina vuota, da un cubetto di ghiaccio sullo zigomo, da un paio di sorrisi dispettosi. Sei anni erano tanti, di cui cinque ininterrotti. Si erano incontrati che lei aveva appena diciannove anni e lui quasi ventidue. Quante cose si erano detti, quanto si erano divertiti, quanto si erano capiti. Erano cresciuti, maturati, uno inevitabilmente influenzato dall’altra e viceversa. Si erano aiutati a crescere a vicenda. Avevano avuto una bambina. Quel giorno si erano sposati. Avevano fatto tanta strada insieme. Frieda sorrise dolcemente, mentre si allungava per riporre un piatto. Come a intuire i suoi pensieri, Johann fece di nuovo capolino in cucina, i vecchi pantaloncini da boxe che gli facevano da pigiama. Si avvicinò come una pantera alle sue spalle, le circondò i fianchi con le braccia posando la fronte sul suo capo. I corpi attaccati. «Ci stai mettendo troppo. Non è gentile da parte tua farmi aspettare» le sussurrò. Frieda ebbe un fremito. «Mi sono persa in pensieri» «E il naufragar t’era dolce in quel mare?» ghignò lui, scostandole i capelli dalla schiena. «Non immaginavo che conoscessi anche autori stranieri» Le baciò la nuca. «Tu esalti la mia forza e la mia speranza, ogni giorno. Il mio sangue aumenta, quando ti sono vicino, e tu taci. Allora nascono in me le cose che col tempo ti meraviglieranno. Tu mi sei necessaria. – recitò in un sussurro, le labbra sulla pelle, la dolcezza nella voce. - Non andare. Io ti veglierò. Io ti proteggerò. Ti pentirai di tutto fuorché di essere venuta a me, liberamente, fieramente. Ti amo. Non ho nessun pensiero tuo, non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai. Non vedo nella mia vita altra compagna, non vedo altra gioia». Lei inghiottì il groppo dell’emozione. Quelle parole erano di per sé molto forti, ma recitate con la voce di Johann e la sua emozionalità, le provocavano ginocchia molli, farfalle nello stomaco e cuore palpitante. Quasi non riusciva più a parlare, per l’emozione. Ogni volta si meravigliava della reazione che lui le provocava, come se fosse una ragazzina alle prese con la prima infatuazione. Era come innamorarsi ogni giorno, inevitabilmente. «Tanti muscoli e tanto cervello» esalò, quasi senza voce. «Non tutti sarebbero d’accordo». Frieda sorrise, il labbro stretto tra i denti mentre lui continuava a depositare una scia di baci lungo le spalle, il collo, sotto l’orecchio. Le sue labbra le avevano fatto scendere una spallina, le sue mani accarezzavano i fianchi con dolcezza. «Non vedo l’ora che sia domani» le sussurrò con un sorriso premuto sulla spalla. «Perché?» «Perché ogni giorno diventi più bella» Frieda si girò, Johann la bloccò tra il suo corpo e il bancone della cucina. «L’alcool ti rende romantico?» Lui strinse le labbra con un sorrisetto divertito. «E terribilmente eccitato, ma per quello puoi rimediare» Frieda scoppiò a ridere, affondando il viso tra le mani, Johann la guardò quasi con imbarazzo. «Che sfacciato, e il filtro bocca-cervello? Ancora rotto?» gli fece lei, bonaria. «Mai avuto. Ora posso avere un bacio da mia moglie oppure la signora Trollmann vuole continuare a parlare?» La ragazza ridacchiò ancora, poi gli prese il viso fra le mani e gli posò un bacio casto sulle labbra. Quando si ritrasse lo stava guardando sfarfallando le ciglia, angelica. Johann storse la bocca, contrariato, e dopo un secondo Frieda si ritrovò caricata sulla sua spalla come un sacco di patate. Si lasciò sfuggire un gridolino di sorpresa, e lui di rimando le mollò una pacca sulle natiche. «Se Rita si sveglia me la prendo con te» e per qualche motivo, non suonava come un terribile castigo, il suo. Johann si chiuse la porta del corridoio alle spalle stando attento a Frieda, e la lasciò cadere sul sofà nel buio del salotto. Poteva vedere la sua ombra, per lei così imponente, e vide il candore dei suoi denti esposti in un sorriso malizioso e pieno di sottintesi. Non ho voluto fare troppo la romanticona nella descrizione del matrimonio, perché non sono una che ci crede. E poi insomma... con questa storia ne ho di occasioni per scrivere romanticherie HAHAHA La citazione che Johann sussurra a Frieda viene da Il Piacere di D'Annunzio, mentre la frasetta prima: "E il naufragar t'era dolce in quel mare?", è un riferimento a L'Infinito di Leopardi. |
Capitolo 25
*** 2.25 - Un posto nel mondo ***
|
Ein platz in der Welt
17 luglio 1935. New York, Stati Uniti d’America.
Ehilà, Gipsy! Come vanno le cose in Germania? La carriera? Ascolta, amico, io devo riprovarci perché un pugile come te ha il diritto di incantare un pubblico che lo merita, e purtroppo a Berlino, dalle voci che mi giungono, questa opportunità ti sarà sempre più preclusa. Perciò che ne dici di venire qui in America a ricominciare? Io, Machon, e Seeling ti aspettiamo a braccia aperte adesso e gli anni futuri. Fammi sapere. Stammi bene! Max Schmeling 26 luglio 1935. Hannover, Germania.
Ciao, Max! Opportunità già preclusa. Nonostante ciò, sono costretto a rifiutare la tua offerta ancora una volta. Vedi, mi sono sposato ed ho una figlia molto piccola. Senza contare che non posso abbandonare mia madre, i miei fratelli e i miei nipoti. Non c’è un bel clima qui, questo no, ma non posso andarmene. Non adesso. Se non dovessi più vedere la torre della chiesa al mercato di Hannover, mi ammalerò. J. Alla metà di giugno era finito il periodo lavorativo di Johann alla panetteria. Ed alla metà di luglio, la signora Berger era morta dopo un periodo di malore, e aveva deciso di lasciare la casa a lui, nel testamento. Aveva fatto scrivere a Clara una lettera, poi, personale per quel giovanotto in cui gli parlava come una nonna, una mamma, e lui aveva scoperto quel lato del carattere della donna che non era mai trasparito con le parole. Al funerale, Johann la pianse come un bambino che perdeva la madre. Disperato all’idea che quell’anima preziosa non fosse più su quella Terra, a renderla un po’ più bella. Avevano dunque presto lasciato il maneggio fuori Berlino e si erano trasferiti ad Hannover, nella vecchia casa della signora Berger. Clara per fortuna abitava di fronte a loro, aiutava quando era necessario. Per i primi mesi, che Rita era piccola, tenne lei il cane Ulma. Johann riuscì a trovare lavoro al mercato Pötte, a un banco della frutta. La mattina all’alba, prima dell’apertura, andava ad aiutare il proprietario con la sistemazione. Era un brav’uomo, Heinrich. Faceva il professore di letteratura, ma era poi stato allontanato dal mestiere perché non seguiva più le regole imposte dal Reich. Aveva due figli piccoli e una moglie con l’aria pacata. Gli dava sempre qualcosa da portare a casa, e riusciva a tirare avanti così. Era tornato a fare il cameriere nelle osterie della città vecchia, luoghi non frequentati dai nazisti o dai loro sostenitori. A volte si ritrovava con Stabeli: il minore, un virtuoso di violino bello come un poeta maledetto, girovagava per le strade e per i vari ristoranti suonando melodie allegre e racimolando soldi. Da quando scoprì che Johann lavorava nell’osteria Rote Garnelen andava a suonare solo lì. Rita era ancora troppo piccola, Frieda non poteva lasciarla per cercare un lavoro. Il suo ruolo era diventato analogo a quello che i nazisti chiedevano alle donne: casa e bambini. Questo un po’ la indispettiva, ma poi guardava la sua piccola Rita e capiva che non c’era altro che potesse fare. La bambina cresceva sana e forte, era molto espressiva e il suo viso esprimeva facilmente ciò che provava e i suoi gusti. Era innamorata del suo papà. Johann amava passare il tempo con lei: le parlava delle cose che aveva vissuto, delle persone che aveva conosciuto, dei luoghi che avrebbe voluto vedere, le raccontava storie che inventava al momento anche se non era sicuro che lei lo capisse. Quando gli si addormentava in braccio, la portava sul balcone e restavano insieme all’aria della sera, mostrandola al cielo notturno e pregando la luna che potesse farle vedere giorni migliori, in futuro. Quando giocava con lei, sventolava un peluche a forma di elefantino e lei si allungava per prenderlo. «Te lo do solo se mi dai un bacio!» poi era lui che la riempiva di baci, giocando a fingere di mangiarla e facendole pernacchie sul pancino. I contatti con la famiglia, Paul e Max, si fecero più intensi, mentre quelli con Kaspar e Gilda, Hildi e Bruno, erano diventati più sporadici. Ogni tanto si telefonavano, qualche volta gli amici da Berlino andavano ad Hannover per salutarli. A volte Leyendecker faceva una telefonata a Johann: era andato via dalla Germania. Ora si trovava a Londra, con Zirzow, e aveva incontrato di nuovo Hans, che aveva avuto un figlio, si era sposato, continuava gli allenamenti di boxe. Ma né l’allenatore e né il manager volevano più avere a che fare con quel mondo, dopo la disfatta di Gipsy. Kaspar continuava con il pugilato, veniva allenato secondo le regole del Faustkampf. Stava emergendo, si stava facendo strada nel professionismo, portava più soldi a casa. Gilda era incinta di nuovo. Hildi non riusciva, invece. I medici le avevano detto che forse era Bruno ad essere un po’ “debole”, e lei non rimaneva incinta pur desiderando un bambino. Continuava la sua carriera da modella, la sua faccia era su quasi tutte le riviste femminili. Bruno non riusciva più a trovare lavoro, in quanto ebreo. Tuttavia, luglio fu un mese che portò guai. Da parte dell’ospedale, arrivò la prima richiesta di sterilizzazione. Si era fatto settembre. La promulgazioni delle Leggi di Norimberga. La difesa del sangue e dell’onore dei tedeschi. Tutti i non-ariani dovevano astenersi dal rapportarsi con una donna o un uomo ariano. I colpevoli, da ambo le parti, sarebbero stati trasferiti in un campo da lavoro con l’accusa di Rassenschande, l’offesa alla razza. Ciò compromise il rapporto tra Hildi e Bruno, costretti a vivere il loro amore in segreto anche più di prima. Tuttavia non toccò Johann e Frieda. In quanto lei non veniva considerata ariana, per via delle origini slave. Dunque due non-ariani potevano stare tranquilli. Per il momento. Arrivò il compleanno di Frieda alla fine di settembre. Venticinque anni. Rita aveva cominciato a gattonare, poi a tirarsi in piedi aiutata da un sostegno e se tenuta per mano riusciva a fare qualche passo. Poi Natale. Poi il compleanno di Johann alla fine di dicembre. Ventotto anni. Capodanno. Era il gennaio 1936. Ulma ora abitava con loro. Rita voleva sempre salire sulla sua schiena. Con lei, Johann stava riacquistando un posto nel mondo. I muscoli che tornavano ad indurirsi quando sollevava la sua bambina. Quel piccolo corpo che gli restituiva importanza e dignità. I pomeriggi che faceva bel tempo si coprivano molto per evitare l’aria fredda, e uscivano nei parchi. Frieda si metteva sulle altalene con lei in braccio, Johann che la spingeva piano e Rita che rideva. Poi il papà, che era più alto, la metteva sullo scivolo e la accompagnava piano con la discesa. Quando aveva soldi in più le comprava un giocattolo nuovo. Rita era vivace, era capace di fare diverse espressioni nel giro di pochi secondi. Frieda le leggeva tante storie, la sera che erano da sole, le parlava lentamente e la bambina cercava di imitare alcuni suoni con il risultato che imparò presto qualche parola. Quando disse “papà” la prima volta, ci fu un momento di confusione. «Secondo me ha detto pappa» aveva detto Frieda. «A me è sembrato che dicesse papà» «Ho un buon udito, ha detto pappa, fidati» «Sono sicuro che invece ha detto papà, fidati tu» «Pappa» «Papà» «Papà!» aveva urlato Rita, dissipando ogni dubbio. Johann aveva guardato Frieda con un sorriso sfacciato e trionfale, le braccia incrociate al petto. Aveva dieci mesi ora. Ripeteva le parole, gattonava senza sosta, si tirava continuamente in piedi e si metteva spesso a muovere qualche passo da sola. Quando le veniva detto di “no”, si imbronciava piegando le labbra verso il basso. Imparò a bere da sola dal bicchiere, tentava anche di mangiare da sé ma non riusciva bene e si sporcava sempre il bavaglino. A febbraio, Rita camminava da sola e senza problemi. Rifiutava categoricamente i passeggini. Quando la portavano al parco correva, inciampava, si sbucciava le ginocchia e cercava il papà. Johann la prendeva in braccio, le dava un bacio sulle sbucciature. «Ora passa, papà ha dato il bacino magico». Con Frieda facevano l’amore in silenzio, durante la notte: «Solo perché siamo genitori non significa che siamo vecchi e non possiamo spassarcela, no?». A marzo Rita aveva compiuto un anno. Mauso aveva cucito per lei un peluche, Johann se l’era rigirato tra le mani: «Ma come si guarda? Da che angolo dovrei guardarlo?» «Stronzo» Rukeli scoppiò a ridere: «Dai, sul serio, che cos’è?» «È un orsetto!» «Ma ha le orecchie lunghe, Mauso…» «Quanto sei pignolo. Sarà un coniglio, allora». Rita correva per casa, faceva i dispetti alla povera Ulma, faceva anche i dispetti a Clara. Quando le parlavano, sembrava ascoltare con attenzione. Gli occhi si erano rivelati color azzurro, come il cielo, il taglio famelico come quello dei lupi. I capelli neri, ricci. Le labbra carnose, la pelle rosea. A seconda dell’espressione che assumeva, ricordava Frieda o Johann. Era una bambina alta e magra, per l’età che aveva, altri suoi coetanei erano paffuti. Con l’arrivo dell’estate, Johann la portava a pesca con lui lungo il Leine. Si bagnavano i piedi, tiravano piccoli sassi nell’acqua. Lui prendeva quelli piatti, li faceva rimbalzare con maestria. Insegnava a sua figlia e a sua moglie come fare. Era un gioco che faceva sempre quand’era piccolo. Altre volte, con Rita, costruivano piccole dighe con sassi e rametti, e poi restavano sulla riva a fissare l’acqua che la buttava giù. Erano tornati un paio di volte a Berlino, a trovare Edmund ed Ivan. Erano andati al maneggio. Frieda era montata su una delle giumente, più mansuete rispetto ad Alfie, e si era messa Rita tra le gambe. Erano andate insieme a fare una lunga passeggiata tra i cespugli di lavanda di Schönower Heide. Johann era rimasto con i due uomini Bilda, a prendere un caffè. Ora abitavano nel casale. «Le cose non si stanno mettendo bene per noi» disse Edmund. «Avete bisogno di soldi?» domandò Johann. «No, ragazzo mio, non è quello. Per i non-tedeschi. Ebrei, comunisti e slavi sono nel mirino nei nazisti. Gli zingari non ancora. – gli fece un sorriso cauto. – Pare che voi siete ancora una questione sociale, non razziale come noialtri. Noi slavi, in particolare noi ucraini, siamo considerati inferiori al pari degli ebrei. Le cose si stanno mettendo male» Una morsa nel petto. «E Frieda?» «Non lo so. È una questione a sé, quella ragazza. Dalla federazione equestre che le tolse il titolo era considerata una slava, anche da chi conosce le sue origini come i medici ad esempio. Ma è per metà ariana pura. È nata e cresciuta qui in Germania. Anche a vederla sembra appartenere alla “pura razza”» «Non la toccheranno» si espresse Ivan, duro. Il suo fidanzato, quel membro delle SS, gli aveva detto che la “questione” Olga Frieda Bilda sarebbe stata trattata in modo diverso. Era il frutto di un’unione anomala tra ariani e sub-umani slavi, era tedesca ed era apparentemente ariana. Non le avrebbero fatto del male fisico. «Johann» lo richiamò Edmund. Rukeli alzò lo sguardo su di lui, incontrando gli occhi antichi e stanchi, quasi rassegnati, del suocero. Poteva sentire il dolore e la preoccupazione di quel padre sulla propria pelle. Non ci sarebbe stato per sempre, e un oscuro presentimento si era insinuato nel cuore dell’anziano cosacco. Ma la sua preoccupazione non era rivolta a sé stesso, ma a quella sua figliola senza arte né parte, con il destino ancora più incerto di quello di tutti loro. «Ti prego… promettimelo, giuramelo, che quando sentirai che le cose potrebbero andare male, la proteggerai. Ti prego, ragazzo. Lei ha solo te, sei tutto ciò che ha e che le resta» Johann inghiottì il groppo di terrore che gli bloccava la gola. «Non la metterei mai in pericolo, né lei né Rita. Puoi stare tranquillo, perché le proteggerò a qualsiasi prezzo. Preferirei di gran lunga soffrire io, che far soffrire loro». Metà luglio 1936. Giochi Olimpici a Berlino. Gli zingari vennero rinchiusi nello Zigeunerlager nel quartiere di Marzhan, ad est di Berlino, per evitare di rovinare l’immagine della città in caso venissero visti. Robert Ritter e la sua assistente Eva Justin cominciarono le ricerche sugli zingari. Con l’arrivo di settembre, Rita andò all’asilo nido. Frieda riuscì a trovare un lavoro come domestica e portare qualche altro soldo a casa, oltre a quelli di Johann. Ad ottobre, Edmund e Ivan furono prelevati con la forza e caricati su un carro bestiame insieme a ebrei, slavi e qualche comunista. Di loro non si seppe più nulla. Frieda mise a ferro e fuoco le centrali di polizia, chiese uno straccio di spiegazioni per quell’arresto. Qualcuno disse a Frieda che erano stati rispediti in Ucraina, qualcun altro le disse che invece erano stati mandati in un campo, Dachau. A nord di Monaco. La notte dormiva di fianco, dando la schiena a Johann. La sentiva singhiozzare sommessamente, nel tentativo di ricomporsi e non svegliarlo. Sentiva quei pianti nel cuore della notte. Allora lui si voltava verso di lei con tutto il corpo, la stringeva forte tra le braccia. «Ssh… Ci sono io qui, andrà tutto bene» glielo sussurrava nell’orecchio quasi a fior di labbra. Frieda singhiozzava ancora un po’, poi il pianto andava a scemare e lei crollava in un sonno profondo. Arrivò il Natale. Poi il compleanno di Johann, ventinove anni. Capodanno. Anno 1937. Alcuni zingari di Hannover vennero trasferiti nella brughiera di Altwarmbüchener. Nel lager vivevano cinquantacinque persone, in dodici case mobili, senza gabinetti né acqua potabile. All’inizio, gli zingari catalogati come “puri” da Ritter venivano lasciati in pace, l’unico obbligo era girare con il passaporto marrone. L’estate arrivò calda, quell’anno. Johann, Frieda e Rita passavano i momenti di riposo insieme sul lungofiume di Hannover, portando con loro anche il cane. Costruivano dighe con rami e sassi, pescavano, lanciavano sassi piatti, giocavano con la palla. Johann tirava un disco di plastica ad Ulma e lei lo andava a prendere e glielo riportava. A volte si mettevano tutti e tre di buona lena a fare pane e biscotti. Le mani nell’impasto, Ulma che girava scodinzolando in cerca di qualcosa da mangiare. Oppure facevano la marmellata. «Ma puzza, questa marmellata» le diceva Johann, annusando un cucchiaino pieno di quella crema colorata, l’espressione confusa e quasi schifata. «Fa’ sentire». Allora lui avvicinava il cucchiaio al viso, e quando lei inspirava per sentire l’odore, Johann le spalmava la marmellata sul naso. Frieda, d’istinto, gli mollava uno schiaffo sulla mano facendo volare il pezzo d’acciaio e insozzando il pavimento con quella crema variopinta. Lui boccheggiava sorridendo, le sopracciglia inarcate, e restava fermo così per interminabili attimi. Poi si soffermava sul naso sporco della moglie, e scoppiava a ridere con quella sua risata rumorosa e contagiosa, che coinvolgeva subito anche Frieda. Johann aveva ritrovato un equilibrio. La sua bambina aveva due anni ora, era vispa e parlava. Male, certo, ma si faceva capire spesso e volentieri. Era un peperino, sempre più dispettosa. Iperattiva, logorroica. Nessuno sapeva dire se somigliasse più a Johann o a Frieda, sotto questi punti di vista, ma tutti sapevano che in quella bambina erano concentrati gli aspetti più fanciulleschi dei loro genitori. Rita sembrava dar retta solo al papà. Quello che lui diceva, per lei era legge. La rimproverava quando faceva la peste, e lei stava zitta. «Non lanciare più le cose per terra, altrimenti papà si arrabbia, hai capito? Promettimelo, fammi la croce sul cuore». E lei prometteva. La croce sul cuore. Un gesto che Johann faceva a sua madre quando prometteva, sin da bambino. Tante espressioni di Rita la rendevano somigliante al papà da bambino. Avevano lo stesso sorriso, la stessa espressione incredula, lo stesso cipiglio stizzito quando venivano rimproverati; da lui aveva ereditato le labbra, e il sorriso, il taglio degli occhi, il naso e i capelli. Ma aveva gli stessi occhi innocenti di Frieda, lo stesso sguardo dispettoso, la stessa occhiata attenta quando non le tornava qualcosa; da lei aveva ereditato poco, in realtà, Rita somigliava molto di più al padre, i suoi lineamenti decisi erano stati ammorbiditi dall'eredità della madre, sul suo visetto. Facevano la lotta, tutti e tre insieme, buttandosi sul letto matrimoniale. Madre e figlia che si alleavano contro di lui. «Non fiatare, sei in minoranza numerica» gli disse Frieda, il sorriso da folletto. Johann era sdraiato sul letto, le braccia aperte. La moglie a carponi su di lui che gli teneva le braccia bloccate. Le fece un sorriso con il labbro inferiore stretto tra i denti. «Merda, hai ragione, pure il cane è femmina» «Non si dice!» cinguettò Rita, in ginocchio sul materasso vicino a lui. «Eh, papà, ma che parole dici?» lo incalzò sua moglie, spostandosi di lato. «Papà è mio!» «No, è mio» «Allora mamma è mia» dichiarò Johann, sdraiato sul letto con le due in ginocchio vicino. Rita lo guardò male. «Mamma è mia» «No, mi spiace, non te la cedo. È mia e basta» «E Rita? – fece Frieda. – Rita è mia» Johann strabuzzò gli occhi, teatrale. «Come osi, mamma? Rita è mia!» «Non ci provare» E Rita rise, sdraiandosi sopra suo papà mentre con la manina stringeva la veste di sua mamma. Frieda si sdraiò vicino a loro, di fianco. Johann le passò un braccio sulle spalle, stringendole entrambe a sé. Si godette il loro profumo, lavanda e talco per bambini, per interminabili momenti. Era convinto che senza la boxe sarebbe rimasto un guscio vuoto. Invece ora eccolo, con un tipo di felicità molto diversa da quella giovanile che aveva durante i tempi d’oro. Una serenità che lo appagava totalmente, una placida gioia molto diversa da quella esplosiva dei tempi da campione. La boxe, in ogni caso, non sarebbe stata per sempre. Frieda e Rita sì. Le donne della sua vita, gli avevano restituito dignità e importanza, un posto nel mondo, la gioia. La luce negli occhi di Rukeli che incantava le folle era rimasta spenta per diverso tempo, dopo l’incontro con Eder. Loro due gliel’avevano restituita con gli interessi. Era un uomo adesso. Un padre, un marito. Era maturato, cresciuto, la vita familiare si era rivelata più divertente del previsto anche grazie al carattere frizzantino di Frieda. Ovviamente, il suo essere un eterno bambino non l’aveva perso. L’anima di Johann era destinata a non invecchiare mai. «Ulma è mia» mormorò, un ghigno sul viso. «Oh, non ti permettere, è mia Ulma» replicò Frieda. «È mia!» trillò Rita. Ulma si sentì chiamata in causa. Si avvicinò al letto scodinzolando, le orecchie dritte, il capo inclinato. Leccò il piedino della bambina e lei scoppiò a ridere. La sua risata è così simile a quella di sua madre. Vorrei poterla ascoltare per sempre. Il mio suono preferito. Ma l’estate, insieme al caldo, portò con sé una nuova richiesta di sterilizzazione. Stavolta più insistente. A Johann Trollmann fu chiesto di presentarsi in ospedale per una preventiva visita medica alla fine di giugno, anno 1937. BUON ANNO ♥ Capitolo di passaggio, riassuntivo e sbrigativo, ma c'è già puzza di tensioni e pericoli. A proposito di questo, vedremo che il "nomadismo" era considerato un gene malato e trasmissibile (come una malattia o, secondo i Nazisti, la pazzia) e per questo motivo gli zingari dovevano essere sterilizzati. Come se fossero pazzi. A presto e ancora buon anno! ♥ |
Capitolo 26
*** 2.26 - Devlesa ***
DEVLESA
«È stato orribile! Mi hanno fatto fotografie ovunque, mi hanno chiesto ogni cosa!» esclamò Edu in piedi vicino al tavolo della cucina. Le famiglie Trollmann e Weiss si erano riunite a casa di questi ultimi. I sinti di Hannover cominciavano ad essere visitati e schedati. Lupi braccati. Ferdinand stesso disse che alla clinica in cui venne visitato, quello che presumibilmente era proprio Ritter, lo salutò in lingua romanì. Con Edu aveva persino scambiato brevi battute nella loro lingua, segno che era in grado di sostenere una piccola conversazione. Gli zingari non erano altro che la “pura razza” degenerata. Un miscuglio pericoloso di razze deteriorate, come detto dal dottor Ritter. Indegni individui primitivi, come li definiva la sua assistente Eva Justin. Commissionati dal Reich, mandavano avanti il Centro di Ricerca Igiene Razziale e presto Ritter divenne il capo dell’Istituto di Biologia Criminale. Dovevano studiare quelle scimmie primitive che vivevano in carovane. Studiarne i geni, le usanze. Studiavano i rom, i sinti, e gli jenish (i zingari “bianchi”). Vennero suddivisi in puri e misti, con altre sottocategorie siglate da ZN+ e ZN- a seconda se si avvicinavano di più ai puri o ai non-zingari. Gli zingari: perfidi, bugiardi, malvagi, sconclusionati e sporchi. Nomadi e delinquenti, ce l’avevano scritto nel DNA e per tal motivo tale erbaccia andava assolutamente estirpata. Per risolvere la “questione zingara” bisognava recluderli, costringerli ai lavori forzati e infine sterilizzarli tutti, anche i bambini dai quattordici anni in su. Nessuno di quei girovaghi delinquenti doveva moltiplicarsi ancora, come topi, né tantomeno dovevano osare inzozzare la razza ariana portandola alla degenerazione. Ritter e la Justin si dedicavano alla ricerca con anima e corpo. Andavano nei campi in cui erano stanziati gli zingari e prelevavano un po’ di sangue. Con sorrisi affabili e simulando un sincero interesse per la loro condizione, erano riusciti ad avvicinarsi ed imparare persino un po’ della loro lingua. * * *
Johann venne chiamato per la visita medica imposta a tutti i rom e sinti. Aveva finito di sistemare la frutta al banco di Pötte, prima di tornare a casa si presentò all’ospedale di Hannover che offriva un appoggio agli assistenti di Ritter. A Frieda non aveva detto niente, a quell’ora probabilmente dormiva ancora. Erano le sette del mattino, lei si sarebbe svegliata dopo un’ora. Si sarebbe cambiata, poi avrebbe vestito la bambina e l’avrebbe accompagnata all’asilo prima di andare a lavorare. Ripensò a quella routine che le vedeva fare la mattina, quando tornava a casa e prima di buttarsi a letto per un paio d’ore di sonno. Prima della sterilizzazione dovevano visitarlo, gli avrebbero fatto firmare una liberatoria e dopo qualche giorno si procedeva con l’operazione. Tre giorni di ricovero e poi ti sbattevano fuori, a casa, senza più un minimo di capacità di creare la vita. Si muoveva a disagio in quella sala d’aspetto. Poi una signorina magrolina, probabilmente sua coetanea e con i capelli castani legati in una coda alta, lo fece entrare. Gli aveva rivolto un sorriso inizialmente sorpreso. L’aveva fatto accomodare, sfiorandogli il braccio. Entrava e usciva da quella porta continuamente, aveva sempre da dirgli qualcosa. Johann si limitava ad annuire, senza darle troppa importanza. Non era nemmeno una bella ragazza. Con quella faccia lunga, gli ricordava un cavallo. «Il dottor Ritter arriverà a breve» gli disse. Lui fece due più due. Prima che potesse dire qualcosa, il dottore entrò nella stanza e le fece segno di uscire. Lei obbedì, diligente. «Hai già conosciuto la mia assistente, vedo, la signorina Justin» «Già» «Ad ogni modo… - si accomodò dietro la sua scrivania. – Devlesa, Herr Trollmann» Lo salutava in romanì. Se lo aspettava. Johann gli diede corda. «Devlesa, doktari Ritter» Ritter aveva usato “herr” per rivolgersi a lui, evidentemente ignorava che “signor” si dicesse raj e preferiva mischiarci un po’ di tedesco. Ma quella era la lingua di Johann, non si rivolse a lui chiamandolo in tedesco, arzt, ma in romanì, doktari. «Sar helo?» E ora gli chiedeva come stava, come se la passava. Se vuoi ti scrivo un libro, pensò Rukeli passandosi la lingua sui denti. «Mišto, parikerav. – rispose con un sorriso affabile, poi fece il finto tonto. - Džanes romanes?» [4] “Bene, grazie. Parli romanì?” L’altro storse le labbra. «Cino» Poco. «Aba. – annuì. – Allora direi di tornare a parlare tedesco, che ne dice?» «Sì, forse è meglio, danke. Allora, signor Trollmann. Le spiego: io devo determinare se lei è uno zingaro puro oppure misto. Ho cinque indicatori per determinarlo. Le devo chiedere di spogliarsi» Johann inarcò le sopracciglia. «Completamente?» «Tenga le mutande, chiaramente» Incerto, obbedì. Non fece ulteriori domande. Come prima cosa, Ritter prelevò un campione di sangue. Le vene di Johann erano spesso gonfie, in particolare quelle sulle mani e le braccia. La vena nell’incavo del gomito sporgeva, l’ago bucò la pelle d’ambra. Dopodiché fotografò ogni angolo del corpo dello zingaro. Fu una sensazione orribile, si sentì come un animale allo zoo. Lo fece alzare, accomodare sulla pedana per misurare l’altezza e il peso. «Cento ottantatré centimetri, settantatré chilogrammi. – lo trascrisse su un foglio. – Proporzioni corporee giuste, gambe leggermente più lunghe del normale… - rimuginava più a sé stesso che rivolto al paziente. ─ Apri bene gli occhi» Gli puntò una lucina contro. Abbozzò un sorrisetto. «Ecco, ecco. A guardarla, prima, non distinguevo la pupilla. Con una luce invece si riescono a intravedere persino le venature dell’iride. Occhi neri e anima nera, signor Trollmann?» «Spero di no». Si accomodarono, il dottore dietro la scrivania e il paziente di fronte. Ritter scrisse qualcosa su un foglio bianco. La calligrafia indecifrabile, Johann non capì cosa stesse scrivendo. Indagò a fondo. Rukeli gli consegnò il certificato di nascita. «Ha frequentato la scuola, signor Trollmann?» «Sì. La scuola primaria a Burgerstraße ad Hannover e secondaria.. Non me lo ricordo» «Si è diplomato?» «No. Ho la licenza media. La scuola superiore costava troppo per la mia famiglia, sono riusciti a mandarci solo mio fratello Carlo» «Quindi lei sa leggere e scrivere» «Sì, tutti noi sappiamo farlo. Eccetto i miei genitori». Era parte della cultura zingara. Di solito i ragazzini smettevano di andare a scuola a tredici anni per lavorare e aiutare la famiglia. Anche se succedeva che nelle famiglie numerose, solo uno veniva scelto per proseguire gli studi e, se voleva, insegnare ciò che imparava ai fratelli più piccoli. Le femmine invece dovevano smettere prima, a undici anni, perché secondo la tradizione dovevano crescere i figli e tenere pulita la casa. Senza contare che, comunque, i bambini zingari non venivano motivati ad andare a scuola: venivano presi in giro, subivano prepotenze, e quando reagivano venivano espulsi senza troppe cerimonie. Arrivavano ad un punto che non vedevano l’ora di lasciare gli studi. Ritter trascrisse queste informazioni. Tamburellò la penna sul mento. «Con quale mano scrive, signor Trollmann?» «Ha davvero importanza?» si lasciò sfuggire Johann. «Tornerebbe utile saperlo» Ma utile a cosa? «Tutt’e due, dottore» «Ah, è nato mancino dunque» «Sì» A scuola lo avevano corretto, imparandogli a scrivere con la destra dal momento che la mancina era considerata “la mano del diavolo”. Ricordava che gliela tenevano ferma dietro la schiena e la bacchettavano con un bastoncino di legno; poi gli facevano copiare pagine di libri con la destra, per esercitarla e dimenticare l’uso della mancina. «Di solito quale usa?» «La sinistra» Ritter trascriveva parola per parola ciò che gli diceva Johann. «Che tipo di vita conduceva ad Hannover, prima di stabilirsi a Berlino nel 1929?» «Vivevo a Tiefenthall numero cinque. Andavo a scuola, giocavo per strada con gli altri ragazzini. A volte andavo sul Leine. Mia madre cuciva per noi abiti ricavandoli da quelli vecchi di mio padre. Con una sua giacca una volta ne ha tirate fuori due, una per me e una per mio fratello Ferdinand. Ad otto anni ho cominciato gli allenamenti di boxe in una palestra semi-clandestina. – abbozzò un sorriso. – Vinsi qualche campionato da amatoriale, poi arrivai ad essere dilettante e vinsi altri campionati regionali e nazionali. Sono stato campione nazionale dei pesi medi dilettanti dal 1925 al 1928. Mi entravano un po’ di soldi, con quelli. Un po’ li davo alla famiglia ma un po’ me li tenevo per me, ero un ragazzino e volevo divertirmi. Andavo a pattinare, nelle sale da ballo, a vedere le corse di moto, a mangiare in giro» «Il rapporto con i fratelli? Me li dica in ordine» «Con Anna e Maria non avevo un particolare rapporto, ero molto più legato a mia sorella Wilhelmine. – sorrise. – Con Wilhelm ci sono sempre stati contrasti, siamo profondamente diversi. Con Ferdinand da piccoli ci picchiavamo sempre e ci dovevano dividere, ma ora che siamo adulti siamo molto uniti. Anche con mio fratello Julius ho un bel rapporto. Poi c’è Albert, a cui ho insegnato qualche trucchetto per la boxe e l’ho fatto allenare con me. Infine Heinrich, sono protettivo nei suoi confronti» Gli domandò delle date e luoghi di nascita dei fratelli e delle sorelle, e Johann rispose facendo un elenco dettagliato. Ritter ascoltava interessato e prendeva appunti. Gli domandò in modo più specifico della carriera da pugile che lui aveva già accennato: gli esordi con la BC Heros, i campionati dilettantistici regionali e nazionali che aveva vinto, la qualifica per le Olimpiadi del ’29, la BC Sparta Hannover-Linden, il passaggio al professionismo e la carriera fino all’apice, al titolo di campione. Gli chiese del suo stato d’animo dopo la caduta, dopo il ritiro della licenza. Gli chiese della sua vita in quegli ultimi anni, aggiungendo che sapeva del matrimonio e della figlia. Non avrebbe potuto toccarla perché era troppo piccola, non rappresentava un problema. «Vivo con mia moglie e mia figlia qui ad Hannover. La mattina all’alba sistemo la frutta ad un banco del mercato Pötte, lavoro come cameriere nell’osteria Rote Garnelen alla città vecchia. Una vita normale. Mia moglie fa la domestica invece» «E come si sente con questa nuova vita così diversa da quella che conduceva prima? È ben lontano dai ritmi serrati della carriera da pugile professionista!» «Appagato. Quei tempi mi mancano, ma d’altronde una famiglia è per sempre. Il pugilato invece prima o poi sarebbe uscito dalla mia vita» mormorò con una punta di rammarico. «Un’ultima domanda. Vieni soprannominato Rukeli, in famiglia. Cosa significa, perché?» «Ruk in romanì significa albero. Rukeli è vezzeggiativo, alberello. – sorrise. – Mi chiamano così da sempre perché sono alto. Anche i miei fratelli sono alti, certo, ma io ho un fisico più longilineo, slanciato, e anche più piazzato rispetto a loro. Quindi paragonano il mio corpo al tronco di un albero e i miei capelli, che sono ricci e folti, alle fronde. Da qui il nome» «Lei parla molto bene, signor Trollmann» Per essere uno zingaro, eh? «Leggo molto, sarà per quello» «Ah sì? Insolito». Alzò la testa verso Johann, un sorriso a labbra serrate. «Ricapitoliamo, in base agli indicatori per determinare la sua appartenenza a uno zingaro puro o misto. Lei risulta essere uno zingaro puro ma perfettamente integrato». Punto numero 1: aspetto fisico e impressione generale.
Il paziente Johann Trollmann si mostra come un uomo alto 183 cm e pesante 73 kg. Mostra un fisico asciutto, visibilmente allenato. Le proporzioni corporee sono giuste, le gambe leggermente più lunghe della norma. Il paziente mostra una pelle ambrata e pulita, liscia: peli sottili e radi sulle braccia e sulle gambe. Fisiologica assenza di peli sul petto, presenti invece sotto l’ombelico in misura contenuta. Sul viso e sotto le ascelle ci sono segni di depilazione. I capelli sono neri, ricci. Gli occhi sono molto scuri, difficoltà a distinguere la pupilla. Nonostante l’esemplare praticasse, in passato, la professione di pugile non mostra il naso bozzato. L’individuo presenta piccole cicatrici pallide sul viso: sotto l’occhio destro, sul sopracciglio sinistro, sulla palpebra sinistra, al lato destro della bocca. L’individuo non presenta tatuaggi né denti in oro. Complessivamente è un uomo di bell’aspetto. Si presenta con un aspetto consono, è pulito, emana persino un vago profumo. La cultura zingara in merito a tatuaggi e denti d’oro, ornamenti e colori sgargianti, non sembra aver attecchito su questo esemplare. Punto numero 2: appartenenza ad una comunità di lingua zingara. Il paziente Johann Trollmann parla la lingua zingara al pari della lingua tedesca. Deduco, tuttavia, che comunichi in tale lingua sporadicamente in quanto la sua famiglia ormai parla quasi esclusivamente il tedesco. Punto numero 3: legame etnico a partire dalla nascita. Il paziente Johann Trollmann ha un vasto e radicato albero genealogico di etnia sinti. Non ci sono mescolanze con i rom né con altre etnie nomadi. Si è unito in matrimonio e procreato con una donna meticcia non appartenente al popolo zingaro.* Punto numero 4: tipo di vita zingara. Il paziente Johann Wilhelm Trollmann è cresciuto nella città vecchia di Hannover, nella via Tiefenthall numero cinque. Insieme ai genitori, Wilhelm Trollmann e Friederike Weiss, le tre sorelle maggiori e i cinque fratelli. Due maggiori e tre minori di lui. Johann Trollmann è il sesto. Per un totale di nove figli. Come gli altri bambini della città vecchia, zingari e non, è cresciuto in strada e sul lungofiume Leine, inventando di giorno in giorno nuovi giochi da fare e piccole cose da costruire. Ha frequentato la scuola elementare a Burgerstrasse, ad Hannover, ma non ricorda dove ha conseguito la licenza media. Non ha frequentato la scuola superiore. Rivela che il suo rapporto con la scuola e il sistema educativo in generale è stato complicato e conflittuale. Trollmann non ha mai dato segno di voler trovare un lavoro. All’età di otto anni comincia gli allenamenti di pugilato in una palestra popolare semi-clandestina. Ha vinto campionati amatoriali e dilettanti. Fu campione nazionale dei pesi medi dilettanti dal 1925 al 1928. Nel 1928 partecipò e superò le selezioni di boxe per le Olimpiadi di Amsterdam che si sarebbero tenute nel 1929. Venne tuttavia scartato. Nel 1929 entrò nel professionismo grazie ad Ernst Zirzow. In conclusione: la famiglia Trollmann ha vissuto nella miseria quasi totale per lunghi anni, tenendosi sollevati solo grazie ai mestieri dei figli. Punto numero 5: certificato di provenienza. Il paziente ha consegnato il certificato di nascita. Riporta scritto il nome completo, luogo, data e ora di nascita. La firma del signor Wilhelm Trollmann, padre del paziente, consiste in tre croci poiché non sapeva scrivere. Il segretario dell’anagrafe sottoscrive questo dettaglio. Johann Wilhelm Trollmann.
Maschio. Peso: 3,2 chilogrammi. Lunghezza: 50,9 centimetri. Nato a Wilsche (Gifhorn), Bassa Sassonia, Germania. Data: venerdì 27 dicembre 1907. Ora: 8:00 del mattino. Note aggiuntive: Il paziente è un appassionato di motociclette, si esprime con garbo usando un linguaggio appropriato. Sorride molto, è affabile. In merito alle dichiarazioni sulla famiglia, Johann Trollmann ha fornito conferme alle dichiarazioni già rilasciate dai fratelli Wilhelm e Ferdinand. *: Johann Trollmann ha sposato Olga Frieda Trollmann nata Bilda. La quale è nata e cresciuta a Berlino, ma ha un cinquanta percento di sangue slavo. La signora Trollmann sarà oggetto di visite. Quest’ultima parte in merito all’asterisco, Ritter non la lesse al suo paziente.
Guardò Johann, che gli rivolse un cenno d’assenso. Si era rivestito. Attese che Eva Justin riportasse un documento con le foto segnaletiche di Johann e glielo mostrò. C’era una sua foto frontale, una di profilo e una di tre quarti; veniva riportato cognome e nome, il nome zingaro, la data di nascita, altezza e peso, e i nomi del padre e della madre. Rukeli alzò lo sguardo su Ritter, con ostilità e confusione. «La mia assistente le consegnerà i fogli da firmare per la sterilizzazione. Sono liberatorie, non autorizzazioni. Questo documento, signor Trollmann, ci servirà in caso lei decida di fare il furbo e sottrarsi ai suoi obblighi. Ho sentito tanto parlare di lei, ha dato molti grattacapi ai gerarchi con questa sua natura… disobbediente. Perciò faccia molta attenzione, signor Trollmann: il provvedimento per chi si sottrae all’operazione, è il lager». [4] “Džanes romanes?” Espressione usata dai zingari tedeschi. Significa, letteralmente: “Parli alla maniera dei rom?”. Salve salvino! ♥ Ma ciancio alle bande, questo documento non esiste. L'ho scritto io. Ritter era molto interessato agli zingari, sembrava quasi adorarli se non fosse stato per le sue dichiarazioni razziste. Allo stesso modo il dottor Mengele, ma lo vedremo più avanti. Diciamo che grazie a Ritter e Mengele, si dà vita l'eugenetica nazista. Ritter faceva domande molto specifiche e quasi inutili (come appunto la mano usata per scrivere), ed era interessato alla vita zingara. Quindi lo stile di vita, i rapporti con la famiglia e la scuola, i soprannomi gitani. Frieda fu un caso molto particolare, per via delle sue origini. Di norma sarebbe finita in un lager, in quanto slava. Ma essendolo stata solo per metà, nata e cresciuta in Germania, e apparentemente ariana pura, i nazisti non potevano permettersi di "sporcare" la sua immagine. Andava contro la loro ideologia, in un certo senso, mi spiego? VABBE BASTA PATERNALE CHE MI SENTO ALBERTO ANGELA. Se vi è piaciuto e vi va di farmelo sapere, io sono qui; altrimenti un calcio nel regale deretano della sottoscritta. Un grazie e un bacetto in fronte a chiunque deciderà di scrivere una recensione, comunque ♥ Buon fine settimana, alla prossima ♥ |
Capitolo 27
*** 2.27 - Io non vorrei ***
27. Ich würde es nicht mögen
Johann era tornato a casa per pranzo, giustificandosi che il lavoro era durato più del previsto. Poi era uscito di nuovo, insieme a Ferdinand erano andati a prendere un caffè nel pomeriggio. Avevano parlato della visita del minore con il dottor Ritter, dei tre giorni di tempo per decidere per la sterilizzazione. Ferdinand gli aveva consigliato di farla. Era sempre meglio del lager, in fondo. Lui aveva firmato, si sarebbe operato dopo due settimane. Prima di tornare a casa, all’ora di cena, passò a comprare verdure e latte in un emporio. Non appena aprì la porta, un profumo di stufato di carne e patate gli invase le narici. Rita stava giocando con una bambola di legno sul tappeto davanti al divano, Ulma era accoccolata lì vicino e sorbiva pazientemente i giochi della bambina. Aveva quasi tre anni ora. L’asilo era stato un toccasana: lasciava più tempo ai genitori per stare insieme e non trascurarsi, aveva aumentato l’appetito e la creatività, le capacità di linguaggio e di gioco erano molto migliorate. Rita parlava bene, per avere quasi tre anni. Qualche parola non si capiva, ma attraverso il resto delle sue brevi e semplici frasi risultava molto chiara. I capelli erano sempre più ricci, sempre più neri. Gli occhi sempre più simili a quelli della donna che l’aveva messo K.O. solo con lo sguardo. Frieda era in cucina, le mani nell’impasto per il pane, il forno acceso sotto i fornelli. «Non vieni a dare un bacio a papà?» esclamò Johann, accovacciandosi di fronte alla porta e allargando le braccia, ad accogliere Rita che gli era corsa incontro. Gli stampò un bacio sulla guancia e lo abbracciò forte. Non dava segni di volersi staccare, quindi lui la tirò su facendola sedere sul suo braccio piegato. Posò la busta con verdure e latte sul tavolo, si avvicinò a sua moglie di soppiatto come un leone che sta per saltare sulla gazzella. Le fece il verso dell’orso nell’orecchio, come faceva alle ragazzine al parco quando era più giovane. Frieda sobbalzò, facendo volare un po’ di farina. Si voltò per scoccargli un’occhiata a metà tra il rimprovero e il divertimento. Johann si morse il labbro con un sorriso. «Voglio un bacio anche da te» «Hai fatto sporcare tutto, non te lo meriti» replicò lei scoccandogli un’occhiata furba. Quanto la amava. Sempre allo stesso modo, da quando l’aveva conosciuta. Non riusciva a smettere di guardarla con un sorriso, era così immerso nel suo sguardo limpido che si accorse dopo che aveva il naso e le guance sporche di farina. Lei soffiò per scostarsi una ciocca di capelli dal viso, Johann gliela incastrò dietro l’orecchio. «Grazie» «Com’è farsi il bagno nella farina?» Posò a terra Rita, che corse di nuovo a giocare. Frieda gli rivolse un’occhiata dispettosa, agitando il sacchetto di farina nella sua direzione. «Vuoi provare?» «Non ti azzardare, vade retro» «Che sarà mai, solo un po’ di farina!» replicò, falsamente piccata. Johann si leccò il labbro inferiore. «Ma io voglio un bacio». Le sollevò il viso tenendole il mento tra le dita, le posò un bacio lento e dolce sulle labbra. Il miele della sua saliva che sempre lo inebriava. «Ho fame» le sorrise, le labbra che si sfioravano. «Tu hai sempre fame» replicò inarcando le sopracciglia. «È vero, è vero. È una fame che sento il doppio sai?» e sorride, malizioso e sfacciato come solo lui poteva essere. Lei gli tappò la bocca con un bacio veloce, quando si ritrasse scoppiò a ridere. «Sei terribile, sfacciato e sporcaccione!» «Ti sbagli, sono maniacalmente pulito» alzò un sopracciglio, il sorriso trionfale. Alzò gli occhi al cielo. «Comincia ad apparecchiare, visto che hai fame. Tra poco mangiamo». Si voltò, tornando con le mani nell’impasto. Lo modellò seguendo la forma allungata e compatta del pane, affondò la punta del dito. Poi se lo portò alle labbra, succhiando via gli ultimi rimasugli. Johann sorrise malizioso, finendo di sistemare i piatti. «Non posso mangiare la mia cena se ha ancora i vestiti addosso» sussurrò, passandole dietro con nonchalance e aprendo il cassetto delle posate. Frieda avvampò. «Oh, dio» si lasciò sfuggire. Non aveva capito che lui intendesse quel tipo di fame. «Sì, è quello che ti farò gridare». Lei si voltò, esterrefatta. Johann alzò le spalle come a dire che non poteva farci niente se era così. Era su di giri, come al solito. La mattina aveva fatto quell’estenuante visita da Ritter. Gli sembrava un ricordo lontano. Si avvicinò come una pantera, prima che Frieda infornasse il pane. Ci infilò il dito per controllarlo. «A forza di metterci il dito, verrà una specie di pane bitorzoluto, fidati del mio giudizio e basta!» esclamò, le mani sui fianchi. «Silenzio, sono io il mastro panettiere qui» il volto verso il basso, gli occhi che si spostarono sulla sua figura, maliziosi e dispettosi. «Okay. Quindi così va bene, chef?» lo prese in giro lei. Johann la guardò da sotto le ciglia. «Sì, sei diventata brava» «L’allieva che supera il maestro. E ora togliti di mezzo, sei ingombrante, mettiti a tavola» Lui inclinò la testa. «Cattiva» «Brutto» «Cornacchia». Frieda gli schioccò un bacio sulla guancia, tenendogli una mano sull’altro lato del viso. Quando si ritrasse, Johann si accorse che lei gli aveva imbrattato la faccia di farina. Sbuffò dal naso, e alzò gli occhi al cielo con un sorriso. Poi si misero tutti a tavola. Rita raccontò al suo papà cosa aveva fatto a scuola, dello zucchero filato che la mamma le aveva comprato mentre tornavano a casa, della divertentissima pozzanghera in cui si era tuffata facendo imprecare Frieda. Ormai mangiava da sola e non si sporcava quasi mai. Mangiava tutto, ma manifestava una forte antipatia verso gli spinaci e i pomodori. Il pane in tavola era quello fatto da Johann due giorni prima, ma era ancora morbido. Persino Rita capiva la differenza tra il pane che faceva suo padre e quello che faceva sua madre. «Il pane di papà è il più buono». Frieda appoggiò il viso sul palmo della mano e le fece una linguaccia. La bimba le regalò un sorriso da squalo che la rendeva così simile a Johann. Un pezzo di cuore. «Diglielo, bambola. Mamma è solo invidiosa» «Tu però non fai le polpette come le faccio io» replicò, fiera. «Le faccio meglio» «Non è vero, papà! – esclamò Rita, contrariata. – Le polpette di mamma sono le più buone!» Frieda guardò suo marito con un sorriso sfacciato e trionfale, si grattò il naso con il dito medio, facendogli alzare gli occhi al cielo. Misero a dormire Rita nella sua cameretta, dandole il bacio della buonanotte e spegnendo la luce. Loro due, invece, quella notte avevano altri piani. * * * *
Si era fatto settembre. Anno 1937. A Johann era stata comunicata la data per la sterilizzazioneo. Ne aveva approfittato per fare qualche ricerca nella biblioteca di Hannover e chiedere a Gilda per telefono. Si imbarazzava a parlarne con altri, lo faceva sentire meno uomo, in qualche modo. Con lei non aveva questo problema, perché non gli importava del suo giudizio. E poi era l’unica in grado di dargli spiegazioni, essendo un’infermiera. «Mi taglieranno via le palle?» aveva sospirato lui, davanti alla cornetta. Lei aveva riso civettuola. «Ma no, sciocco! Non so come avverrà l’operazione. Ma posso dirti con certezza che eiaculazione ed erezione avverranno normalmente. Semplicemente, verrà impedito agli spermatozoi di fondersi con il resto del liquido seminale» «Esiste un’operazione reversibile o che so io?» «No, mi dispiace». Non lo aveva nemmeno detto a Frieda ancora, anche se avrebbe dovuto. Si sentiva meno uomo. Tutta la sicurezza sfacciata che aveva di sé, tutta la sua boria… sembravano quasi scomparse. La sterilizzazione non avrebbe compromesso la crescita della barba o di altri peli maschili, ma l’avrebbe reso al pari di un bambino prima della pubertà. «Che succede se non mi presento?» aveva sussurrato. Gilda era rimasta in silenzio qualche istante di troppo. «Dipende. Se non hai dato l’autorizzazione, ti arrestano e ti mandano in un campo da lavoro. Se invece hai firmato ma non ti presenti, ti verranno a prendere e ti porteranno in ospedale con la forza. Ma nessuna ripercussione grave come il lager. Perché me lo chiedi?» «Semplice curiosità». Quel giorno Rita era a scuola, sarebbe uscita dall’asilo nel pomeriggio. Frieda non lavorava quel giorno, e Johann avrebbe avuto il turno all’osteria solo in serata. Avevano deciso di fare insieme un giro per Hannover. Lei avvolta nel suo cappotto beige con i bottoni neri, una sciarpetta rossa ed un cappellino di lana rosso da cui uscivano i capelli biondi. Aveva deciso di tagliarli di nuovo, fino alle spalle come quando l’aveva conosciuta. Un po’ gli dispiacque: amava farle le trecce, con i capelli così corti sarebbe stato più difficile. Johann portava un cappotto di cammello con i bottoni di pelle, i pantaloni grigi, una sciarpa sottile, nera a strisce grigie incastrata nel cappotto, ed un berretto grigio e piatto sulla testa. I ricci che uscivano leggermente dalla visiera davanti. Portava i guanti a mezze dita. Si erano fermati a bere qualcosa e a pranzo fuori. Gli faceva bene passare il tempo con lei. Il lavoro, la famiglia, li aveva fatti trascurare più del dovuto. Era da un po’ che non passavano il tempo insieme così, come quando erano amici e fidanzati. «C’è qualcosa che ti angoscia» esordì Frieda, abbandonandosi sulla sedia e incrociando le braccia al petto. Erano al coperto, fuori tirava vento gelido. Il locale era caldo e loro avevano tolto i cappotti, i guanti, i cappelli, le sciarpe. Portavano entrambi dei maglioncini: lei un golfino corto, lui un maglione nero a collo alto. Appoggiò il viso sul palmo della mano, con un sorriso. «Tu dici?» «Oh sì. – mise in bocca un’altra oliva. – Ti conosco quasi meglio della tua famiglia. Sono la tua migliore amica, la tua amante, la tua fidanzata, tua moglie e la madre di tua figlia. Direi che basta» Lui le regalò un sorrisetto furbo. «E cosa mi angoscia, secondo lei, signora Trollmann?» Gustò quel nome rotolargli sulla lingua, la signora Trollmann. Quanto amava guardarla. Frieda si era accorta che qualcosa turbava l’animo di suo marito, all’inizio era stata una delle sue solite intuizioni dovute all’empatia, ma poi aveva cominciato a palesarsi. Perciò nonostante le regalasse sorrisi e occhiate dispettose, lei notava un fondo di inquietudine. Johann si accese una sigaretta con un fiammifero, e lo sventolò per farlo spegnere. Qualcuno una volta gli aveva detto che ogni volta che un cerino si consumava del tutto, un marinaio moriva. Oppure era un soldato? Non se lo ricordava, ma qualcuno moriva. «Non lo so, dimmelo tu» replicò lei, sfarfallando le ciglia. Sbuffò il fumo dalle narici, come un drago. La guardò così intensamente che per un attimo Frieda si sentì a disagio, come un cerbiatto che incrocia gli occhi del lupo un momento prima di essere azzannato. Johanna, in realtà, stava solo decidendo se dirglielo oppure no. Prese un’altra boccata dalla sigaretta e lasciò cadere un po’ di cenere nella scodellina di vetro al centro del tavolo. Sbuffò ancora dalle narici, senza distogliere lo sguardo. Alla fine lanciò un’occhiata fuori dalla vetrata, e lei tornò a respirare. Cercò di placare il battito cardiaco. Quanto potere che aveva, con solo uno sguardo… riusciva a farle trattenere il respiro, battere il cuore, sentire ancora le farfalle nello stomaco e, per qualche motivo, farle salire l’adrenalina. Come se si stesse preparando a scappare. «Devono sterilizzarmi» disse infine, tradendo amarezza. Frieda inarcò le sopracciglia. «Che cosa? E perché mai?» Lui alzò le spalle. «Sono zingaro» Inclinò la testa da un lato, confusa. «E allora?» «E allora non possiamo rischiare di “sporcare” la razza ariana. – mormorò, con voce piatta. – Il nomadismo è un gene che non deve essere diffuso, a quanto pare» «Come se foste malati mentali? Vi trattano così, adesso?» Le lanciò un’occhiata. «A quanto pare. Ed ho il vago presentimento che questo sia solo la punta dell’iceberg, che faranno anche di peggio» «Come fai a non arrabbiarti neanche un po’? Vi trattano come animali! Come se foste malati di mente, geneticamente sbagliati, non so… Non è giusto, non è giusto» Johann schiacciò la sigaretta nel posacenere, ed allungo le mani per prendere quelle di Frieda. Si sporse verso di lei, per guardarla meglio. «Io sono incazzato nero. Non vorrei farlo, ma ho già firmato» «Non sarai meno maschio o meno virile. Fossi stato tu a scegliere di farla, non reagirei male. – mormorò. – Ma, Johann… è forzata. Per motivi assurdi». Lui intrecciò le dita a quelle di Frieda, con una dolcezza che cozzava con la furia che sentiva montare. Aveva ragione, era una condizione imposta. Le imposizioni infastidivano chiunque, ma lui… lui non le sopportava. Talvolta persino le più semplici e logiche regole lo infastidivano, gli stavano strette. «Potresti annullare la decisione» proseguì lei. «Sì, così verrei trasferito in un lager» brontolò. «Allora scappa». Lo disse con una naturalezza tale che gli sembrò giusto, quasi scontato. Poi aggrottò le sopracciglia e strinse appena le dita sulle piccole mani di lei. «Io non vi lascio da sole» «Non per molto. Posso cercare una soluzione mentre ti nascondi» «Lasciarvi sole per fuggire e nascondermi… non mi piace, Frieda, non mi appartiene». Per un attimo, ma solo per un attimo, al telefono con Gilda ci aveva pensato e gliel’aveva chiesto cosa sarebbe accaduto. Aveva avuto un momento di debolezza, ma tutto sommato non era sicuro che l’avrebbe fatto davvero. Avrebbe significato lasciare sole Frieda e Rita, alla mercé dei nazisti. Lui doveva proteggerle, doveva attirare la loro attenzione su di sé per non farla ricadere sulla sua famiglia; non poteva scappare. Era da vigliacchi lasciarle e nascondersi. Lei si stizzì. «Smettila di fare il caprone. Cerca di evitare di sbatterci la testa stavolta, e proviamoci» «Non vi lascerò per scappare e nascondermi» ribadì, stringendo di più le sue mani. «Maledetto testardo, dammi ascolto per una volta! – sbottò sporgendosi verso di lui. – Non accadrà niente. Ti farò sapere io quando potrai tornare, prima devo cercare una soluzione». Non ho molto da dirvi, in realtà, se non che ancora assistiamo all'andamento solito dei capitoli: un po' di momenti spensierati e un po' di momenti un po' tesi. Credo sia la caratteristica più evidente di questa seconda parte della storia, Der Mann. Come ho detto, essendo il nomadismo considerato un gene tipico zingaro ed ereditario - come le malattie mentali, pure - i nazisti ricorsero alla sterilizzazione forzata per questi individui. Secondo Ritter per prevenire il "fenomeno zingaro" bisognava sterilizzarli e ridurli a lavori sfiancanti. Era l'unico modo per renderli utili. Un po' ironico il fatto che riesca ad aggiornare proprio oggi, che è la Giornata della Memoria. Trovo davvero sbagliato dire sempre e solo "Shoah". Dire Shoah porta il pensiero solo agli ebrei, e non è giusto. |
Capitolo 28
*** 2.28 - Farà freddo senza di te ***
Es wird ohne dich kalt
Quella sera avevano cenato presto. Poi si erano seduti sul tappeto di fronte al camino acceso, Ulma accoccolata lì vicino. Si erano messi a fare un puzzle con un centinaio di pezzi. Le manine di Rita che cercavano di incastrare i componenti, Johann che rideva e l’aiutava spiegandole con dolcezza dei lati combacianti. Frieda li guardava. Guardava suo marito, pieno d’amore e affetto nei confronti della figlia. Lo guardava come la toccava con delicatezza, come se avesse paura di romperla, come le spiegava le cose in tono dolce e paziente. Rita era innamorata del suo papà. Come non poteva? Johann si faceva volere bene da tutti. Donne, uomini e bambini. Per questo Frieda non riusciva a capire coloro che lo disprezzavano. Era un uomo dal cuore d’oro, grande e puro. Nonostante tutte le umiliazioni subite, tutte le cattiverie, Johann non credeva nella malvagità. Non credeva che nei cuori di alcune persone si annidasse il male più nero e non capiva come qualcuno avesse scatti di cattiveria gratuita. Lui non credeva nell’esistenza del male, della cattiveria. Era questo il suo problema, la sua innocente ingenuità. Era come un bambino, genuino e onesto. Frieda amava quel suo lato così puro. «La luna è grande. M-ma però l’altro giorno era piccola» commentò Rita, distogliendo la madre dai suoi pensieri. Si era resa conto di star fissando Johann, così intensamente che lui si era voltato e ricambiava lo sguardo. Ma lei era così presa che lo guardava senza vederlo. Le aveva fatto un sorriso sornione, lei era arrossita. «Lo sai perché? – fece lui. – Perché suo figlio sta dormendo» «Il figlio di chi?» domandò la moglie, di getto. «Della luna» Rita e Frieda lo guardarono interrogative. Johann si alzò, prese in braccio sua figlia e la avvicinò alla finestra, mostrandola alla luna. Fuori faceva freddo, non voleva portarla sul balcone come quando era piccola e gli si addormentava in braccio. «Una volta c’era una ragazza. Era come me: pelle scura, capelli scuri, occhi scuri. Era innamorata di un ragazzo della sua comunità, ma lui non la ricambiava. Allora lei è salita in cima ad una collina, una notte che la luna era grande come quella di stasera. Cominciò a piangere, fino all’alba, implorando la luna di sposare quell’uomo». Rita lo ascoltava rapita, gli occhi fissi sul satellite luminoso nel cielo senza stelle rischiarato da quella luce pallida. Anche Frieda era rimasta come paralizzata, ascoltando quella storia. Non sapeva se Johann la stesse inventando. Lo faceva sempre, a volte Rita gli faceva domande a cui lui non poteva rispondere in modo realistico, e inventava storie. Come in quel momento. Non poteva dirle che la luna era un grosso sasso che non emetteva nemmeno luce propria e che i suoi cambiamenti erano frutto di una rotazione rotazione. Avrebbe distrutto la magia, per questo inventava storie da raccontarle: per amplificarla, mai smorzarla. Riprese a parlare. La voce bassa, vellutata. Le espressioni del volto che mutavano in base alla scena che raccontava, come se recitasse. «La luna le parlò dal cielo: “Avrai il tuo uomo, zingara. Ma in cambio voglio il primo figlio che avrai da lui”. La ragazza sapeva che la luna le stava chiedendo il suo bambino per non stare più da sola. “Luna, tu vuoi essere madre ma non puoi in quanto non sei una donna” le disse la ragazza. “Dimmi, luna di platino, cosa speri di ottenere da un bambino gitano?”. «Ma l’accordo venne fatto comunque. I due si sposarono, lei aspettava un bambino. «Da genitori gitani, scuri come me, nacque un bambino con la pelle bianca come il latte, invece che nocciola. Gli occhi grigi, invece che neri come carboni. I capelli bianchi, invece che neri. «Era troppo diverso dai suoi genitori, non poteva essere figlio loro! Il padre si arrabbiò, accusò sua moglie di tradimento. Si sentì disonorato. “Di chi è questo bambino? Tu mi hai tradito!”, urlò contro di lei. Prese in braccio il piccolino, andò fino alla collina dove tempo prima la ragazza aveva pregato la luna. Abbandonò lì suo figlio. La luna aveva ottenuto ciò che voleva, come da patto. Era diventata madre di un bambino che non era il suo e non aveva messo al mondo lei. Da quel momento, la luna fu molto occupata con questo piccolino. Quando la luna è grande così, come quella di stasera, vuol dire che il bambino sta dormendo ed è tranquillo, e lei può illuminare le serate degli uomini; se invece il bambino piange, la luna prende la forma di uno spicchio, si abbassa, per fargli una culla». A Rita la storia era piaciuta, ma non fece rumore perché non voleva svegliare il figlio della luna. Andò subito a dormire anche lei, fingendo che il suo lettino era la il satellite che la cullava. Johann e Frieda restarono seduti sul tappeto a sistemare i pezzi di puzzle nella scatola, Ulma riposava. La storia aveva molto colpito sua moglie. C’era qualcosa di terribilmente sbagliato. La ragazza gitana aveva fatto un patto che prevedeva l’abbandono di un figlio, pur di avere l’uomo che amava. Aveva fatto un patto così doloroso ed era stata accusata di tradimento. Era ingiusto. «L’hai inventata?» «No. Questa volta no. – rispose, piano. – È una leggenda dei kalé spagnoli, ma ha viaggiato per l’Europa e ci ha raggiunti tutti, rom, sinti, romanichals. Tutti. In realtà, nella storia originale, lui era talmente accecato dalla rabbia per il presunto tradimento che ferì a morte la moglie con un coltello. Ai bambini di solito non viene mai raccontata correttamente, si racconta come ho fatto io per ovvi motivi. E pensare che certe cose potrebbero accadere tutt’ora». Frieda sentì una morsa al cuore. Era una leggenda tremenda. Ed era tremendo il fatto che, come aveva detto Johann, certi equivoci dovuti all’ignoranza erano ancora possibili. «Ti è piaciuta?» le domandò, con un sorriso dolce. «È una storia forte, ingiusta» «Nessuna storia d’impatto fila liscia senza ingiustizie» le fece notare, con una punta d'amara ironia. «Già... Da ora Rita non guarderà più la luna allo stesso modo». E Frieda aveva ragione. Per tutta la sua infanzia, Rita avrebbe guardato la luna e avrebbe pensato a quel bambino abbandonato sul monte da suo padre, sentendosi vicina a lui per l’assenza di un papà. Ma non avrebbe avuto idea del perché conoscesse quella storia. Johann abbassò gli occhi. «Andrò via. Per un po’, come mi hai detto. Però… come faremo?» «Tu dove pensi di andare?» «Nella foresta di Teutoburgo. Ci sono alcuni sinti, lì, e non è molto lontana da Hannover». Lei annuì, piano, e si alzò con la scatola del puzzle per riporla su una mensola, vicino alcuni libri. «Quando?» «Stanotte, prima vado e meglio è». Frieda annuì di nuovo, appoggiandosi al bracciolo del divano mentre lui si alzava e si avvicinava. Lo vide titubante, come se non sapesse come comportarsi. Le sfiorò le dita, la mano, il braccio fino a risalire sul viso e accarezzarle gli zigomi con i pollici. Le fece un sorriso incerto: «È stata una tua idea, eh» le ricordò bonario. Lei sospirò e gli scoccò un’occhiata di vago rimprovero. «Lo so. Troverò il modo di contattarti» «Non lasciarmi lì» «Cercherò di fare in fretta. – rispose, determinata, poi però sorrise sorniona. – A meno che non mi piaccia stare senza di te» «Sono sicuro che accadrà. - replicò, dandole un piccolo bacio sulle labbra. – Così come a me piacerà stare senza di te» Frieda ridacchiò, allacciandogli le braccia intorno al collo. «A questo punto perché abbiamo cominciato a convivere e ci siamo persino sposati?» Johann strofinò la punta del naso sul suo. «Ci annoiavamo. – sorrise divertito. – E adesso smettila di baciarmi il collo, bambina, altrimenti finirà che ti prendo su questo divano e non me ne vado più, e avevo in programma di filarmela prima dell’alba» «Farà freddo senza di te» sussurrò con un sospiro lieve, poggiando la testa nell'incavo del suo collo. Le baciò la fronte. «Non potrà piovere per sempre, Frieda, sarà difficile dividerci per tutto quel tempo» «Cosa dirò a Rita?» sospirò lei. «L’idea è stata tua, non ci hai pensato? – ridacchiò. – Beh potresti dirle che sono andato ad aiutare il popolo del bosco, gnomi, elfi silvani, fate» Frieda sollevò le sopracciglia. «Fantasioso» «Fiabesco. – la corresse. – Ai bambini piace. Rita ha due anni, ci crede in queste cose ancora» «D’accordo, va bene» «Tu ora va’ a dormire, mro vòci. Non aspettare sveglia che me ne vada, è tardi». Lei annuì a si scostò da Johann per avviarsi verso la camera da letto. Si infilò sotto le coperte e strinse tra le braccia il cuscino del marito, inspirando quel profumo che ormai conosceva così bene. Scivolò presto nel dormiveglia. Un dormiveglia lieve, che le permise di sentire attraverso il velo del sogno, movimenti leggeri nella camera. Ante che si aprivano, la zip di uno zainetto, frusciare di vestiti. Labbra calde che si posavano prima sulla sua spalla, poi sulla sua tempia, baci lenti dal retrogusto malinconico. La porta di casa che si richiudeva piano e una lacrima che bruciava solcando le guance. * * * * *
Johann tagliò la corda, si nascoste tra i sinti che attraversavano la foresta di Teutoburgo, tra la Bassa Sassonia e la Renania-Vestfalia. Era arrivato fin lì saltando sui camion da trasporto merci, nascondendosi di cassone in cassone. La foresta aveva un aspetto quasi tetro, macabro e oscuro, in molti punti. In altri sembrava il paradiso terrestre. Per trovare i sinti della foresta gli ci volle un po’, ma fu accolto subito come un fratello. Qualcuno lo riconobbe come Gipsy. Johann aiutava gli altri, giocava con i bambini e insegnava loro qualcosa di boxe. I sinti della foresta usavano molto i cavalli, stando con loro per quei mesi si riavvicinò al maestoso animale. Gli sembrava d’essere tornato alle sue radici, e il pensiero tornava inevitabilmente a casa, da Frieda e Rita. C’era un bambino, in particolare, a cui si era affezionato. Si chiamava Tankred, come suo nipote. Era un tipetto malinconico, Johann andava a dargli fastidio per farlo giocare e fargli togliere quel muso lungo. Rukeli dormiva nella carovana di un uomo più grande di lui, di nome Riek. Aveva un incisivo d’oro, la barba incolta e un cespuglio di capelli neri. L’incarnato più scuro di quello di Johann, e le sopracciglia folte e rettangolari. Amava l’alcool e il suo cavallo Gas. Alla domanda del perché questo nome, aveva risposto con una risata sguaiata: «Perché è uno scorreggione!» La sera, prima di dormire, parlavano molto di ciò che avrebbero voluto fare e cosa avevano fatto invece. Riek veniva da Hannover come Rukeli, voleva diventare burattinaio ma la sua fidanzatina morì durante la breve epidemia di peste che colpì la città vecchia nel 1926. Da allora si buttò sull'alcool e non riuscì a combinare niente della sua vita. Johann ricordava quell'anno, come poteva dimenticare? Da sempre la città vecchia era in condizioni disumane ed era facile morire in quell'ambiente. Anche un'amica di Rukeli morì di peste in quell'anno, aveva solo diciannove anni. Il pomeriggio, a volte, Riek si faceva insegnare qualcosa di boxe ma poi finivano a fare una lotta senza regole. Aveva imparato quali bacche si potevano mangiare, quali invece erano velenose. Riek gli insegnò a sparare con il fucile, per prendere qualche lepre o qualche cervo da mangiare. «Eri un pugile o un maledetto cecchino? Dannazione, Rukeli!» gli urlava, e l’altro scoppiava a ridere. Agli uomini spettava la caccia e la raccolta delle bacche, i ragazzi adolescenti dovevano andare a raccogliere la legna. Le ragazze aiutavano le donne con le faccende dell’accampamento. I bambini giocavano, qualcuno imitava il cinguettio degli uccelli. La sera dopo cena le anziane zingare si radunavano intorno al fuoco con i bambini, raccontavano loro le vecchie favole che si tramandavano. Non aveva mai sentito quelle storie. Erano diverse da quelle tra i sinti di Hannover. A volte, finite le storie, ballavano sulla musica di chitarre, violini e tamburelli. Musica che si disperdeva tra gli alberi, fili di fumo del fuoco che ascendeva alle fronde, alle stelle. Stelle. Lo diventeremo tutti, un giorno. Bentrovati! Chiedo scusa per questo grande ritardo, non ho avuto tempo per mettermi al computer e correggere/postare. Questo è un caso, poiché oggi non avevo praticamente nulla da fare e ne ho approfittato. È un capitolo... di passaggio, credo che potrei definirlo così. Nonostante non abbia ricontrollato con chissà quanta attenzione e scritto con un po' di superficialità, ho voluto comunque postarlo. In fondo questa storia sarà soggetta a una revisione, questa versione (nonostante sia la terza che che scrivo, sì giuro) deve essere corretta e rivista, ma mi piace e mi convince perciò non saranno grandi le modifiche. Sto prendendo in considerazione di aumentare un pelino il ritmo della narrazione, e arrivati circa a metà della storia immagino che una volta completa avrà tra i 60 e i 70 capitoli. Sarà parecchio lunga, lo so, ma scriverò anche ciò che accade dopo, oltre la storia di Trollmann - ovviamente sarà una parte molto breve e inventata. Insomma sì, mentre voi festeggiate San Valentino, Johann e Frieda si separano. Il periodo in cui Johann scappò nelle foreste di Teutoburgo viene confuso con un periodo precedente. Qualcuno dice che si rifugiò nella foresta solo con un cavallo, qualcun altro dice che trovò asilo tra una comunità di sinti che attraversava la zona, appunto. Ho preso in considerazione quest'ultima opzione, che mi sembrava più verosimile. Ma non è la prima volta che capitano queste confusioni nella sua storia: la tradizione zingara è esclusivamente orale, e spesso le cose vengono dimenticate o confuse. Fortunatamente la storia di Johann è "recente", abbastanza da essere ricordata piuttosto precisamente nonostante alcune confusioni. Detto ciò, se volete lasciarmi la vostra opinione sul capitolo o sulla storia in generale, sono tutta orecchie e sarò ben felice di accogliere qualsiasi cosa! Basta un feedback, insomma hahah Buon San Valentino, alla prossia ♥ PS: la leggenda raccontata da Johann all'inizio viene davvero da una "favola" dei kalé spagnoli. Un gruppo spagnolo ci fece anche una canzone, ve la lascio: ♪. |