La verità degli Jotnar
(/viewuser.php?uid=153562)
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** Capitolo 1 ***
Capitolo 2: *** Capitolo 2 ***
Capitolo 3: *** Capitolo 3 ***
Capitolo 4: *** Capitolo 4 ***
Capitolo 5: *** Capitolo 5 ***
Capitolo 6: *** Capitolo 6 ***
Capitolo 1
*** Capitolo 1 ***
Dedico questa storia a Violet Acquarius, perché il mantello di Thorfinn è diventato il suo pulisci-naso preferito e a EmilyBlack28 perché Thorfinn NON è Regulus XD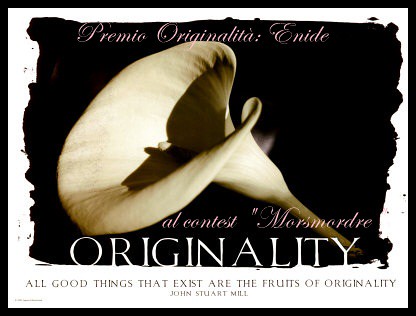
NdA importante: in norreno i Giganti erano chiamati Jotnar (Jötunn al singolare). Secondo la mitologia, esistevano due tipi di Jotnar: gli Hrímþursar o "giganti di brina" e i Múspellsmegir o "giganti di fuoco".
A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada.
|
Capitolo 2
*** Capitolo 2 ***
Capitolo 2Mia madre si chiamava Amelia, ed era originaria di un piccolo villaggio del Devon. Ricordavo ancora perfettamente i suoi occhi marrone chiaro, frangiati da lunghe ciglia, e il suo sguardo caldo e avvolgente. La sua era una famiglia benestante e non molto nota in Inghilterra, ma dallo stato di sangue impeccabile. Anche lei, come me, ricevette la sua lettera per Hogwarts nel suo undicesimo anno di vita. Quando fu il mio turno di prepararmi per andare per la prima volta in quella scuola, temetti il giudizio del Cappello Parlante. Non mi sentivo né coraggioso, né paziente, né ambizioso, né intelligente. Mia madre mi tranquillizzò dicendo che anche con lei il Cappello aveva avuto qualche difficoltà. Era stato in dubbio fino all’ultimo se smistarla tra i Corvonero o tra i Serpeverde. Alla fine, seppur con qualche incertezza, il Cappello Parlante aveva deciso che la sagacia e l’acume di mia madre prevalessero sulla sua ambizione e furbizia, ed io ero d’accordo. Avevo sempre pensato che mia madre fosse una donna generosa e amorevole, e che non avesse fatto niente per meritare il suo destino.Terminati i suoi studi e guadagnato un ottimo numero di MAGO, mia madre si prese un anno sabatico, com’era consuetudine nella sua famiglia. Mio nonno fu entusiasta all’idea che la figlia potesse viaggiare, conoscere nuovi luoghi, nuove culture, nuove forme di magia. Era convinto che uno studio sul campo potesse essere più utile di sette anni chiusi in un castello di pietra a sventolare bacchette e ammuffire sui libri. Tutti in famiglia erano così orgogliosi dell’intelligenza di mia madre che si congratularono per giorni per la sua opportunità di conoscere il mondo. Tutti credevano che sarebbe stato un ottimo modo per permetterle di allargare i suoi orizzonti e mettere alla prova il suo cervello. Fu così che mia madre lasciò l’Inghilterra, intenzionata a esplorare l’Europa, e poi perché no, magari anche gli altri continenti. La sua prima tappa fu la Svezia. Amelia era sempre stata affascinata dalle leggende norrene, dai miti e dagli usi di quei luoghi. Sapeva che la Scandinavia era una terra antica, ricca di tradizioni sconosciute agli Inglesi, culla di una magia potente. Il desiderio di conoscenza di mia madre era effettivamente molto grande, così come aveva previsto il Cappello Parlante sette anni prima. Mia madre aveva previsto di fermarsi in Svezia non più di due settimane, ma, quando giunse il momento di partire, non si mosse. Raccontò ai suoi genitori di essersi innamorata dei paesaggi, della quiete, delle inesauribili fonti di conoscenza. E di un uomo, ovviamente. Mio padre, Odinresk, aveva l’aspetto del classico vichingo, e non solo quello. Alto e massiccio, capelli e barba rossi così chiari da sembrare quasi biondi, occhi azzurri. Le mani erano grandi e callose, probabilmente sarebbe riuscito a spezzare un collo umano senza troppa difficoltà. Ogni muscolo del corpo era perfettamente sviluppato dall’attività fisica e dalle lunghe marce in condizioni proibitive durante la caccia. Nel suo villaggio mio padre veniva considerato un cacciatore leggendario. Laddove non riusciva ad uccidere la preda al primo colpo, si lanciava all’inseguimento della bestia ferita, riuscendo ugualmente a farla sua, prendendola per sfinimento. Non mi fu difficile capire perché mia madre si fosse invaghita di un uomo come mio padre. Ancora più facile fu per me spiegarmi perché lui l’avesse ricambiata. I miei nonni chiesero più volte a mia madre di ritornare nel Devon, ma lei non acconsentì. Essi passarono allora agli ordini e alle minacce, ma lei non si mosse da Fagersta, dove aveva iniziato a convivere con Odinresk. Mi era stato sempre raccontato che l’amore tra i miei genitori fu profondo e travolgente. Quando ero piccolo ci credevo, ma ora non riuscivo più a trattenere una smorfia disgustata ogni volta che la mente rievocava quei ricordi. Amore. L’invenzione più stupida e repellente mai creata dall’uomo. I miei genitori non convivevano che da pochi mesi che mia madre rimase incinta di me. Sorpresa e turbata da questa scoperta, Amelia non seppe come comportarsi, né mio padre le fu molto d’aiuto. Mia madre si sentì, per la prima volta da quando aveva messo piede in terra straniera, davvero sola. Non lo ammise mai, non con me almeno, ma io lo capii dal velo scuro che le ricopriva gli occhi ogni volta che parlava della sua gravidanza. Non sapendo in che altro modo comportarsi, scrisse alla sua famiglia, raccontando tutta la verità. Mio nonno tuonò come neanche Odino Gunnarr, padre della battaglia. Comunicò a mia madre che l’avrebbe aiutata solo se lei e il padre di suo figlio fossero tornati in Inghilterra per sposarsi. Disperata, lei era pronta ad accettare le condizioni di mio nonno, ma non così solerte fu mio padre. Impiegò mesi per convincerlo che l’aiuto di qualcuno della sua famiglia sarebbe stato necessario, dato che Odinresk non aveva parenti in vita, né alcuno che potesse aiutare la coppia con il loro primogenito. Fu così che io nacqui a Fagersta, tra la neve, i neri tronchi d’albero protesi verso il cielo, il ghiaccio delle montagne, l’ululato dei lupi in lontananza. Amelia non fu felice come dovrebbero esserlo tutte le madri dopo il parto. Inveiva contro l’uomo che l’aveva ingravidata, sostenendo che le avesse rovinato la vita, inveiva contro la terra inospitale in cui era costretta a vivere e contro la solitudine che l’opprimeva. Quando mia madre non gridava, piangeva. Da adulto capii che si trattò sicuramente di depressione post partum. Fu allora che anche mio padre si accorse del grande bisogno d’aiuto che avevano, e acconsentì a venire in Inghilterra: la preoccupazione per le condizioni di mia madre prevalse sul suo attaccamento alla terra natia. Odinresk e Amelia tornarono quindi nel Devon, dai miei nonni materni, e si sposarono nella cappella della loro grande casa di campagna. Come magicamente risanata dal ritorno in patria e in famiglia, mia madre guarì in fretta, e le cose tornarono ad andare per il meglio. Con il tempo, anche i miei nonni impararono a conoscere mio padre, e a volergli bene. Ricordavo i miei primi undici anni come un’infanzia molto piacevole. Più crescevo, più tutti si convincevano della mia somiglianza con mio padre. La mia famiglia era sicura che avessi preso da lui la corporatura massiccia, gli occhi azzurri e il pallore della pelle. I miei capelli biondi invece dovevano essere il punto di incontro tra il colore della capigliatura di mio padre e quello delle chiome di mia madre. Fui istruito a casa con un precettore, era un uomo anziano e un po’ burbero, ma molto paziente. Con lui imparai a leggere, a scrivere e a far di conto, inoltre mi insegnò la storia, la geografia, le scienze. Avevo circa sei anni quando si manifestarono in me le prime scintille di magia; tutti i miei parenti erano estremamente fieri di me. Nonostante fosse passata praticamente una vita, ricordavo ancora perfettamente come avvenne. Mio padre, rimasto legatissimo alla cultura e agli usi scandinavi, usava portarmi a caccia nei boschi di proprietà di mio nonno. Si lamentava sempre che la selvaggina fosse troppo piccola e meno feroce di quella della nostra terra natale, ma ogni tanto riuscivamo ad abbattere qualche cervo. Nonostante le deboli proteste di mio nonno, mio padre mi portò nei boschi fin da quando ero piccolissimo. Ancora non avevamo avuto la certezza che avessi poteri magici, perciò cacciavamo con arco e frecce. Mio padre però portava sempre la sua bacchetta infilata nella cintura, nell’eventualità in cui il suo utilizzo fosse stato indispensabile, e io fui fin da subito attratto da quella misteriosa ma potente stecca di legno. Un giorno che mio padre mi portò tra i boschi, scorgemmo presto uno splendido esemplare di cervo: il manto era chiaro e lucente, le corna enormi e ramificate. Era una bestia giovane e perfettamente in salute. Non sarebbe stato facile riuscire ad abbatterla, perciò non mi sarei stupito se avesse voluto provarci mio padre. Invece lui insistette affinché tentassi io. Finalmente riuscimmo a braccare il cervo in una radura, ma, per la tensione, la freccia che avevo incoccato nel mio arco mi sfuggì di mano e colpì l’animale in un punto che non gli fu letale. Mio padre non mi rimproverò per l’errore, ma mi spronò a gettarmi all’inseguimento del cervo ferito. Con ostinazione mi infilai a testa bassa nel folto degli alberi, seguendo la scia della bestia. Dopo un po’, con mio grande disappunto, mi accorsi di averla persa. Mio padre era rimasto un po’ indietro, volendo lasciarmi fare da solo. Non avrei mai voluto deluderlo tornando da lui a mani vuote. Fu così che mi arrampicai su un albero che protendeva i suoi lunghi rami su una radura, attraversata da un gorgogliante corso d’acqua. Prima o poi il cervo si sarebbe venuto ad abbeverare, avrei aspettato anche tutta la notte, se necessario. Ma le mie speranze vennero esaudite prima del previsto: quando vidi il collo lungo e muscoloso dell’animale chinarsi verso il ruscello, incoccai un’altra freccia nel mio arco. Tesi bene la corda: intendendo evitare altri errori. Ma prima che potessi scoccarla, preceduto da un sinistro scricchiolio, il ramo sul quale sedevo si ruppe, precipitandomi al suolo. Riuscivo ancora a sentire l’urlo di mio padre, affacciatosi alla radura appena in tempo per vedermi venire giù dall’albero. La paura che provai mi impedì di ricordare successivamente cosa accadde, sapevo solo che d’un tratto mi ritrovai comodamente seduto su un mucchio di foglie secche ai piedi dell’albero, al sicuro. Nelle mani stringevo solo l’arco, vuoto. La freccia emergeva dal collo del cervo, stramazzato al suolo, con il sangue che gorgogliava dalla carotide recisa. Quel giorno compii per la prima volta una magia. E uccisi il mio primo cervo. Da quel momento in poi, non cacciai mai più con arco e frecce. Io e i miei genitori provammo un’emozione simile quando, in occasione dei miei undici anni, ricevetti la lettera di ammissione ad Hogwarts. Partii per il mio primo anno di studi con il sorriso sulle labbra e l’immagine di mia madre che mi salutava sventolando un fazzoletto negli occhi. Il Cappello Parlante mi smistò tra i Serpeverde, quella fu davvero un’ottima scelta, pensai posando lo sguardo sul Marchio Nero impresso sul mio avambraccio sinistro. Negli anni successivi circolarono strane storie, secondo cui i maghi appartenuti alla Casa del grande Salazar sarebbero stati i più facili a convertirsi al lato oscuro, alla causa di Lord Voldemort. Non sapevo se quelle voci fossero fondate, potevo però dire che per me le cose andarono esattamente in quel modo. Gli anni che passai ad Hogwarts furono molto piacevoli e soddisfacenti; tornavo a casa solo in occasione delle vacanze di Natale e di quelle estive. La mia era sempre stata una famiglia felice, non vedevo l’ora di recarmi di nuovo nel Devon. Non seppi precisamente quando, ma d’un tratto le cose cambiarono, o forse fu solo che io presto crebbi abbastanza da rendermi conto che erano sempre state diverse da come ero abituato a vederle. Il silenzio composto di mio padre si rivelò essere un ostinato mutismo, i modi pacati dei miei nonni un freddo distacco. Mi accorsi che, nonostante mia madre sorridesse sempre, la luce emanata dalle sue labbra non riusciva a raggiungere i suoi occhi. Come avevo potuto essere cieco per tutti quegli anni? La mia non era una famiglia felice, era solo brava a sembrare tale. Mio nonno non aveva mai potuto perdonare Odinresk per aver messo incinta la figlia. Mio padre non riusciva a sentirsi a casa sua in Inghilterra, rimpiangeva ogni giorno di più i ghiacci e le tenebre della sua amata Scandinavia. Mia madre si era solo illusa di essersi ripresa, di essere riuscita a fare combaciare i pezzi della sua vita, ma mentiva a se stessa. Mi accorgevo dell’atmosfera pesante che si respirava in casa solo nei momenti in cui ero nel Devon per le vacanze, nonostante i miei parenti si sforzassero di mantenere una parvenza di normalità. Chissà che cosa doveva essere quel luogo durante la mia assenza. La svolta però avvenne durante il mio diciassettesimo compleanno. Ero nel salone della villa di campagna dei miei nonni, i miei parenti erano tutti intorno a me. Non riuscii a credere ai miei occhi quando mio padre mi regalò il ciondolo a forma di Drakkar che portava sempre. Dopo aver brindato con il vino elfico, quando i miei nonni e mia madre si furono ritirati nelle loro stanze, mio padre, che per una volta mi sembrava genuinamente felice, mi trattenne, posandomi le mani sulle spalle. Mi disse che presto saremmo tornati in Svezia, a Fagersta. A casa. L’indomani tornai ad Hogwarts senza essere riuscito a riprendermi dalla sorpresa provocatami da quelle parole. Ero insieme spaventato ed eccitato dalla prospettiva di una nuova vita. Inoltre, dopo anni in cui avevo vissuto con gli usi e le abitudini delle terre del nord, parlando con mio padre solo in svedese, l’idea di ritornare a Fagersta mi riempiva di aspettativa. Non passò neanche una settimana che mi arrivò una lettera da parte di mia madre, con cui diceva che mio padre era andato via. Svanito, fuggito abbandonando lei e me. Pochi mesi più tardi, consunta dal dolore, mia madre morì. |
Capitolo 3
*** Capitolo 3 ***
Capitolo 3Rievocando i ricordi della mia infanzia, sentii la rabbia montarmi nel petto, fino ad esplodere quando la mia memoria tornò al mio diciassettesimo compleanno. Mi alzai di scatto dal divano e iniziai a percorrere il mio soggiorno, cambiando bruscamente direzione, come se fossi stato una fiera chiusa in gabbia. Erano passati quattordici anni, eppure ogni immagine, ogni sensazione, bruciava ancora intensamente, come carne viva esposta all’aria. Dai sorrisi di mio padre mentre mi porgeva il ciondolo a forma di Drakkar, dalle sue parole ispirate, mai avrei potuto cogliere cosa stesse meditando di fare veramente. Perché aveva dovuto illudermi con la prospettiva di tornare a Fagersta con lui e con mia madre, quando neanche una settimana dopo era fuggito, senza voltarsi indietro? Da quando quel maiale andò via, non ebbi mai più notizie di lui. Non l’avrei mai perdonato per ciò che aveva fatto a mia madre.Terminati gli studi, mi feci assumere alla Gringott e lasciai la casa dei miei nonni. Non volevo più vivere in un luogo in cui dietro ogni angolo vedevo l’ombra di mia madre. Per il resto, condussi la mia esistenza fingendo di non aver mai avuto un padre. E avrebbe anche funzionato, se solo il Signore Oscuro non mi avesse incaricato di tornare in Svezia, pensai colpendo un tavolo con un pugno con tanta forza da farlo tremare. Non avrei mai potuto prevedere che la strada che avevo intrapreso come Mangiamorte mi avrebbe costretto a confrontarmi con un passato che avevo cercato in tutti i modi di negare e di dimenticare. Un deciso bussare alla porta mi distolse dai miei pensieri. Quando andai ad aprire, scorsi Fenrir Greyback sulla soglia. -Diavolo, hai una cera orribile. Che ti è successo?- mi salutò cordialmente. -Fatti gli affari tuoi.- lo invitai altrettanto cordialmente ad entrare. Con pochi passi decisi, il lupo mannaro fu nel mio salotto, dopodiché si stravaccò senza chiedere il permesso sul mio divano, poggiando gli anfibi sudici di fango su un tavolino. Non che tenessi particolarmente alla mia casa, per me era solo un posto dove vivere. Senza protestare, andai a sedermi di fronte a lui. Fenrir parve contemplare per qualche istante la serie di corna che avevo appeso alla mia parete; presto però si riscosse e tornò a concentrarsi su di me. -Allora? Sei pronto?- Risposi con un irritato suono gutturale, abbandonandomi sullo schienale della poltrona. Lui sapeva di mio padre. Cambiò posizione, andando a sedersi sul limite del divano, posando mollemente le braccia sulle ginocchia, e fissandomi incuriosito e vagamente divertito. -Questo che cosa vuol dire?- -Lo sai benissimo che vuol dire, Fenrir.- risposi seccato, alzandomi in piedi e riprendendo a camminare nervosamente. Di contro, il lupo mannaro si sentiva perfettamente a suo agio. -Non capisco che cosa ti turba.- ribatté tranquillamente, iniziando a pulirsi i denti aguzzi con un’unghia. Con uno scatto gli fui davanti, talmente vicino al suo viso da sentire l’odore di rancido che emanava. Fenrir trasalì. -Lo sai che cosa significa tornare in Svezia per me,- ringhiai, -non fare il finto tonto.- Mi allontanai altrettanto repentinamente, senza però smorzare il mio tono rabbioso. -A te piacerà pure tornare a Fagersta, ma certo, prendila come una gita scolastica. Sarà divertente, come no. Prendiamo questa missione con leggerezza, in fondo è come se il Signore Oscuro ci avesse mandati a comprare le sigarette dietro l’angolo. Forse ci sono un paio di cose che non ti sono chiare: innanzitutto tu non devi tornare nella terra del padre di cui non hai notizie da quattordici anni, inoltre prendere contatto con gli Jotnar non sarà facile!- Fenrir seguitò a tacere dopo il mio sfogo, il sorriso sghembo gli era scomparso dalle labbra. Con aria seria, esordì: -Adesso falla finita.- Sapevo che non meritasse tutto quello che gli avevo detto, ciononostante continuai a fissarlo con le narici dilatate e il respiro ansante. -So che si tratta di una missione importante, cosa credi? Ci siamo uniti al Signore Oscuro da poco, questa è l’occasione che aspettavamo per dimostrare il nostro valore. Non dobbiamo fallire, lo so, neanche se sarà difficile. Lascia perdere tuo padre, non ha niente a che fare con la nostra missione. Devi rimanere concentrato sugli Jotnar, è chiaro? E su nient’altro.- -Già,- sibilai per tutta risposta, -e come credi che li raggiungeremo? Io manco dalla Svezia da una vita, tu comunque da un paio d’anni. Abbiamo bisogno di aiuto per trovare anche un solo Jötunn, e mio padre è l’unica conoscenza che ci è rimasta per metterci in contatto con loro.- Il mio fiato si condensava in nuvolette perlacee che spiccavano sullo sfondo della notte nera. Accanto a me, Dolohov tremava, ma io mi sentivo rinvigorito, come finalmente sveglio dopo un lungo sonno. Eravamo l’uno di fronte all’altro, le schiene aderenti a scabrosi tronchi d’albero. Tendevamo i colli verso alcuni fuochi appiccati ai piedi del promontorio sul quale ci trovavamo: figure nere, alte e minacciose si stagliavano contro le fiamme, dandoci le spalle. Alcuni mucchi più scuri della notte, in quanto non raggiunti dai bagliori sprigionati dal fuoco, suggerivano che si trattasse di un agglomerato di tende e baracche. Alcune urla risuonarono in lontananza, portate alle nostre orecchie dal vento. Non avevano nulla di umano. Distolsi lo sguardo dalle ombre delle figure, che si allungavano per molti piedi sul terreno brullo, per guardare il Mangiamorte di fronte a me. Antonin Dolohov era uno dei maghi più capaci e fedeli al Signore Oscuro, ero onorato di essere stato assegnato a lui. Quando mi accorsi del cenno del capo che mi rivolgeva, trattenni il fiato. Entrambi scivolammo con cautela lungo il promontorio, sgusciando come le ombre tra le quali cercavamo di confonderci. Quando giungemmo alle spalle delle nere figure di fronte al fuoco, queste quasi non si accorsero di nulla. Vedere i loro volti ferini e deformati dalle frequenti trasformazioni non produsse in me alcuna reazione, eccezion fatta per un impercettibile sollevamento del labbro superiore. I lupi mannari tacquero improvvisamente nell’istante in cui scorsero i nostri volti, illuminati dai bagliori del fuoco. Dolohov mosse un passo nella loro direzione, austero, ma non minaccioso. Io rimasi dietro di lui. -Il mio nome è Antonin Dolohov. Vorrei parlare con il vostro capo.- La voce era calma, ma il suo tono non ammetteva repliche. Un mormorio innervosito percorse i lupi mannari davanti a noi. Sembravano tutti interrogarsi sull’identità dei nuovi arrivati, le femmine in particolare erano propense a cacciarci subito. Tra le tende, qualcosa si mosse: un brandello di tessuto era stato sollevato per lasciar passare un lupo mannaro più grande di tutti gli altri raccolti intorno al fuoco. Incedeva lentamente, sembrava non avere nessuna fretta. Si posizionò davanti al fuoco a gambe larghe, i pugni sui fianchi. In controluce, non riuscii a scorgere immediatamente il suo volto. -Chi siete, e che cosa volete?- latrò minaccioso. Dolohov si ripresentò, utilizzando lo stesso tono fermo di prima. Il lupo mannaro lo squadrò per qualche istante, dopodiché proruppe in una risata fredda e selvaggia. -Che cosa ci fate da queste parti? Non lo sapete che questo è il territorio dei mannari? Quei galantuomini del Ministero è qui che ci hanno relegato.- aggiunse poi con tono più cupo. Gli altri lupi mannari si unirono alla sua risata, il capo continuò, più aggressivo: -Andatevene immediatamente, se non volete che io dia ordine alla mia gente di saltarvi addosso e sbranarvi.- Fu un attimo. Con una rapidità che non avevo mai visto in nessuno, Dolohov sguainò la bacchetta, e un istante più tardi si trovava contro il lupo mannaro: con la mano sinistra gli tirava la chioma grigiastra, costringendo il suo capo all’indietro, con la destra gli puntava la bacchetta sulla gola scoperta. Gli altri lupi mannari iniziarono ad agitarsi intorno a noi, muovendosi minacciosamente nella nostra direzione. -Non farei così tanto lo spaccone se fossi in te, lupo! Noi siamo Mangiamorte, imparerai a temerci prima di quanto immagini.- sibilò contro il capo del clan, strattonandolo ancora. In quella posizione, riuscii ad intravedere il suo volto alla luce delle fiamme. -Ma tu sei…- Due lupi mannari di grosse dimensioni si erano portati ai lati di Dolohov; il mago avrebbe attaccato prima di loro, ne ero sicuro. A meno che… -Un momento, fermi!- urlai, affiancandomi al Mangiamorte. I lupi mannari si immobilizzarono, con i denti ancora scoperti in un ringhio sommesso. Dolohov attese qualche secondo prima di lasciare andare il capo. Mi avvicinai a lui, mentre questi mi fissava con timoroso astio. Quando mi riconobbe a sua volta, sollevò le sopracciglia in un’espressione sorpresa. -Rowle? Non ci posso credere, sei Thorfinn Rowle?- Quanti anni erano passati. Ci abbracciammo con fare cameratesco di fronte allo stupore dei presenti. -Non sapevo che il capo clan fosse Fenrir Greyback!- spiegai ad un interdetto Dolohov, -Siamo entrambi originari di Fagersta, in Svezia; lui è una mia vecchia conoscenza. Non mi aspettavo di rivederti.- dissi rivolto a Fenrir. Successivamente, non fu difficile per noi convincere i lupi mannari a schierarsi dalla parte del Signore Oscuro. Quando misi il primo piede in terra scandinava, mi sarei aspettato di provare chissà quale spaventosa e conturbante emozione, ma non accadde nulla del genere. Fenrir sbuffò nella mia direzione, come a volermi sfidare ad aprire bocca su quello che sapeva stessi pensando. Lo ignorai, concentrando la mia attenzione sul manto erboso che stavo calpestando. Era solo erba, uguale in ogni parte del mondo. Sollevai la testa e abbracciai con lo sguardo la pineta alle nostre spalle: solo alberi. Seguii con gli occhi un sentiero bianco di ghiaia, nulla di eccezionale. Inspirai profondamente, avvertendo l’odore di qualche fonte d’acqua nelle vicinanze. Ero nella mia terra natia, e ancora non riuscivo a rendermene conto. Fenrir ed io ci mettemmo in cammino molto presto, desiderosi di darci da fare il prima possibile. Fagersta, la mia città. Guardavo i profili delle case, le vetrine dei negozi e i bordi delle strade come se sperassi di ricordarmeli, ma non mi suggerivano nulla di familiare. Sforzandomi di non pensarci, tirai dritto, fendendo col mio corpo il vento, freddo anche d’estate, che si incanalava tra due file di abitazioni. Fenrir mi seguì docilmente, dopo un po’ mi giunse la sua voce: -Hai una vaga idea di dove dovremmo andare? Dove abita il tuo vecchio?- Naturalmente non ne avevo la minima idea. Mancavo da Fagersta da oltre trent’anni, e avevo perso notizie di mio padre da quattordici, non sapevo neanche da dove dovevo cominciare. Ma qualcosa dovevamo pur fare. -Non lo so. Proviamo a chiedere in giro, che io sappia, Odinresk era abbastanza conosciuto da queste parti.- proposi. Trascorremmo il resto della giornata a chiedere a qualsiasi passante, destando anche qualche sguardo di disapprovazione, probabilmente a causa della nostra insistenza. Ma di mio padre sembrava essersi persa traccia. Verso l’ora di cena, decidemmo di fermarci in un pub. Sembrava un posto abbastanza dimesso, semplice, costruito in legno. Fenrir ed io andammo a sederci al bancone. -Buonasera, vi porto qualcosa?- domandò una voce armoniosa. Sollevai lo sguardo sulla cameriera che aveva appena parlato: aveva lunghissimi capelli biondi che le cascavano lungo le spalle strette, alcune ciocche erano acconciate in morbide trecce. Il viso era illuminato da due scocche rosee, l’espressione dolce. Le braccia erano rotonde e sembravano pronte ad accogliere e a dispensare calore. Quando la cameriera ci portò da mangiare e da bere, non riuscii a staccare i miei occhi da lei, che pareva ricambiare il mio sguardo, come se i nostri bulbi oculari fossero stati poli opposti attratti da un irrefrenabile magnetismo. Finito di cenare, e notato che, eccezion fatta per le nostre persone, il pub era deserto, invitai la ragazza a sedersi accanto a noi. Scoprii che si chiamava Agnes, e la sua voce delicata sembrò sciogliere ogni nodo di tensione in me. Dopo alcuni istanti di banale conversazione, le chiesi se avesse mai conosciuto mio padre. Fenrir ed io ci irrigidimmo di colpo quando lei annuì appena. -Sai dove abita? Puoi portarci da lui? Abbiamo bisogno di vederlo.- -Sì, so dove abita,- rispose sommessamente Agnes, -ma temo non potrete incontrarlo.- -Perché mai?- domandò Fenrir, sbattendo i palmi sul tavolo. La ragazza sussultò, ma quando ripose, per quanto fioca, la sua voce sembrò salda: -Perché è morto sei mesi fa. È stato ucciso dagli Hrímþursar, Jotnar di brina.- |
Capitolo 4
*** Capitolo 4 ***
Capitolo 4Trascorsi la notte in bianco, rigirandomi incessantemente nelle coperte in cui mi ero avvolto. Prima dell’alba, uscii dalla tenda che condividevo con Fenrir, e che avevo costruito con due colpi di bacchetta la sera prima. Agnes ci aveva invitati a restare al pub in cui lavorava, dato che al piano superiore disponeva di alcune stanze, ma sia Fenrir che io ci eravamo rifiutati energicamente. Lui preferiva senz’altro dormire all’addiaccio piuttosto che rinchiudersi in una costruzione umana, si trattava di un’abitudine consolidata in diversi anni. Io ero diventato più insofferente del solito dopo la notizia che Agnes ci aveva riferito.Mi guardai intorno: avevamo scelto per accamparci un punto pianeggiante sul limitare di una foresta che sorgeva appena fuori Fagersta. Il sole si stava evidentemente apprestando a sorgere, dato che le chiome degli abeti in lontananza si stavano tingendo di un azzurro sempre più tenue. Dall’interno della tenda provenne il rasposo e intenso russare di Fenrir. Calcando l’erba sotto ai miei piedi e facendo frusciare il mio mantello, mi allontanai da quella piazzola, andando ad infilarmi tra i rami della foresta. Quando mi fui inoltrato abbastanza da non riuscire più a vedere i profili della tenda, mi fermai dentro un cerchio di alberi. Chiusi gli occhi e inspirai profondamente: l’aria frizzante mi penetrò nelle narici, portandomi gli intensi odori di resina e muschio. La foresta non era ancora così fitta da non permettere ai raggi del sole di superare le chiome degli alberi: sentivo il loro calore sul mio viso. Schiocchi di rami in lontananza mi avvisarono della presenza di qualche animale che si aggirava nel sottobosco. Il mio istinto di cacciatore riaffiorò in me, prepotente e incontrollato. A giudicare dai rumori prodotti, l’animale non doveva essere molto grande. Incedeva rapidamente, ma non riuscivo a distinguere i tonfi prodotti dall’alternanza di tutte e quattro le zampe. Doveva trattarsi di una lepre, o di qualcosa del genere. Senza comandare il mio corpo, sentii le gambe cedere e, senza far rumore, mi ritrovai inginocchiato sull’odoroso muschio che ricopriva il suolo. Le mie braccia si mossero in gesti lenti, come se stessi eseguendo un antico rituale, la mano destra giunse alla cintura e ne trasse la bacchetta in uno sguiscio silenzioso. L’animale si era fermato, ma poco dopo riprese a muoversi: stava venendo verso il punto in cui mi trovavo. A giudicare dalla direzione del lieve alito di vento, non avrebbe annusato il mio odore. Era necessario che non si accorgesse della mia presenza. Persistevo a tenere gli occhi chiusi: avevo imparato ad usare durante la caccia tutti gli altri sensi, riuscendo a fare a meno della vista, che a volte poteva anche ingannare. Il riverbero della luce poteva fare brutti scherzi, i manti delle bestie potevano mimetizzarsi nel sottobosco, ma un odore o un suono correttamente interpretati non avrebbero dato adito a dubbi. Sentii i peli delle mie braccia rizzarsi mentre un altro alito di vento mi portò un odore nuovo, ma che ricordava in qualche modo quello delle lepri che cacciavo in Inghilterra. Tesi il braccio sinistro davanti a me, ad indicare il vuoto, altrettanto lentamente e silenziosamente ritrassi il destro fino a portare il pugno che stringeva la bacchetta all’altezza del mio orecchio. Udii un sibilo alla mia sinistra, ruotai di scatto sul mio ginocchio, lasciando scattare la corda del mio arco immaginario. Bastò un incantesimo non verbale ben assestato, e un tonfo mi avvertì che la bestia era caduta stecchita al suolo. Tornato alla tenda, Fenrir mi accolse con un’esclamazione soddisfatta, motivata dalla vista della lepre col collo spezzato che stringevo in pugno. Gli lasciai cadere l’animale in grembo, per permettergli di soddisfare la sua fame. -Tu non mangi?- mi domandò sollevando il muso imbrattato di sangue dal fianco della lepre. -No.- risposi con tono piatto, -Più tardi dovremo elaborare una strategia per metterci sulle tracce degli Jotnar. Ora mangia senza pensieri, ho una cosa da sbrigare prima.- Quando gli voltai le spalle, avvertii lo sguardo interrogativo del lupo mannaro bruciarmi sulla nuca, ma, quando mi misi in moto, sentii di nuovo il rumore delle sue mascelle che infrangevano le fragili ossa dell’animale. Tornare al pub in cui avevamo cenato la sera precedente fu per me molto facile. Agnes ci aveva detto che lei alloggiava in una delle stanze del locale, quando la trovai, bussai con discrezione. La ragazza mi aprì quasi subito, rivolgendomi la stessa espressione dolce che avevo visto in lei la sera prima. -Portami alla casa di Odinresk.- le dissi, sperando che la frase fosse risuonata con l’autorità di un ordine, ma senza la stessa ostilità. La giovane annuì e mi prese l’avambraccio con una stretta delicata, ma decisa. Sussultai a quel contatto, non sapendo cosa aspettarmi. Nulla avrebbe comunque potuto essere più sorprendente dell’essere inghiottito insieme a lei nel meccanismo della materializzazione congiunta. Apparimmo un instante più tardi in un luogo che non sembrava affatto Fagersta: dalle rade abitazioni e dall’aria dimessa delle stesse, che rischiavano quasi di essere inglobate dalla foresta, dedussi che dovevamo trovarci nella periferia della città. Posai lo sguardo sugli occhi limpidi di Agnes in attesa di assimilare la sorpresa. La sera prima, nessuno di noi aveva parlato di magia: non sapevo che fosse una strega, né avevo avuto conferma del contrario. Lei invece non aveva avuto remore ad eseguire un incantesimo davanti a me. -Sapevo che Odinresk fosse un mago, immaginavo che chi lo stesse cercando lo fosse a sua volta. Specialmente se quel qualcuno è suo figlio.- spiegò lei semplicemente, sorprendendomi ancora una volta. Da quando ci eravamo materializzati nella periferia di Fagersta, Agnes non aveva spostato la sua mano dal mio braccio, né lo fece quando mi condusse verso un’abitazione che era poco più di una catapecchia. -Alohomora.- mormorai, puntando la mia bacchetta contro la serratura della porta d’ingresso, che scattò rumorosamente. Quando fummo dentro, una sola parola mi venne in mente per descrivere gli interni dell’abitazione: abbandono. L’ambiente era avvolto nella semi oscurità, i mobili sembravano disposti a caso, tutto odorava di muffa. Non sapevo cosa di preciso mi avesse condotto lì. La prospettiva di rincontrare mio padre dopo quattordici anni mi aveva innervosito, ma la notizia della sua morte in qualche modo mi aveva placato, legittimando l’emergere della curiosità per quell’uomo un tempo tanto amato, e poi successivamente odiato a morte. Forse speravo solo di trovare la risposta alla morte di mia madre. D’impulso, iniziai ad aprire i cassetti e le ante dei mobili, frugando alla ricerca di qualsiasi cosa. Agnes mi aspettava in piedi vicino all’ingresso, senza fare domande, come se avesse capito che quel comportamento irrazionale da parte mia fosse qualcosa di cui avevo bisogno. Quando mi sentì smettere di frugare in giro, mi chiamò con la sua voce armoniosa: -Va tutto bene?- Non risposi, assorto com’ero nell’osservare alcune fotografie nelle cornici. Tutte ritraevano mio padre, mia madre e me, in diversi contesti della nostra vita. Alcune ci ritraevano in un bosco come quello al limitare del quale Fenrir ed io ci eravamo accampati: io e mio padre reggevamo delle prede appena uccise e sorridevamo. In altre indossavo la mia divisa scolastica, altre ancora erano state scattate in occasione di compleanni o di altre feste. In una ero poco più che neonato e mi aggrappavo alla barba di mio padre. La scagliai con violenza contro la parete di fronte a me, provocando la rottura del vetro e della cornice. Un ruggito smorzato mi proruppe dal petto quando feci cadere tutte le altre fotografie dal piano del mobile su cui si trovavano. Il sangue aveva cominciato a bollirmi nelle vene: perché quell’animale aveva conservato le nostre fotografie dopo averci abbandonato? Qualcosa sulla spalla mi fece trasalire: era il tocco leggero di Agnes. Nel mio scoppio d’ira, neanche mi ero accorto che lei si fosse avvicinata, fino a trovarsi dietro di me. Mi alzai in piedi di scatto, respingendo la sua mano. Agnes si ritrasse silenziosamente, come a volermi lasciare tutto il tempo di cui avevo bisogno per sfogarmi. La rabbia e il nervosismo non si erano smorzati in me, e lei doveva averli captati. Ero infuriato perché tutto mi sarei aspettato di trovare, fuorché le fotografie che ritraevano episodi della nostra vita familiare. Avrei preferito trovare le tracce di un’altra donna, magari di altri figli, prove del fatto che il maledetto si era fatto una nuova vita, gettando la sua vecchia nell’immondizia, come se fosse stata un cartone di succo di zucca scaduto. Già odiavo Odinresk, una scoperta del genere non avrebbe aggiunto nulla di più. Ma quelle fotografie, più che dare delle risposte, facevano sorgere nuove domande. Perché quell’animale era andato via? Come aveva osato essere la causa della morte di mia madre? Una nuova ondata d’ira mi infiammò, e io la sfogai sferrando un pugno contro un armadio, sfondando un’anta. Avrei preferito rompermi le nocche piuttosto che convivere con quegli interrogativi. L’immagine degli occhi di mia madre mi attraversò la mente, e io continuai ad attaccare e a devastare i mobili della casa di mio padre con l’intenzione di non lasciare nulla di integro. Alcune carte mi vennero per le mani, mi preparai a stracciarle, quando leggere il nome di mia madre su quei fogli mi fermò. Con il respiro ansante a causa di quello sfogo, incominciai la lettura, al termine della quale non potei fare altro che accasciarmi sul divano semisfondato. Quei fogli erano tutte lettere che Odinresk aveva scritto ad Amelia, senza mai averle inviate. I toni usati erano dimessi e avviliti, sembrava che mio padre cercasse di convincerla a fare qualcosa. Il penultimo foglio che lessi fu quello rivelatore, e allora le idee che mi ero fatto, le cose in cui avevo creduto per quattordici anni mi percossero come chicchi di grandine impazziti durante una tormenta. Mio padre non ci aveva abbandonati davvero. Rievocai gli eventi del mio diciassettesimo compleanno, in particolare il dono del Drakkar e la sua proposta di tornare a Fagersta. Rividi i suoi occhi luminosi di genuina felicità. Tutti sapevamo che mio padre non aveva mai vissuto bene lo sradicamento dalla sua terra natia. Profondamente legato alla Scandinavia, era venuto in Inghilterra solo su richiesta di mia madre, ciononostante non si era mai riuscito ad abituare. La lettura delle lettere mai spedite mi rivelò come la prospettiva del mio ultimo anno di studi ad Hogwarts avesse indotto mio padre a prendere in seria considerazione l’idea di tornare in Svezia, con mia madre e con me. Amelia non aveva avuto più bisogno di assistenza per crescermi, aveva scritto, né io avrei dovuto più frequentare quella scuola. Convinto che nulla più ci trattenesse in Inghilterra, mi aveva fatto quella proposta il giorno del mio compleanno, e l’aveva fatta a mia madre il giorno della mia partenza per Hogwarts. Evidentemente lei aveva opposto il suo più netto rifiuto. Odinresk doveva essersi sentito profondamente ferito, perché nelle lettere aveva scritto tutte le parole che mia madre gli aveva rivolto in risposta, come se gli fossero rimaste impresse nella memoria e lo avessero ossessionato fino a quel momento. Rimasi esterrefatto nel percepire il veleno che lei gli aveva sputato in faccia. L’aveva ricoperto di insulti, probabilmente sfogando un malessere che si annidava in lei da anni, l’aveva respinto ed era stata volutamente brutale. “Maledetto,” mi avevi urlato contro, “è tutta colpa tua! Sai cosa? Vuoi tornare in Svezia? Benissimo, vattene, tornatene da dove sei venuto e non farti più vedere. E portati Thorfinn, se ci tieni tanto, la mia vita era migliore senza di voi.” Dovevo essere onesto, quelle parole scritte con la scrittura di mio padre, ma risuonate nella mia testa con la voce di mia madre, mi colpirono come uno schiaffo. Odinresk non ci aveva abbandonati, era stata mia madre a cacciarlo via. Lei era morta poco dopo, evidentemente consumata da un malessere diverso da quello che mi ero immaginato. Ciò che contava veramente era però che non era stato mio padre il responsabile. Mi ero consumato d’odio per quattordici anni per un uomo che non aveva colpa. Ancora una volta mi accorsi di essermi dimenticato della presenza di Agnes. Silenziosa e discreta come un fantasma, si era venuta a sedere sul divano accanto a me, pur mantenendo una certa distanza. Da come mi guardava, mi resi conto che era sinceramente turbata nel vedermi in quello stato, ma non voleva essere invadente. Mi rilassai con un sospiro contro lo schienale, come a farle capire che non avevo eretto difese, non contro di lei almeno. Agnes interpretò correttamente il mio segnale, e si arrischiò a posare delicatamente la sua mano sulla mia spalla. Avvertii di nuovo quella strana sensazione, come se lei fosse in grado di sciogliere tutti i miei nodi di tensione. Non seppi perché iniziai a baciarla, forse essere circondato dalle sue tiepide braccia rotonde era l’unica cosa di cui avessi bisogno in quel momento. |
Capitolo 5
*** Capitolo 5 ***
Capitolo 5Quando tornai all’accampamento, erano già calate le ombre della sera. Udendo i miei passi sulla ghiaia, Fenrir uscì dalla tenda che avevamo costruito.-Sua maestà ha riposato bene? La vacanza è di suo gradimento?- mi domandò con aria beffarda. Storsi il naso quando gli risposi di farsi gli affari suoi. -Mentre tu girovagavi per Fagersta, facendo incetta di prodotti tipici, io mi sono dato da fare.- continuò Fenrir, canzonatorio. Il suo tono però, più che disappunto nei confronti della mia sparizione, palesava soddisfazione e compiacimento. -Ho continuato le mie ricerche, e alcuni anziani mi hanno detto dove possiamo trovare gli Jotnar! Gli Hrímþursar non saranno difficili da rintracciare.- Sfilò dalla tasca una mappa parzialmente rovinata, che doveva essere stata innaffiata tra l’altro da una discreta quantità di Whiskey Incendiario dato l’odore che emanava. Il dito tozzo e artigliato di Fenrir indicò la catena montuosa che percorreva il confine della Svezia con la Norvegia. -Dobbiamo solo metterci in cammino e…- -Fenrir.- lo interruppi prima che potesse concludere la frase. Strabuzzando gli occhi per la sorpresa, il lupo mannaro attese che mi spiegassi. -Non so se riesco a farlo.- -Che cosa?!- latrò, schizzando goccioline di saliva tutt’intorno. I suoi occhi erano più sgranati che mai, l’espressione basita di chi aveva difficoltà a capire. Gli raccontai allora che ero stato a casa di mio padre, e gli descrissi dettagliatamente tutto ciò che avevo scoperto su di lui. Dopo gli anni di studi ad Hogwarts, complice la scomparsa di mia madre e l’odio verso mio padre, avevo limitato al minimo i contatti umani. Non solo sentivo di non averne bisogno, ma anzi la frequentazione con altri maghi mi indisponeva e innervosiva, la trovavo insopportabile. Preferivo senza dubbio i vasti e silenziosi spazi del bosco vicino la mia casa. Quando decisi di unirmi al Signore Oscuro, sapevo che fosse la cosa più sensata da fare. Solitario ed aggressivo, avrei potuto impiegare le mie energie al servizio di una causa degna. Era stato tra i Mangiamorte che avevo trovato le uniche anime la cui compagnia non mi infastidiva. Tra loro c’era Dolohov, alla cui supervisione ero stato affidato i primi tempi, e ovviamente Fenrir, che conoscevo da prima che si unisse al Signore Oscuro. Fu forse per questa ragione che trovai sorprendentemente naturale parlare con lui di mio padre, nonostante non fossi espansivo per indole. Lui sapeva dell’abbandono di Odinresk e di tutto ciò che aveva provocato in me, credevo che avesse il diritto di sapere come fossero andate davvero le cose. E di sapere anche cosa mi turbasse. Quando terminai il mio racconto, Fenrir si portò le dita alle tempie, pensieroso. -Capisci?- gli domandai, -Come posso andare alla ricerca dei Giganti di brina per persuaderli ad unirsi a noi e al Signore Oscuro, quando sono stati gli stessi Hrímþursar ad ucciderlo?- -Il fatto che fossero stati gli Jotnar a farlo fuori non aveva costituito un problema fino a poco fa.- obiettò il lupo mannaro. -Hai ragione,- convenni con impazienza, -ma come avrebbe potuto? Ho sempre odiato mio padre, sono cresciuto avvelenandomi per causa sua, pensando che fosse il responsabile della morte di mia madre, e ora scopro che non è così!- -Non lo è?- domandò Fenrir, sollevando un sopracciglio, -Lui vi ha comunque abbandonati.- -Ma è stata mia madre a cacciarlo!- Mi tastai le tasche della giubba nera, rimpiangendo di non aver portato con me le lettere scritte da Odinresk. -Non sai con che parole si è rivolta a lui. Gli ha persino detto che, se avesse voluto tornare in Scandinavia, avrebbe potuto portarmi con sé, che lei sarebbe stata meglio. Quando morì, una settimana dopo la partenza di mio padre, pensai che fosse stato a causa del dolore che lui le aveva provocato, ma non fu così. Evidentemente non si era mai ripresa dalla forma di depressione in cui era caduta.- Tornai a sedermi, la testa tra le mani. -Dunque mi stai dicendo che aver scoperto la verità ti ha fatto venire dubbi sulla missione della quale siamo stati incaricati? O forse sulla tua scelta di unirti al Signore Oscuro?- mi domandò con un’occhiata inquisitoria. Erano in momenti del genere che mi rendevo conto che parlare con qualcuno che conoscevo e che soprattutto mi conosceva bene aveva i suoi vantaggi. Fenrir aveva dato voce ad un sottile seppur insidioso interrogativo che mi si era affacciato alla mente dal momento in cui avevo realizzato la verità su mio padre. Mi ero reso conto che, seppur inconsciamente, l’odio verso di lui mi aveva trasformato e reso quello che ero. Gettai un’occhiata fugace al Marchio Nero sul mio avambraccio, parzialmente nascosto dalla manica della giubba. Se l’odio per Odinresk mi aveva forgiato negli anni, probabilmente era stato anche ciò che mi aveva condotto a diventare un Mangiamorte. L’aver scoperto che mio padre non era il responsabile della morte di mia madre aveva fatto vacillare tutto ciò su cui avevo fondato la mia vita, come se avessi vissuto in una perenne menzogna. La risata di Fenrir mi sorprese. -Thorfinn, fai sul serio? Ma è ridicolo!- Io mi stavo lambiccando il cervello con mille interrogativi, e quello rideva. Piccato, gli chiesi con una certa rudezza di spiegare quello che intendesse. -Puoi crearti tutti gli alibi che vuoi, ma io ti conosco bene. So come sei fatto. Hai odiato a morte tuo padre per quattordici anni, d’accordo. Di sicuro le tue vicende familiari hanno avuto un certo peso nella tua formazione, ammettiamolo pure. Ma non è tutto qui! La sostanza di cui sei fatto non si esaurisce in questo, tuo padre non è la causa di ogni tua azione. Tu, Thorfinn Rowle, hai imparato a vivere per conto tuo e pensando solo a te stesso. Diventare un Mangiamorte è stata una tua scelta. Ricordo quando tu e Dolohov siete venuti tra noi lupi mannari. Parlavi del Signore Oscuro con la stessa convinzione del suo luogotenente. È stata quella convinzione a convincermi ad unirmi alla sua causa!- Io lo osservai mentre parlava, sorpreso dalla profondità del suo discorso. Fenrir non era uno stupido, ma non era avvezzo ad approfondite analisi comportamentali. In quel momento però, sembrava non avere dubbi. -Ascoltami bene Thorfinn,- continuò, scuotendomi per le spalle, -io so che tu ti sei unito all’Oscuro Signore perché volevi davvero farlo. L’odio per tuo padre ti avrà anche incattivito, ma ha trovato in te terreno fertile. Tu sei nato per questo.- concluse sollevandomi di scatto la manica della mia giubba, per rivelare il mio Marchio Nero. Rimasi a guardare il mio avambraccio attonito, come se stessi vedendo quel teschio e quel serpente per la prima volta. Le parole di Fenrir mi risuonarono nelle orecchie per qualche istante ancora: sapevo che aveva ragione. Ripensai a tutte le volte che avevo sollevato la mia bacchetta contro qualche Babbano, Mezzosangue o Sanguesporco. L’esaltazione che avevo provato nello scagliare maledizioni non poteva spiegarsi con l’odio che avevo nutrito per mio padre. Provai ad immaginare la mia vita senza quel Marchio, senza la mia obbedienza all’Oscuro Signore, senza la fede che avevo abbracciato. Non ci riuscii. Dopo che ebbi fatto chiarezza in me, mi sentii molto meglio. Mi faceva ancora uno strano effetto pensare che saremmo dovuti andare a reclutare gli assassini di mio padre, ma sapevo anche che non avevo scelta. Il Signore Oscuro non ammetteva fallimenti o ripensamenti: se fossi venuto meno agli ordini impartitimi, la Sua vendetta sarebbe stata grande e dolorosa. E io mi ero unito a lui con coscienza, accettando tutto ciò che questo avrebbe comportato. Inoltre, come Fenrir mi aveva fatto notare, avevo vissuto fino al giorno prima fingendo di non avere un padre; per quanto la mia opinione su di lui fosse cambiata, non potevo in poche ore cancellare lo stato d’animo di quattordici anni. Era stato deciso che saremmo partiti l’indomani alle prime luci dell’alba per incontrare gli Hrímþursar. Avrei voluto salutare Agnes prima di lasciare Fagersta, così le lasciai detto di farsi trovare all’accampamento che Fenrir ed io avevamo costruito. In attesa di incontrarci, svolsi altre commissioni in città, in modo da avere tutto pronto per la partenza. Quando tornai al limitare del bosco però, Agnes non c’era. Mi accostai alla tenda, in attesa di udire qualche rumore, ma tutto taceva. Quando sollevai il tessuto che ne chiudeva l’apertura e feci il mio ingresso, scorsi Fenrir, stravaccato sul giaciglio che usava come letto, mentre si leccava le dita con l’aria più soddisfatta del mondo. Quando mi fui avvicinato, mi accorsi che quello che tingeva i suoi polpastrelli, il suo mento e la sua barba era proprio sangue. In risposta alla mia occhiata interrogativa mi disse: -Devo ammettere che quella cameriera era davvero tenera. Probabilmente d’ora in poi ci sarà un nuovo lupo mannaro in città!- e proruppe in una risata panciuta. Io non dissi nulla. Ripensai all’aria dolce di Agnes e alle sue braccia rotonde. Non la cercai, né mi misi in contatto con lei: dopo che Fenrir l’aveva inquinata con le sue zanne, non volevo averci più nulla a che fare. |
Capitolo 6
*** Capitolo 6 ***
Capitolo 6Quando uscii dalla tenda, il cielo era ancora nero, ma all’orizzonte dei fumi azzurro-violacei rischiaravano l’atmosfera. Il sole non era ancora sorto, ma non mancava poi molto.Fenrir ed io ci scambiammo uno sguardo d’intesa: era ora di andare. La familiare sensazione di forze provenienti da direzioni diverse che premevano contro il mio corpo accompagnò la Smaterializzazione. Quando aprii nuovamente gli occhi, lo scenario che mi si parò davanti era da togliere il fiato. Ci trovavamo sulla cima innevata di una montagna, bianca e fredda nonostante fossimo in piena estate. Intorno a noi, altre superfici nere di roccia e bianche di ghiaccio e nevischio facevano a gara per raggiungere il cielo viola. L’aria era più frizzante e rinvigorente di quella che avevo respirato a valle, desiderai avere una cassa toracica più grande per contenerla tutta. Il silenzio, in quel luogo impregnato di magia, era assoluto. La neve scricchiolò, rompendo la quiete, quando Fenrir mosse un passo verso nord. Sapevamo grazie alle informazioni raccolte a Fagersta che gli Hrímþursar abitavano le caverne che scavavano i fianchi di quei monti. Con cautela, scendemmo lungo la parete di roccia in direzione del primo antro nero che eravamo stati in grado di scorgere. Di fronte alla bocca della caverna, il mio sangue gelò nelle vene a causa degli spifferi di aria tagliente che, contro ogni legge della fisica, provenivano dall’interno. Feci segno a Fenrir di seguirmi, ed entrambi ci addentrammo nel buio cunicolo roccioso. -Lumos.- mormorai, accendendo la punta della mia bacchetta. A quella flebile luce, notammo diverse gallerie diramarsi davanti a noi. Ognuna era alta diversi metri, ma quella centrale era la più larga di tutte. Decidemmo di seguire proprio quella: sapevamo che il capo di quella tribù di Jotnar avrebbe soggiornato al termine della galleria più maestosa delle altre, era il suo modo per ricordare ai suoi sottoposti la sua superiorità nei loro confronti. Quando i miei anfibi calcarono la nuda roccia, umida a causa delle sgocciolature prodotte dalle stalattiti, mi sentii fastidiosamente piccolo. Percorremmo diversi metri al buio, rischiarato solo dall’Incantesimo della Luce, prima di incontrare alcune torce appese alle pareti grazie a sostegni di grezzo metallo brunito. Sembrava che fossero state ricavate da interi abeti dato che ognuna era parecchio più alta di me e Fenrir messi insieme. Mi volsi a guardare il lupo mannaro: i suoi occhi erano sgranati per lo stupore suscitato dal luogo in cui ci trovavamo. Quelle torce erano la prova che quelle caverne fossero abitate, ma dei Giganti ancora c’era alcuna traccia. Camminammo ancora per quelle che mi sembrarono ore, addentrandoci sempre più nel ventre della montagna. D’un tratto, un fiato di vento accompagnato da un sibilo sinistro ci costrinse a fermarci. Fenrir ed io ci scambiammo delle occhiate nervose, ma non aprimmo bocca, rimanemmo in attesa, con le orecchie tese. Il sibilo si ripeté, ma questa volta risultò più nitido. Sembravano delle parole pronunciate con voce stridente. Dalla cadenza e dal suono, immaginai dovesse trattarsi di un rituale. Mi domandai se interrompere gli Hrímþursar durante l’esecuzione di qualche incantesimo fosse una buona idea, ma non avevamo scelta. Continuammo a camminare, l’eco dei nostri passi ormai sovrastato dalle parole della cantilena, la bacchetta stretta in pugno. Finalmente, dopo una curva a gomito della galleria, mi sentii investire da una luce intensa. Fui costretto a fermarmi e a schermarmi gli occhi con una mano, in attesa di abituarmi a quella luminosità, dopo aver camminato nel buio per tanto tempo. Nello stesso momento, la cantilena tacque: gli Hrímþursar si erano accorti che due intrusi avevano fatto il loro ingresso nella stanza del padre della tribù. Ci fu un lungo silenzio, a segnalare che gli Jotnar non si erano aspettati di venir interrotti in quel modo. Quando avvertii che le mie pupille si erano abituate nuovamente alla luce, sprigionata da delle grandi pietre che si trovavano al centro di quell’antro, abbassai la mano dal viso e presi a scrutare gli abitanti di quel luogo. Si trattava di una mezza dozzina di esseri enormi, solo il polpaccio di uno di loro era alto quanto me. Gli Jotnar avevano la pelle nera lucida e tesa sui muscoli enormemente sviluppati, alcuni di loro avevano il torso ricoperto da pelliccia altrettanto scura. Tutti erano muniti di grosse zanne giallognole che fuoriuscivano dalle labbra serrate; gli occhi, piccoli e cisposi, erano dello stesso colore dei denti. I capelli della maggior parte dei Giganti, lisci e neri come il resto del corpo, arrivavano fino ai loro gomiti. Nessuno di loro sembrava avere un’aria particolarmente intelligente, ma io sapevo che le apparenze non dovevano trarmi in inganno: gli Hrímþursar da tempo immemore erano depositari di una grande conoscenza. -Chi siete voi, e cosa volete? Non avete il diritto di stare qui.- fece con voce cavernosa lo Jötunn più corpulento di tutti. Fenrir ed io muovemmo con cautela un passo nella loro direzione. Gli Jotnar più piccoli ci fissavano tendendo il collo verso di noi. Nei loro occhi, a ben guardare, non c’era diffidenza, ma solo grande curiosità. Ricordai il tono con cui Dolohov aveva parlato ai lupi mannari e cercai di emularlo: -Noi siamo originari di queste terre, siamo Svedesi.- Volevo far capire al capo di quel gruppo di Jotnar che Fenrir ed io avevamo lo stesso diritto che avevano loro di calcare quel suolo, nello stesso tempo non volevo apparire rigido fin da subito. Lo Jötunn più grosso di tutti piegò il suo largo torace, fino a posizionare il suo viso davanti a me. Mi scrutò per qualche istante con i suoi occhi opachi, io rivolsi i palmi delle mani verso di lui, come a fargli capire che avevo intenzioni amichevoli, contemporaneamente sostenni il suo sguardo a testa alta. -Hai un’aria familiare.- disse il Gigante, con aria perplessa. Si ritirò presso gli altri Jotnar, che probabilmente costituivano il suo concilio di saggi, e iniziò a confabulare con loro. Diverse voci dalle più varie tonalità si accavallarono, parlando in norreno talmente rapido da impedirci di afferrare il significato di quelle parole. Non ci volle un interprete però per capire che gli animi degli Jotnar si stavano scaldando. Qualcosa stava andando storto? -Io lo so chi è!- strillò d’un tratto uno Jötunn. Riconobbi la stessa voce che aveva formulato quell’incantesimo fino al momento del nostro arrivo: probabilmente doveva trattarsi di una femmina. -Tu sei il figlio di quell’uomo, Odinresk.- Per alcuni istanti, mi mancò il fiato per respirare. -È proprio lui!- fecero eco gli altri Jotnar, -Gli assomiglia davvero moltissimo.- -Anzi, potrei giurare di avere proprio Odinresk davanti,- continuò la femmina, -se non fosse per i capelli biondi.- Gli altri iniziarono ad urlare, facendo tremare le pareti della caverna quando si alzarono di scatto. Avevano ripreso a parlare in norreno, ma questa volta riconobbi una parola: hefnd, vendetta. Da come baluginarono le sue pupille, capii che anche Fenrir aveva riconosciuto quel termine. -No, un momento!- aveva iniziato a gridare, ma il fragore prodotto dai Giganti era troppo alto. -Sonorus!- dissi, dopo aver puntato la mia bacchetta contro la mia gola. Con un volume di voce decisamente più alto, riuscii ad impormi sugli Jotnar e a ripristinare la calma in mezzo a loro, anche se continuavano a guardarmi con diffidenza. -Non sono qui per vendicarmi, non dovete temere nulla da me! Il motivo della mia visita non ha a che fare con mio padre.- Il capo degli Hrímþursar mi rivolse uno sguardo accigliato: -Sappiamo che sei al corrente del fatto che siamo stati noi ad uccidere tuo padre, non mentire.- disse senza mezzi termini. In virtù del riscatto dell’onore infranto, avrei dovuto vendicarmi di loro. Ma quello Hrímþursar non sapeva che il mio onore ormai risiedeva in me, nel mio essere un Mangiamorte, nel Signore Oscuro, non in mio padre. -La vostra magia è grande, Hrímþursar.- esordii, -Non mento, so come è morto mio padre. Quello che non so è perché.- Un movimento nervoso da parte di Fenrir accanto a me mi avvisò che probabilmente non avrei dovuto affrontare quel discorso. Gli Jotnar si guardarono perplessi, il capo poi rispose: -Odinresk si è spinto troppo oltre. È venuto a cercarci, probabilmente avrebbe voluto derubarci delle nostre conoscenze. Ha varcato il confine che separa il regno degli uomini da quello degli Jotnar, regno in cui voi stessi ci avete relegati! Tu ti sei macchiato dello stesso crimine, perciò preparati a ricongiungerti al tuo vecchio.- Strinsi l’impugnatura della bacchetta che avevo legato alla cintura, pronto a difendermi se ce ne fosse stato bisogno. Ma non avrei attaccato per primo: le parole del Gigante mi avevano appena dato un’idea. Sapevo che la Scandinavia era appartenuta agli Jotnar, e che fosse stato il Ministero della Magia a relegare sui monti gli Hrímþursar e nel sottosuolo i Múspellsmegir. Avrei utilizzato l’odio degli Jotnar contro la comunità magica per portarli dalla parte dell’Oscuro Signore. -Avete ragione.- esordii, facendo sobbalzare Fenrir, che non aveva idea di ciò che avessi in mente, -È stato ingiusto e ignobile da parte del Ministero della Magia relegarvi in questi luoghi aspri e inospitali. Un tempo eravate liberi di andare dove volevate, eravate i signori di queste terre.- Feci una pausa per osservare la reazione del mio auditorio: gli Jotnar tacevano, scambiandosi occhiate perplesse. Capii che era il momento di rincarare la dose: -Che diritto hanno avuto alcuni maghi di ghettizzarvi in questo modo, di allontanarvi dalla comunità magica, come se foste delle bestiacce da tenere lontane? Come si sono permessi di rinchiudere i sovrani? Tutto ciò è stato abominevole. Io non sono qui per mio padre.- Indicando Fenrir, continuai: -Noi siamo giunti in Svezia in rappresentanza di un mago molto potente, che si è prefissato una nobile missione: riformare il mondo magico, sovvertire l’ordine costituito che, come considererete anche voi, è sbagliato. Il Signore Oscuro vuole ripulire il mondo dalla feccia e reintrodurvi invece dei preziosi alleati, come potreste essere voi.- -È così. Guardatemi!- intervenne Fenrir, indicando se stesso, -Io sono un lupo mannaro. Anche contro la mia specie il Ministero della Magia è sempre stato ingiusto, ci ha allontanati e scacciati come cani rognosi. È intollerabile!- Intervenni per l’affondo finale: -Per costruire il mondo della visione del Signore Oscuro, abbiamo bisogno del vostro appoggio come di quello dei lupi mannari. E proprio in questo mondo troverete tutti legittima cittadinanza.- Dopo aver parlato con gli Hrímþursar e averli convinti a unirsi a noi, persuadere i Múspellsmegir, i Giganti del fuoco, fu molto più facile. Quando marciammo fuori dalle grotte scavate nel sottosuolo e illuminate costantemente dall’Ardemonio, non mi sentivo più piccolo e insignificante, come nelle gallerie nelle montagne dei Giganti di brina. Calcavo la roccia con sicurezza, seguito da un centinaio di Jotnar di dimensioni abnormi. Gonfiai il petto, soddisfatto per la riuscita della missione che Lord Voldemort mi aveva affidato, stendendo le mani, come se con esse avessi potuto sostenere l’intero peso del mondo. Mi sentivo più forte degli Jotnar che docilmente mi seguivano. Non avendo più ragione di restare in Svezia, Fenrir ed io decidemmo di tornare in Inghilterra, accompagnati dagli Jotnar, così curiosi di conoscere la magnanimità del Signore Oscuro. Prima di partire, fu necessario tornare a Fagersta. Camminai davanti alla casa di mio padre volgendo la testa dall’altro lato. La decisione che avevo preso era stata quella di tornare all’oblio, all’ignoranza. Lasciai la Svezia senza voltarmi mai indietro: non aveva senso gettare un occhio al passato dietro di me, ciò che contava era soltanto un glorioso futuro al servizio del Signore Oscuro. NdA: un grazie speciale a Charme, EmilyBlack28, Latis Lensherr, LauriElphaba, LilyMercury e Violet Acquarius l'interesse con cui hanno seguito questa storia! Ringrazio anche saramichy per la disponibilità che ha dimostrato salvando questo contest dall'oblio (XD), per il suo giudizio e per i premi. http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=10053132&p=4 |