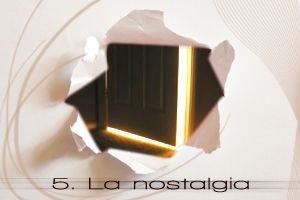Lovers in arms - Amanti nella guerra di Roxar
(/viewuser.php?uid=31966)
Disclaimer: Questo testo proprietà del suo autore e degli aventi diritto. La stampa o il salvataggio del testo dà diritto ad un usufrutto personale a scopo di lettura ed esclude ogni forma di sfruttamento commerciale o altri usi improri.
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** Prologo ***
Capitolo 2: *** La routine ***
Capitolo 3: *** Il ritrovamento ***
Capitolo 4: *** La nemesi ***
Capitolo 5: *** La rottura ***
Capitolo 6: *** La nostalgia ***
Capitolo 7: *** La tregua ***
Capitolo 8: *** Il danno ***
Capitolo 9: *** La curiosità ***
Capitolo 10: *** La svolta ***
Capitolo 11: *** L'addio ***
Capitolo 12: *** Epilogo ***
Capitolo 1
*** Prologo ***
Nuova pagina 1

Lovers
in arms
(Amanti
nella guerra)

Stamattina un folto stormo di anatre ha spezzato la
linea azzurra dell’orizzonte, macchiando le gonfie nuvole grigie e perlacee che
promettono pioggia; migrano da nord, cercano un riparo dal freddo e forse anche
dalle bombe.
Per pochi, deliziosi, paradisiaci secondi ho chiuso gli
occhi, vivendo la finta parvenza di una normalità che non esiste più.
Ho rivisto, sotto il velo sottile delle palpebre, mio
nonno Hanks condurre la mandria al pascolo, ho rivisto le sue mucche brucare
l’erba e sventolare le orecchie, ho riassaporato l’effluvio intenso dell’erba
intrisa di pioggia e della terra bagnata, ho riascoltato la sua risata bassa e
gutturale.
Poi, però, è arrivato il vento. Una folata sola, tiepida
ma decisa, brutale perfino. E il miraggio della normalità di ieri è scivolato
nelle pieghe del presente, inabissandosi tra le bombe e la guerra.
Ho riaperto gli occhi solo per incontrare una densa
colonna di fumo, così lontana da sembrare innocua foschia. Cosa testimonia?
L’abbattimento di un edificio? Il bombardamento di una scuola? Un aereo
precipitato al largo, lontano dalle abitazioni?
Ho trattenuto il respiro, voltando la schiena.
Eppure, nonostante tutto, io conservo ancora la
speranza. Spero ancora che una mattina non molto lontana il rintocco delle
campane spazzi via il sibilo stridente delle sirene, spero ancora che il sorriso
torni sulle labbra di chi ha perso ogni cosa, spero ancora che il cielo torni
limpido e pulito e che l’alba annunci che la pace è tornata e che la guerra è
finita.
NdA: Il mio ultimo accesso a questo fandom risale
a molto, molto tempo fa.
L'ultima volta ho proposto una one-shot, stavolta
propongo una long-fiction (peraltro già scritta, altrimenti col cavolo che mi
impelagavo in quest'impresa!).
Un paio di note.
Come già detto nell'introduzione, questa storia tratterà
la tematica della guerra. Per mancanza materiale di tempo (e incapacità della
sottoscritta) non ho analizzato nel dettaglio le vicissitudini belliche,
pertanto la guerra è presente solo come background di questa storia.
Come avrete modo di notare nei capitoli a venire, la
storia si concentrerà maggiormente su Valerie e sulle sue relazioni
interpersonali, con brevi richiami alla situazione esterna.
Inoltre, già nel prossimo capitolo capirete che
l'ambientazione principale sarà un ranch texano. Ora, so come funzionano i
ranch, ma è vero anche che so come funzionano i ranch enormi. Nel nostro
caso, Valerie si ritrova alle prese con un ranch di piccole dimensioni, che
conta giusto un manipolo di animali, per questo non sarà dedita a quelle
mansioni specifiche che questi posti richiedono (pascolo delle mandrie,
controllo delle proprietà terriere, eccetera eccetera).
Consideratela una licenza creativa, va.
L'aggiornamento sarà a cadenza settimanale,
presumibilmente ad ogni mercoledì del mese, imprevisti e/o tempo permettendo.
Ultimo, il disclaimer.
DISCLAIMER:
Ogni riferimento a fatti, luoghi,
cose o persone è puramente casuale.
Questo racconto è pura opera di
fantasia in ogni sua parte, pertanto i lettori sono tenuti a prendere la
narrazione senza rilevanza alcuna nel mondo reale.
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 2
*** La routine ***
|
Nuova pagina 2

«Val! Svegliati!»
Jack mi scosse forte e
sussultai, mettendomi fulmineamente a sedere tra le lenzuola sgualcite.
«Che succede? Le
sirene?» mormorai frenetica, aguzzando l’udito per cogliere solamente il
canto spensierato dei passeri appollaiati sul tetto.
«No, c’è Sam. Scusa se
ti ho spaventata».
Sospirai di sollievo,
attendendo che il battito cardiaco si acquietasse. Restai perfettamente
immobile per pochi attimi, scansando la frangia madida di sudore dalla
fronte.
«Non importa. Digli che
mi vesto e lo raggiungo».
«Va bene. Scusa ancora»
disse, sorridendo colpevole mentre sgusciava via dalla mia camera da
letto.
Mi stropicciai il viso,
dando il benvenuto ad una nuova giornata e alla consueta ondata di
terrore che, come la risacca sulla battigia, andava e veniva ad
intervalli cadenzati e tuttavia troppo vicini tra loro.
Come ogni giorno, mi
sciacquai frettolosamente il viso, spazzolai i capelli e indossai gli
abiti ormai vecchi e sformati, ma puliti.
Come ogni giorno,
sostai più del dovuto davanti allo specchio, appurando quanto i miei
tratti somatici fossero mutati in soli cinque anni, di come il mento si
fosse affilato e di come la carne si fosse ritratta sino a diventare il
guscio molle delle ossa sporgenti.
Come ogni giorno,
sfregai inconsciamente sulla cicatrice pallida e frastagliata che mi
segnava il collo, retaggio indesiderato del primo bombardamento, il
primo di una sequenza che pareva destinata a protrarsi fino
all’estinzione dell’umana specie.
E come ogni giorno,
abbandonai lo specchio senza ulteriori indugi, percorrendo quindi quel
pugno di passi che mi separavano da Sam.
«Buongiorno, Sam; buone
nuove?»
«Buongiorno, Valerie.
Nuove sì, buone no di certo».
Nulla di nuovo, dunque.
Nessuna resa, nessuna vittoria, nessun perdente.
«Entra, mangiamo
qualcosa».
Sam si sfilò il
cappello da mandriano dalla tesa lisa e sbiadita e i suoi stivali
picchiarono ritmici contro il legno rovinato che, una volta, era stato
un bellissimo parquet.
Mentre mi dava le
spalle, anticipandomi in cucina, notai quanto i suoi capelli bruni
fossero cresciuti dal giorno in cui ci eravamo incontrati.
Si dispiegavano in
crespe onde che nascevano sulla nuca, per adagiarsi poi morbidamente
sulle spalle larghe e forti abbastanza da sorreggere il peso di non una,
ma ben due famiglie da sfamare e accudire: la sua e la mia.
Sedette al solito
posto, lasciandosi sfuggire il solito sospiro stanco.
Poi si passò una mano
sul viso, sulla barba incolta e ispida, sulla bocca rossa e screpolata.
Sam era una bellezza
poco convenzionale, selvaggia quasi, terribilmente affascinante.
Forse, se la guerra non
fosse mai scoppiata, se l’avessi incontrato in circostanze più felici,
se non ci fosse stato quel divario di ben dieci anni, me ne sarei potuta
innamorare.
Ma in tempi tanto
disperati l’amore era una creatura fuggiasca e spaventata oltre ogni
immaginazione, che badava bene di tenersi lontana dalla civiltà, o da
quel che ne restava.
«Allora, che succede?»
domandai, servendo le ultime fette di pane stantio ma ancora
commestibile, accompagnate dai rimasugli della confettura all’albicocca
che lasciava sul palato un retrogusto acre e acido.
«La Germania ha
tradito; è passata dalla parte della Russia e con lei anche il Belgio e
l’Austria. Si sono vendute al nemico, fottute puttane» imprecò con
leggerezza, addentando il pane.
Qualche giorno prima
avrei sorriso dei suoi modi irruenti, ma quel giorno la mia mente era
così ottusa, offuscata dalla gravità della notizia, che me ne restai
perfettamente immobile, respirando piano per frenare il panico
disperato.
«Fortunatamente,
l’Italia, la Francia e la Spagna sono appena scese in campo. Ne abbiamo
perse tre, ma ne abbiamo guadagnate altrettante» aggiunse, sfiorandomi
distrattamente il gomito.
«Gli alleati sono
soltanto soldati semplici che aiutano i generali, Sam» dissi,
lentamente, spezzettando il pane.
«I generali sarebbero
già a gambe all’aria senza i soldati semplici, Valerie» mi contraddisse,
sorridendomi appena. I sorrisi di Sam erano rari quanto la possibilità
di acquistare dei vestiti nuovi o della carne fresca, per questo ne
approfittavo ogni volta, sorridendo di rimando.
«Credi che finirà mai?
Che ci sarà mai un vincitore?»
«La Russia non molla e
noi nemmeno; la stanno portando per le lunghe, quando potrebbero
sfoderare le armi nucleari e farla finita».
Trasalii.
«Non dirlo nemmeno per
scherzo» mormorai aspramente, ipotizzando solo una piccolissima frazione
del danno che tali armi potevano arrecare.
Zone radioattive ed
inabitabili per decine di anni, campi sterili, flora contaminata e
destinata a marcire, nascituri malformati o gravemente malati...
«Accadrà, lo sai che
accadrà. La Russia armerà le testate nucleari e noi li bombarderemo con
il gas VX» mi provocò, ammiccando.
«Spero di morire prima,
allora» sbottai infastidita, lasciandomi deridere dalla sua risata
beffarda. Scattai in piedi come se la sedia mi avesse morsa, percorrendo
lo stretto perimetro della cucina. Fu Sam a fermarmi, portandosi alle
mie spalle e afferrandomi per i fianchi, il mento poggiato sulla mia
spalla.
Gesti come quello erano
così naturali, tra noi, che l’imbarazzo era morto subito o forse non era
nemmeno mai esistito.
«Rilassati, Val. Non
arriveranno a questo punto; cercano di tenersi stretto quel che hanno,
distruggerlo sarebbe controproducente e inutile».
«Pensavo... pensavo che
siccome settant’anni fa la guerra tra noi e loro era stata sventata,
anche questa volta sarebbe andata così...» lasciai che la mia voce
scemasse nel silenzio.
«Settant’anni fa non
esisteva che una minima parte di tutto quello che oggi fa gola»
borbottò, allontanandosi da me per gettare sul tavolo un pesante sacco
di iuta.
«Piuttosto, ti ho
portato un po’ di cibo. Chiudi quella bocca, non replicare. È l’unico
modo che abbiamo di ripagarti delle erbe medicamentose che ci fornisci»
disse, riconoscente e segretamente soddisfatto delle mie discrete
abilità.
«Ringrazia il fatto che
a poche miglia da qui ci sia qualche bosco sparso qua e là» replicai,
accecata quasi dal profumo denso del formaggio fresco. La saliva mi
riempii la bocca e fui costretta a deglutire e restare concentrata sulla
voce bassa e cupa di Sam.
«Adesso devo andare.
Ah, ho visto il ragazzino; sta bene».
«Non dà problemi»
replicai rigida, perché la questione del ragazzino era sempre talmente
spinosa e nebulosa che avrei dato un organo per poterlo restituire alla
sua vera quanto sconosciuta famiglia.
«Ci vediamo, Val» mi
lasciò la solita carezza sui capelli, montando poi in sella al suo
cavallo e galoppando via, lontano diverse miglia da me.
Indugiai sulla porta
più del necessario, soccombendo puntualmente davanti al desiderio
sfrenato di vederlo tornare per restare con me, per offrirmi la sua
compagnia e la sua protezione e forse anche una spalla su cui piangere
le mie paure e le mie ossessioni.
Agivo per puro egoismo,
perché ben sapevo che Sam avrebbe frainteso un così intenso desiderio;
non aveva mai negato di volere una relazione con me, non aveva mai
pensato alla differenza d’età come ad un problema. La guerra aveva
spazzato via vita, abitudini e convenzioni; che differenza faceva? In
fondo, non credevamo davvero in un domani roseo e prosperoso, senza
fuoco né esplosioni.
Peccato che io e lui
fossimo sintonizzati su frequenze diverse, peccato che io non fossi
pronta a soverchiarmi del peso di un sentimento troppo fragile e troppo
pericoloso come l’amore.
«Val, andiamo a mungere
Georgie?»
Allungai una mano oltre
la mia schiena fino a carezzare il braccio di Jack, annuendo
distrattamente.
La nostra routine –
debitamente condita di ansia e sensi allertati – prevedeva la mungitura
di Georgie, la più anziana delle mucche che i miei genitori avevano
ereditato da mio nonno Hanks.
Nonostante l’età, il
clima ostile e il mangime sempre di qualità più scadente, Georgie
continuava a ripagarci con latte bianco e delizioso, facendoci sentire
degli ingrati per quel poco che avevamo da offrirle.
Presi posto su un
piccolo sgabello, alle spalle di Jack, mentre il ragazzino mungeva con
neonata abilità la mucca; quelle di Jack erano le uniche braccia
maschili su cui potessi contare e avevo capito ben presto che era
davvero il caso di tramandargli tutto l’insegnamento ricevuto da mio
padre; da sola faticavo a badare alle esigenze dei pochi animali che
avevamo e Jack, da quando aveva compiuto quattordici anni, inoltrandosi
nell’adolescenza, era un preziosissimo aiuto.
Oramai aveva acquisito
una certa manualità con la procedura, tanto che spesso me ne restavo in
disparte, ad analizzare il flusso scoordinato e disordinato dei miei
pensieri.
Quella mattina, mentre
fissavo il profilo del ragazzino, ripensai al giorno in cui l’avevo
trovato, appena tre anni prima.
Una figuretta smunta e
pallida, rosa dal freddo e dalla fame, accasciata sul ciglio della
strada che collegava il mio ranch a Fort Worth. Lo avevo soccorso
immediatamente, portandolo a casa, offrendogli un letto caldo e
casalinghi rimedi contro la febbre alta.
Quando fu abbastanza
lucido da potermi raccontare la sua storia, scoprii che il bambino era
fuggito dalla St. Antoine Family House, casa-famiglia che ospitava
tossicomani volenterosi di guarire, prostitute alla ricerca di
protezione dalle angherie dei loro protettori e orfanelli abbandonati,
di anno in anno, sulla soglia della porta.
Di Jack si sapeva
soltanto che era stato abbandonato in quella struttura quando aveva solo
una manciata di mesi di vita sulle piccole spalle. Chi lo aveva
abbandonato non si era nemmeno premurato di lasciare detto il nome del
bambino, al quale, successivamente, ne era stato affibbiato uno
fittizio: Jack Peterson.
Mi raccontò di come era
stato costretto a subire i soprusi degli altri ospiti, di come i
ragazzini lo prendessero in giro, di come lo picchiassero per puro
divertimento, di quanto i cocainomani, coi loro occhi vacui e rossi, lo
spaventassero a morte.
Non ebbi cuore di
mandarlo via, sebbene tenerlo con me fosse un vero azzardo. Sapevo di
non potergli offrire molto (e come avrei potuto, senza genitori né
fratelli, con soltanto il nonno Hanks che si approssimava sempre più
alla morte?), ma sapevo anche che avrei potuto garantirgli una vita
molto migliore.
Fu l’unica spalla che
mi offrì conforto quando nonno Hanks morì.
Lo vedevo crescere di
anno in anno, vedevo il suo viso tondo affilarsi, la pelle tendersi sul
mento e sugli zigomi, il corpo allungarsi, gli occhi grigi assumere
un’espressione sempre più rassegnata, sempre più consapevole, sempre più
adulta.
E soprattutto, era
l’unica forma d’amore che potessi permettermi, quello fraterno, quello
che un tempo era stato destinato tutto al mio vero fratello, Adrian, che
combatteva al fianco di mio padre, nel valoroso corpo dei Marines degli
Stati Uniti d’America.
La piccola Liz, invece,
era stata abbandonata nel mio fienile, avvolta in una logora coperta
gialla a cui era stato allegato un biglietto che ne citava solo il nome
e la data di nascita.
Ma era talmente piccola
e malnutrita – malata, anche – che l’avevo prontamente affidata alle
cure della madre di Sam, pregando quest’ultimo di tenerla con loro, ché
di sicuro non sarei stata capace di badare a lei.
Di tanto in tanto Sam
la portava con sé, tenendola ben stretta nella curva del proprio
braccio.
Chiusi gli occhi e
sotto le palpebre rievocai l’immagine di una graziosa bambina dai
luminosi capelli biondi e grandi occhi castani.
«Val, ho finito» Jack
mi riportò al presente e mi alzai per baciargli i capelli spettinati,
ringraziandolo.
«Mettilo pure in
pentola, lo bolliremo stasera. Adesso vai a studiare un po’, mentre io
raccolgo le uova di Netty».
Netty era la decrepita
gallina che, assieme a Linda e Giselle, ci riforniva quotidianamente di
uova piccole ma saporite.
Jack sbuffò della
prospettiva poco gradevole, guadagnandosi una spintarella tra le
scapole.
«Studiare è importante
e tu sei così bravo con la matematica... Su, più tardi vengo a
controllare il tuo lavoro».
Avevo fatto appena in
tempo a diplomarmi, prima che scoppiasse la guerra e sconvolgesse ogni
cosa. Oggi era troppo rischioso mandare i bambini a scuola, perciò era
compito delle madri o dei padri o dei nonni sobbarcarsi la loro
istruzione.
E io non ero stata da
meno con Jack, il quale prometteva bene, sebbene la svogliatezza.
Lo osservai
allontanarsi – strascicando i piedi sulla terra rossa – borbottando tra
sé e sé.
Da quel momento il
tempo era trascorso lentamente. Avevo raccolto le uova nel pollaio,
pulito Kellan, la punta di diamante del mio ranch, che mi aveva
ricompensata con un nitrito soddisfatto, spazzato il pavimento della
casa, lavato i vestiti e rassettato le camere, dedicandomi quindi alla
pulizia del bagno. Avevo preparato il pranzo e io e Jack avevamo
alternato i bocconi a chiacchiere frivole, concentrate essenzialmente
sulla mia vita passata, scorci di ricordi felici che parevano così
inadeguati al presente.
Il pomeriggio era
scivolato tra la bollitura del latte e uno sguardo ai compiti di Jack,
tra la preparazione della cena e l’organizzazione della giornata
successiva.
Dopo aver mangiato
eravamo ancora abbastanza in forze da poterci concedere un po’ di
televisione, i cui programmi si alternavano continuamente a strazianti
bollettini di guerra.
Quando venne l’ora di
andare a dormire, Jack mi augurò una buonanotte e si rintanò nella
camera un tempo appartenuta ad Adrian. Pochi minuti dopo lo sentii
russare piano e borbottare parole spezzate nel sonno.
Odiavo la notte, odiavo
il buio e la vulnerabilità nella quale ci sprofondava irrimediabilmente.
Temevo il suono delle sirene (indice che non eravamo poi così lontani da
Fort Worth) a squarciare il silenzio e il mio riposo, temevo un
bombardamento improvviso o un’incursione nemica a sorpresa. Ma sopra
ogni altra cosa, temevo che la nemesi mi piombasse in casa, favorita
dalle tenebre, e facesse del male a me e a Jack.
Mai come in quei
momenti desideravo la presenza solida e rinfrancante di Sam.
Sam. Sorrisi,
rammentando la burrascosa occasione in cui ci eravamo conosciuti.
Ad entrambi serviva un
cavallo, entrambi avevamo puntato lo stesso stallone selvatico, entrambi
eravamo finiti con un serramanico puntato alla gola.
E dopo aver discusso
civilmente, decisi che poteva tenersi il cavallo che alla fine ero
riuscita ad ammansire, a patto che mi lasciasse metà del contenuto della
sua bisaccia gonfia.
E così iniziò la nostra
amicizia. Da quel momento, non era mai trascorso un giorno senza che Sam
si presentasse alla mia porta. Avevo imparato a conoscerlo, scoprendo un
pezzo alla volta della sua vita.
Era il più grande di
tre fratelli e suo padre, come il mio, era un soldato impegnato sul
fronte di guerra; era lui l’adulto di casa, che si spartiva tra il
lavoro in città e quello al ranch, che aiutava sua madre – unico medico
nel raggio di miglia – a curare bambini malati o giovani mandriani
caduti da cavallo o da uno sperone di roccia.
Talvolta ci scambiavamo
viveri ed erbe medicamentose, che avevo imparato a riconoscere nelle
tante sessioni di pascolo assieme a mio nonno.
Con il dilungarsi della
guerra, i medicinali ed altri beni di prima necessità tardavano ad
arrivare o non arrivavano affatto; così, all’approssimarsi del 2021, sua
madre era stata costretta a riesumare dalla soffitta il vecchio libro di
famiglia – medici da sei generazioni – infarcito di ricette di unguenti
e farmaci casalinghi, ma efficaci.
Da tre anni, Sam era la
mia salvezza, mia e di Jack. Spesso ci ospitava per intere settimane nel
loro ranch – tre volte più vasto del mio, con cavalli magnifici che gli
avevo profondamente invidiato –, soprattutto quando il notiziario
annunciava un’incursione che, fortunatamente, non era mai arrivata.
I bombardamenti, da un
anno a quella parte, si erano limitati a colpire le nazioni
settentrionali. La nostra posizione ci proteggeva; per quanto, non
sapevamo dirlo.
E mentre ponderavo sui
diversi tempi della guerra – su quanto ci avrebbe messo a raggiungerci –
mi appisolai, rigirata sul fianco destro.
NdA: Ed eccoci
al primo capitolo di questa long, che non sarà poi così long (dieci
capitoli, esclusi prologo ed epilogo).
Ciò detto, ho pensato e
ripensato spesso a come introdurre Valerie, Jack e Sam, come introdurli
nella storia senza creare confusione.
Ho scelto di seguire
una giornata di ordinaria amministrazione, perché le abitudini di una
persona dicono molto di essa.
Perciò, considerate
questo capitolo come un modo per conoscere Valerie, così che le sue
azioni, nell'immediato futuro, non vi sembrino troppo strane o
inopportune.
Ciò detto, vorrei fare
qualche ringraziamento: prima di tutto, ringrazio nali, che si è
accollata il compito di betare questa storia, mostrando una grande
pazienza con la sottoscritta e di questo non posso che ringraziarla
davvero col cuore in mano; poi, ringrazio le cinque persone che hanno
recensito e quelle che seguono questa storia, ringraziandoli per la
fiducia riposta in questa storia e sperando di non tradirla.
Bon, temo d'aver
concluso.
Appuntamento a
mercoledì prossimo, non mancate, mi raccomando.
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 3
*** Il ritrovamento ***
Nuova pagina 2

Le sirene squarciarono la notte dopo un paio d’ore o forse meno. Cercai
di annientare lo stordimento e il battito del cuore che mi fischiava
nelle orecchie mentre uscivo incespicando, urlando a Jack di venire, di
raggiungermi.
Trafelato e con gli occhi pieni di lacrime, si fece piccolo accanto a
me, mentre lo trascinavo quasi di peso giù, nella botola sotto il
tappeto del salotto, nella cantina polverosa e pregna di umidità.
Non appena il coperchio tornò ad essere parte integrante del pavimento,
il suono delle sirene si attenuò nettamente, come se fosse solo un
sibilo nelle orecchie provate.
Jack ansimava e piangeva e io ero sulla buona strada per imitarlo; ma,
mi dissi, io ero l’adulta, io avrei dovuto mantenere la calma,
rinfrancarlo, garantirgli che sarebbe andato tutto per il verso giusto.
L’avevo appena abbracciato quando il fragore dell’esplosione sbriciolò
il mio già labile autocontrollo. Mi strinsi al ragazzino e strillai,
accasciandomi su pavimento e gemendo, mentre le lacrime scorrevano
rapide e abbondanti sulle nostre guance.
Non sapevo con esattezza se a tremare fossimo noi o le mura; poi la
polvere ci piovve addosso, soffocandoci, costringendoci a strisciare
nello spesso strato di terra e pulviscolo, fino all’angolo più lontano,
dove ad attenderci trovammo una famigliola di topi spauriti che
sgattaiolarono via, in una fessura nel battiscopa.
Restammo accovacciati in quella scomoda posizione fino a che le
esplosioni – ne contai ventitre – non terminarono, scivolando nel
silenzio.
«È finita?» sussurrò Jack, impercettibilmente, tanto che dovetti
chinarmi sulle sue labbra e invitarlo a ripetere nuovamente la domanda.
Mi strinsi nelle spalle e feci leva sulle ginocchia molli e tremanti,
reggendomi a Jack che, a sua volta, si reggeva a me.
Il silenzio mi terrorizzava ancor più delle esplosioni; temevo che il
fragore ci avrebbe assordati nuovamente, all’improvviso.
Mai come in quel momento agognai con così tanta disperazione la voce e
le braccia e le mani di Sam.
Attendemmo forse mezz’ora, forse un’ora o forse due. Solo quando la luce
filtrò dalla finestrella sudicia ci accorgemmo di essere rimasti
sottoterra per almeno quattro ore.
Come il silenzio, anche l’alba mi pareva in qualche modo sbagliata,
inopportuna. Come se fosse giunta, con arroganza, a cancellare il
ricordo delle esplosioni, a rendere inconsistente il peso della nostra
paura.
Confusa, osservai la finestra e mi domandai se tutto – il rumore, le
bombe, le sirene, il pianto, il terrore e l’ansia – fosse realmente
accaduto.
Il corpo tremante di Jack avvinto al mio fu una dolorosa ma esauriente
risposta.
«Torniamo di sopra» mi schiarii la voce e il sollievo fu quasi doloroso,
nello stomaco, quando appurai che le onde d’urto non erano state forti
abbastanza da arrecare danni alle finestre, che le esplosioni erano
avvenute troppo lontano per lesionare la mia casa, tutto ciò che avevo.
«Valerie, Valerie, guarda!»
Mi trascinai sino alla finestra – realizzai solo allora il peso della
stanchezza nelle gambe rigide come ciocchi di legno – e i miei occhi
stanchi e arrossati registrarono la densa colonna di fumo che si levava,
lenta e goffa, dalla scarpata mezzo miglio dal ranch, in direzione
ovest.
Gli abitanti della zona – noi compresi – la chiamavano “L’ultima
spiaggia”, perché, effettivamente, era davvero improbabile che si
riuscisse a visitare qualcos’altro dopo esservi precipitati dentro. Era
una scarpata ingentilita dal manto erboso che cresceva spontaneo sui
fianchi, profonda settanta metri o giù di lì; una discesa che finiva
dritta a valle, o, se vi si cadeva, nella bocca della morte.
Conoscevo bene l’ultima
spiaggia; molte delle erbe medicamentose che raccoglievo per Sam
crescevano sui tratti più assolati e morbidi, facilmente raggiungibili.
«Cosa pensi che sia?»
«Qualcosa è precipitato lì. Un elicottero, forse, o una bomba».
E tuttavia mi pareva improbabile. Se fosse stata una bomba, ogni cosa ne
avrebbe risentito e il mio ranch sarebbe rimasto coinvolto
nell’esplosione, o no?
Un elicottero, allora. Il che implicava pilota e co-pilota e di
conseguenza, cadaveri o sopravvissuti.
Deglutii, tirando le tende.
«Non ci interessa, comunque. Qualunque cosa sia, manderanno i ranger a
controllare» spiegai nervosamente, intenzionata più che mai a darmi una
ripulita.
«Ma... e se qualcuno fosse sopravvissuto?»
«Peggio per loro, Jack; noi non aiutiamo chi vuole ucciderci» lo
redarguii velenosamente, inoltrandomi nel bagno e sbattendo la porta,
così che intendesse bene che la discussione era chiusa.
Oh, quanto mi sbagliavo!
Quando finalmente tornai in cucina, rinvigorita dalla doccia, di Jack si
notava solo l’assenza.
«Jack?» chiamai, muovendomi in ogni camera, il panico che dilagava con
l’aumentare dei miei passi.
«Jack!» urlai a pieni polmoni, correndo sul selciato per arrestarmi poi
per assottigliare lo sguardo.
Jack era sporco di terra, fango e – un moto di isteria mi pervase –
sangue e si trascinava al fianco il corpo moribondo di un soldato.
La sua divisa, sebbene insozzata e strappata e bruciata, risplendeva
ancora dei colori della sua madrepatria. La mimetica logora e
sbrindellata lasciava intravedere la tel'njaška a
righe bianche e blu fiordaliso, macchiata di sangue e terra; il basco
blu era scivolato sul volto del soldato e il grande emblema dorato
riluceva, nonostante la crepa che lo divideva in due metà asimmetriche.
Li chiamavano berretti blu,
ma gli americani li avevano spregiativamente rinominati uccelletti
blu, riferimento alla loro attività di piloti e, sospettavo,
racchiudeva un qualche insulto implicito a livello anatomico e sessuale.
Ma di una cosa ero assolutamente certa: erano i più spietati, i più
pericolosi membri delle forze armate russe; un corpo a sé stante, un
privilegio di pochi, il riconoscimento di una carriera ricca ed
encomiabile.
Una cerchia esclusiva che aggregava i più capaci militari russi.
Non ebbi occasione di lanciarmi in ulteriori congetture; persi il filo
del pensiero quando notai il kalashnikov pendere
dalla spalla di Jack.
Balzai in avanti e quando fui abbastanza vicina, lo strattonai con
violenza, calciando via l’arma, disgustata.
L’uomo – morto o moribondo, non avrei saputo dirlo – si accasciò in una
nuvola di terra, senza emettere alcun lamento.
«È vivo» sussurrò Jack, badando, adesso che mi era vicino, di tenersi
lontano dall’uomo.
Come a voler confermare le sue parole, l’uomo mugolò pianissimo.
«Vedo», attestai gelida e atona, «porta dentro questo cane bastardo;
dopo, parleremo».
Jack eseguì rapidamente l’ordine e trascinò l’uomo in salotto,
adagiandolo sul tappeto che custodiva il nostro rifugio, la nostra unica
speranza di salvezza.
«Bisognerà chiamare la madre di Sam—»
«Sei impazzito?! Ci arresterebbero tutti!»
Era vero. Di questi tempi, chi veniva sorpreso ad offrire asilo al
nemico era tacciato di tradimento e chissà quale altro crimine contro la
Patria.
«E cosa facciamo? Lo lasciamo morire?»
Buona idea, pensai
perfidamente.
Scossi la testa, mordicchiandomi freneticamente le unghie, indecisa sul
da farsi, terrorizzata da quel corpo inerme.
Ucciderlo sarebbe stato facile come respirare; un colpo di quel suo bel
giocattolino e tutto sarebbe finito. I ranger lo avrebbero ritrovato
carbonizzato tra le fiamme che avrei facilmente appiccato e avrei
portato il peso del mio segreto sulle spalle fino ai miei ultimi giorni.
Ma avevo troppo a cuore il concetto di “vita”, e tutto quel che
significava, per poter uccidere così, a sangue freddo, un essere umano,
un essere vivente.
Nonno Hanks diceva sempre che ogni vita ha il suo valore, che ogni vita
ha il suo significato, che ogni vita, che si intreccia alla nostra, lo
fa con uno scopo ben preciso.
Quando furono trascorsi molti minuti, decisi finalmente di
inginocchiarmi al fianco dell’uomo. Allungai le mani per sfilargli la
tuta e appurare l’entità dei danni, salvo poi trattenermi. Al petto se
ne stava appuntata la spilla della sua truppa – la 76esima, quella dei
volontari, ne riconoscevo lo stemma – che fissavo come fosse un
disgustoso rettile, viscido e velenoso.
Era l’incarnazione della fine del mondo, del capovolgimento dell’ordine
mondiale; era il simbolo su cui colava il sangue degli innocenti e dei
soldati miei compatrioti.
«Devi spogliarlo? Vuoi che lo faccia io?»
Jack mi ridestò dalle mie lugubri elucubrazioni.
«No. Aiutami a portarlo di sopra, in mansarda» domandai, vincendo la
repulsione e afferrando un braccio mentre Jack stringeva l’altro.
Ansimando e inciampando, lo trasportammo sino alla soffitta, un tempo
adibita a camera per gli ospiti, oggi azzardato nascondiglio di un
soldato nemico.
Lo adagiammo piano sul letto, le cui coperte candide si insozzarono
prontamente di lerciume e sangue.
«Chiama Kim, dille che sono malata e che la settimana prossima resterò a
casa, poi prendi l’automobile e chiudila nel capanno; quando verrà Sam
digli che sono andata in città per, uhm, inventati qualcosa. Infine,
prendi Kellan e vai a farti un giro».
Jack annuì diverse volte e sgattaiolò giù; il suo borbottio infastidito
dal timbro marcato e non più infantile mi raggiunse fin lì.
A Kim – la droghiera presso cui lavoravo per il carico e lo scarico
delle merci – non avrebbe fatto piacere, non ora che erano in arrivo le
scorte di viveri e beni di prima necessità.
Scoccai un’occhiataccia al soldato esanime prima di inoltrarmi in bagno
per procurarmi il kit del primo soccorso, spugne, asciugamani e un
secchio colmo d’acqua limpida e pulita.
Non avendo mai spogliato nessuno in vita mia, incontrai diverse
difficoltà, prima tra tutte il mio accentuato senso del pudore.
Armeggiai con cinture, stringhe, fibbie e cerniere per tirare fuori
l’uomo dai suoi vestiti e quasi temetti – temetti, non sperai, la cosa
mi sconvolse non poco – che fosse morto quando non sopraggiunse nessun
lamento, nessun gemito.
Nudo (o quasi; non avevo trovato il coraggio di sfilargli la
biancheria), indifeso ed esanime, potevo valutare l’entità del danno.
Oltre alle molte escoriazioni, ferite superficiali e abrasioni, notai un
profondo squarcio sul fianco destro, che continuava a trasudare sangue
caldo e denso.
Dovetti spalancare la finestra per non vomitare, non sapendo se a
suggestionarmi fosse l’intenso odore metallico o il colore vivido del
liquido.
Intrisi la spugna d’acqua e la passai sull’intero corpo: sul collo, sul
petto, sull’addome, sulle braccia e sulle gambe, tenendo per ultimo il
fianco squarciato e il viso.
Quando anche l’ultimo strato di sudiciume venne lavato via, restai
colpita e affascinata.
Non era un uomo. Era solo un ragazzo, forse mio coetaneo, forse poco più
anziano. Ed era bello, della classica bellezza russa, delicata e
pericolosa, quasi felina.
Poi, pervasa da un gelido controllo, gli scostai timorosamente i capelli
biondi dalla fronte, spingendoli sulla testa.
Non sapevo praticamente nulla di procedure mediche, se non qualche
rudimentale base.
Mi inginocchiai per scrutare il taglio nel fianco e persino un’ignorante
in materia come me sapeva che occorreva una pratica di sutura.
Vidi l’ago minuto, le pinze e il filo, impaccati in una busta
trasparente, ma esitai.
Era semplice come rammendare un calzino? Gli avrei inferto dolore?
Probabilmente, ma non tanto quanto lui – o chi per lui – ne aveva
inferto alla mia gente.
Eppure.
Eppure non ero così sadica, né così coraggiosa. Sapevo di dover prendere
una scelta, sapevo che la riserva di sangue umano era limitata, scarsa
perfino.
Chiusi gli occhi, pregai che la buona sorte fosse in mio favore e
strappai la busta trasparente, inserendo il filo nell’impercettibile
cruna dell’ago, afferrandolo poi con le pinze.
Ricordavo quel paio di volte in cui avevo osservato Keira, la madre di
Sam, praticare la sutura; ricordavo i movimenti sciolti, praticati con
consumata abilità.
Era come cucire; il trucco era nel considerare la pelle al pari della
stoffa, ignorando preferibilmente l’intensa emanazione del sangue.
Piantai l’ago nella carne, unendo i lembi della ferita, praticando un
primo, sghembo punto.
Mi arrestai quando il filo ebbe traversato la ferita, scoccando
un’occhiata al ragazzo.
Avrei dovuto anestetizzarlo? Oppure il dolore non era così forte da
ridestarlo?
Praticai altri tre punti prima che lui gemesse piano, scoprendo i denti
digrignati.
Velocemente, ne cucii altri otto prima che la ferita fosse interamente
richiusa. Strappai delicatamente il filo e solo allora mi domandai come
diavolo l’avrei bendato.
Mi occorreva Jack e l’insolita forza delle sue braccia.
Ma Jack era lontano, lontano da me e da ciò che lo avrebbe atteso al suo
ritorno.
Così, impacciata e lenta, sfruttai il materasso morbido per stringere la
benda cinque, sei, sette volte attorno al torace, fino a crearne un
bozzolo bianco e pulito.
Feci un doppio nodo e attesi, sforzandomi di non guardare le mia dita,
impregnate di sangue.
Era ancora svenuto. Possibile?
Feci una corsa veloce al bagno, mi lavai tre volte le mani e tornai da
lui, tastandogli il polso.
Il battito, lento e leggero, era presente. Cosa dovevo fare? Attendere
che si svegliasse? O forzare il risveglio? Mi grattai nervosamente una
spalla e decisi di aspettare.
Sedetti, esausta, in una poltrona poco lontana. Non appena chiusi gli
occhi, la stanchezza si riversò nel sangue, che ottenebrò il cervello,
sprofondandomi in un sonno vivido di colori e ricco di esplosioni.
Fu una scarica di dolore alla schiena che mi risvegliò, molto tempo
dopo. La posizione aveva anchilosato le articolazioni e irrigidito i
muscoli oltre la soglia dell’umana tolleranza.
Gemetti e mi schiarii la voce, stropicciandomi gli occhi e scansando i
capelli dalle guance.
Impiegai un minuto pieno a concatenare tutti gli ultimi eventi,
chiudendo la stringa con il volto del soldato russo scampato
all’abbattimento aereo.
Sollevai le palpebre per scorgere il sole ormai giunto al tramonto, la
cui luce aranciata ammorbidiva i profili degli oggetti, riverberandosi
in un paio di occhi azzurri che mi fissavano insistentemente.
NdA: E finalmente Alek entra in scena.
Mi scuso se a qualcuno queste NdA sembreranno
diverse, ma ho combinato un mezzo casino con questo e il successivo
capitolo, e a distanza di due settimane non lo ricordo mica cosa avevo
scritto.
Tant'è.
Giusto un paio di precisazioni.
Non sono un'esperta in medicina, pertanto il
paragrafo sulla sutura prendetela molto alla leggera; ho solo ipotizzato
come si reagisca in una situazione così, ho solo cercato di ricreare un
intervento di fortuna.
Ringrazio chi ha letto e recensito lo scorso
capitolo.
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 4
*** La nemesi ***
Nuova pagina 1

Un rivolo di gelido sudore mi colò tra le
scapole, strisciando lungo la schiena per infrangersi contro l’orlo dei
pantaloni.
«Vy dovolʹno,
sei carina».
Mi irrigidii, prestando scarsa attenzione al
complimento ironico, o alla voce strascicata dal lieve accento russo.
Fissavo di rimando i suoi inquietanti occhi
azzurri – chiari come ghiaccio e come ghiaccio gelidi – mentre la mia
vista periferica coglieva la figura sfocata di un’ombra sul pavimento.
No, non un ombra. Il suo giocattolino,
che Jack doveva aver raccolto e portato su mentre trasportavamo lui.
Mi bastò allungare il braccio per sentire le
dita serrarsi sull’impugnatura più vicina alla canna, fredda e liscia.
Glielo puntai addosso, mirando dritto al cuore.
«Intendi spararmi, bellezza?»
«E diventare assassina a mia volta? No, grazie».
L’odio sbocciò come lo schizzo su carta di un
capace pittore, veloce, frenetico, marcato.
Odiavo tutto di quel soldato: la cadenza lenta
della sua voce, i suoi perforanti occhi azzurri, l’arrogante sicurezza
del suo modo di fare, i colori della bandiera che serviva con tanta
fedeltà.
«Questo mi conforta. Ora, se potessi avere un
bicchiere d’acqua...»
Lo fissai sprezzante e socchiusi le palpebre
prima di afferrare una bottiglia d’acqua e porgergliela con la stessa
accortezza che avrei prestato con un ragno velenoso.
Bevve a lungo, per niente intimorito dall’arma
che ancora puntava dritta al suo cuore. Quando fu soddisfatto, gettò la
bottiglia – praticamente vuota – sul pavimento, notando solo allora la
spessa fasciatura.
«L’hai fatta tu?»
Non risposi.
«Ah, mi hai anche ricucito», disse mentre
tastava la ferita sul fianco, «e, se posso, come mai tanta apprensione
per il nemico? Non sarebbe stato più semplice lasciarmi morire tra quei
maledetti rottami?»
«Non sono stata io a salvarti» ribattei con
astio.
«Dunque, cosa hai intenzione di farmi, adesso?
Consegnarmi ai tuoi soldati?» l’insopportabile sicurezza del suo tono
vacillò sull’ultima sillaba, tradendo una paura radicata, nascosta, ma
profonda.
«Se lo facessi, verrei accusata di tradimento»
spiegai a denti stretti, notando solo allora il pesante muro di nebbia
che celava il mio avvenire.
Cosa avrei fatto di lui?
«Allora, mi terrai prigioniero?» la malizia
nella sua voce fu talmente insolente da spingermi a sollevare il
kalashnikov all’altezza della sua fronte.
«Non lo sai che non si punta mai un’arma al
volto? Che abbia o meno la sicura inserita, è inteso» attese che il
senso delle sue parole penetrasse nella mia consapevolezza, prima di
ridere. La sua ilarità lasciò il tempo che trovò: il riso si trasformò
in una smorfia di dolore e la mano premette contro il fianco.
«Ecco perché siamo in guerra; dei figli di
puttana come te hanno stuzzicato gli americani, hanno tirato la corda
fino a spezzarla» lo insultai, gettando rumorosamente l’arma sul
pavimento e calciandola via, lontana da me e da lui.
«Su un totale di ottantasette battaglie, ne
abbiamo vinte cinquantatre. Siamo in vantaggio, bellezza».
La brutale leggerezza con cui parlava della
guerra mi sconvolse. Ripensai all’onnipresente necrologio sul “Fort
Worth News”, alle molte foto che testimoniavano la vita spezzata di
bambini innocenti, ripensai alle lacrime sui volti di genitori
disperati, ripensai a tutti i cittadini caduti sotto il fragore delle
bombe e dei fucili, ripensai a mio padre e mio fratello impegnati sul
fronte settentrionale, alla possibilità di non rivederli mai più...
Il disgusto mi colmò lo stomaco e la bile
risalì, bruciandomi la gola.
«Ce l’hai un nome?» sbottai a denti stretti,
dirottando il discorso altrove.
«Aleksandr Lebedev, comandante in seconda della
76esima Divisione» si presentò, accompagnandosi con un gesto della mano,
quasi stesse sfiorando la tesa di un immaginario cappello.
Quando si diceva l’ironia della sorte. La mia
personalissima nemesi portava lo stesso nome – in forma russa, certo –
di mio padre, Alexander.
«Bene, Aleksandr Lequalcosa, questa è
casa mia e qui vigono le mie regole. Dai miei ospiti pretendo che
mostrino la dovuta educazione e il dovuto rispetto; dai prigionieri
russi cani bastardi pretendo che se ne stiano a marcire in questa
mansarda, arrecando il minor fastidio possibile. E se ti riesce, evita
di parlarmi. Vy ponimayete?» domandai, pescando da chissà dove la
reminescenza di quel “Capito?” in russo, ascoltato molto tempo fa da
chissà chi.
«Zakazy, agli ordini» imitò un perfetto
cenno militare di obbedienza, storcendo poi il viso in una smorfia
sprezzante.
Girai sui tacchi, premurandomi di portare con me
qualsiasi oggetto che avrebbe potuto trasformare in una potenziale arma,
e andai via, chiudendo a chiave la porta.
Non sarebbe fuggito, non mi avrebbe messa nei
guai.
Trovai un mogio Jack seduto al tavolo della
cucina a spiluccare l’ultima fetta di pane raffermo.
«Ehi, ciao Jack, ti sei divertito?»
«Mi dispiace, Valerie» mormorò contrito e
dovetti stringere il pugno per non schiaffeggiarlo.
«Figurati. Che sarà mai un soldato russo,
arrogante e insolente, che potrebbe metterci in grossi, grossi casini?!»
«Non lo farà! Insomma, gli abbiamo salvato la
vita, non può...» tacque all’improvviso, quando un grido sferzò il
silenzio.
«Ho fame, piccola stronza!»
«Carino, eh?» domandai, facendolo ridere. Il
suono della sua risata era così bello, puro e spensierato che sorrisi a
mia volta, ammorbidendomi.
Avercela con Jack non aveva senso; piuttosto,
ero in collera con me stessa e l’orgoglio, compagno inopportuno e
indiscreto, mi pungolava. Avrei dovuto essere io quella ad uscire in
perlustrazione e tirare fuori il soldato bastardo dalle lamiere, non un
ragazzino quattordicenne. Invece, mi ero limitata a tirare le tende e
voltare le spalle, agendo con freddo cinismo.
Fortunatamente, Jack pareva esistere apposta per
riesumare il lato più umano e caritatevole di me.
Preparai una grossa pentola di minestra a base
di verdure; roba leggera, che ci riempì solo dopo tre scodelle. Eppure
non potevo permettermi una vasta scelta, non potevo sprecare il cibo. E
non potevo di certo sfamare quello stronzo con carne e formaggio, non
dopo l’incidente, la perdita di sangue e tutto il resto. Una piccola
parte di me suggerì che quei viveri di scorta, poi, era per noi, non per
lui. Me ne vergognai quasi subito e sentii il viso bruciare di
imbarazzo.
Solo quando Jack fu sazio versai la minestra
densa e pallida in una scodella, adagiandola su un vassoio con tanto di
acqua, stoviglie e tovaglioli.
Avrei dovuto rammentare di informarlo che il
servizio in camera non era previsto e che non appena la ferita fosse
guarita avrebbe dovuto sistemarsi altrove, tornando magari a quella sua
Divisione che sembrava amare tanto.
Lo trovai seduto sulla poltrona, impegnato a
trastullarsi con le piccole code che chiudevano il nodo della sua
fasciatura. Notai con piacere che aveva indossato nuovamente la
mimetica, lasciando tuttavia che la parte superiore pendesse sui fianchi
e sulle gambe. Scoccai un’occhiata disgustata alla sua maglia a righe,
chiazzata di polvere e sangue, divelta in diversi punti.
«Le lenzuola sono sudice» mi informò irruento e
nervoso.
«Dovrebbe importarmene qualcosa? Questi sono i
tuoi appartamenti, soldato. La cena».
Posai il vassoio sul piccolo tavolo alla sua
destra, valutando l’effettivo stato delle lenzuola.
Irritata, dovetti convenire con lui e assumermi
una giusta fetta di colpa: molto del sangue che le striava – come il
manto di un animale – era fuoriuscito durante la mia maldestra sutura di
fortuna. Le grandi macchie circolari di fango, poi, certo non
contribuivano a migliorarne l’aspetto.
«Dovrei mangiare questa porcheria? Stai
scherzando?»
«Oh, mi dispiace che il pasto non sia di suo
gradimento. Dica, preferisce una succosa bistecca cotta al sangue, con
contorno di patate dorate, pomodorini a fette e smeraldine foglie di
lattuga?»
Ci fissammo torvo per qualche secondo, prima che
affondasse il cucchiaio nella minestra.
Lo vidi muovere la mascella a destra e sinistra,
vagliando il sapore e la densità del piatto, decidendo infine che non
era davvero di suo gradimento.
Lo sputò sdegnato – ma sarebbe meglio dire che
me lo sputò addosso – e con un fermo manrovescio scaraventò la
ciotola sul pavimento, incrociando quindi le braccia al petto.
«No, non è di mio gradimento, americana del
cazzo».
Sospirai e sopportai. Solo pochi giorni,
continuavo a ripetermi, solo il tempo di rimettersi e poi andrà via.
«D’accordo; troverai l’acqua più gradevole,
immagino».
Mi allontanai per recuperare scopa, paletta,
qualche straccio e un secchio d’acqua.
Pulizie notturne, fantastico.
Mi osservò ripulire senza fiatare, immobile
nella poltrona. Quando ebbi finito, gettai tutto nel secchio del
pattume, e tornai da lui, cambiandogli le lenzuola.
La stanchezza aveva sciolto le briglie dei miei
pensieri e l’astio era montato nel sangue, portandomi a riflessioni
molto poco carine, spingendomi sull’orlo di una crisi isterica che, in
qualche modo, avrebbe previsto l’uscita di scena di quel piccolo
insolente, in maniera assai dolorosa.
Immaginai la pelle morbida del collo modellarsi
sotto la salda prese delle mie mani, l’onnipotenza di sentire la sua
vita tra le dita, le labbra rosate che digradavano in una mortifera
sfumatura di blu...
«Ho fame» disse quando ormai lo credevo
addormentato, strappandomi alle mie fantasticherie.
«Hai avuto la tua occasione, russo bastardo»
replicai lestamente, serafica, augurandogli una buona nottata. Jack mi
aspettava a ridosso del muro, seduto sul pavimento.
«Vai a dormire, Jackie, è tardi».
«Non andate d’accordo, eh?» domandò imbarazzato,
tirandosi in piedi.
«No di certo».
«Lascia parlare me. Magari tra maschi ci
intendiamo».
Non mi allettava l’idea di lasciare il ragazzino
da solo con quel soldato, ma la certezza della sua disastrosa condizione
fisica fu sufficientemente forte da impedirmi di replicare.
Jack era forte, se la sarebbe cavata in caso di
aggressione e, soprattutto, io sarei rimasta nei paraggi. Nella tasca
della felpa sentivo il peso rinfrancante del serramanico.
«Come vuoi. Ma è tempo perso» mi allontanai e
solo quando sentii la porta chiudersi tornai in mansarda, acquattandomi
contro la parete.
Riuscii a cogliere ogni battuta del loro
dialogo, con stizza crescente.
«Ciao, sono Jack».
«Ciao, Jack. Mi hai
trovato tu?»
«Sì. Mi dispiace per il tuo compagno... ho
cercato di...»
«Non importa, conoscevamo ogni rischio. Grazie,
comunque, non avrei mai pensato di dirlo ad un americano ma... ti sono
debitore».
«Dovere, ehm...»
«Aleksandr. O Alek, se preferisci».
«Alek, okay. Bene. Quindi, sei un pilota, fico».
«Pilota giovane e inesperto, aggiungo. Avrei
dovuto prestare più attenzione al radar e meno al mio istinto. Ti
piacciono gli aerei, ragazzo?»
«Molto. Ma non mi piace quando ci bombardano.
Immagino che... stanotte... eravate voi...?»
«Spiacente. Io e il mio compagno siamo arrivati
qui solo questa mattina, intorno alle cinque».
«Ah. Lo parli bene, l’inglese».
«Mia madre è americana, così come i miei nonni.
E tu, da dove vieni?»
«E chi lo sa? Sono stato abbandonato, non ho mai
conosciuto i miei genitori».
Pausa di silenzio. Un’imprecazione in russo, a
denti stretti.
«Quindi, tu e quella lì siete orfani?»
«Oh no, io e Valerie non siamo parenti. Lei mi
ha trovato e mi ha portato a casa sua. È una bella storia, magari un
giorno te la racconto».
«Sì, magari».
«E Valerie, be’, lei è una bella persona».
Una risata di scherno.
«Oh, sì, ho visto».
«Non è male, davvero; è solo che suo padre e suo
fratello combattono con i Marines, su, al nord, e quindi per lei tu sei
una specie di incarnazione del male o qualcosa del genere».
Dannato Jack, dannata la sua indiscrezione.
Strinsi i denti, prendendomi la testa tra le mani.
«Be’, ora è tutto chiaro. E sua madre?»
«Non me ne ha mai parlato, ma credo sia morta».
Morta. Probabilmente. Per me lo era di sicuro.
Soffocai uno sbadiglio, ribellandomi al sonno che premeva sulle
palpebre.
Il terrore era più forte della stanchezza,
abbastanza da tenermi in piedi per qualche altra ora, forse. Non mi
fidavo. Non potevo dormire con la consapevolezza di avere il nemico ad
un piano dalla mia testa, con la paura di non sentirlo insinuarsi in
camera da letto per tagliarmi la gola.
Non potevo dormire, suggestionata com’ero dagli
avvicendamenti della notte precedenti, dall’eco delle esplosioni ancora
nitido, ancora orribile.
Mi costrinsi a strapparmi dall’intorpidimento e
dal flusso sconnesso di pensieri quando captai i passi lenti di Jack
avvicinarsi alla porta. Sgusciai in un’intercapedine abbuiata, scrutando
la figura di Jack che, dopo aver salutato il soldato, scendeva
pesantemente le scale.
Pochi minuti dopo, e senza sapere come,
mi ritrovai adagiata tra le coperte. Ero così esausta da non saper più
collegare i fatti, ordinarli secondo una precisa cronologia; avevo la
sensazione che il mio cervello si addormentasse ad intervalli regolari,
tramortendomi.
Pensai distrattamente all’atteggiamento del
russo nei confronti di Jack, finendo col paragonarlo inevitabilmente con
quello che aveva riservato a me. Non invidiavo Jack e capivo fin troppo
bene perché io e lui fossimo così reciprocamente ostili e riluttanti a
trovare un punto d’incontro.
Chiusi gli occhi, umettandomi le labbra.
Alla fine, la guerra mi aveva raggiunta di
soppiatto, colpendomi alla schiena. E sapevo bene che, per quanto avrei
voluto gettarla a calci fuori dalla porta, quella sarebbe prontamente
rientrata dalla finestra.
Mi addormentai che un paio di vividi occhi
azzurri mi fissavano da dietro il vetro dei ricordi.
NdA: Settimana nuova, capitolo nuovo.
Per chi ancora sia rimasto a filarsi questa
storia, è inteso. Non che mi dispiaccia, eh; io pubblico questa storia
perché piace a me, quindi venti persone o una, tra i recensori,
non farebbero poi una grande differenza.
Chiusa questa parentesi, questo capitolo, per
una mia dimenticanza, non è stato betato e di questo chiedo scusa a
nali, verso la quale sento d'aver mancato di rispetto e puntualità,
ma giuro che non accadrà più: so bene quanto sia importante mantenere un
impegno preso.
Riguardo al capitolo non ho particolari note da
lasciare; si è visto un po' del carattere di Alek, un tipetto
assolutamente suscettibile e orgoglioso, un cavallo selvatico e bizzoso.
Un capitolo forse statico, ma necessario ad
introdurre il rapporto che, da qui in poi, correrà tra lui e lei.
Non ho altro da aggiungere, se non ringraziare
chi legge questa storia e sperando che sia di suo gradimento.
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 5
*** La rottura ***
Nuova pagina 1

«Buongiorno, Val. Senti...» Jack tentennò,
grattandosi la nuca mentre un’ondata di rossore affiorava sulle guance
scarne.
Sollevai lo sguardo, passando le dita tra i
capelli corti e indisciplinati, reduci da una nottata animata da incubi
sgradevoli e così vividi da sembrare reali.
«Cosa?»
«Ecco, Alek mi ha chiesto di vestiti puliti...
la sua, ehm, divisa è sporca e strappata e...»
Strinsi le labbra in una smorfia di
disapprovazione.
«Alek? Siete amiconi, insomma. Bene, dì
ad Alek che noi non siamo un negozio di abbigliamento e che non
abbiamo soldi da spendere per lui – né per noi, figuriamoci. Non appena
vedrò Sam—»
Quattro colpi secchi alla porta, quattro colpi
persi dal mio cuore.
Deglutii, scattando in piedi.
«Vai dal soldato, tienilo chiuso in quella
maledetta mansarda!» bisbigliai concitata, spingendo il ragazzino verso
le scale.
Quando sparì oltre l’angolo del primo piano,
trassi un profondo respiro e spalancai la porta.
«Sam!» squittii, sorridendo troppo.
L’uomo fiutò la stranezza e piccole rughe gli
incresparono la fronte.
«Stai bene?»
«Sono ancora un po’ scossa per via del
bombardamento. Tutto bene da te?»
«Fortunatamente sì. A parte i ranger, certo»
sbuffò, sistemandosi il cappello.
Una scarica di panico mi fece tremare le
braccia.
«Ranger?»
«Sì. Non l’hai saputo? Un cacciabombardiere è
precipitato nell’ultima spiaggia e il pilota è scappato. Il suo
compagno non è stato altrettanto fortunato, le lamiere lo hanno
trapassato da parte a parte» la nota di compiacimento nella sua voce e
nei suoi occhi mi fece rabbrividire.
Sam sapeva essere spietato e il suo
atteggiamento lo rese sinistramente simile all’ospite indesiderato che
alloggiava nella mia mansarda.
«Quindi, cosa fanno i ranger? Passano in
rassegna le abitazioni?»
Annuii, aggiungendo che probabilmente sarebbero
entrati in casa mia per accettarsi che lo straniero non si fosse
introdotto di soppiatto.
No, di certo non si era introdotto di soppiatto.
L’esatto opposto.
«Okay. Sam, ascolta, ho bisogno di vestiti
vecchi, della tua taglia».
Di Sam apprezzavo la sua profonda discrezione,
il suo non perdersi mai in domande indiscrete.
Non mi stupii di vederlo annuire,
soprappensiero. Poi, dopo un lungo minuto di riflessione, mi domandò di
inviare Jack da lui, nel pomeriggio, così che raccogliesse il pacco di
vestiti vecchi appartenuti a suo padre.
Lo ringraziai e aspettai che il suo cavallo
fosse ben lontano prima di rientrare in casa.
Jack e il russo erano seduti al tavolo della
cucina; si scambiavano occhiate enigmatiche e complici, tacendo e
sorseggiando il loro caffè.
«Sam vuole che tu vada da lui, questo
pomeriggio» dissi a Jack, il quale annuii poco sorpreso. La nostra
conversazione, evidentemente, era giunta sino alle loro orecchie.
«Jack, ragazzo, in una tasca della mia mimetica
c’è una piccola palla di spugna, sai, è il mio anti-stress, ne ho
davvero bisogno; andresti a prendermela?»
Jack non colse il tono sottile e mansueto con
cui avanzò la richiesta, perciò annuì piano e si inoltrò in mansarda. Lo
fissai per una frazione di secondo prima che la sedia scaraventata sul
pavimento attirasse la mia attenzione; capii troppo tardi che era solo
un velocissimo diversivo per ingannarmi e trasalii quando la canna del
kalashnikov spinse tra le mie scapole.
«Ma che fai? Che fai?» strillai, in panico.
«Ascolta, stronzetta: non sono sfuggito al
disastro aereo per farmelo spingere su per il culo da te, che tradotto
significa: non mi consegnerai a quei fottuti ranger» bisbigliò
freneticamente, il suo respiro che soffiava sulla mia nuca e un pesante
accento russo a striargli la voce.
«Se evitassi di puntarmi quella cosa addosso,
forse potrei pensare a qualcosa prima che—»
«Allora pensa in fretta!» ringhiò, spingendomi
lontano da lui.
Quando i ranger spensero il motore dei loro
fuoristrada e bussarono alla porta con fare urgente non ci trovarono
impreparati.
Sebbene avessi spronato il cervello a trovare
una soluzione, nulla mi aveva folgorata quanto le vecchie fedi
impolverate nel secondo cassetto del mobile. Un piano stupido, grezzo e
azzardato, ma se il soldato avrebbe taciuto, lasciando parlare me,
probabilmente ne saremmo usciti entrambi illesi e, non di minore
importanza, avremmo evitato la galera.
La parte più velenosa e patriottica di me
suggeriva di darlo in pasto ai ranger, di mettere su una lacrimevole
messinscena in cui io, fragile ragazza indifesa, ero stata costretta a
curarlo e offrigli asilo, tenuta schiava e prigioniera nella mia stessa
casa; la parte più codarda e leale mi diceva invece di coprirlo, di
proteggere lui e me stessa, che la pena capitale, per quanto applicata
nel giusto, era orribilmente sbagliata. Che nessuno poteva – e doveva –
arrogarsi il diritto di spegnere una vita nell’elettricità o nel veleno
nonostante la crudeltà dei reati commessi. Non era giustizia, ma freddo
abuso di potere.
I due uomini mi spiegarono il già noto motivo
della loro visita e fui la prima ad offrirgli di entrare e verificare
personalmente che nessun intruso fosse sgattaiolato di soppiatto in casa
mia.
Passando per la cucina, mostrandomi debitamente
preoccupata e tesa, presentai loro “mio marito Alexander Jones”, il
quale badò di salutare con la mano sinistra, dove la fede che stringeva
l’anulare riluceva di ritrovata pulizia.
«Tesoro», mi chiamò Aleksandr – era la prima
volta che pensavo al suo nome, la prima volta che non lo apostrofavo
mentalmente con dispregiativi come “il soldato” o “il russo” –
battendosi una pacca sulla gamba e sfoggiando un perfetto quanto
disarmante accento texano, «vieni qui mentre aspettiamo che i ranger
controllino» mi tese la mano che, per non tradire la circostanza che
così bene stavamo fingendo, afferrai prontamente, lasciandomi poi
accomodare sulle sue gambe.
Badai di sedermi sulla gamba destra, dove il mio
peso non avrebbe influito sulla ferita nel fianco, eliminando così la
possibilità di tradirci.
Il suo braccio mi circondò i fianchi e sorrise
affabile ai ranger che si congedavano, poggiando infine la guancia
contro il mio collo.
Rabbrividii e il disgusto mi pervase,
addensandosi nelle braccia che tremavano nel vano tentativo di tendersi
per allontanarlo.
Ogni negativo pensiero mi esplose dentro,
inondandomi la mente. La differenza tra noi mai come allora era stata
così tangibile, come mai così tangibile era stata la reciproca
avversione.
Solo qualche giorno. Solo il tempo necessario
affinché guarisca e poi finalmente uscirà dalle nostre vite.
Jack entrò a passo felpato in cucina e piegò la
testa di lato davanti alla nostra posizione equivoca.
Gli feci segno di tacere, indicando poi con un
brusco cenno del mento il fuoristrada parcheggiato proprio davanti alla
finestra della cucina.
Jack, che vantava una certa arguzia, mi scoccò
un’occhiata complice, annuendo impercettibilmente; poi, con disinvolta
naturalezza, sedette accanto a noi.
Al piano di sopra gli stivali dei ranger
picchiavano contro le assi del pavimento, facendomi sobbalzare ad ogni
tonfo; ogni volta che li sentivo camminare fremevo di impazienza –
impazienza che se ne andassero – e ogni volta che li sentivo borbottare
scontenti temevo il peggio, che avessero scoperto il nostro inganno, che
ci arrestassero tutti e, infine, assistevo impotente alle crude immagini
della mia fantasia persuasa dall’orrore, in cui i nostri corpi erano
legati a sterili brande bianche in attesa che l’ago penetrasse la vena,
uccidendoci.
Paradossalmente, fu la causa di ogni mio
malessere a permettermi di restare attaccata alla sanità mentale e al
debole autocontrollo; solo quando i ranger tornarono da noi mi accorsi
di quanto forte avevo stretto l’avambraccio di Aleksandr.
«Tutto okay» ci informarono, scusandosi per il
disagio arrecatoci e raccomandandoci di stare all’erta e di correre
subito al riparo nel caso in cui le sirene avrebbero suonato.
Garantimmo loro la massima prudenza, ogni cosa
purché si sbrigassero a mettere molte miglia tra noi e loro.
Solo quando il loro fuoristrada diventò una
macchia ronzante e argentata trassi un profondo sospiro di sollievo,
sfilandomi celere la fede che mi attanagliava il dito e che avvertivo
incredibilmente pesante sulla carne.
Senza porre alcuna domanda, tesi il palmo aperto
verso il soldato, che mi restituì l’anello, ben lieto di potersene
liberare.
Sospettai che non fosse un grande ammiratore del
matrimonio.
«Bell’idea, Val!» ruggì Jack, lasciandomi una
pacca sulla schiena.
«Ringrazia il tuo amichetto e la sua capacità di
simulare il nostro accento» ribadii gelida, scoccando una rapida
occhiata al cielo terso oltre la finestra.
Mi venne spontaneo domandarmi fino a quando
sarebbe durata la quiete, quando sarebbe giunto il terribile momento in
cui lo status quo sarebbe cambiato.
I giorni a seguire si trascinarono lenti e
l’atmosfera elettrica che regnava in casa mia ci sprofondava tutti in un
clima cupo e ostile. Solo il giovane Jack pareva immune; la spola tra me
e il soldato non sembrava infastidirlo, così come ben sopportava i
nostri insulti, velati e non velati. Jack era così profondamente buono
che la sera in cui litigammo per quel maledetto kalashnikov (io
pretendevo che fossi io a prenderlo in custodia, lui insisteva col dire
che ci avrei uccisi tutti grazie alla mia inettitudine) si frappose tra
noi prima che arrivassimo alle mani – un passo breve, in ogni caso, non
sventato, ma soltanto posticipato.
Il giorno in cui rischiammo davvero di
picchiarci arrivò fin troppo presto.
Il cielo era coperto da una moltitudine di
nuvole grigie e dense, unite in una cupola che pareva sul punto di
crollarci addosso, soffocandoci.
Vidi Aleksandr grattarsi furiosamente il fianco
sinistro e ricordai i punti di sutura, a quel punto probabilmente
inutili.
«Devo toglierti quei punti, ormai sono inutili»
sbottai irritata, lasciando che i piatti cozzassero tra loro nel lavello
sciabordante d’acqua e schiuma.
Mi fissò con un vago sorriso malizioso prima di
sfilarsi la vecchia camicia appartenuta al padre di Sam, raggiunta
quindi dalla bendatura pulita e bianca, che presentava solo qualche
alone nei punti in cui, lavandosi, il sapone era schizzato sul tessuto.
«Hai ragione, sono superflui. Guarda che razza
di cicatrice: sbilenca e frastagliata. Ottimo lavoro» si lamentò,
tirando la pelle per osservare meglio il segno.
«Non sei morto, quindi ottimo lavoro davvero» lo
rimbrottai aspramente, spingendolo poi sulla sedia e invitandolo a
restare fermo, a meno che non avrebbe gradito la lama delle forbici
sprofondare nella carne.
«Sei così debole che non riusciresti ad uccidere
un uomo nemmeno se fosse sul punto di stuprarti» mi insultò, ridendo
sguaiato.
La mano tremò mentre le forbici recidevano il
filo sottile che aveva tenuto insieme la carne.
«Ma guarda che fortuna: ho una vita così
impeccabilmente noiosa che non ho mai corso il rischio» replicai
distrattamente.
Sfilai il filo con troppa foga e lo sentii
sussultare mentre il sangue affluiva rapidamente alla cicatrice, che,
pallida, svettava contro la pelle arrossata.
«C’è sempre una prima volta e saresti comunque
debole, tanto da lasciarti violentare senza neppure opporre resistenza.
Voi americani siete così... così...» sventolò leggermente la mano, alla
ricerca della parola che gli sfuggiva.
Lo inchiodai con uno sguardo pieno di
riprovazione.
«Topi che ballano quando il gatto non c’è,
ecco. Sbandierate coraggio, arroganza e disinvoltura, ma basta mettervi
all’angolo per farvi tremare, basta che torni il gatto per farvi
scappare. Codardi» mi provocò deliberatamente e, sciocca, caddi nella
trappola, puntandogli le forbici alla gola, premendo fino a che non le
sentii affondare nella carne.
«Non mi preoccupo nemmeno; io lo farei, tu no».
«Questo perché tu sei un assassino».
«Questo perché tu ostenti una determinazione che
è falsa».
Strinsi l’impugnatura gommosa delle forbici.
«Non costringermi, russo».
Accadde tutto così alla svelta che mi domandai
cosa fosse esattamente accaduto. L’attimo prima ero china davanti
a lui, protetta in qualche modo dalla sua situazione di svantaggio (ero
io a puntargli una potenziale arma alla gola, non lui), l’attimo dopo mi
ritrovai schiacciata contro il muro, uno dei mobiletti della cucina a
pochi soffi dal mio viso. Sentivo la schiena talmente inarcata da
smorzarmi il respiro e il suo corpo premuto al mio. Il disgusto mi
investii.
Alzai la testa e vidi solo le forbici, ancora
strette nel pugno ora tremante.
Era talmente semplice per lui tenermi ferma che
me ne sentii umiliata.
Una mano era sufficiente per stringermi alla
gola e farmi annaspare, le sue gambe erano strette attorno alle mie e
la mano libera era posata sul sul fianco, leggera, quasi fosse stato un
movimento casuale e distretto, un movimento destinato a rimarcare la sua
posizione di evidente ed umiliante vantaggio.
«Vedi? Vedi come sarebbe semplice prenderti qui,
adesso, contro questo muro?» mi sbeffeggiò, allentando la presa.
Fu una chiara dimostrazione di quanto, pur
potendomi liberare, fossi poco incline ad attaccarlo.
«Stai bluffando» la mia voce si spezzò
sull’ultima sillaba, suonando come uno squittio impaurito.
«Sì?» sorrise, scoprendo una fila di denti
bianchi e ordinati, e sentii le sue dita sollevarmi la maglietta,
bruciare sulla pelle nuda e lì restare, in una sfrontata attesa.
«Però, se ci pensi bene, sei tu ad avere il
coltello dalla parte del manico. O le forbici, fa lo stesso» mormorò,
avvicinandosi al collo madido di sudore.
Sapevo cosa stava cercando di fare. Voleva farmi
rinunciare a me stessa, voleva compromettermi, traviarmi, allontanarmi
da ogni principio in cui fermamente credevo. Sarebbe bastato un
movimento ben calibrato, le forbici che veloci risalivano dal basso per
colpirlo al torace, alla gamba o al collo.
Non avevo permesso alla guerra di cambiarmi, non
avevo lasciato che la sofferenza mi indurisse o che il dolore mi
corrodesse. Ero rimasta fedele a ciò che ero, la parte più cinica,
fredda, calcolatrice e velenosa di me era rimasta al suo posto, a
compensarsi con le molte altre parti di me.
Aprii il palmo della mano e sentii la forbice
scivolare sul pavimento.
Ecco la mia resa incondizionata, sembrava
dire quel gesto, ecco tutta la mia debolezza.
Vidi il suo sorriso trionfante e un lampo di
delusione negli occhi azzurri.
«Permetteresti ad un uomo di praticare la più
vile e disgustosa delle violenze pur di non macchiare la tua purezza»
mormorò sprezzante e la mia gola tornò libera, arrossata, scorticata. Mi
persi in un attacco di tosse canina, secca, persistente.
Solo un dettaglio pareva essergli sfuggito: il
fatto che non fossi capace di uccidere non implicava che non
fossi capace di difendermi. Tentennai, repressi un conato
istintivo e lessi lo sgomento sul suo viso quando il mio manrovescio
impattò contro la guancia, lessi la sofferenza nei suoi occhi un poco
adombrati quando gli sferrai una ginocchiata al basso ventre.
Rantolò, piegandosi in avanti e chiudendo le
mani a coppa sui genitali.
«Ecco la mia reazione» lo schernii e fui io a
restare sgomenta davanti ai suoi occhi brucianti d’ira e al pugno chiuso
che vedevo avvicinarsi velocemente al mio viso.
Portai le braccia sulla testa, in un patetico
tentativo di difesa, e irrigidii i muscoli, in attesa del dolore.
Ma il dolore non arrivò.
Abbassai lentamente la guardia per vedere il
pugno chiuso tremare accanto al mio volto e distendersi lentamente,
riluttante.
Contrasse le dita diverse volte e, infine, mi
lasciò perfino una rigida carezza sulla spalla.
Ansimava come un cane rabbioso cui avevano dato
l’ordine di interrompere l’attacco proprio quando la gola del
malcapitato era già tra le sue fauci.
E in quel momento, capii. Capii che giudicava
duramente la mia debolezza per celare la sua. Capii che le sue
provocazioni erano state fatte non per irritarmi o provocarmi una
reazione, ma per tenere i riflettori lontani dal suo tallone d’Achille,
lontano dalle sue debolezze, così da apparire perfetto ed inattaccabile
nella sua arroganza.
Mi passai le mani tra i capelli e sospirai
pesantemente.
«Senti, così non va» mormorò roco, sbuffando.
«Sai, sono d’accordo. Vattene» sputai rabbiosa.
«Cosa?»
«Raccogli le tue cose e vattene. Ti ho curato,
ti ho dato da mangiare, ti ho salvato dai ranger, quindi dimmi solo
“grazie” e poi vai via» parlai lentamente, misurando il tono,
raccogliendo le parole giuste affinché tutto penetrasse nella sua mente,
affinché capisse che non era l’attuazione di una sciocca vendetta, ma
l’arrivo al capolinea della mia pazienza.
«Grazie, ma non me ne andrò».
«Tu devi andartene! Io... più di così non
posso, okay? Tu sei il mio nemico, odio te e tutto quello che incarni.
Quindi, per favore, vai via da casa mia. Domattina non voglio più
trovare traccia di te» mi congedai e dovetti controllarmi per non
fuggire in camera mia.
Quando sedetti piano sul letto, però, il
sollievo che tanto avevo atteso non giunse.
Giunse lesta, invece, un’immotivata amarezza.
NdA: Questo capitolo ha avuto bisogno di
una drastica riveduta perché i colpi di scena degni di Beautiful non mi
piacciono, ma non temete: la trama non ha subito alcun mutamento.
Oltretutto, solo ora mi sono accorta che per
qualche assurdo motivo il testo del secondo capitolo era uguale a quello
del terzo e, di fatto, mi sono ritrovata con due capitoli uguali.
Preciso immediatamente che non era una scusa per
risalire in cima alla classifica (tanto non è che ci sia un'orda di
persone a filarsi questa storia, anzi!), ma si è trattato di uno
spiacevole disguido puramente tecnico.
Detto ciò e poste le mie scuse, questo capitolo
lascia poco spazio ai chiarimenti. Alek è imbecille arrogante, Valerie
si è francamente rotta le scatole e c'è stata la rottura.
Ad onor del vero, di tutto questo capitolo conta
solo la parte in cui quei due adorabili personaggi vengono alle mani,
c'è un sacco di roba superflua ma... tant'è.
E la storia dei ranger... bah, prendetela come
viene, non ho avuto abbastanza fantasia da giustificare Alek in altro
modo né mi sono fatta venire in mente posticini strategici dove
nasconderlo.
Ancora una volta - e spero sia l'ultima - questo
capitolo ha subito un unico betaggio, ossia il mio. Visto che la mia
beta ufficiale aveva già i suoi pensieri, non ho voluto sovraccaricarla
e, quindi, se avete trovato errore di qualche genere, non esitate a
segnalarlo.
Ciò detto, mi congedo e ci si risente mercoledì
prossimo.
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 6
*** La nostalgia ***
Nuova pagina 1
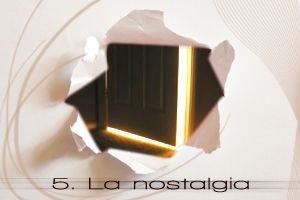
L’avanzata russa era continuata, spietata e
devastante, e infine mi aveva raggiunta.
Abbattute le difese di Dallas, l’esercito e
l’aviazione si preparavano ad invadere e sottomettere Fort Worth. Io e
Jack avevamo rassettato la cantina e capitava spesso che trascorressero
giorni interi nel suo spazio angusto, ma protettivo, salvo per
riemergere in casa per pranzare o espletare le funzioni corporee.
Non che parlassimo granché, comunque; da quando
avevo cacciato Aleksandr, Jack mi era ostile, scontroso e, ogni
qualvolta gli porgevo una domanda, mi sputava letteralmente addosso le
risposte, chiudendosi poi in un silenzio offeso.
Era colpa mia, immaginavo, non avrei mai dovuto
permettere che il ragazzino si affezionasse tanto al soldato; una colpa
che sentivo mia solo in parte, tuttavia, poiché lo stesso Jack aveva ben
saputo che presto l’uomo sarebbe andato via, lasciandoci alla nostra
vita di sempre, restituendoci la routine che aveva sconvolto.
«Jack, aiutami con queste bottiglie, ci
serviranno, dobbiamo riempirle d’acqua e tenerle quaggiù; non è più prud—»
domandai un pomeriggio di fine settembre e mi sfilò la pesante cassa di
bottiglie ancora prima che avessi il tempo di concludere.
La trasportò sino in cucina, lasciandola andare
con poca grazia.
Le bottiglie tintinnarono feroci, qualcuna andò
in frantumi.
Analogamente alla mia pazienza. Ero stanca,
spaurita, ansiosa e avevo raggiunto il punto di rottura. La tensione che
mi aveva stretta nelle ultime settimane tracimò, soffocandomi, senza
lasciarmi scampo.
«Adesso basta, basta! Ne ho abbastanza di
te, della tua ostilità, dei tuoi silenzi e della tua inutile
arrabbiatura! Sapevi che prima o poi sarebbe andato via, hai sbagliato
ad affezionarti tanto!» strillai, neppure cosciente della mia mano che,
molte urla prima, era volata alla sua guancia, colpendolo forte.
Vidi i suoi occhi riempirsi di lacrime di rabbia
e la mascella irrigidirsi.
«Sapevo che sarebbe andato via, non che tu
l’avresti cacciato! Che cosa ti aveva fatto?!»
Oh, ricordi pericolosi e vividi fuggirono
dall’angolo in cui li avevo barricati e sentii ancora le sue mani, il
suo respiro, la sua voce, e rividi i suoi occhi azzurri, ostili,
arrabbiati...
«Questo non ti riguarda».
«Bene! Bene!», ansimò e per un attimo fu a corto
di pensieri e parole, «Bene! Allora me ne vado, prima che cacci via
anche me» urlò, spazzando le lacrime con un gesto secco del polso.
«Jack, non... aspetta... senti, mi dispiace, per
averti urlato addosso, per lo schiaffo... ma sono così stanca, così...
Jack! Dove vai?» il panico nella mia voce era tangibile, ma non
abbastanza da trattenerlo.
Lo vidi correre in camera per uscirne pochi
minuti dopo, furioso e con una sacca lacera in spalla.
«Dove vai?» ripetei, sull’orlo di una crisi di
nervi.
«Non ti riguarda!» sbraitò, come se avesse
atteso debitamente quella domanda per ripagarmi della mia stessa moneta.
«Ma questa è casa tua e—»
«No! Questa non è casa mia e tu non sei mia
sorella, o mia madre, non sei niente per me!»
Le parole, l’insolita rabbia nella sua voce e
nei suoi gesti mi ferirono profondamente, tanto da inchiodarmi al mio
posto e togliermi la voce anche mentre si sbatteva la porta alle spalle,
anche mentre montava in groppa a Kellan, cavalcando via.
Instupidita e attonita, mi lasciai scivolare
contro lo stipite della porta, assistendo impotente alla tempesta di
ricordi che mi scuoteva; ricordi confusi, caotici, che mi colpivano con
la stessa intensità dei miei schiaffi sui loro visi.
Restai accasciata sul pavimento anche quando le
sirene, molto tempo dopo, esplosero, anche mentre gli aerei giravano in
tondo sulla città e sulle case limitrofi, anche mentre le bombe
distruggevano quel poco che si era salvato dagli attacchi precedenti.
Ma avevo troppo istinto di conservazione per
restarmene lì, ad attendere che una bomba mi facesse saltare per aria, e
strisciai lentamente verso la botola.
Il buio fu come le bombe, come le sirene, come
il fuoco e il vento. Il buio conciliò la rievocazione dei più recenti
avvenimenti, suscitando le lacrime e, dopo, i singhiozzi.
Molto tempo dopo, quando anche l’ultima bomba
venne sganciata, rientrai in casa. L’assenza di Jack e quella di
Aleksandr fu pesante almeno quanto lo era stata la loro presenza.
Immaginavo che Jack avesse raggiunto Sam,
speravo che l’avesse fatto prima dell’incursione. Il dolore mi strinse
lo stomaco e corsi al telefono solo per trovarlo muto.
Azionai l’interruttore del lampadario più volte,
senza successo.
Tagliata fuori dal mondo, senza collegamenti
telefonici né elettricità. Sola, in quella casa che ora sembrava tanto
immensa, tanto spaventosa.
Senza sapere se Jack fosse ancora vivo e se, con
lui, lo fosse anche Aleksandr.
Ripensai a quella mattina di molti giorni prima,
quando salendo in mansarda l’avevo trovata vuota e spoglia, esattamente
come prima del suo arrivo; come se non ci fosse mai stato.
Aveva badato bene di portare via ogni cosa,
prendendomi in parola.
Ma i ricordi, quelli mi facevano abbastanza male
da rammentarmi continuamente che sì, lui c’era stato.
E che forse, forse, anch’io avevo
commesso lo stesso sbaglio del ragazzino, permettendomi un inconscio
slancio di affetto realizzato solo grazie alla sua assenza.
Mi passai una mano sullo stomaco, poco sorpresa
di trovarlo chiuso e restio ad essere riempito.
Non mi restò altro da fare che accostarmi alla
finestra e osservare le prime gocce di pioggia autunnale picchiare sullo
sterrato che una volta aveva accolto la mia automobile, prima che
Aleksandr me la rubasse, picchiare sulla facciata della casa,
trasformandola in una grottesca figura piangente, percuotere i vetri,
gli arbusti bassi, le praterie che, sconfinate, sbiadivano
all’orizzonte.
Solo una cosa mi sollevò dal baratro di
autocommiserazione e disperazione in cui stavo lentamente scivolando:
presto la linea telefonica e quella elettrica sarebbero state
ripristinate, presto avrei provato quel sollievo quasi doloroso davanti
alla voce calda di Sam che mi confermava che Jack era da lui.
L’elettricità, però, non tornò l’ora successiva,
né quella dopo e quando ne furono trascorse una buona manciata mi arresi
all’evidenza dei fatti: il pesante bombardamento a Fort Worth aveva
irreparabilmente danneggiato le linee elettriche e forse anche quelle
telefoniche.
Seduta al tavolo, con la testa tra le mani,
fissavo assente la lingua tremolante della candela, accesa con
l’approssimarsi della notte, che gettava ombre sinistre e deformate sui
muri, rendendo il più innocuo degli oggetti una figura inquietante.
Dentro di me, sentimenti forti e opposti
spingevano e lottavano per accaparrarsi la porzione più grande del mio
animo. Non posi barriere o freni, lasciai che la mente vagasse in
direzioni un tempo proibite, adesso necessarie. C’era la nostalgia di
Alek, che mi spingeva irrimediabilmente verso lui; c’era l’odio per le
sue origini, per il suo modo di essere e per il suo mestiere che mi
allontanava e che, al contempo, mi faceva ritrovare più vicina di quanto
volessi.
La verità era che ero così assuefatta alla sua
presenza da non sopportarne l’assenza.
Non c’era nessun legame affettivo a tenerci
insieme, né romantico o di qualsiasi altra positiva origine. Al
contrario, l’astio e l’avversione erano stati dei collanti infallibili.
Ma potevano sentimenti così negativi unire due
persone così diverse? Potevano cancellare i colori che ci dividevano? O
al contrario li avrebbero ravvivati, accrescendo la reciproca
avversione?
Dunque, era quella la vera natura del nostro
legame: avevamo bisogno di stare vicini per odiarci, per dare libero
sfogo al malessere che ci affliggeva.
Ma ci odiavamo davvero, poi? Due mesi di forzata
convivenza non erano stati sufficienti a sbiadire emozioni così cattive,
incentivando magari qualcosa di più genuino e salutare?
Di domande ce n’erano quante volevo, di risposte
nemmeno a pagarle.
Avrei voluto che quell’ondata soffocante di
punti interrogativi si acquietasse, trasformandosi in una placida
distesa di punti fermi, avrei voluto cambiare l’ordine delle parole così
da non formare più una domanda, ma una risposta.
Sbuffai, accasciandomi tra le mie stesse braccia
che, molli, se ne stavano distese sul tavolo.
Mi lasciai cullare dalla pioggia che batteva le
finestre, il tetto, la terra rossa.
Poi, il ruggito di un motore spezzò il silenzio
e trasalii; la paura si mischiò all’adrenalina, inchiodandomi al mio
posto e irrigidendo i muscoli, pronti a scattare.
Qualcuno bussò.
Le dita strinsero istintivamente il serramanico,
il pollice pronto ad azionare il meccanismo di rilascio della lama.
Ma quando la porta rivelò la figura curva e
fradicia di Alek, il coltello precipitò sul pavimento con un tonfo
pesante e cupo.
Le palpebre sfarfallavano e battevano molto più
del normale, nel vano tentativo di liberare le ciglia dalla pioggia.
«Allora, mi fai entrare?»
Stordita, mi scansai per farlo passare. Lo vidi
chinarsi per raccogliere il coltello e porgermelo, un sorriso nervoso a
curvargli la bocca.
«Perché sei tornato?» domandai aspra mentre si
privava dei vestiti bagnati, sedendo poi a breve distanza dal fuoco che
scoppiettava fragoroso nel camino.
«Avevo fame e mi mancava dormire in un letto
vero».
La delusione mi gonfiò il petto, occludendomi la
gola. Null’altro, dunque. Tutti i miei lunghi e asfissianti ragionamenti
parevano così stupidi, adesso!
«Ti avevo chiesto di sparire!» gridai,
prendendomi la testa tra le mani e lasciandomi andare ad una serie di
mugolii lamentosi.
«Ho rischiato di rimanerci secco, oggi; abbi un
po’ di compassione, eh?» si sfregò le mani, avvicinandole quindi alle
fiamme.
Sedetti sul divano dietro di lui, sentendo le
spalle incredibilmente più leggere. Era tornato, e sarebbe tornato anche
Jack.
«E comunque, lasciatelo dire: sei davvero molto
poco ospitale. Sbattermi fuori in quel modo...» si voltò per fissarmi,
il fuoco che gettava ombre tremule sul viso, risaltando gli occhi nel
chiaroscuro dei suoi lineamenti.
Non c’era un vero sorriso sulle sue labbra, ma
qualcosa di molto simile; un ghigno bonario, volto a deridermi senza
però la solita cattiveria.
Scioccamente, mi sentii sopraffare da una
timidezza che mai mi era appartenuta.
«E tu sei un dannato ladro, mi hai rubato la
macchina».
«Touché» disse, e sollevò le mani in
segno di resa.
Era un Aleksandr molto diverso da quello che
ricordavo. Più umano, in qualche modo, animato da qualcosa di simile
alla gentilezza, più incline ad un abbozzo di sorriso che ad un ghigno
beffardo.
Un Aleksandr che mi riscoprii a gradire più di
quanto fosse lecito.
«Dov’è Jack?»
Inconsapevolmente, affondò la lama in una ferita
freschissima che trasudava ancora sangue.
Dovetti attendere che il nodo alla gola si
sciogliesse, prima di parlare.
«Da Sam; abbiamo litigato ed è andato via».
«Litigato? E perché?»
«Per colpa tua. Non accettava il modo in cui ti
avevo buttato fuori. In qualche modo ti è affezionato» feci una smorfia,
stringendomi le ginocchia al petto.
«Che c’è, sei gelosa?»
«No, è solo che non credo sia una buona idea»
spiegai, impacciata, desiderosa di parlare d’altro o, meglio, di non
parlare affatto.
I silenzi mi mettevano a mio agio, parlare, al
contrario, mi infastidiva.
«Lo penso anch’io. Oh» si allungò verso il
camino, afferrando la vecchia radio appartenuta a mio nonno.
«In Russia, nei paese poveri, ce ne sono
moltissime, di questa» per la prima, vera volta, Aleksandr sorrise di un
sorriso autentico, ma nostalgico.
L’azionò, soffermandosi sugli ultimi
aggiornamenti di guerra: gli americani avevano fermato l’avanzata dei
russi, scontrandosi a Wako, costringendoli ad arretrare fino ad Austin
dove, come topi caduti in trappola, avevano perso ben due battaglioni.
Aleksandr non gradì particolarmente la notizia,
ma ebbe il buon gusto di non commentare né di spegnere il sorriso
fiducioso che mi era spuntato sulle labbra. Sintonizzò la radio su
frequenze più placide, fermandosi ad ascoltare una vecchia canzone in
voga nel 2000, lenta e melodica.
Si alzò, del tutto a proprio agio nella sua
quasi nudità, e mi offrì la mano.
«Oh, no» scossi la testa e la risata risalì dai
polmoni, sbocciando sulle labbra. Ridere mi faceva bene, mi allontanava
per un attimo dalla realtà, dandomi respiro, tregua.
«Non ti piace ballare?»
«Sì, certo, ma non mi pare proprio il caso».
«A me invece sembra un momento più che giusto;
festeggiamo la vittoria dei tuoi...» mi afferrò per un polso,
trascinandomi in piedi e stringendomi in vita, «... e la sconfitta dei
miei».
Sorrisi con rinnovato disagio, mentre lentamente
assecondavo i suoi movimenti ciondolanti.
A distanza così ravvicinata, notai molti
dettagli che da lontano mi erano sfuggiti.
Primo tra tutti, era molto più alto di quanto
avessi mai pensato; mi superava di una testa abbondante, la mia bocca
appena a livello delle sue spalle.
Scoprii che le sue spalle erano larghe, solide,
irrobustite dai muscoli tonici che sentivo guizzare sotto le dita ad
ogni movimento.
Notai la piccola fossetta sul mento ogni volta
che canticchiava la canzone, di come si accentuasse al suono delle “I” e
di come si distendesse a quello delle “O”.
Ad incuriosirmi maggiormente, però, fu il segno
sbiadito di una spessa cicatrice che sfiorava appena la spalla, come se
fosse l’inizio di qualcosa di molto più vasto, più lungo.
Distratta, ne tracciai il profilo, scoprendo che
lo sfregio si arrestava al delimitare della biancheria. Distesi le dita
solo per scoprirne un’altra, a distanza ravvicinata, e un’altra ancora.
Aggrottai la fronte e solo allora fui
consapevole dei suoi occhi che mi fissavano insistentemente, brucianti
non d’odio, ma piuttosto di disagio.
«Le scuole militari, da me, sono molto...
severe» si attardò a trovare l’aggettivo, pronunciato con chiara
riprovazione.
Dondolavamo ancora, sebbene fosse iniziata una
nuova canzone sulla scia della precedente, quando gli domandai cosa
intendesse.
In risposta, sciolse il goffo abbraccio e mi
invitò ad aggirarlo, così da poter osservare la sua schiena illuminata
dal bagliore delle fiamme.
NdA: Inizio a pensare che dovrei creare
un'enciclopedia per i personaggi perché, a conti fatti, pare che di
capitolo in capitolo questi due sbarellino e diventino le versioni
dementi di se stessi.
A tal proposito, voglio chiarire giusto un paio
di cose.
Alek. L'avrete capito, no? Alek non è cattivo,
non è crudele; è solo un ragazzo un po' sborone che nasconde le sue
paure dietro l'arroganza. La prepotenza e la falsa determinazione sono
gli unici modi che conosce per preservarsi. È diffidente, Alek, non si
fida di nessuno, immaginate poi di un americano.
Ma essendo un essere umano, ha avuto dei
ripensamenti, ha realizzato che probabilmente il suo atteggiamento è
stato errato sin dall'inizio, che quei due giovani ragazzi non volevano
fargli del male, che se l'avessero voluto l'avrebbero consegnato ai
ranger molto prima o l'avrebbero lasciato morire.
Per questo torna a casa di Valerie e si scusa,
si mostra più vicino a quel che è realmente. O quasi.
E poi c'è Valerie che, no, non è innamorata di
lui, mettiamolo ben in chiaro. Valerie si era assuefatta alla presenza
di Alek, un po' come la storia della rana e dell'acqua calda: Valerie ha
imparato a convivere con Alek senza neppure rendersene conto ed è
plausibile che, nel momento in cui lui va via, lei realizzi tutto d'un
tratto questa situazione. Ma questo, lo ripeto, non vuol dire che lei ne
sia innamorata. Non per ora, almeno.
Ora, non avrei voluto fare tutte queste
precisazione perché (e nals mi è testimone) voglio che i lettori,
nelle mie storie, traggano le loro conclusioni senza ulteriori
spiegazioni, voglio che costruiscano i personaggi così come loro li
preferiscono, seguendo una loro chiave di lettura e non la mia.
Ma se è vero questo, è vero pure che queste
cose, in una long, non posso permettermelo, in quanto rischierei di
compromettere l'intera comprensione della storia.
Ultima precisazione. La scena di quel loro goffo
balletto... concedetemela e prendetela come è venuta. Ogni tanto anche
la sottoscritta ha piacere nell'immaginare un momento di quiete e di
quasi-romanticismo tra due persone (così diverse tra loro, poi; era una
tentazione troppo forte!). So che sembra una scena uscita direttamente
da una ficcyna e, ahimé, non posso che tacere e annuire.
Passando ai ringraziamenti, vorrei ringraziare
di cuore nals, che è tornata a betare 'sta storia qua e di questo
le sono infinitamente grata (ti amo oltre ogni concezione, lo sai)
e Shadow_soul che si è presa la briga di recensire, spendendo
qualche parola per esprimermi il suo parere e di questo non posso che
esserne infinitamente contenta (ti risponderò a breve, promesso).
Per la miseria, che nda lunghe! Sarà davvero il
caso di congedarsi.
A mercoledì prossimo.
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 7
*** La tregua ***
Nuova pagina 1

Orrore, fu la prima cosa che pensai,
immediatamente seguita da dolore e disgusto.
Lunghe e spesse cicatrici gli marchiavano
indelebilmente la schiena, come artigli impietosi che scavarono, a loro
tempo, nella carne tenera di un ragazzino.
«Sono i segni delle scudisciate, di quelle più
forti, almeno» non c’era dolore o pesantezza nella sua voce, solo una
vaghissima traccia di rammarico. Era disinvolto, come al solito, come se
non gli importasse, come se si stesse parlando di qualcun altro.
«Ma... perché?»
«Perché è la vita militare, perché spesso è
difficile, per un adolescente, obbedire agli ordini o tacere davanti
all’irruenza e all’arroganza degli addestratori» sorrise divertito, come
se avesse rievocato un ricordo particolarmente spiritoso.
«Ma questo non è...», pensai alla parola più
giusta, che potesse esprimere al meglio ciò che intendevo, «umano»
conclusi, scuotendo la testa.
Si voltò, chinandosi leggermente in avanti per
portare i nostri volti alla medesima altezza.
«Quando capirai che le guerre cambiano le
persone?» domandò, toccandomi la fronte con l’indice.
«Ho capito una cosa di te: non vuoi rinunciare a
te stessa, o qualcosa del genere. Non hai permesso che tutto questo ti
cambiasse, sei rimasta fedele alla tua sushchestvovaniye*, alla
tua, mmh, non mi viene adesso, scusa. Però sei rimasta te stessa.
Stupido, da parte tua; questo non fa di te oggetto di vanto, ma di
disapprovazione. Se resti te stessa, ti condanni a vivere nella
debolezza. Per questo le persone cambiano, per essere più forti e per
insegnare agli altri ad esserlo. I miei superiori, all’accademia, ce lo
ripetevano tre volte al giorno e, be’, alla fine finisci col capire che
è vero».
Era il discorso più lungo che gli avessi mai
sentito pronunciare, le prime parole che non fossero impregnate di
sarcasmo, ma, al contrario, serie, adulte.
«Non è comunque umano, esistono modi più
gentili per inculcare questo concetto» ribadii, scuotendo la testa.
Qualcosa lo fece ridere sprezzante, restituendomi uno scorcio del
vecchio Aleksandr.
«Gentile? Siamo soldati, bellezza, non timide
ballerine classiche».
Storsi il naso, completamente in disaccordo con
la sua visione; la visione di un militare, tuttavia, e per questo, per
lui, corretta.
«Stavo ripensando... quando hai detto: “Così non
va bene”, che cosa intendevi?» domandai, desiderosa di cambiare
discorso.
«Ah, te lo ricordi, eh?» domandò a disagio.
«Sì. Allora?»
«Non mi hai dato il tempo di spiegarmi;
intendevo che avremmo dovuto cambiare atteggiamento, venirci incontro
per il tempo della nostra convivenza. Ma mi avevi appena buttato fuori,
quindi non aveva più senso, la convivenza era già terminata».
Riflettei sulle sue parole, voltando la testa
fino a sfiorare, con la tempia, la sua spalla, la sua pelle.
Venirci incontro. Era possibile farlo? Trovare
un comune accordo, un compromesso per vivere bene sotto lo stesso tetto?
In fondo, ne avevo appena avuto una piccola dimostrazione, no? Era
tornato da un paio d’ore, ormai, e non ci eravamo urlati addosso nemmeno
una volta.
«Potremmo, sì. Renderebbe tutto più facile»
mormorai e sbadigliai, chiudendo gli occhi, cullata dai suoi movimenti
ciondolanti che continuavano ancora, sebbene la radio fosse muta da
molto tempo.
«Hai sonno?»
«Un po’».
Mi scansai, aggiungendo poi che ero veramente
assonnata e che avrei avuto bisogno di dormire. Scrollò le spalle e
tornò ad adagiarsi sul tappeto davanti al camino, stringendosi addosso
la coperta che, scomposta, se ne era stata ammassata sul divano fino ad
un attimo prima.
«Non vai a dormire?» domandai, arrestandomi
sulla soglia della porta.
«Dormo qui; la mansarda sarà gelida».
«Ah. Okay, buonanotte, allora».
«’notte» replicò, sollevando una mano in segno
di saluto.
Sdraiata sotto una spessa coltre di lana e
cotone, passai distrattamente in rassegna la giornata appena trascorsa,
di quanto fosse iniziata male e di quanto si fosse conclusa fin troppo
bene.
L’ultima immagine che mi accompagnò nel sonno fu
quella del suo sorriso nostalgico.
Il mattino mi sorprese con un timido e pallido
raggio di sole, sul sorgere dell’alba.
Abituata ad iniziare le giornate di buon’ora, mi
alzai, sgranchendomi come un gatto, allungandomi e ritraendomi tra le
coperte. Mi passai quindi le mani sul volto, liberandolo dai capelli e
dagli ultimi strascichi della dormita.
Mi sentivo inaspettatamente riposata, come se
avessi dormito non per poche ore, ma per giorni interi. Il sole illuminò
perfino la bizzarra sensazione di benessere che mi strisciava addosso,
mettendomi di buon umore.
Mi permisi addirittura di canticchiare piano
sotto la doccia o mentre mi asciugavo i capelli o mentre scendevo le
scale.
Passai davanti al salotto, puntando dritta in
cucina, salvo poi arrestarmi bruscamente e indietreggiare sino a tornare
indietro, sulla soglia della stanza.
Aleksandr era mollemente abbandonato sul tappeto
e durante la notte, con l’estinguersi delle fiamme, si era fatto più
vicino al camino dove, accese e iridescenti, le braci brillavano,
ammiccando.
Dormiva scompostamente, a bocca schiusa, come
avrebbe fatto un bambino. Di tanto in tanto le sue labbra si muovevano
appena, formando parole spezzate e indistinguibili.
Decisi di allontanarmi con passo felpato e
chiudermi alle spalle la porta della cucina; avevo la sensazione che la
neonata tregua non prevedeva la sveglia all’alba e che di sicuro non
l’avrebbe affatto presa bene. Lungi da me, poi, il desiderio di litigare
o, peggio, urlare.
L’ostilità mi affaticava, litigare mi
intristiva; la pacifica convivenza, al contrario, faceva di me una
persona speravo gradevole.
Ancora con la bottiglia del latte tra le dita,
mi immobilizzai, rivedendomi dallo spazio lontano dei ricordi, rivedendo
il mio atteggiamento scortese e i tratti del viso pregni di rabbia e
avversione.
Me ne vergognai. Mi vergognai del mio essere
così incostante e contraddittoria. Mi vergognai della mia puerile
acidità e dei dispetti adolescenziali che ci eravamo fatti
reciprocamente.
Mi strinsi nelle spalle, rinfrancandomi con il
nuovo compromesso cui eravamo giunti e che, pensai rammaricata, avremmo
potuto raggiungere molto prima.
Quanto tempo ed energie avremmo risparmiato!
Scaldai il latte, tamburellando le dita sul
ripiano e rabbrividendo di tanto in tanto. Pur sapendo che sarebbe stato
un tentativo vano, azionai l’interruttore della luce alzando gli occhi
al lampadario, che rimase irrimediabilmente buio.
«Buongiorno».
Sobbalzai e inavvertitamente urtai la fotografia
incorniciata che mi ritraeva in compagnia di nonno Hanks e nonna
Rosemary, che impattò contro il pavimento senza tuttavia infrangersi.
«Siamo distratte» sbadigliò, chinandosi poi a
raccogliere la foto. Feci per riprenderla, ma approfittò della sua
altezza e tese il braccio in alto, dove mai avrei potuto raggiungerlo.
«Rilassati, voglio solo darci un’occhiata. Il
tuo latte sta bollendo, comunque» mi informò, puntando l’indice ai
fornelli.
Impegnata a travasarlo in due diverse ciotole,
lo sentii trascinare la sedia sul pavimento e sedere piano.
«Sei tu?» domandò e accennò un ringraziamento
quando gli porsi la scodella e la confezione di biscotti ormai stantii.
Annuii, trangugiando piano la bevanda fumante.
Approfittai di quel momento per studiarlo da
sopra l’orlo della tazza; i suoi occhi azzurri vagliavano attentamente
lo scatto, dondolando piano sulle figure che l’immagine immortalava.
Sapevo cosa stava guardando: una me più piccola
e paffuta, di appena nove anni, seduta sulle spalle di un uomo alto e
nerboruto, dai fitti capelli neri screziati d’argento, affiancato da una
donnina fragile e minuta, che sorrideva fiduciosa all’obiettivo,
carezzandomi i capelli che, lisci, mi ricoprivano la schiena, come un
bruno mantello.
«Eri carina» sentenziò infine, sventolando piano
la cornice.
Aggrottai la fronte. Ero? Non era stato
forse lui a dirmi, non molto tempo prima: “Sei carina”?
Mi strinsi nelle spalle, sprofondando nel
consueto silenzio ostinato che mi trovava ogni volta che ricevevo un
complimento.
«Non ti piacciono i complimenti» non era una
domanda, ma una secca constatazione.
«Mi mettono a disagio» e no, non mi piacevano;
avevo sempre la sensazione che fossero delle velate prese in giro.
«Allora niente complimenti per te; non che poi
ne meriti tanti, comunque...» mi punzecchiò e quando piegai il viso in
una smorfia che pareva voler dire: “Ah, davvero?” lui ghignò, buttando
le mani avanti e pregandomi di non scaldarmi, ché stava solo
scherzando.
«Oggi mi aspetta una lunga giornata,
bombardamenti permettendo» aggiunsi, scoccando un’occhiata bieca al
cielo sereno oltre la finestra.
«Vuoi una mano?» non c’era un vero
interessamento nella sua voce, quanto una lieve forma di cortesia. Ci
ponderai su, riflettendo che due braccia forti mi avrebbero fatto
comodo; i viveri scarseggiavano e senza l’aiuto di Jack avrei impiegato
il doppio del tempo per caricare le scorte che Kim mi aveva tenuto da
parte.
Fui sul punto di accettare, quando ricordai poi
che dovevo assolutamente passare da Sam e convincere Jack a tornare a
casa.
«Devo andare da Sam, non saprei come
giustificare la tua presenza. Non posso certo permettere che scopra che
tu sei il pilota che non hanno più ritrovato» spiegai, infilando la
giacca a vento e afferrando le chiavi.
«Nessun problema», disse, «ti aspetterò in
macchina» mi tolse il mazzo di chiavi e si diresse al mio pickup,
sedendo al posto passeggero.
Sospirai. Fino ad ora la fortuna era stata dalla
mia parte, pregai che anche quel giorno mi aiutasse e soprattutto che
aiutasse Aleksandr.
Durante il tragitto, mi permise di scoprire
qualche piccolo dettaglio della sua vita prima della guerra; aveva due
sorelle minori, era nato a Mosca ma subito dopo la sua nascita la
famiglia era migrata a San Pietroburgo, che descrisse come una città
solenne e affascinante, colma di moschee arroccate sulle alture
della città, cosicché la loro cupola a cipolla fosse sempre ben visibile
ai fedeli.
Mi parlò a lungo della più piccola delle
sorelle, Inna, che descrisse come una bambina amabile, dai lunghi
capelli neri e enormi occhi azzurri; da come ne parlava non fu difficile
intuire che fosse la sua preferita. Ne elogiava la bontà d’animo e la
remissività, condannandone tuttavia l’eccessiva timidezza. Quando
parcheggiai lontano da casa di Sam, aveva appena terminato di dirmi che
Zoya, l’altra sorella, aveva dato alla luce il suo primo figlio, Igor,
appena prima che lui partisse per la guerra.
«Bene, resta qui. Mi riprendo Jack e andiamo a
Fort Worth» lo avvertii e alzai le spalle davanti alla sua smorfia
irritata quando lo chiusi in macchina. Non potevo sfidare la sorte in
modo così sfacciato.
Bussai alla porta e la piccola Rachel, una
ragazzina alta e smilza, mi sorrise raggiante, abbracciandomi.
«Ciao, Val! Speravo che venissi!» mi salutò,
irruenta ed entusiasta come sempre, mentre gentilmente la allontanavo da
me.
«Ciao, Rachel. Mi dispiace, piccola, ma sono
davvero di fretta; sono venuta a prendere Jack».
«Oh, certo. Lo vado a chiamare subito. Ma non
startene lì sulla porta! Vieni, vieni» mi trascinò in casa e mi invitò
perfino a prendere una tazza di caffè nel mentre.
Al quinto sorso, Jack apparve sulla soglia,
imbronciato.
«Ehi, ciao» lo salutai, facendolo cenno di
avvicinarsi; obbedì, seppur sbuffando.
«Aleksandr è tornato ieri sera; torna a casa con
me, Jack» sussurrai piano e lo vidi aprirsi in un sorriso soddisfatto.
«Bene,» disse ad alta voce, «prendo le mie
cose».
Prima di congedarmi, pregai Rachel di salutare
Sam, suo fratello Mark e sua madre.
In macchina, quando fummo ben lontani, Jack e
Aleksandr si strinsero la mano in cenno di caloroso saluto, e il
ragazzino iniziò a parlare a raffica, domandando senza concedere
all’altro il tempo di rispondere.
«Ehi, bellezza, per chi devo spacciarmi, oggi?»
domandò Aleksandr quando il cartello di Fort Worth ci diede il
benvenuto.
«Mmh, per un mio cugino dell’Illinois mandato
qui per sfuggire alle bombe» improvvisai, parcheggiando davanti alla
drogheria di Kim.
«Fantastico. Allora oggi sarò il cugino Alex»
strizzò l’occhio a Jack, che sorrise complice.
«Smettetela, voi due. E restiamo uniti»
l’allusione nella mia voce era chiara, così come il timore che
l’affliggeva.
Avevamo appena caricato la seconda cassa d’acqua
quando un’ombra lunga e sinuosa oscurò per un secondo il sole. Sollevai
lo sguardo al cielo, identificando il profilo noto di un
cacciabombardiere che volava in tondo sulle nostre teste.
Vidi un corpo grosso e scuro precipitare dalla
pancia dell’aereo; la bomba esplose ancor prima che le sirene
suonassero.
*essenza.
NdA: Sì, be', questa storia prende sempre
più la piega scontata di una ficcyna d'eccellenza, con la peculiarità
d'essere scritta grammaticalmente bene (si spera, almeno).
Non ho saputo resistere al passato oscuro e
tormentato e doloroso di Alek che, diciamocelo, un po' se lo merita.
A tal proposito, prima che l'intelligence russa
bussi a casa mia, butto le mani avanti e dico subito che il modus
operandi dell'addestramento militare russo NON comporta le scudisciate
(almeno, per quanto ne so io).
Solo che ho sempre visto quest'etnia come un
popolo particolarmente, uhm, brutale, quindi ho pensato che le frustate
e le punizioni corporali ci stessero.
Il finale di questo capitolo è uno dei miei
soliti anzi, se non vi ci siete ancora abituati, bene, fatelo. Perché
molti capitoli si concluderanno esattamente così. Che volete farci, la
suspance ha il suo fascino!
Come al solito, ringrazio immensamente la mia
personalissima Pulce/moglie/beta Nals che, udite udite!, in
questo capitolo non ha corretto niente e io ero tipo una gioia continua.
Nals, ti amo, lo sai. ♥
Colgo l'occasione anche per ringraziare Jè
e Shadow_soul, spero di poter rispondere alle vostre
recensioni in tempi brevi, spero. Però nel frattempo vi ringrazio per
l'attenzione che mostrate a questa storia; lasciatemi pure il vostro
indirizzo, per Natale vi recapiterò vagonate di scatole di biscotti al
cioccolato. :3
Infine, grazie a chi segue/ricorda/preferisce
questa storia e, come sempre, se qualcuno ha qualcosa da dire sulla
storia, lo invito a farlo. Non uccido mica. Non voi, comunque.
Bon, a mercoledì prossimo.
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 8
*** Il danno ***
Nuova pagina 1

Era l’inferno, alla periferia sud di Fort Worth.
Il fuoco divampò e si allungò come una bolla
inevitabile, rossa e calda, travolgendo ogni ostacolo sulla propria
avanzata. Spinsi Kim all’interno della sua drogheria, urlandole di
nascondersi, sgolandomi per sovrastare il fragore delle bombe e lo
squillo delle sirene.
Poi, frenetica e nel panico, afferrai Jack e lo
spintonai fino a che non fu al sicuro sul posteriore del pickup. Avevo
appena individuato Aleksandr, che restituiva un bambino in lacrime alla
madre altrettanto sconvolta, quando la seconda bomba esplose alla fine
dell’isolato.
L’onda d’urto ci spazzò via come formiche al
getto impietoso dell’acqua.
Sentivo la strada umida premermi contro la
guancia e strane luci bianche e rosse mi lampeggiavano davanti agli
occhi, sovrastando la scena drammatica che scorreva a pochi metri da me.
Una scena colorata, vivida, eppure senza alcun suono.
Lo stesso bambino salvato da Aleksandr aveva
trovato la propria pira nell’abbraccio materno; li vedevo urlare,
vedevo le fiamme mangiarli pezzo per pezzo, li vedevo rotolare
sull’asfalto bollente e, infine, giacere esanimi, schiacciati dal fuoco.
Vedevo gli pneumatici rotolare malfermi e
infuocati, bruciare, rilasciare una sottile colonna di fumo denso e
nero.
Vedevo il panico dilagare e muovere le gambe dei
cittadini, che, terrorizzati scappavano alla ricerca di un rifugio.
Vedevo, vedevo, vedevo, ma ero incapace di
distogliere lo sguardo dal corpicino immobile e arroventato; un
orsacchiotto di pezza bruciava accanto a lui.
Ero incapace di ascoltare e quando
strisciai sulle ginocchia per rialzarmi – l’istinto di sopravvivenza era
forte e disperato come mai prima d’allora – le vertigini mi ghermirono,
lasciandomi prona sull’asfalto.
Mi tastai la guancia solo per trovarla coperta
di sangue. Ero ferita? E dove? Alla testa? Alla tempia?
No. Il sangue fiottava dall’orecchio sinistro.
Nel silenzio, che così tanto stonava con l’inferno che mi circondava,
vidi Aleksandr – i capelli biondi incollati alla fronte sudata e
insanguinata – corrermi incontro e prendermi tra le braccia.
E il dolore esplose sul polpaccio, diramandosi in tutto il corpo. Urlai.
Ero sicura di stare urlando. Sentivo la gola gonfia e graffiata dalla
mia stessa voce, sentivo la bocca aperta in grido muto.
Vidi Aleksandr dirmi qualcosa prima di adagiarmi
sul sedile del passeggero, scavalcandomi poi per raggiungere la
postazione di guida.
Jack riemerse dal fondo dell’auto, bianco come
un cencio. Mi teneva la mano, lo sentivo, pelle contro pelle, ad occhi
chiusi, incapace di sopportare le vertigini.
Lo stomaco si accartocciò e forse implose,
spingendo la bile e la colazione su per la gola.
Mi chinai in avanti prima di liberarmi,
soffocando nella mia stessa saliva.
Solo allora fui consapevole del forte fischio
nelle orecchie, raccapricciante colonna sonora del paesaggio in fiamme
che mi scorreva accanto ad una velocità impossibile.
L’addome si contrasse, pronto ad una nuova
ondata di nausea. Ma l’incoscienza mi trovo prima.
«...Pensi che tornerà a sentire?»
«La dottoressa ha detto che la lesione non è
grave, che si sarebbe rimarginata spontaneamente. Dobbiamo solo
aspettare».
«Ma perché non si sveglia? Sono passati due
giorni, ormai».
«Ci vuole tempo, Jack».
A fatica, trovai le palpebre e ricordai come
sollevarle. Sfarfallarono, respingendo la luce.
Provai a chiedere cosa fosse successo, ma mi
ritrovai ad emettere un rauco e patetico: “Aah”.
Fu però sufficiente a placare l’ansia di Jack,
il quale si fiondò al mio fianco, prendendomi la mano.
«Come ti senti?»
La sua voce giunse da lontano, come se mi stesse
parlando da est mentre io ero voltata ad ovest. Poi capii. Solo
l’orecchio destro era capace di cogliere suoni e rumori, il sinistro
pareva morto. Decisi che me ne sarei preoccupata più tardi; ero viva e
tanto bastava.
«Uno schifo; dov’è?» gracchiai, aggrappandomi al
suo braccio per sollevarmi sul cuscino. Fortunatamente, la stanza rimase
immobile al suo posto.
«Chi? Alek? È qui».
Jack allungò il braccio per indicare la figura
di Aleksandr in piedi contro la parete. Sollevò il mento e sorrise mesto
ed esausto.
Si era ripulito; i capelli biondi, tuttavia,
erano stati accorciati di qualche centimetro, liberando la fronte,
attorno alla quale era ben stretta una fascia bianca su cui campeggiava
una macchia scarlatta, piccola e circolare.
Notai anche le pesanti occhiaie livide e mi
domandai da quanto e perché non dormiva.
«Come stai?»
Mi aspettavo un senso di ovattato stordimento,
invece ero incredibilmente lucida e ricordavo perfettamente ogni cosa.
L’immagine del bambino in fiamme mi tolse l’aria dai polmoni e
rabbrividii.
«Tu chiedi a me come sto?».
Mi spiegò che il timpano sinistro era stato
lievemente danneggiato e che la dottoressa Hourani era fiduciosa circa
la spontanea guarigione; poi indicò la gamba, sostenendo che una
scheggia aveva reciso il polpaccio, scheggiando l’osso.
In definitiva, mi attendeva una lunga
riabilitazione, mal di testa frequenti e crampi dolorosi alla gamba.
«La dottoressa Hourani? Sam?»
Jack e Aleksandr si guardarono; il primo guardò
altrove, l’altro sbuffò, toccandosi inavvertitamente lo zigomo che, solo
allora lo notai, era gonfio e tumefatto.
«Il tuo amico non è un tipo diplomatico».
«Cosa?» fissai Jack, il quale mugolò sofferente
un: “Hanno fatto a pugni”.
«Perché non ti sei nascosto?» gridai e una fitta
di emicrania mi spezzò il respiro.
«Qualcuno doveva pur badare a te mentre il
ragazzino andava a chiamarli» si giustificò e l’idea di saperlo a
vegliare su di me mi mise a disagio.
«Comunque non mi denunceranno, se è questo che
ti preoccupa; Sam», pronunciò il nome con arrogante scherno, «ha
detto qualcosa come “la sua vita per la tua”. Ci siamo fatti il
fidanzatino, eh?»
Bentornato, Aleksandr versione soldato
stronzo e indisponente.
«Oh, piantala» mi lamentai, prendendomi la testa
tra le mani.
«Non addormentarti, principessa; il tuo principe
azzurro sta per arrivare» e si congedò con un enfatico inchino di
commiato, sbattendosi la porta alle spalle.
«Ma che ha?» chiesi a Jack, il quale sorrise con
l’aria di chi la sapeva lunga.
«Credo sia geloso di Sam» sussurrò con
fare cospirativo, dandomi perfino il gomito.
«Geloso? Santo Cielo, e perché mai?» risi
incredula, ignorando il pulsare violento dell’orecchio.
«Be’, magari gli piaci» sputò con
ovvietà, come se fossi stata una stupida a non aver colto l’evidenza
prima.
«Magari», convenni indulgente, «o magari no».
L’arrivo della dottoressa fu provvidenziale e
mise a tacere la pronta replica di Jack.
Sam, al suo fianco, era rigido, il volto solo
una maschera inespressiva di gelida formalità.
Feci per dire qualcosa, ma la donna iniziò
tastarmi, a puntarmi un fascio di luce negli occhi, a chiedere di
toccarmi il naso con la punta dell’indice e dirle come mi chiamavo,
quando e dove ero nata.
Superai l’esame a pieni voti, a giudicare dal
sorriso radioso che le illuminò il volto, facendola apparire decisamente
più giovane.
«Per il tuo orecchio non posso fare niente,
purtroppo; per la ferita alla gamba tornerò tra due giorni per
controllare la sutura. Nel frattempo, in casi di dolore intenso, ti
lascio queste iniezioni intramuscolari» spiegò con fare professionale e
pratico, lasciandomi una manciata di fiale e siringhe sul comodino.
«Aspetti, aspetti. So quanto sono rari i
medicinali, la prego, li risparmi per casi più gravi del mio».
Inaspettatamente, si chinò per carezzarmi la
guancia.
«La tua gentilezza è nobile, davvero, ma ho
appena fatto rifornimento da Crockett e Joshua, stai tranquilla; e poi,
queste sarebbero solo acqua fresca per un caso più grave».
Scoccò poi un’occhiata a Sam e gli domandò di
uscire.
«Perché?» l’aggredì e mi sentii in dovere di
difenderla; ma non sapevo che sotto quel viso tondo e gentile si
nascondesse una personalità poco intenzionata a soccombere.
«Devo spogliarla per visitarla e non credo che
lei gradirebbe essere vista nuda da te» replicò mordace e Sam, dopo
avermi letteralmente incenerita con lo sguardo, andò via,
sbattendo la porta.
Sospirai e afferrai i lembi della maglietta, ma
lei mi prese le dita e scosse la testa.
«Volevo solo dirti che quello che hai fatto per
quel soldato è stato un gesto davvero magnanimo. Un altro, al tuo posto,
l’avrebbe lasciato morire o ucciso con le sue stesse mani. Sei una brava
persona» si complimentò e sentii di non meritare tante belle parole; non
l’avevo salvato io, ma Jack; non ero stata io a trattarlo con i dovuti
riguardi, ma Jack. Io avrei solo voluto sbarazzarmene, io gli avevo
ostinatamente voltato le spalle.
«Arrivederci, Valerie».
«Arrivederci, dottoressa».
La vidi avanzare fino alla porta, per poi
arrestarsi e voltarsi appena.
«Non essere troppo dura con Sam. Lui ti vuole
bene, lui non capisce...» si strinse nelle spalle e andò via, non
concedendomi neanche il tempo di chiedere spiegazioni.
Spiegazioni che mi vennero fornite negli
immediati minuti successivi, dalla voce tuonante e furiosa di Sam.
Percorreva furiosamente il perimetro della
camera, passandosi le mani tra i capelli sconvolti, spettinati, ritti
sulla testa.
«Tu devi consegnarlo!» urlava continuamente, in
un rumoroso monologo, senza concedermi il tempo di rispondere;
crucciata, incrociai le braccia e lo fissai sfacciata, in attesa di
ricevere la parola.
Approfittai di un momento di silenzio.
«Ne hai ancora per molto?»
Mi fissò torvo, ma ebbe la decenza di tacere.
«Non posso consegnarlo, tu sai che non
posso farlo» dissi piano, quasi dolcemente.
«Perché non me ne hai parlato? Quel dannato
figlio di puttana indossa perfino i vestiti di mio padre!»
«Non te ne ho parlato perché sapevo che avresti
reagito esattamente così».
«E come, se no?! Tu sfami un assassino!» urlò,
scaraventando sul pavimento un bicchiere colmo d’acqua, che esplose in
piccoli pezzi.
«Un assassino, sì, un uomo che ha combattuto per
il suo paese; non potremmo forse dire lo stesso noi, dei nostri
soldati?» domandai e indietreggiai bruscamente quando sedette sul mio
letto; a spaventarmi fu l’improvvisa calma che emanava da lui.
«Ti ha cambiata. Un tempo condannavi i russi, li
odiavi. E adesso li ospiti sotto il tuo tetto, parli in loro difesa»
scosse la testa.
«In sua difesa» precisai.
«Questo è ancora peggio. Perché? Perché lo vuoi
qui a tutti i costi, anche a rischio della vita?»
La domanda mi prese in contropiede; sorrisi
scioccamente, affaccendandomi alla ricerca di una risposta.
«Avete una storia?» sbottò rude, stringendo i
denti.
«No».
«Ti ha minacciata?»
«No di certo».
«Allora ti sei innamorata di lui?»
Esitai. Ero innamorata di lui?
«No» la marcata dolcezza era tagliente
abbastanza da intimargli di tagliare corto.
«Ti fai scopare da lui?»
Un’ ondata di sangue intriso di rabbia e veleno
mi esplose sulle guance, portandomi ad arrossire di indignazione.
«Vattene» sputai a denti stretti, massaggiandomi
le tempie doloranti.
«Scusa»
«Vai via, per favore. Vai» insistetti piano,
prendendomi la testa tra le mani.
Attesi, ad occhi chiusi, e un basso brusio
cacofonico giunse all’orecchio sano, interrotto all’improvviso da un
tonfo seguito da un rantolo.
Sentii la porta riaprirsi e chiudersi
nuovamente.
«Jack ha accompagnato il cane rabbioso alla
porta».
Approfittai dello scudo delle mie stesse braccia
per sorridere piano. Alzai la testa, chinandomi in avanti e
domandandogli di passare alla mia sinistra, così che potessi sentirlo
senza difficoltà.
«Sam, lui è...» sorrisi e fissai il soffitto,
ritrovandomi poi a scuotere la testa.
«Un figlio di cagna, già» commentò acidamente,
facendosi più vicino. Notai che anche l’altro zigomo era arrossato.
«Vi siete presi ancora a pugni?»
«Ci siamo andati leggeri, lo giuro. Tuttavia, se
non la pianta con le sue allusioni del cazzo, la prossima—»
«Non ci sarà una prossima volta! Basta! Dovete
smetterla, tutti e due!» lo redarguii con una certa difficoltà,
tenendomi il fianco pulsante di dolore, forse diretto riflesso della
ferita alla gamba.
«Non adesso, ti prego. Mi diverte da morire,
è così facile provocarlo!»
«Tu e le tue stronzate mi state facendo
scoppiare la testa» sibilai, realizzando effettivamente quanto
l’emicrania fosse cresciuta, dolente e inarrestabile.
«Allora, dormi» ordinò sbrigativo, avendo poi
l’ardire di distendersi accanto a me, restando tuttavia a distanza di
sicurezza.
Le parole di Sam tornarono a galla,
indesiderate.
Ti fai scopare da lui?
«Che fai?»
«Rilassati, riposo solo un po’ gli occhi; tu
dormi, non ti darò fastidio».
«Non riesco a dormire, con te accanto» mormorai
a disagio, spingendolo per convincerlo a scendere dal letto e andare
via. Mi afferrò il polso e lo posò sulla mia stessa pancia.
«Piantala. Tra dieci minuti vado via» mi
assicurò, chiudendo gli occhi.
Mi addormentai, nonostante tentai di opporre più
volte resistenza, e quando mi svegliai il letto era piegato solo dal mio
peso, Alek andato chissà dove.
NdA: Orbene, eccoci al settimo capitolo.
Siccome sono una personcina perversa che gode a
distruggere i propri personaggi - e, in generale, i propri lavori - ho
deciso di inserire un po' di azione, giacché la storia iniziava a farsi
un po' piatta.
E poi, perbacco, siamo in tempi di guerra, no?
Insomma, è necessario farla vedere, di tanto in tanto.
Però, state tranquilli: Valerie è stata
fortunata e la fine del conflitto mondiale è quasi al termine (poiché
quasi al termine è anche la storia).
Un monito: se state aspettando un happy ending,
bene, evitate di perdere tempo perché non ci sarà.
In un vaghissimo e lontano seguito probabilmente
sì, ma in questa storia certamente no. Lettore avvisato, mezzo salvato.
Come al solito, ringrazio Jè e Shadow
per le loro recensioni, che mi fanno sempre molto piacere.
A tal proposito, rinnovo il mio invito a
recensire, giacché questa storia è seguita da quasi venti persone e mi
farebbe piacere sapere cosa vi ha spinto a seguirla, se c'è qualcosa che
andrebbe cambiato, se qualcosa non vi ha convinto o se c'è qualcosa che
vi ha colpito particolarmente.
So che recensire è un atto tremendamente noioso
e che la pigrizia è la piaga delle fan-writer, ma non vi si chiede di
commentare tramite un poema, bensì anche solo con poche parole, giusto
per capire se questa storia è scadente come io stessa ritengo o se sono
io a sottovalutarmi come al solito.
Bene, chiudo qui questa mio invito e ci si
rivede mercoledì prossimo.
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 9
*** La curiosità ***
Nuova pagina 1

Feci sogni orribili, quella notte.
Lo avevo messo in conto e avevo cercato di
prepararmi, di erigere le difese necessarie, ma tutti i miei sforzi non
furono premiati.
Continuavo a rivedere, dalla mia sfera di
silenzio, il bambino bruciare sull’asfalto, focalizzandomi spesso
sull’orsacchiotto al suo fianco; come o perché, non avrei saputo dirlo.
Probabilmente, il giocattolo che bruciava rendeva vivida l’evidenza di
una piccola vita che termina.
L'immagine diventava cenere e si addensava in
una nuova scena, in un nuovo orrore.
Uno pneumatico rovente che rotolava incerto.
Cenere, immagine. Uomini e donne in fuga. Cenere, immagine. Panico nelle
bocche mute dei passanti. Cenere, immagine. Una bomba sganciata dal
ventre di ferro di un elicottero che mi precipitava addosso, sempre più
nera, sempre più pesante, sempre più minacciosa.
La vedevo precipitare, veloce, impietosa e
pregavo disperatamente alle mie gambe di muoversi, di spostarsi, di
portarmi in salvo.
Ma loro restavano inchiodate al selciato e la
bomba mi colpiva in petto. Annaspavo e il sangue fluiva caldo nella
bocca, sul mento.
Ansimavo, non ero più padrona del mio corpo. E
poi rimase solo il dolore. Accecante, sordo, insistente. Eterno.
Cenere, buio.
Rinvenni biascicando qualcosa, tossendo per
scacciare il grumo di saliva che mi soffocava.
Annaspai nel buio e mi tastai la tempia destra,
pulsante, estremamente fastidiosa, al pari della gamba gonfia e
dolorante.
Un'ombra lunga e sinuosa spezzò il riverbero di
un piccolo lume poggiato sul comodino.
Sentii i muscoli irrigidirsi e l'urlo di terrore
rimase a fermentare nello stomaco, stringendolo.
«Non farti venire un colpo apoplettico, sono io»
mi rassicurò Alek, emergendo dall'ombra come se il suo corpo fosse privo
di consistenza.
Rabbrividii.
«Cosa vuoi?» soffiai velenosamente.
«Ti lamentavi; ti si sentiva fin dalla soffitta»
spiegò, afferrando la sedia di paglia appena sotto alla finestra e
posizionandola accanto al mio letto.
Poi, senza saperne il motivo, mi fissò a lungo,
insistente e impertinente, la testa un po' piegata come per carpire
qualche segreto.
«Stai male?» mi domandò dopo un lungo silenzio.
«Ovviamente sto male».
Afferrò una siringa e se la rigirò tra le mani,
porgendomela.
«Vuoi una di queste iniezioni?»
La volevo? Non potevo davvero sopportare il
dolore? Ripensai alla cenere e agli orrori che il sonno mi aveva
regalato, ripensai a quella vertigine allo stomaco, al cerchio alla
testa. All'orsacchiotto di pezza che lentamente bruciava.
No, non potevo.
«Sì, per favore» mi ritrovai a supplicare,
patetica e stupida. Le sue mani affondarono nel materasso e il suo viso,
d'un tratto, fu vicinissimo. Si protese verso il mio comodino, tastando
per cercare qualcosa.
Mi irrigidii, scattando sulla difensiva.
Fortunatamente si allontanò prima che fossi io a
spingerlo via e qualche secondo dopo la stanza riverberò del fascio
giallastro di una torcia.
La gettò sull’estremità del letto, puntata
dritta sulle nostre facce assonnate e stropicciate.
Incrociai i suoi occhi ingrigiti dalle tenebre,
che brillavano come quelli di un gatto.
Era spaventoso.
Non che lui mi prestasse molta attenzione,
comunque. Era impegnato a riempire la siringa di un liquido denso e
giallastro, seguendo movimenti precisi e sciolti.
Scansò da parte le coperte, invitandomi poi a
calare i pantaloni lunghi e sformati del pigiama.
«Eh?»
«I pantaloni, abbassali. La vuoi o no questa?»
mi sventolò la siringa davanti al naso e una fitta di intenso dolore
spazzò via esitazione, disagio, timidezza, tutto quanto.
Mi rigirai sul fianco, dandogli le spalle,
calando poi l’indumento sino alle ginocchia.
Sperai che non commentasse, ma il fischio basso
che emise fu comunque imbarazzante e umiliante.
A dispetto della sua natura irruenta e perfino
aggressiva, le sue mani erano delicatissime mentre insinuavano l’ago
nella carne. L’effetto fu immediato, tanto da procurarmi un compiaciuto
sospiro di sollievo, che solleticò il sonno interrotto.
Intontita, mi persi il momento in cui doveva
essersi alzato per gettare via l’ipodermica e quasi sussultai quando
sentii il materasso piegarsi al suo peso.
«Pensavo fossi tornato in mansarda».
«Il tuo letto è più comodo e non abbiamo neppure
il riscaldamento... e tu, be’, tu sei più pratica di un caminetto da
accendere» mi informò, le sue labbra che quasi mi sfioravano il collo.
«Smettila».
«Non mi pare ti dia molto fastidio, Valerie»
rimbeccò e sussultai violentemente – perché, poi?! – quando lo sentii
pronunciare il mio nome, per la prima volta e senza alcuna traccia di
derisione o scherno.
«Oh, sta’ zitto» lo redarguii senza cattiveria,
sbadigliando.
«Vy ocharovatelʹny,
suka da, no prekrasnyy; rano ili pozdno, ya tebya potseluyu*»
mormorò in russo, in una cadenza lenta e quasi ipnotica, in un suono
morbido e dolce.
«Non te la prendere, ma non ho capito niente»
biascicai, in realtà poco interessata alla traduzione che, comunque, non
arrivò. Lo sentii ridere piano.
«Dormi» tagliò corto.
«Non vorrai restare qui, vero?»
«Certo che no, stupida. Per quanto tu sia calda
e invitante, preferisco andarmene» rimbeccò svelto e quando chiusi gli
occhi era già fuori dalla mia stanza
Il mattino seguente, il sole dritto negli occhi
e un dolore lontano ma persistente mi diedero il buongiorno.
Mi voltai lentamente, stiracchiandomi.
L’orecchio sinistro era ancora sordo, ma la gamba, in compenso, andava
molto meglio.
Cautamente, poggiai il piede per terra,
valutando quanto e per quanto potesse sostenermi.
Mossi tre passi, esaltata dall’assenza di
dolore.
Poi aggrottai la fronte; Aleksandr doveva
essere andato via da un pezzo, come confermavano le lenzuola fredde.
Lo ritrovai in cucina, in compagnia di Jack, il
quale gli insegnava come e per quanto tempo bollire il latte delle mie
mucche.
Zoppicai sino a lasciarmi andare sulla sedia,
scacciando stralci di ricordi infiammati come mosche fastidiose.
«Come va, Val?» domandò Jack, servendomi il
latte ancora caldo e qualche biscotto dall’aspetto delizioso, croccante
e dorato.
«Molto meglio; cosa avete fatto?» domandai,
spiluccando piano la colazione.
Il viso di Jack si illuminò, contento.
«Ho mostrato a Alek come mungere le mucche,
abbiamo raccolto le uova e sistemato le provviste. Poi abbiamo fatto un
giro del ranch, gli ho mostrato le piante commestibili e quelle
velenose, l’ho portato sino ai confini della nostra proprietà e poi
siamo scesi giù, all’Ultima spiaggia e gli ho mostrato l’antica
quercia e il fiumiciattolo che ci fa da confine. Avresti dovuto esserci,
la vegetazione non è mai stata così rigogliosa e sana; gli ho perfino
insegnato a montare Kellan» aggiunse, palesemente orgoglioso.
Piegai la testa di lato, mostrandomi sorpresa.
«Bravi» mi complimentai senza particolare
entusiasmo e Aleksandr si fece avanti, indicando le chiazze verdi sulle
ginocchia e la camicia a quadri insozzata di terra sulla schiena.
«Non proprio; sono caduto un paio di volte»
ammise disinvolto e Jack, che sospettavo lo venerasse o che ne fosse
innamorato, si lanciò in sua difesa, sostenendo che per essere stata la
sua prima volta se l’era cavata molto bene e che aveva un sacco di tempo
per migliorare.
Alek gli strizzò perfino l’occhio e lui rise.
«Val, devo andare da, ehm, Sam; voleva vedermi»
confessò, come se stesse affrontando un argomento particolarmente
ostico.
Mi irrigidii, stringendo le labbra.
«Perché?»
«Non lo so» era sincero, lo si capiva dai suoi
occhi verdi, limpidi e veri, senza traccia di menzogna.
«Va bene» sospirai laconica, ingollando anche
l’ultimo sorso di latte.
Essere convalescente era sinonimo di annoiarsi
fino a morirne. Aleksandr mi aveva trascinato – per quanto lo
permettesse la zoppia – fino al divano e, piazzatomi la radio tra le
mani, mi disse di rilassarmi e restarmene ferma, aggiungendo che se
avessi avuto bisogno di compagnia sarebbe bastato uno schiocco di dita.
Il tono con cui lo disse fu così malizioso da
garantirgli subito che la solitudine ed io eravamo grandi amiche e che
godevamo della reciproca presenza.
Però, due ore e tre bollettini di guerra dopo,
ero quasi tentata di ritrattare la mia versione.
Il divano iniziava a diventare scomodo, mi
anchilosava i muscoli e l’osso sacro protestava di dolore.
Quando il senso di disagio divenne
insopportabile, mi alzai faticosamente, zoppicando per trovare
Aleksandr; non era esattamente una verità che la solitudine mi
aggradava. Ero un essere umano, un animale socievole che necessitava
della compagnia altrui o anche solo di scambiare qualche vuota
chiacchiera.
Lo trovai in mansarda, così assorto da non
essersi nemmeno accorto di me. Senza coglierne il motivo, mi nascosi
oltre la soglia così che solo la mia testa sporgesse dallo stipite.
Fissava una fotografia piccola e strappata agli
orli, seguendone il profilo con la punta dell’indice. I suoi occhi
azzurri erano lucidi, in disarmonia con le labbra tirate in un ringhio.
Le sue mani tremavano, le dita si aprivano e si
serravano di continuo, come se afferrasse i pezzi di sé per non
lasciarli scivolare via.
Mi sentii un’intrusa, come se stessi assistendo
di qualcosa a me precluso, di troppo intimo.
Così, il più silenziosamente possibile, andai
via, ponderando a lungo su quella fotografia.
Chi ritraeva? Perché era stata così importante
da meritarsi un posto nella sua vecchia tuta mimetica? Cosa significava?
«Non ti sei ancora annoiata?»
Sobbalzai. Era sempre talmente silenzioso che
pareva scivolare sul pavimento, come un’ombra al calare del sole.
«Non ancora, no» mentii, ma non fui poi così
credibile. Lo vidi prendere posto accanto a me per alzarsi poi qualche
secondo dopo per rispondere al telefono.
«Era tuo fratello; dice che Kellan è stato
spaventato da un tuono e che è fuggito. Vuole che lo vada a riprendere.
Devo cercare anche il tuo cavallo?»
Risi.
«Kellan tornerà. Vai a prendere Jack e tornate
prima che il temporale arrivi qui».
Qualche minuto più tardi sentii il motore del
pickup ruggire e allontanarsi, accompagnato dal cupo rimbombo di fulmini
lontani.
Il pensiero della fotografia mi assalì,
stuzzicando la parte più curiosa e invadente di me.
Per questo mi diressi in mansarda e, come mai si
dovrebbe fare, frugai tra le sue cose, fino a ritrovare lo scatto che
tanto mi aveva dato da pensare.
Ritraeva il viso monocromatico di una ragazza
dall’espressione tenera, dolce, con grandi occhi che dovevano essere
azzurri o verdi.
I capelli lisci e neri le circondavano il volto,
adagiandosi piano sulle guance piene. Mi concentrai a lungo sul suo
sorriso; un sorriso ingenuo, onesto, di cui non ci si poteva non fidare.
Tutto, in quel delicato volto femminile,
ispirava fiducia e protezione.
Voltai la fotografia, incontrando una serie di
simboli cirillici. Come quando Aleksandr mi aveva parlato in russo, non
ci capii nulla né persi tempo ad interpretare la dicitura.
Mi soffermai piuttosto sul tratto dei simboli,
morbido e tondeggiante, vergati forse dal volto immortalato.
Studiai per qualche altro minuto quella giovane
donna, che, per qualche ragione, mi fece sentire insignificante.
«Carina questa tua propensione a ficcanasare tra
le cose altrui».
Sobbalzai, squittendo spaventata, e la foto
volteggiò sinuosa, adagiandosi infine sul parquet lacero.
*sei adorabile, stronza eh, ma adorabile;
prima o poi ti bacio.
O almeno, questa è la traduzione secondo
Gugol Transleit, perciò non prendetela per oro colato. Anzi.
NdA: Le feste sono quasi trascorse e io
vi propino un altro capitolo.
Ci tengo a precisare che questo capitolo è
interamente dedicato/regalato a Jè, che è la mia più fedele seguace e
che non manca mai di commentare qualsiasi cosa io pubblichi. Quindi
spero vivamente che questo capitolo sia stato di suo gradimento. :3
Ciò detto, non credo di avere qualcosa da
aggiungere stavolta, a parte il solito ringraziamento a nals che
ha gentilmente e pazientemente betato il capitolo. :3
Non mi resta che augurarvi buone feste ed
esprimere un sentito grazie a chi segue questa storia. :)
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 10
*** La svolta ***
Nuova pagina 1

Mi raggiunse in due falcate ampie e ferine,
agguantando la fotografia per riporla tra le sue cose; poi, ignorando il
momentaneo handicap che mi affliggeva, mi strattonò per un polso,
sbattendomi letteralmente fuori dalla camera.
«Hai ragione, non avrei dovuto» chiarii
immediatamente, avendo anche il buon gusto di mostrarmi pentita e
imbarazzata.
«No, non avresti dovuto. Non mi pare di aver mai
ficcanasato tra le tue, di cose» mi redarguì aspramente e seppi con
certezza d’aver distrutto il labile sentiero di pace e tregua che
avevamo percorso per pochissimo tempo. Innalzò le barriere e mi chiuse
fuori, inchiodandomi con occhi nuovamente ostili, nuovamente colmi
d’odio.
«Infatti», convenni mansueta, «prima ero venuta
a cercarti e ti ho visto guardare quella foto. Ero solo—»
«Curiosa, certo» concluse per me, deglutendo e
respirando profondamente, più volte, come se stesse cercando di
mantenere la calma.
«È bella» mi lasciai sfuggire, sussurrando;
avevo gli occhi bassi e non mi accorsi della sua mano che, veloce e
forte, volò al mio viso, schiaffeggiandomi.
Alzai la testa, la bocca aperta in una grottesca
espressione di sgomento. In risposta al dolore, sentii gli occhi pungere
e colmarsi di lacrime mentre mi strofinavo piano la zona lesa.
Lo vidi indietreggiare, letteralmente sconvolto,
e aprire la bocca più volte per dire qualcosa, optando poi per il
silenzio.
Il gesto mi umiliò profondamente, tanto fu
inaspettato e deciso, ma, ancor di più, mi ferii.
Sapevo che Aleksandr fosse una testa calda, con
scarso self control e una disarmante tendenza ad adoperare la
violenza anche per le sciocchezze. Ma mai, mai, lo avrei creduto capace
di picchiare una donna, sebbene io stessa più volte avessi corso il
rischio.
Ma ogni volta era stato capace di controllarsi,
ogni volta era stato un bluff.
Una singola lacrima precipitò veloce sul mento e
la spazzai via con un gesto lento del dorso della mano.
In altri tempi forse avrei replicato il gesto,
forse avrei urlato, forse l’avrei nuovamente cacciato. Invece, restai
muta e sorrisi in direzione del pavimento, stringendomi nelle spalle e
voltandomi per andare via.
«Valerie» mi chiamò e quando mi voltai – troppo
velocemente – lui era già davanti a me.
Sentii le sue mani tremanti stringersi sul mio
volto, piano, delicate, scendere poi sul collo e sulle spalle, per
tornare poi nuovamente al mio viso.
Mormorò una sequela fitta di scuse, alternando
parole russe a parole inglesi, senza mai trovare il coraggio di
guardarmi negli occhi.
«Va tutto bene» dissi apatica, senza alcuna
emozione, senza alcuna rassicurazione, senza niente.
«No, non è vero. Non... è...» strinse i denti,
aggiungendo qualcosa in russo.
«Senti», mi alterai, stringendogli il mento per
forzarlo a guardarmi, «smettila di parlare in russo. Non capisco nulla e
mi sento un’idiota. Sei in America, adesso» lo redarguii e sentii la
pelle tendersi tra le mie dita, curvarsi in un sorriso accennato,
timido, sbagliato.
«Vse chto vy khotite» replicò lentamente
e non ebbi nemmeno il tempo di irritarmi; la sua bocca mi trovò prima.
Che relazione turbolenta, la nostra. Quando
credevo di aver commesso un fallo, quando pensavo che la tregua fosse
giunta al termine, tutto si era capovolto un’altra volta e tutto era
terminato sulle nostre labbra.
Ogni muscolo si contrasse, contrariamente alle
dita, che allentarono la stretta e che ritirai al petto. Sentivo le
gambe pronte a scappare, le braccia pronte ad allontanarlo, ma
l’indecisione mi paralizzò, seconda solo alla goffaggine.
Alek – Alek! – mi incoraggiava con
movimenti lenti e studiati, sentivo la sua lingua scivolare sul mio
labbro inferiore e nella linea dritta della bocca, invitandomi a
schiuderla.
Obbedii, remissiva e molto poco lucida, e
assecondai le movenze delle sue labbra e della sua lingua. Mi preoccupai
quando mi sentii pervadere da uno stranissimo senso di onnipotenza,
malamente mescolato all’adrenalina in circolo e alla voglia di
toccarlo.
Non volevo più fuggire, anzi farmi più vicina.
Colse l’impercettibile cambiamento del mio umore e il bacio si trasformò
velocemente: non più dolce e lento, ma rapido, rude, erotico.
Poi, come una folata di brezza autunnale, tutto
finì. L’attimo dopo stavo già scendendo le scale a piccoli balzi, due
gradini alla volta, goffa, sbilenca e zoppicante, dirigendomi a passo di
carica verso il vecchio capannone che ospitava la riserva di fieno e
mangime dei miei animali. Era il mio nascondiglio, la mia fortezza, il
luogo dove poter sciogliere le briglie alle emozioni che mi passavano in
viso senza essere vista o giudicata.
Era tutto sbagliato. Sconfitta e abbattuta, mi
lasciai cadere su un mazzo di fieno, prendendomi la testa tra le mani.
Rabbia e sgomento mi trovarono indifesa,
contendendosi equamente l’intero spazio del mio animo.
Perché l’aveva fatto? Perché baciarmi se fino ad
mese prima sbandierava tanto orgogliosamente la propria avversione nei
miei confronti?
Quando il buio mi impedii di vedere oltre le mie
scarpe, arrancai passi lenti e incerti verso casa, le cui finestre buie
si conformavano perfettamente alla facciata annerita dall’avvento della
notte. Aggrottai la fronte, fermandomi.
Jack e Alek erano entrambi in casa, perché
diavolo non avevano acceso le luci?
La risposta fu: perché Jack dormiva e Alek era
rintanato nella propria camera.
L’idea di bussare mi solleticò per qualche
secondo e il mio piede era già sul primo gradino quando cambiai
intenzione, facendo un brusco dietrofront, diretta in cucina.
Sintonizzai la radio su una frequenza che
trasmetteva vecchissime canzoni degli anni ’80 e mi trastullai con i
preparativi della cena. Era un diversivo abbastanza impegnativo da
distrarmi, ma non sufficientemente da scacciare il ricordo della sua
bocca e dei suoi occhi così vicini, così azzurri, così trasparenti...
«Interrompiamo le trasmissioni radio per
riportare, a reti unificate, l’ultimissimo comunicato stampa della Casa
Bianca. “Fratelli e sorelle americani, è con immenso orgoglio e gioia
che vi informo della nostra vittoria. Le armate russe hanno innalzato
bandiera bianca, le abbiamo allontanate dal nostro Paese. La guerra è
finita. Sono vicino alle vostre perdite e garantisco che già da domani
provvederemo ad intraprendere il lungo e faticoso cammino per la
ricostruzione. Ricordate questo giorno come il giorno in cui gli Stati
Uniti d’America sono tornati ad essere un Paese libero».
Il piatto mi scivolò dalle dita, impattando
contro il pavimento. Le dita mi tremavano così forte da contrarsi in
spasmi dolorosi, quasi volendo contenere la gioia selvaggia, quasi
temendo che fosse tutto un terribile bluff.
Ma non poteva esserlo, non con la voce del
Presidente che continuava ad elogiare l’operato delle forze armate, ad
elencare le battaglie che si erano rivelate essenziali per la vittoria
della guerra.
«Oh, mio Dio. Jack! Jack!» strillai,
scrollandolo con foga.
«Cosa?»
«Abbiamo vinto, Jack! Abbiamo vinto, la guerra è
finita! Finita!»
Vidi i suoi occhi sgranarsi di stupore; poi, i
suoi folti capelli neri mi oscurarono la vista, le sue braccia strette
intorno ai miei fianchi
«È finita, è finita, è finita» cantilenava e
rideva, coinvolgendomi in un goffo balletto di esultanza, alzandomi
perfino da terra.
Stavamo ancora festeggiando quando qualcuno
bussò forte alla porta, quando quel qualcuno si rivelò un Sam entusiasta
e ridente, bello come mai mi era sembrato.
Mi strinse forte – nulla a che vedere con
l’amichevole abbraccio di Jack – e tuffò il viso tra i miei capelli,
sospirando.
«Abbiamo vinto!» sussurrai frenetica,
stringendomi a lui.
In quel momento, tutto svanì, tutto venne
perdonato. Il nostro ultimo quanto burrascoso incontro dimenticato, i
dissapori mai esistiti. Eravamo solo Val e Sam, due ragazzi costretti a
portare sulla schiena il peso della guerra, complementari l’uno
all’altra.
«Lo so. È finita, Val, finita» mi assicurò,
scoccandomi poi un lungo bacio sulle labbra.
Impietrita e sorpresa, me ne restai rigida tra
le sue braccia, le dita goffamente strette alle sue spalle. Ad occhi
sgranati, lo vidi sollevare le palpebre e fissare qualcosa dietro me; le
sue labbra si curvarono, contro le mie, in un sorriso cattivo.
E poi li sentii. Freddi, insistenti,
inespressivi, gli occhi di Alek piantati sulla mia nuca.
Mi sentii stranamente in dovere di allontanarmi
velocemente da Sam e, codarda com’ero, non ebbi nemmeno il coraggio di
voltarmi per fronteggiare l’altro.
«Il Presidente dice che dobbiamo festeggiare e
io voglio prenderlo in parola. Venite da me, tu e Jack» mi chiese,
ignorando ostentatamente Aleksandr, del quale colsi il suono di un
ghigno di scherno, seguito dai suoi passi pesanti sulle scale.
«Non sei stato molto carino» lo schernii,
ricevendo in risposta uno sbuffo contrariato.
«Senti, la guerra è finita, adesso può anche
andarsene, no?»
«No!» esclamai in fretta, arretrando davanti ai
suoi occhi, scuri, densi, brucianti.
«Valerie», disse, afferrandomi per le spalle,
«dimmi che non hai commesso la stronzata di innamorarti di lui».
Strinsi i denti e sospirai.
«Non si tratta di questo, Sam. È solo che non
posso – non voglio – mandarlo via; è una sua scelta».
Sam sorrise, accostando la fronte alla mia.
«Tu meriti di meglio. Meriti una persona
migliore, che ti capisca, che ti supporti».
«Una persona come te, è questo che vuoi dire?»
Annuì, baciandomi i capelli. Era strano; sapevo
che questo momento, presto o tardi, sarebbe arrivato, lo sapevo da molto
tempo, eppure mi sentii presa alla sprovvista, incapace di negare,
incapace di spezzare la sua tenacia.
Incapace di infliggergli consapevolmente del
male.
«Sam—»
«Lo so, lo so. Per te non è mai stato lo stesso,
ma forse con il tempo impareresti ad amarmi» propose, senza tuttavia
crederci davvero.
«Forse. O forse no. Sam, non è questo che
voglio» farfugliai, facendo sempre più fatica a tenere insieme il
discorso, gestirlo con le parole giuste.
«No, certo, non è questo che vuoi da me»
precisò, ma fui sollevata di non trovare ostilità nella sua voce.
«Quindi, non venite?»
«No, Sam. Non senza Aleksandr».
Ci pensò su per qualche secondo, riuscendo
infine a strapparsi dalla mente quelle parole che suonarono come una
specie di insulto.
«Allora fai venire anche lui. Ultimamente non
abbiamo avuto molto tempo per noi».
Che era come dire: “Accetto la sua presenza
pur di riuscire a farmi vedere sotto una luce diversa”.
Quante forti, insistenti speranze destinate a
sciuparsi!
«Meglio di no. Ma ti prometto che passerò presto
a trovarti, andremo a cavallo insieme» giurai, perché ad ogni parola lo
sentivo scivolare sempre più lontano da me.
«Va bene» concesse, baciandomi un’ultima volta –
sulle labbra, velocemente – prima di inforcare il cappello e congedarsi.
Solo allora mi accorsi di Jack, in piedi e
nascosto dalla soglia.
«Mi dispiace» mormorò, parte del viso celata
dallo stipite.
«Non è colpa di nessuno» sospirai, decidendo che
rimandare il momento del confronto con Alek non era più possibile.
Bussai due, tre, quattro volte, ma non venne mai
ad aprirmi, fino a quando non fui io ad abbassare la maniglia per
sentirla sprofondare nel vuoto, bloccata dalla sicura.
Spalle contro la porta, mi passai le mani sul
viso, tenendole premute sugli occhi, sulle guance, sulla bocca per molto
tempo.
Ripensai ai due baci – così diversi eppure
egualmente intensi – ricevuti nel giro di poche ore di distanza e sentii
il cuore battere come se dovesse implodere a momenti.
«Alek, quello che è successo con Sam... è stato
solo un momento di euforia, abbiamo vinto la guerra, eravamo felici...
Alek... Alek, vorrei...»
Cosa volevo, esattamente?
Avere tempo, prima di tutto. Tempo per rimettere
in ordine le cose, considerarle sotto la luce giusta, attribuire loro il
corretto significato, tempo per scandagliare tra i molti sentimenti che
mi animavano, analizzarli e sezionarli a mente fredda, giungendo infine
a capire cosa provassi per Alek e cosa per Sam.
Restai accasciata contro quella porta, senza
tenere il conto dei minuti e dei secondi che mi scivolavano addosso,
lenti e costanti.
Poi, in un qualche momento che non riuscivo a
collocare, il sonno mi prese con sé.
E gli incubi tornarono.
*tutto quello che vuoi.
O almeno, questa è la traduzione secondo
Gugol Transleit, perciò non prendetela per oro colato. Anzi.
NdA: Oh, cielo, che capitolo intenso.
Solo a leggerlo mi è venuta l'asma mentale.
Tant'è. Suvvia, non fate quelle facce, sapevate che questo momento
sarebbe arrivato, così come sapevate che questo è il penultimo capitolo.
Eh.
Nel prossimo capitolo ci sarà la scelta
definitiva di Valerie e... niente, non mi scucio e non spoilero.
Ringrazio come sempre chi segue questa storia e
chi la recensisce. Un grazie speciale a Els che ha recensito
tutti i capitoli e che sta stravedendo (posso dirlo?) per questa storia,
lusingandomi non poco. :3
Ci si ribecca la settimana prossima con l'ultimo
capitolo.
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 11
*** L'addio ***
Nuova pagina 1

Alek si rifiutò di vedermi e parlarmi. A notte
inoltrata, che l’euforia per la vittoria statunitense era già scemata,
mi risvegliai di soprassalto e non mi rimase altro da fare che arrancare
verso la mia camera da letto.
Quella notte non riuscii più a dormire. Il sonno
mi girò intorno senza mai ghermirmi completamente, sprofondandomi in
fastidiosi stati di dormiveglia, fatti di sogni insensati e
confusionari.
Quando il sole gettò fasci luminosi sulla terra,
inaugurando un nuovo giorno – nuovo in ogni senso possibile – mi
stropicciai il viso stanco e non riposato e scostai le coperte.
Il pensiero di Alek non mi abbandonò mai.
Sentivo l’esigenza di chiarire quanto prima. La guerra era finita e non
avevo più tempo. Immaginavo sarebbe andato via, tornato a casa sua, in
un altro emisfero, in un altro continente.
Perciò, dopo una doccia impacciata e dopo
essermi liberata della benda ormai inutile, mi trascinai sino alla
mansarda per trovare la porta spalancata e il suo interno completamente
vuoto. Di lui restavano solo fugaci tracce: una carta nel cestino, un
bicchiere sul comodino, il letto riordinato frettolosamente. Qualcosa,
appena sotto la finestra, brillò, ammiccando.
La riconobbi ancor prima di prenderla tra le
dita: la spilla della sua divisione, quella spilla incrinata in due metà
asimmetriche. Per scrupolo e con l’amara consapevolezza che non vi avrei
trovato nulla, aprii l’armadio alla ricerca della sua tuta mimetica,
ovviamente assente.
Solo il ripiano più basso ospitava i vecchi
vestiti del padre di Sam. Il gesto aveva un significato inequivocabile:
addio.
Per questo, quando furiosa scesi in cucina,
rischiai di inciampare nei miei stessi piedi quando lo vidi in piedi
davanti al bancone, a trangugiare caffè.
Indossava la sua tuta – che moltissimi giorni
prima avevo messo a lavare – da cui spuntava la tel'njaška a
righe bianche e blu. Il basco azzurro era abbandonato sul tavolo.
A colpirmi fu il senso di ordine e compostezza
che emanava da lui. Si era accuratamente sbarbato e aveva pettinato
indietro i capelli, scoprendo la fronte. Il suo viso era una maschera di
gelida indifferenza.
«Che fai?» domandai, avvicinandomi. Non seppi se
fu un gesto conscio o meno, ma lui indietreggiò con disinvoltura,
evitandomi.
«Bevo un caffè prima di andarmene».
Non che ci volesse un genio, questo l’avevo
capito da me.
«E perché vuoi andartene?» avvertì l’ansia nella
mia voce, perché le sue labbra si piegarono in un sorriso serafico.
Oh, bentornato soldato Lebedev.
«La guerra è finita, è ora di tornare in patria.
In questa fogna ho perso fin troppo tempo».
Mi domandai se si riferisse al mio ranch o
all’America. Ma tutto ciò che riuscii a dire fu: «Non mi pare che ti sia
dispiaciuto troppo».
Probabilmente fu la cosa sbagliata perché la sua
bocca tornò ad essere una linea dritta e dura e i suoi occhi mi
studiarono con scherno.
«Ho dovuto adattarmi. In verità», disse,
facendosi vicino, «fare il carino con te non è servito a niente. Avrei
voluto infilarmi tra le tua gambe, ma, ahimè, ho fallito. Sono certo che
Sam avrà più fortuna di me, state così bene insieme. Siete
uguali, tu e lui».
Con il tempo, avevo imparato a capire che quando
l’accento russo era particolarmente evidente nella sua voce, Alek era
nervoso.
Nondimeno, c’era una cosa che non avevo colto
affatto: Alek non era affezionato né a Jack né a me. La sua era stata
una recita ben costruita, un castello di equivoci e frasi ambigue
interpretate male, proprio come desiderava.
Questo era quello che mi imponevo di pensare,
almeno. Perché non potevo permettermi di afferrare l'altra metà di
quella medaglia, di considerarla, di ritenere le sue parole una mera
bugia. Perché questo avrebbe implicato cose e sentimenti per cui non ero
pronta.
Chiudere gli occhi era più semplice.
Seguendo questa mia malata linea di pensiero,
riuscivo a vedere con disarmante lucidità le motivazioni che l’avevano
spinto ad agire; bisognava accaparrarsi l’amicizia di Jack perché il
ragazzino sarebbe stato forte abbastanza da buttarlo fuori a calci.
Bisognava accaparrarsi la mia, di amicizia, perché ero attraente
abbastanza da poter soddisfare qualche sua perversa fantasia, oltre il
primordiale desiderio carnale.
Ma era davvero così semplice chiuderli, gli
occhi?
Lo fissai a labbra schiuse e dovevo avere
un’aria davvero stupida.
«Avanti, non prendertela. Te la sei presa?»
aggiunse frettolosamente, preoccupato. Abile attore, consumato bugiardo.
Russo fin nel midollo.
Sorrisi stordita.
«No, no affatto» mi concessi una pausa leggera,
soppesando le parole.
«Non è colpa tua», continuai, «è che sei fatto
così. È colpa nostra, mia e di Jack, che abbiamo sempre interpretato
male tutti i tuoi gesti e tutte le tua parole» recitai bene la mia
parte, eravamo due attori talentuosi, dopotutto.
Mi sentii parlare con voce ferma, rassegnata,
per nulla incollerita. Un moto di gioia mi strinse lo stomaco quando
registrai d’essermi ascoltata con entrambe le orecchie.
Il sinistro, a quanto pareva, era
definitivamente guarito. Un’altra bella notizia, un’altra bella notizia
di cui non riuscivo a rallegrarmi.
Il cerchio di stupore e sgomento e sospetto che
mi stringeva la testa non allentava la morsa, non mi permetteva di
provare i giusti sentimenti, schiacciati dal peso delle domande.
«Bene, nessun rancore allora?» tese la mano,
come in un ultimo, benevolo gesto.
La chiusura della storia, il punto alla fine
della frase, la parola fine vergata in fondo al foglio.
La strinsi con foga, come se fosse mio desiderio
incrinarne ogni articolazione. Il cerchio alla testa si allentò.
«Nessun rancore» convenni.
Nessun rancore davvero. Non gli avrei donato
quell’ultima soddisfazione di vedere il mio sangue incendiarsi di rabbia
e la mente rimuginare su un proposito di vendetta.
Lo avrei scaraventato in un angolo lontano della
testa, sepolto dagli impegni quotidiani, incatenato, imprigionato,
occultato.
O quanto meno, ci avrei provato.
«Bene. Ho saputo che l’aeroporto di Dallas-Forth
Worth ha riaperto i battenti. Mi domandavo se—»
«Nessun problema, ti ci porto» lo interruppi
bruscamente, ammorbidendo quindi il tono imperioso con un sorriso
tirato.
Aleksandr Lebedev doveva uscire dalla mia vita e
volevo essere io ad accompagnarlo all’uscita.
Eppure. Eppure.
«Pensi che i tuoi torneranno a casa?» domandò
all’improvviso e qualcosa, nella sua facciata disinvolta, si incrinò.
Mi strinsi nelle spalle. Il pensiero di mio
padre e mio fratello era troppo doloroso, avevo bisogno di calma e
serenità per considerare l’ipotesi della loro morte.
«Allora, partiamo immediatamente?» chiese,
impaziente.
«Certo».
Quando intrapresi il breve tragitto dalla cucina
alla mia camera da letto, ebbi la sensazione di lasciarmi alle spalle
molti pezzi di me stessa.
Inchiodai appena sotto uno dei rarissimi
semafori sopravvissuti alle bombe, tornato finalmente in funzione.
Preferii scrutare il cielo sulle nostre teste e
ignorare gli enormi pilastri di cemento che un tempo avevano sorretto
belle villette a schiera, le fondamenta sradicate dal cuore della terra,
gli alberi dal tronco mozzo e annerito come il corpo di un moccolo di
candela.
«Nervosa?»
«Affatto».
Eppure, quando ingranai la prima e le ruote
slittarono sull’asfalto impolverato la mia negazione si rivelò talmente
fasulla che Alek sbottò in una risata compiaciuta, sistemando la
cerniera della tuta.
«Toglimi una curiosità, prima di partire» disse
all’improvviso, gli occhi puntati sulle distese di grano un tempo
lussureggianti, ora ridotte ad un cumulo di sterpaglie carbonizzate.
Non ero certa di voler rispondere. Quale che
fosse stata la sua domanda, sospettavo sarebbe stata estremamente
personale. Potevo perfino tirare ad indovinare su cosa vertesse.
«Che fine ha fatto tua madre?»
Sorrisi stizzita. Avrei potuto scommettere tutti
quei pochi dollari che mi erano rimasti e li avrei riavuti indietro con
i dovuti interessi.
«La vita domestica non faceva per lei. Quando io
e Adrian eravamo ancora molto piccoli, fece le valigie e andò via di
notte, come una ladra. Non la vedo da più di diciotto anni. Fine»
aggiunsi seccamente, sperando che capisse l’antifona e che non
insistesse.
Ma l’informazione sembrò accontentarlo perché,
per grande parte del viaggio, tenne gli occhi puntati in un punto cieco,
nel vuoto, a rimuginare.
Quando avvistai l’indicazione stradale –
sbilenca e penzolante – che indicava l’uscita per l’aeroporto, il
ricordo di quella misteriosa fotografia – la fine di tutto – mi balzò
davanti agli occhi, con così tanta intensità che quasi sbandai.
«Toglimi una curiosità, prima che tu te ne vada.
Chi era la ragazza della foto?» domandai velocemente, prima di avere
ripensamenti.
Azzardai un’occhiata solo per vederlo
irrigidirsi sul sedile, le spalle tese e la mascella contratta. Era
palese che l’argomento lo mettesse in imbarazzo e non me ne dispiaceva
nemmeno un po’. Non avevo assolutamente dimenticato tutte le sue
carinerie dal fine pervertito. Non le avevo dimenticate e non le avevo
neppure analizzate.
Benché armata dei migliori propositi, sapevo bene che quella notte mi
sarei rigirata tra le lenzuola, sopraffatta da emozioni negative e
domande.
Sapevo che avrei sviscerato il suo comportamento
fin nel profondo per giungere a chissà quale conclusione.
«Mia sorella. Ma è una storia troppo lunga per
essere raccontata in un paio di miglia o poco più» precisò, utilizzando
il mio stesso tono fermo e incontrovertibile.
La risposta mi confuse, come se non lo fossi già
abbastanza. E tuttavia, non feci ulteriori domande. Fissai la strada
senza vederla veramente, chiedendomi se si trattasse di Inna o di Zoya o
di una sorella di cui aveva opportunamente omesso l’esistenza. Quando le
mie congetture raggiunsero un livello tale da confondersi ed
accavallarsi tra loro, il profilo basso e frastagliato dell’aeroporto
internazionale spezzò la linea dell’orizzonte.
Da quanto ne sapevo, era stato riaperto per
permettere ai soldati stranieri di tornare in patria; anche ai russi era
stato concesso il perdono. Gli Stati Uniti avevano preferito spartire i
territori russi con gli alleati, smembrando la nazione fino a ridurla ad
una dimensione irrisoria, come l’Austria e la Svizzera.
Ai soldati nemici non era stato torto un
capello; si era deciso, di comune accordo, che in quei sei anni i morti
erano stati fin troppi. Nessuno doveva più macchiare la propria bandiera
del suo sangue.
«Eccoci» dissi, posteggiando il pickup poco
lontano dall’entrata principale. Riflettei che Alek non aveva nessun
bagaglio con sé, nessun ricordo da portar via.
Come me, forse anche lui desiderava lasciarsi
l’esperienza americana alle spalle.
«Vediamo un po’» mormorò soprappensiero,
scrutando i tabelloni elettronici che, in alcuni punti, erano guasti. Le
destinazioni, nonostante alcune lettere mancanti, erano chiare e l’aereo
per Mosca partiva da lì ad un quarto d’ora.
Era previsto uno scalo intermedio a Shangai e da
lì la rotta era relativamente breve per giungere in Russia.
«Bene, il tuo volo parte tra quindici minuti»
dissi, arretrando.
«Già».
«Allora, buon viaggio» lo salutai, stringendomi
nelle spalle.
La tristezza mi pervase. Mesi di convivenza
sfumati tutti in un gesto freddo e distaccato, impersonale. Ripescai
appositamente quei pochi, bei ricordi che avevo di lui, quasi volendomi
persuadere a provare un poco di nostalgia. Ma non accadde. I ricordi più
recenti erano anche i più vividi. E le menzogne erano veleno.
«Grazie» mi fissò sfacciatamente, quasi in
attesa. Accolsi il suo invito alla svelta, avanzando a passo svelto
verso l’uscita.
Era tutto finito. Così, nel peggiore e nel più
desolante dei modi. Quella che avevo prospettato come un’amicizia solida
e duratura, magari sincera, era scemata in un gelido addio in un
aeroporto affollato.
La rabbia mi risalì dallo stomaco e stavo quasi
per sferrare un calcio ad uno pneumatico bruciato quando la voce
tagliente di Alek sferzò il silenzio.
«Non posso crederci! Mi lasceresti davvero
partire così?»
Mi voltai fulminea, incredula.
«Cosa?!»
«Sei un’idiota. Speravo che abboccassi alle mie
provocazioni e invece sei una dannata credulona, un’ingenua, una
stupida» mi aggredì, spintonandomi.
«Ehi!» mi difesi, spingendolo a mia volta.
«Credevo avessi un’opinione più alta di me»
sbottò, quasi ringhiando.
E pensai di essere finita in un universo
parallelo, invertito.
«Tu dici che avresti voluto solo portarmi
a letto e io dovrei avere un’opinione più alta di te, infido bugiardo?!
Dimmi, Alek, hai mai voluto bene al ragazzino? O hai approfittato anche
di lui? E già che ci sei, quali delle tue parole devo considerare vere e
quali false? Perché, dannazione, sei così bravo a mentire che non riesco
a capire quando lo fai o quando no».
Andava tutto per il verso sbagliato. Mi ero
ripromessa di analizzare tutto dopo, ma la rabbia mi aveva
trovato prima. Nessun rancore? Non proprio.
«Come al solito sei giunta alla conclusione
sbagliata» mi fece notare.
«Ah, piantala!» strillai e sì, me ne vergognai
anche molto quando due giovani coppie di fidanzati si voltò a fissarci
con fare comprensivo.
«Dimmi che vuoi che io parta, dimmi che vuoi
stare con quel figlio di troia, dimmi che quando ti ho baciata non hai
sentito assolutamente nulla» mi strinse il braccio e sentii i nervi
protestare sotto le sue dita.
Dunque, avevamo scoperto il nervo principale di
tutta quell’assurda pagliacciata.
E sicuramente non avremmo potuto parlarne lì, in
quello spiazzo polveroso e con il rombo assordante di un aereo che
decollava, diretto a Shangai.
E anche se avessimo preso tempo, non sarebbe
cambiato nulla comunque. Se mio padre e mio fratello fossero tornati,
non avrebbero mai accettato Alek e Sam non mi avrebbe mai più neppure
guardata.
Ma era davvero un prezzo così alto? I
sentimenti si potevano davvero pesare e scartare quelli in eccesso?
Scoccai un’occhiata rammaricata a quel volo.
Alek doveva andarsene e questo era quanto.
«Voglio che tu parta» dissi stancamente, solo
per sentirmi afferrare bruscamente per il mento.
«Ripetimelo».
E invece, mi ritrovai a studiare con languore i
suoi occhi azzurri, fin troppo lucidi, fin troppo chiari.
Solo quattro parole.
«Voglio che tu parta» ripetei e trattenni il
fiato, senza battere ciglio. Quel che mi esplose dentro, invece, non lo
dimenticai mai e continuò a tormentarmi anche nei giorni a seguire. Fu
lui il primo ad abbassare gli occhi e allontanarsi come se lo avessi
profondamente ferito.
«È un addio?» domandò e il tono definitivo della
sua voce non lasciava spazio ad equivoci.
«Sì», convenni, «è un addio».
Lo vidi avanzare di una sola, singola falcata e
chinarsi sul mio orecchio.
«Il prossimo volo è alle venti di stasera. Io
sarò qui. Pensaci».
Il suo sussurro, benché non avesse nulla di
suadente o persuasivo, mi portò a tentennare, improvvisamente insicura.
Avrei voluto dirgli di restare, che avevo già
sperimentato il senso tagliente della sua mancanza, che di Sam non me ne
importava niente e che se ne sarebbe fatto una ragione.
Avrei voluto essere sincera, senza freni né
limiti. Solo sincera.
Dirgli almeno che gli volevo bene e che non mi
interessavano le sue intenzioni, giacché ero certa che fossero menzogne
e che, in fondo, anche lui tenesse a me.
Forse avrei voluto dirgli anche che quel bacio
mi aveva rammentato di essere viva più di quanto non avessero fatto le
bombe o le risate di Jack o la solida presenza di Sam.
Ma tutto ciò che mi limitai a dire fu: «Addio,
Alek».
Lo spinsi dolcemente via, sbattendo la portiera.
Avrei voluto frenare, invertire la marcia e tornare da lui, eppure tenni
le dita ben strette sul volante e vidi per quella che credevo essere
l’ultima volta la figura di Alek che, lentamente, sbiadiva nella nuvola
di terra rossa sollevata dagli pneumatici.
NdA: Zanzanzan. Fine.
Teoricamente la storia finisce qui. E
finisce proprio con questa conclusione all'americana, con l'automobile
che si allontana in molte nuvole di terra rossa.
O almeno, questa era la fine che avrei
desiderato, perché i presupposti per attuarla c'erano tutti. Ma
praticamente non ho saputo resistere e mi sono rifatta nell'epilogo.
Alla fine è capitato che anche io mi sia
innamorata di questi due e che mi sembrava giusto concedere loro il
lieto fine, dopo tante tragedie e tanto angst.
Quindi, ai fan della Valek (ossì, ho dato anche
i nomi alle ship, giusto per risparmiare tempo e caratteri) dico: state tranquilli, l'epilogo sarà
di vostro gradimento.
Ai fan della Salerie (Sam/Valerie, per
intenderci) invece dico: *patpat* vi rifarete nel sequel, se e
quando verrà scritto.
Riguardo questo capitolo, ebbene, spero che sia
stato confusionario abbastanza. Le molte frasi in corsivo - in chiaro
disaccordo con il contesto in cui sono inserite - avevano il solo scopo
di creare un senso di ansia e confusione, così da potervi far sentire
più vicini a Valerie.
Se ci sia riuscita, ahimé, io non posso dirlo.
Ma potete farlo voi; il mio invito a recensire è sempre valido.
Accidenti, mi sembra ieri che postavo il prologo
e invece siamo già arrivati alla fine del viaggio!
Ebbene, stando così le cose, io mi sento in
dovere di ringraziare tutte le persone che hanno recensito, tutte quelle
che hanno inserito la storia tra preferite, ricordate e seguite.
E visto che siamo arrivati alla fine, mi tolgo
anche il famoso sassolino nella scarpa: mi ha molto rammaricata vedere
che questa storia è stata seguita da più di venti persone e che solo tre
o quattro abbiano espresso il loro parere.
Una recensione non sarebbe costata nulla, se non
qualche minuto del vostro tempo. E non dico questo perché mi premeva
avere tante recensioni (della quantità, francamente, me ne sbatto, così
come me ne sono sempre sbattuta e sempre ne ne sbatterò), ma perché mi
premeva avere dei giudizi obiettivi e sinceri. Tant'è. Ovviamente
io ci ho fatto il callo, ma molto bravi autori si scoraggiano proprio
per questo e gettano la spugna, giacché si sentono poco apprezzati ad
essere seguiti da tante persone ed essere poi ripagati con il nulla.
Ho sentito tante persone lamentarsi di autori
bravi che hanno mollato EFP; ebbene, prima di lamentarsi forse
occorrerebbe chiedersi perché quel tale autore o quella tale
autrice abbiano chiuso la baracca.
Comunque, non spetta a me impartirvi ramanzine
sulla moralità (credo che da una certa età in poi si abbia un minimo di
autocritica e auto-giudizio) o roba del genere, perciò chiudo la
parentesi.
Non sentitevi offesi, era qualcosa che mi
premeva di dire sin dai primi capitoli e che tuttavia mi sono riservata
per la fine.
Ciò detto, l'appuntamento ultimo è fissato per
mercoledì prossimo, con l'epilogo.
Ancora una volta, grazie. È stato un bel giro.
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Capitolo 12
*** Epilogo ***
Nuova pagina 1

«E poi cosa è successo? Mamma, dimmelo!»
La giovane scansò la frangia dalla fronte della
figlia, chinandosi per baciarla.
«Questa è un’altra storia, tesoro. Adesso a
letto, forza».
«Cosa vuoi che sia successo? Lui è tornato in
Russia, vero mamma?»
Il bambino si stropicciò gli occhi,
stiracchiandosi nel lettino fino a che la maglia del pigiama azzurro non
scoprì la pancia piatta.
Sospirò pazientemente, la giovane donna,
rimboccando per bene le coperte del bimbo.
«Non è vero, Hanks! Lei è tornata, lei lo
amava!» protestò la bambina, stringendo i pugni.
«Ma per favore! Erano solo amici e lui era
russo, non sarà di sicuro restato qui!»
«Bambini», li interruppe, «basta, su. È ora di
dormire; magari domani vi racconto il seguito».
«Mamma, mamma aspetta! Dimmi almeno se lei
tornò!» squittì, aggrappandosi al collo della ragazza.
Valerie sospirò, sedendo sul letto.
«Sì, tesoro, lei tornò».
«Oh! E lui cosa le disse?»
«Be’», temporeggiò, captando l’ombra di suo
marito oltre la porta, «le disse che le voleva bene e che senza di lei
proprio non poteva stare» tagliò corto, spingendola dolcemente sul
materasso.
La ragazzina mugolò contenta, il fratello invece
sbuffò.
«Che smidollato».
«Chi è uno smidollato?» domandò il padre,
entrando in camera.
Valerie mosse la mano, sminuendo la questione.
«Nessuno, caro».
«Oh, papà, papà! La mamma ci ha raccontato una
storia bellissima! Allora, ascolta: c’era questa ragazza americana e
questo soldato russo che...» la bambina si lanciò in un dettagliato ma
ristretto resoconto della storia che la madre le aveva proposto quella
sera, lasciando infine un sorriso ironico sul viso dell’uomo.
«E, dimmi Val, che fine ha fatto quello
smidollato russo?»
Valerie si strinse nelle spalle, baciando la
fronte di ciascuno dei suoi figli, spegnendo quindi la luce.
Oltre la porta chiusa, i bambini borbottavano e
discutevano della storia.
La ragazzina, Margo, propendeva al romanticismo;
il maschio, Hanks, si mostrava più pratico e cinico.
«Non dovresti raccontare queste cose ai
ragazzini, sai come sono fatti» la redarguì bonariamente, baciandole la
nuca scoperta.
Valerie rise.
«Tanto, prima o poi...»
«Già. Ma non mi hai detto che fine ha fatto quel
russo idiota» la punzecchiò, tirandole una ciocca di capelli. Gli
schiaffeggiò la mano, fissandolo con aria di rimprovero.
«Vaporizzato. Sparito nel nulla, per la gioia di
lei».
Lui rise, baciandole le labbra.
«Spasibo» mormorò con una perfetta
inflessione russa, abbracciandola.
Valerie sorrise.
«Spasibo a te, Alek».
«Allora», cantilenò lui, stringendole la mano
per trascinarla in veranda, «raccontami cosa accadde quando lei andò a
riprenderlo all’aeroporto».
«Bene», iniziò,
schiarendosi la gola con fare saccente, «alle venti meno dieci minuti la
ragazza correva a perdifiato nell’aeroporto e credeva che ormai fosse
troppo tardi. Invece lui era lì, seduto, tutto triste e abbattuto...»
NdA: Zanzanzan. Fine.
L'ho detto nello scorso capitolo, ma questa
volta è la fine per davvero.
Gente, questo è un periodo intenso e turbolento,
quindi il mio tempo è assolutamente limitato.
Pertanto, non mi dilungo oltre e ringrazio di
cuore tutti coloro che hanno recensito (risponderò quanto prima), che
hanno seguito questa storia e che l'hanno inserita tra preferiti e
ricordate.
Questa storia è stata una bellissima esperienza
e chissà che non ci si riveda presto con il sequel!
A risentirci presto!
Passo e chiudo.
|
Ritorna all'indice
Questa storia è archiviata su: EFP
/viewstory.php?sid=1349258
|