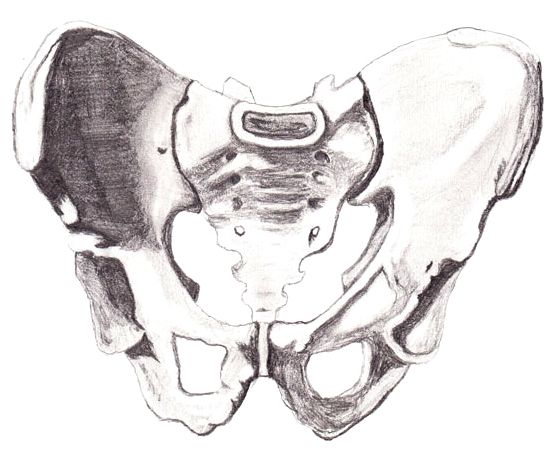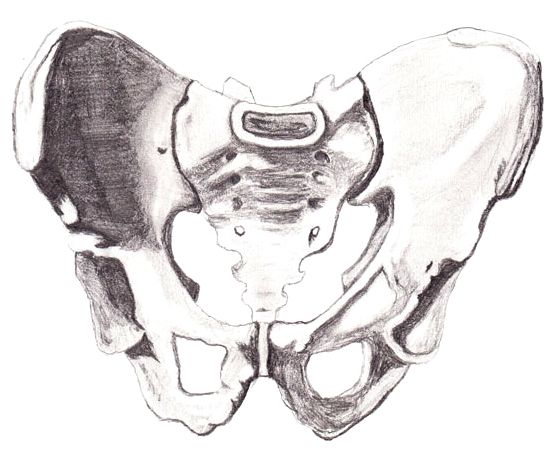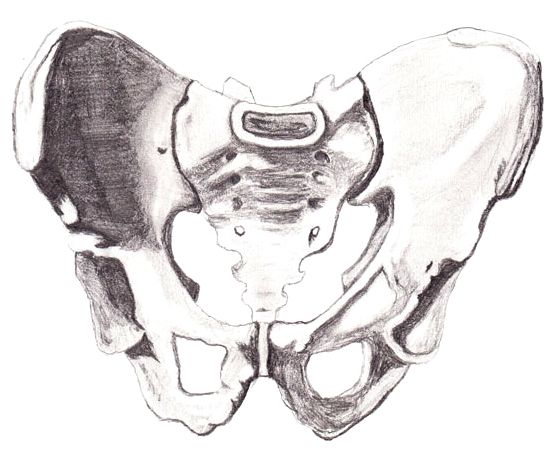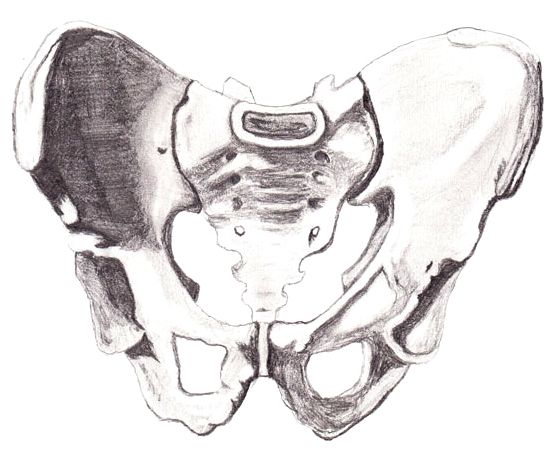Saremi morte già dolce paruta di Lechatvert
(/viewuser.php?uid=453208)
Disclaimer: Questo testo proprietà del suo autore e degli aventi diritto. La stampa o il salvataggio del testo dà diritto ad un usufrutto personale a scopo di lettura ed esclude ogni forma di sfruttamento commerciale o altri usi improri.
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** prologo – ossa del tarso: degli eroi non si conosce la fine ***
Capitolo 2: *** prologo – ossa del tarso: a ferro e fuoco ***
Capitolo 3: *** parte prima – femore, I Vallesanta: un infausto inizio ***
Capitolo 4: *** parte prima – femore, I Vallesanta: il pettirosso ***
Capitolo 5: *** parte prima – femore, I Vallesanta: la scommessa ***
Capitolo 6: *** parte prima – femore, I Vallesanta: la botola ***
Capitolo 7: *** parte prima – femore, I Vallesanta: il corridoio dei santi ***
Capitolo 8: *** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: il tasso ***
Capitolo 9: *** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: riccioli neri ***
Capitolo 10: *** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: la mappa ***
Capitolo 11: *** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: di morti è piena la via ***
Capitolo 1
*** prologo – ossa del tarso: degli eroi non si conosce la fine ***
|
polverenera
Per
iniziare
Bentrovati c:
Finalmente, dopo sedicimila anni di scrittura, correzioni, pare
mentali, smatto selvaggio, assilazione alla beta (ChemicalLady ftw
<3) ... finalmente siamo giunti al giorno gioiglorioso della
pubblicazione su EFP.
E lo so, lo so, lo so che
è appena cominciata la seconda stagione e che adesso che
sono in voga gli Incas probabilmente vorrete sentir parlare solo di
loro ... ma a noi non ce ne frega nulla e quindi la congiura dei Pazzi
e pota per tutti u.u
Per chi è nuovo
sembrerà tutto molto vago e polveroso, per chi invece c'era
anche nella vecchia "All'ombra del giglio rosso",
bé ... saprà già cosa aspettarsi :)
Non prometto nulla, se non che
tenterò in ogni modo di essere il più precisa
possibile nelle note circa riferimenti storici e/o traduzioni,
spiegazioni eccetera.
Spero che come me possiate
affezionarvi a questi insoliti personaggi e che, caratteracci a parte,
potrete apprezzarne le (poche) qualità.
Per ora mando a tutti quanti un
grande abbraccio.
Buona lettura,
Lechatvert
Saremi
morte già dolce paruta
I sogni in cui muoio
sono i più
belli che io abbia mai fatto.
Tears for Fears – Mad World
Gennaio
1478, quattro mesi prima la Congiura dei Pazzi.
Un soffio di vento mosse appena le tende della stanza, facendo
svolazzare il velo immacolato dell’abito nuziale appeso al
muro.
Con una candela stretta in mano, Porpora si avvicinò,
illuminando quel mucchio di stoffe candide che il sarto era stato
così bravo a confezionarle. Mai, in tutta la sua vita, si
sarebbe immaginata di maritarsi lontana da Roma. Non aveva mai nemmeno
pensato di sposarsi, in realtà, mai all’interno di
un castello, coperta di riguardi e parole gentili, al caldo, promessa a
un nobile.
Tutto questo andava oltre ciò che sua madre avesse mai
potuto sperare per lei. Doveva sentirsi felice.
Invece, più guardava quell’abito, più
sentiva le lacrime spingere per uscire a rigarle il volto.
Debolmente, portò le mani alle tempie, cercando di
ricostruire quella che una volta era la sua figura.
Capelli scuri raccolti a treccia, camicia sporca di fango, occhi
cattivi, come diceva sempre la gente. Dov’era finita? Avvolta
in una vestaglia di lino, profumata e ripulita a dovere, era incapace
di ritrovare se stessa.
Udì la porta dietro di sé aprirsi, segno che era
ora di ricacciare indietro i singhiozzi e darsi un minimo di contegno.
Stava per diventare una contessa, dopotutto.
«Non si usava bussare?», chiese, voltandosi per
rimettere la candela nel doppiere.
Sulla soglia, coperto dall’oscurità della notte,
c’era il suo futuro marito. Diciotto anni e un viso da
bambino, un cappello di piume a coprirgli i capelli castani e un
vassoio tra le mani su cui erano state preparate due tazzine di
porcellana e una teiera.
«Ti sentivo camminare senza pace, così mi sono
chiesto se non fosse il caso di portarti del tè»,
le rispose, accomodandosi sul divano davanti al caminetto spento.
«Domani è un grande giorno.»
Porpora si avvicinò lentamente, rannicchiandosi sulla
poltrona di fronte.
«Credevo portasse male, vedere la sposa prima delle
nozze.»
Lui le sorrise.
«Mia cara, non penso che il Signore ne avrà a
male», rispose, mite, servendo il tè.
«Non dopo tutto quello che hai combinato,
perlomeno.»
Porpora prese una tazza tra le mani, rimirandone la fattura.
Incredibile come anche in quell’angolo di terra dimenticato
dal mondo vi fosse la più fine porcellana.
«Vogliono uccidermi?», chiese, sottovoce.
Più che una domanda sembrava una constatazione.
Il suo futuro marito strinse le spalle, spaparanzandosi sul divanetto.
«Hai fatto arrabbiare Roma, questo è
certo», considerò, mostrandosi pensieroso.
«Non credo lasceranno correre un simile oltraggio. Fingerti
morta, rubare al nipote del Papa … decisamente non sono
state le tue idee più brillanti. Hai ancora la chiave,
almeno?»
Porpora dondolò il capo.
Da quando aveva messo le mani su quello stramaledettissimo oggetto, non
se n’era più voluta allontanare. La portava sempre
legata al collo, con lo stesso cordoncino che aveva strappato al Conte.
«Non è che ci dia un grande vantaggio»,
rispose, con un sospiro afflitto. «Abbiamo perso
l’altra, il che ci riporta daccapo.»
«Mi permetto di dissentire: questa volta, una chiave ce
l’hai tu, mentre l’altra è scomparsa.
Riario, invece, non ha niente.»
«Scommetto che sa già dove siamo.»
Il suo futuro marito sorrise appena.
«E io scommetto che sta già pregustando la morte
di entrambi. Ma non temere; ho predisposto una chiesa lontano da qui.
Un amico fidato ci aspetterà domani mattina per ufficiare il
rito. Entro mezzogiorno, sarai la Contessa di Fonterossa. Magra
consolazione, lo so, ma è il meglio che io abbia da
offrirti.»
Porpora arricciò il naso.
Lo era davvero, una magra consolazione. Rispetto a tutto quello che
aveva perso per arrivare fino a lì, duecento soldati e una
cittadina circondata da vigne non le parevano affatto un giusto
compenso.
«Li voglio uccidere tutti, Conte»,
mormorò, posando la tazzina sul vassoio. «Formiamo
alleanze, prendiamoci Roma. Firenze è già in
subbuglio, potremmo convincere anche Milano.»
Il Conte scosse il capo, ridacchiando.
«E firmare un atto di matrimonio col sangue? Belle teste, voi
Lysimachus! Siete uno più impulsivo
dell’altro.»
Porpora sbuffò.
«Prima o dopo il matrimonio, poco importa»,
dichiarò. «Voglio che Riario passi lo stesso che
ha fatto passare a mio fratello.»
«Se devo essere franco, pagare il sangue del fratello minore
con quello del maggiore non mi pare una buona soluzione.»
Porpora si accigliò.
«Il mio unico fratello maggiore morì la notte
dell’elezione di Papa Sisto», dichiarò.
Il Conte ridacchiò di nuovo, massaggiandosi le tempie con
fare divertito.
«Naturalmente. Ma non siamo forse tutti figli di Dio? Poco
importa da chi discendiamo», commentò, trattenendo
un’ulteriore risatina. «Ti vedo stanca, mia cara.
Sarà meglio che ti lasci dormire, avremo tempo per parlare
una volta rientrati, domattina.»
Si alzò in piedi e la raggiunse sulla poltrona, lasciandole
un piccolo bacio sulla fronte coperta da un ciuffo di capelli castani.
«Cerca di risposare, d’accordo?», chiese,
facendole l’occhiolino.
Lei sospirò, sprofondando nel velluto della federa.
Al suo posto, cosa avrebbe fatto suo fratello?
Prese un respiro profondo, convincendosi che un minimo di gratitudine
era il minimo che potesse mostrare.
«Grazie», disse, sottovoce, mentre il Conte si
allontanava. «Mi dispiace avervi dato del codardo,
l’altra volta. Non lo penso davvero.»
Lui rimase sulla soglia a guardarla per qualche istante, la mano
appoggiata alla porta, lo sguardo buono perso in qualche punto
imprecisato della stanza.
«Non c’è di che», rispose,
senza togliere gli occhi da quel nulla. «Ti devo molto, in
realtà. Consideralo come un riscatto. Buonanotte.»
La lasciò così, senza dare ulteriori spiegazioni,
sparendo nel buio del corridoio da cui era arrivato.
Porpora rimase rannicchiata sulla poltrona per tutta la notte, sola,
stretta alle sue stesse ginocchia, in balia dei pensieri.
Non chiuse occhio, non ci provò nemmeno.
Senza suo fratello a cingerle le spalle e a sussurrarle che sarebbe
andato tutto bene, non sarebbe mai riuscita a prendere sonno.

|
Ritorna all'indice
Capitolo 2
*** prologo – ossa del tarso: a ferro e fuoco ***
|
polverenera
Per
continuare(?)
Sono tornata! In ritardo, ma ci sono :3
Grazie a tutti quelli che si sono fermati a leggere il primo prologo,
ora ecco a voi il secondo! (Sì, perché un singolo
prologo è troppo mainstream
Con il prossimo capitolo - il
primo, vero della storia - entreremo nel vivo della faccenda ^^ E vi
anticipo l'arrivo di Lupo Mercuri, che manderà qualcuno in
fuga.
Per quanto riguarda le parole in
corsivo che troverete in questa parte: è tutto scritto in
lingua ebraica, con l'aiuto di una carissima amica e compagna
d'avventura :) La traduzione è quasi sempre presente, se non
nell'ultimo caso. (Ani
ohevet otcha, yeled sheli, insomma: vuol dire "ti amo,
bambina mia")
A tutti un grosso bacio,
Lechatvert
Saremi
morte già dolce paruta
Cara, dimmi il tuo nome
Puoi sentirmi?
Hurts – The Road
Agosto
1471, quindici ore dopo l’elezione di Papa Sisto IV
La porta della taverna si richiuse sulla sua mano con tanta violenza
che, per un instante, Orso credette di sentire le ossa del polso
spezzarsi una a una sotto la pesante morsa del legno.
Con il viso bagnato di lacrime, si voltò verso sua madre in
cerca di aiuto ma, anziché trovarla al suo fianco, la vide
arrancare tra i tavoli vuoti in cerca di chissà cosa.
Aveva i capelli rossi sporchi di cenere e si copriva il volto, forse
per non respirare il fumo dell’incendio, forse per non
mostrarsi piangente agli occhi di suo figlio.
«Ìmma!»,
la chiamò allora Orso, avvicinandosi con la mano
insanguinata stretta sul petto. «Madre!»
La donna si voltò appena, chinandosi per accarezzargli il
capo con la sua solita dolcezza.
«Akol beseder»,
gli sussurrò, baciandogli piano la mano. «Va tutto
bene.»
La porta della taverna si aprì di nuovo, stavolta lasciando
entrare il passo scattante e rapido di un ragazzo ben piazzato avvolto
nei mantelli della guardia cittadina.
«Hanno dato fuoco a tutto il ghetto»,
dichiarò, mettendo a terra la bambina che aveva in braccio,
stretta al suo petto e nascosta appena dalla cappa. «Celia,
dobbiamo andare.»
Si voltò per bloccare l’entrata nella taverna,
mentre dalla strada delle voci cominciavano ad avvicinarsi, sempre
più forti, sempre più irate.
La donna gemette, radunando in un abbraccio entrambi i suoi figli
più piccoli.
«Starete bene», mormorò con tono sicuro,
sebbene soffocando qualche singhiozzo. «Io e vostro padre
torneremo a prendervi domani mattina, d’accordo?»
Orso rimase in silenzio.
Aveva solo undici anni, ma era abbastanza sveglio da capire che quello
non era uno dei tanti incendi che di tanto in tanto distruggevano un
ghetto fatto di legno. C’era qualcosa di più, lo
leggeva negli occhi grigi di sua madre e il solo pensarlo lo
terrorizzava.
Guardò sua sorella, anche lei sull’orlo delle
lacrime e con gli occhi sgranati dalla paura. Istintivamente le strinse
la mano.
«Staremo bene», disse, sforzandosi di apparire
coraggioso. «Gregorio ci proteggerà.»
Alle sue spalle, suo fratello maggiore sbuffò.
«Ci troveranno», lo sentì borbottare.
«Lo faranno sempre.»
Celia gli posò una mano sulla spalla.
«Gregorio», mormorò, seria come mai
prima d’ora. «Quando tutto sarà finito,
dovrai cercare una persona.» Fece una pausa. «Lupo
Mercuri, un cliente di vostro padre. Un amico.»
Gregorio sospirò.
«Un figlio di Mitra», la corresse.
Lei annuì.
«Un tempo lo era. Pregate che le promesse fatte in passato
valgano ancora qualcosa, per lui.»
Gregorio sbuffò e Orso percepì in
quell’istante tutta la sua insicurezza, mentre Celia si
chinava sul pavimento per aprire una botola rotonda.
«Quaggiù sarete al sicuro», disse,
sorridendo appena. «Non uscite prima di domattina.»
Orso annuì, quasi convinto, ma sua sorella si
liberò dalla sua presa, aggrappandosi alla veste della madre.
«Non voglio scendere là sotto»,
dichiarò, tirando su col naso. «Ci sono i
morti e …»
Non fece in tempo a finire la frase che un colpo alla porta di legno la
bloccò.
Orso si sentì afferrare per le spalle da suo fratello e un
attimo dopo venne sollevato in aria, pronto per essere nascosto.
«Madre, non c’è tempo»,
sussurrò Gregorio.
La donna gemette di nuovo, stringendo a sé Porpora. Poi si
scostò, togliendosi la croce intagliata nell’osso
di un santo che da sempre portava al collo per poi consegnarla alla
figlia.
«Dì ad Orso le preghiere che ti ha insegnato
Gregorio», le disse, sorridendo con dolcezza.
«Sarà tutto passato prima di domani
mattina.» La strinse a sé e le baciò
piano la fronte, scompigliandole appena la frangia castana che le
copriva gli occhi. «Ani
ohevet otcha, yeled sheli.»
Un altro colpo alla porta la convinse a prendere Porpora tra le braccia
e a infilarla nella botola.
Quando si sporse per baciarle di nuovo il capo, Orso notò
che al collo aveva un altro pendaglio, uno che non le aveva mai visto
addosso prima di allora: una piccola chiave di ferro legata ad un
semplice cordoncino di canapa, uno di quelli che lui e Porpora
intrecciavano insieme la sera, davanti al fuoco di casa.
Aveva un che di affascinante, quel piccolo oggetto, ma Orso non
riuscì ad osservarlo meglio poiché suo fratello
lo calò nella botola prima di seguirlo sulla piccola scala a
pioli che scendeva nell’oscurità.
L’apertura da cui erano passati venne richiusa velocemente e
l’unica fonte di luce che gli rimase fu un piccolo spiraglio
tra le assi del soffitto.
Nel buio, Orso udì sua sorella singhiozzare, mentre sopra le
loro teste passi veloci e rumori di lame si alternavano alle grida
ovattate della strada.
Poi, tutto d’un tratto, calò il silenzio.
Orso sentì il morbido mantello di Gregorio avvolgerlo per
bene, mentre le mani di suo fratello maggiore si facevano strette
attorno alle sue spalle.
La voce di Celia giunse così tenue che Orso si
stupì di poter udire un suono così flebile.
«Sono figlia della terra e del cielo stellato, di sete son
arsa, vi prego fate che io mi disseti alla fontana della
memoria.»
Il suono stridulo di una spada sfoderata coprì il suo
respiro, dopodiché qualcosa rotolò sul pavimento
marcio della taverna.
In lontananza, le campane annunciarono l’arrivo del nuovo
giorno.
Era il ventisei agosto 1971, quindici ore dopo l’elezione di
Papa Sisto IV, e Orso, assieme a sua sorella, aveva appena compiuto
dodici anni.

|
Ritorna all'indice
Capitolo 3
*** parte prima – femore, I Vallesanta: un infausto inizio ***
|
polverenera
Per
continuare(?)
Buonasera, miei prodi!
Ho deciso di pubblicare ora questo
capitolo perché credo sia stato il primo scritto (prima dei
prologhi, yessa) ed è stato rivisto più volte.
Inoltre, ieri sera l'ho usato come ricatto verso Chemical Lady per
farle concludere il suo ventunesimo (o giù di lì
xD) e con questo ho ricevuto anche la sua benedizione v__v
Dunque: entra in scena Lupo Mercuri
il quale, vi posso assicurare, gironzolerà per un po'.
Almeno per la prima parte della storia che, come avete visto, porta il
nome del femore e il cognome dei protagonisti della storia, i
Vallesanta. Ho deciso che non numererò i capitoli, voglio
essere una vera bastian contraria! (Questa cosa mi farà
perdere, a un certo punto, ne sono sicura!)
Non saprei davvero che aggiungere,
sono pessima.
Un bacio enorme a tutti i lettori,
vi strapazzerei tutti uno dopo l'altro <3
Biscotti,
Lechatvert
Saremi
morte già dolce paruta
Perché cerchi per
anni,
ma perdi sempre ciò che trovi.
Passenger – Caravan
Inizio
agosto 1475. Quattro anni dopo l'omicidio di Celia Lysimachus
Agosto era arrivato così velocemente che in campagna non
avevano ancora trovato il tempo di vendemmiare, che i bambini non
avevano ancora cominciato ad arrotolarsi i pantaloni fino alle
ginocchia, che il sole non aveva ancora deciso di riscaldare le
giornate con la sua solita afosità.
Così, godendosi i primi raggi mattutini, Orso se ne stava
seduto sui gradini del Pantheon con le gambe addossate a una delle
colonne, gli occhi chiusi, le braccia molli incrociate sul petto, quasi
non avesse nulla di veramente importante da fare.
Non che lo avesse, naturalmente.
Suo nonno era morto due giorni prima, lasciandolo completamente solo a
venti giorni dal suo sedicesimo compleanno. I suoi genitori erano stati
uccisi, suo fratello maggiore morto nel tentativo di salvarli, sua
sorella spedita in un convento e scomparsa qualche settimana dopo,
senza lasciare traccia di sé.
Tutto quello che gli era rimasto erano, in ordine di valore, un pugno
di scudi sufficienti a farlo sopravvivere qualche settimana, la spada
di suo padre che non sapeva usare e un conto da pagare al ghetto per
quella botola maledetta in cui buttavano i morti a marcire. Senza
contare naturalmente la vecchia casa di famiglia a Vallesanta da cui,
in quel momento, Orso intendeva tenersi il più lontano
possibile.
Così, abbandonato anche il lavoro da raccogli fieno che
aveva col nonno, non gli restava che godersi le giornate
nell’ozio e nella calura che l’imminente agosto
andava portando.
Cominciava a pensare che ci sarebbe morto, su quei gradini, magari di
freddo una volta sopraggiunto l’inverno, forse di fame.
Solitamente era con quei pensieri in testa che si appisolava,
dondolando i piedi sul marmo, immaginando l’uomo a cui
sarebbe toccata la briga di raccogliere il suo cadavere congelato.
Invece, quel pomeriggio, il sonno non voleva decidersi ad arrivare.
Orso se ne stava lì ad occhi socchiusi, saltando, di tanto
in tanto, per afferrare qualche insetto e strappargli le ali e le zampe.
Poi assemblava i suoi bottini con qualche goccia di cera.
Le ali di una mosca, il torace lucido di una vespa, le zampe lunghe e
pelose di un ragno. Dove gli mancava un arto, aggiustava con un rametto
o una spina di bosco.
Alla fine, quello che creava erano minuscoli scheletri, tanto piccoli
da raggiungere a malapena le dimensioni di un’ape.
Quando era piccolo le chiamava le fate crudeli* e suo padre gli aveva
insegnato a confezionarle.
Non era difficile, ma era un lavoro che richiedeva di certo grande
concentrazione.
Fu per tutta quella concentrazione, più o meno, che si
accorse troppo tardi del gruppo di guardie svizzere in avvicinamento.
Non ebbe il tempo di allontanarsi, giusto quello di mettersi in
posizione seduta e di lasciar cadere le sue fate sulla strada.
« Siete Orso di Vallesanta?», gli chiese la guardia
più anziana, senza mascherare il forte accento tedesco.
Orso alzò le spalle.
«No», rispose, scuotendo appena il capo con fare
seccato. «Quel vigliacco se n’è andato
stamani all’alba.»
Non era un granché a mentire, in realtà, ma era
risaputo che le guardie di Roma non fossero molto attente a questo
genere di imbrogli. Probabilmente lo cercavano per un’altra
tassa sulla sepoltura del nonno, cosa a cui Orso non era per niente
interessato. Non aveva intenzione di pagare uno scudo in più
per un pezzo di camposanto dove far marcire le ossa di un vecchio.
Quindi si rimise comodo, assottigliando lo sguardo
sull’insolito gruppo e optando per pazientare fino a che la
guardia non si fosse allontanata.
Ma non accadde. Non esattamente, almeno.
Una voce si alzò sopra le altre, costringendo Orso a
rimettersi di nuovo in una posizione più o meno attenta.
«Riconoscerei le fate dei Vallesanta ovunque»,
disse l’uomo che sostava dietro le guardie, facendosi spazio
per avvicinarsi. «E gli occhi cattivi, anche. Talmente simili
a quelli di vostro padre che per un istante ho creduto fosse tornato
dalla tomba.»
Non era stata una guardia svizzera, a parlare.
Mostrando un mezzo sorriso, Orso allargò le braccia in segno
di resa, osservando l’uomo fermarsi a pochi passi da lui.
Era uno dei prefetti di Roma, non uno dei più giovani, a
giudicare dai capelli bianchi che gli coronavano il volto tirato dalle
rughe.
Orso aveva già avuto il piacere di conoscerlo, ma erano
passati anni e a stento ne ricordava la voce.
Quando i loro occhi si incontrarono, però, non ebbe
difficoltà a rimembrare.
«Lupo Mercuri», biascicò, colto di
sorpresa.
Dopo la morte di suo padre, non credeva avrebbe rivisto simili
personalità se non fuori dalla messa domenicale.
Guardò il prefetto attentamente, assicurandosi una via di
fuga all’interno del Pantheon. Se le guardie svizzere erano
da considerarsi una visita indesiderata, quelli che sedevano alla
stessa tavola del Papa per pranzo erano ancora peggio.
Suo padre aveva sempre parlato di Lupo Mercuri come di un
brav’uomo, ma non c’era da fidarsi.
C’era un solo motivo per cui un uomo come lui poteva trovarsi
in un simile posto, a parlare con una persona sporca e maleodorante
come Orso di Vallesanta.
L’imbalsamatore di corte era
morto.
«Ho sentito dire che siete un imbalsamatore con il doppio del
talento di vostro padre», esordì infatti il
prefetto, aprendo il mantello con un gesto della mano per estrarne una
busta chiusa recante l’insegna papale.
«È vero?»
Orso alzò le spalle.
«Questo è quello che dicono», rispose.
«Ma non faccio più l’imbalsamatore. Ora
mi dedico …», a cosa si dedicava, ultimamente?
«Ad altro.»
Lupo Mercuri si accigliò.
«Naturalmente», commentò.
«Dicono anche che vostro padre vi abbia lasciato una certa
quantità di artefatti.»
Lo aveva fatto? Lo aveva fatto di certo. E Orso sapeva anche dove
andarli a cercare, gli artefatti. Peccato che in quella botola non
avesse più voglia di tornarci.
Quindi sospirò rumorosamente, passandosi una mano sulle
piume colorate che teneva legate attorno alla testa con un laccio di
cuoio. Servivano per coprire la parte d’orecchio che un tizio
alla taverna gli aveva reciso in un’esplosione di rabbia, in
realtà lo tenevano calmo quando il nervosismo prendeva il
sopravvento.
«Di cosa andate alla ricerca, Prefetto?», chiese,
senza batter ciglio.
Fissava Mercuri dritto negli occhi, senza però andare alla
ricerca di una sfida.
L’uomo socchiuse appena lo sguardo, prendendo fiato per
parlare.
«Il ragazzino a due teste morto dieci anni fa a Viterbo. La
sua bara è stata trovata vuota.»
«E perché mai dovrei averlo io?»
Bastò uno sguardo perché Orso realizzasse il
motivo.
Chi altro poteva avere lo scheletro di un bambino morto? Se non era tra
le reliquie della botola, allora era di certo andato distrutto da
qualche scaramantico del luogo.
Provò a focalizzarsi sull’ultima volta in cui era
sceso nella cripta, sugli scheletri che erano stati raccolti attorno al
tavolo, ma era tutto buio e confuso. La paura aveva cancellato tutto
ciò che i suoi occhi erano stati in grado di registrare.
«Non c’è modo di recuperare gli
artefatti di mio padre», disse, infine, lasciandosi sfuggire
un sospiro rassegnato. «Che fossero nelle mani della mia
famiglia o meno ha poca importanza, visto che non possiedo la chiave
per la cripta. Arrivate in ritardo; mio nonno era l’unico a
potervi accedere, ma la morte se l’è preso due
giorni fa.»
Lanciò a Mercuri un’occhiata mortificata,
dopodiché alzò le spalle e fece per andarsene, ma
la lettera che il prefetto teneva tra le mani gli venne consegnata con
così tanta forza che dovette accettarla.
«Fossi in voi troverei un modo, Vallesanta», gli
disse l’uomo, senza che il suo tono si alterasse.
«Al Santo Padre non piace ricevere rifiuti dalle spiccate
personalità che lo circondano, figurarsi da voi.»
Si voltò appena, facendo segno alle guardie di allontanarsi.
«Ci vedremo presto, immagino», lo
salutò, avviandosi verso la strada.
Orso rimase lì, impalato con la lettera ancora stretta sul
petto, a fissare il vuoto.
Prese un respiro profondo, poi iniziò a correre nella
direzione opposta a quella presa da Mercuri.
Aveva mentito.
Un modo ce l’aveva, eccome, se ce l’aveva.
Ammesso che sua sorella fosse ancora viva.

* Le fate crudeli
Non sono ahimé una mia
idea, ma un capolavoro dell'artista Tessa
Farmer. Il metodo di costruzione indicato nella storia
è, più o meno, lo stesso che utilizza lei
(sì, sono opere d'arte biodegradabili al 100% :D)
Qualche foto delle fate (tutte
prese dal suo sito web), tanto per farvi venire gli incubi. Uno, due, tre, quattro, cinque
|
Ritorna all'indice
Capitolo 4
*** parte prima – femore, I Vallesanta: il pettirosso ***
|
polverenera
Per
continuare(?)
Non abituatevi a questi aggiornamenti lampo, non durerà
molto.
Comunque: bentrovati! :D
Oggi siamo in un "tutto al
femminile". Sarà un capitolo solo per la protagonista
femminile, con il Turco e uo uo uo Girolamo Riario! E c'è
anche un pettirosso, ma su di lui tralasciamo :3
Nel prossimo capitolo, vi
preannuncio un giovane Zoroastro!
Alla prossima,
Lechatvert
Saremi
morte già dolce paruta
Sognerò il giorno
in cui tu mi raggiungerai
e potremo ricominciare da capo.
Adrisaurus – Iris
Imola,
venti agosto 1475. Tre anni prima della congiura dei Pazzi
La calura di agosto la destò allo scoccare
dell’ottava, quando le voci delle comari al mercato divennero
troppo acute e insistenti per essere ignorate.
Porpora aprì piano gli occhi, stiracchiandosi con aria
svogliata nel covone di fieno dove si era addormentata qualche ora dopo
il tramonto. Sentiva la dita intorpidite affondare tra gli steli
d’erba secca e l’odore caldo della paglia
mischiarsi a quello acre del sangue secco sulla sua pelle.
Sospirò.
Si era data alla fuga la sera prima per un pezzo di pane rubato in una
taverna e aveva finito con l’inciampare sulle tegole di un
tetto e sbattere il naso contro un comignolo. Il segno del suo
inesorabile fallimento nella corsa sui tetti era ancora sul suo viso,
sgargiante nel rosso del sangue che le macchiava le guance.
Se lo tolse di dosso con uno sbuffo, sputando sul palmo e passandosi la
mano sulla faccia.
«Sveglia e risplendi», disse a se stessa, mentre
con le gambe si preparava a balzare fuori dal fieno che
l’aveva protetta per la notte.
Lo stomaco reclamava cibo ed era ora di mettersi al lavoro, per non
finire a pancia vuota.
Una volta uscita sulla piazza, recuperò la borsa che portava
a tracolla e fece un rapido inventario dei suoi averi: due patate lesse
rubate il giorno prima, un tozzo di pane e formaggio ottenuto dal
baratto del pelo di un coniglio morto, un coltello e un osso
dissotterrato al camposanto.
Con un sospiro, ingurgitò un boccone di pane.
Attendeva con impazienza l’arrivo del Conte.
Lo faceva sempre.
Ogni qualvolta Girolamo Riario tornava da Roma, portava con lui
qualcosa di interessante da vedere, qualcosa che valeva la pena di
stare per ore sul tetto di una vecchia casa, magari sotto la pioggia,
fermi ad aspettare.
La prima volta era stata una squadra di guardie svizzere che avevano
rimesso in riga la città, un’altra una
quantità spropositata di libri e manoscritti, poi una decina
di cavalli dall’oriente, tessuti … uno spettacolo
delizioso da vedere con il pranzo, quando Porpora aveva qualcosa con
cui banchettare.
Quel giorno, invece, il Conte non aveva portato niente.
Niente più di un barcollante se stesso, malfermo sulla sella
e anche parecchio trasandato, quasi tornasse da una battaglia
anziché dal Vaticano. Sembrava febbricitante, tanto era
pallido e tremante.
Colpita da quella visione, Porpora abbandonò momentaneamente
il suo pezzo di pane, facendolo sparire sul fondo della borsa, per
sporgersi verso la strada.
Era raro vedere il Conte in quello stato. In tutti gli anni in cui lei
aveva vissuto nei dintorni di Imola, non c’era mai stata una
volta in cui lo aveva trovato scomposto.
Curiosa, assottigliò lo sguardo, avvicinandosi al muro della
casa di fronte che aveva usato come scala per arrivare alla sua
postazione.
Un istante dopo camminava per le strade di Imola, cauta, con
l’orecchio sempre teso alla ricerca di un buon pretesto per
correre via, ma non pareva esservi motivo di tanta agitazione. La gente
si spostava silenziosa al passaggio del Conte, quasi avesse di che
pentirsi alla sua vista. Da quando aveva preso il possesso di Imola,
una strana paura aleggiava nell’aria, sebbene egli fosse ben
visto dalla maggior parte della gente, in città. Era un buon
governatore, un uomo di guerra e di fede, di scienza e di lettere.
Senza abbandonare la difensiva, Porpora gli si avvicinò con
attenzione, restando dietro le spalle di qualche passante e dietro i
banchi del mercato.
Tra una schiena e l’altra, però, lo guardava in
viso. Ed era un viso che aveva visto centinaia di volte, quello del
Conte Riario, eppure quel giorno c’era qualcosa di diverso,
qualcosa di più prudente.
Il riflesso di un gioiello alla luce del sole le accecò un
occhio, costringendola a fermarsi.
Nell’istante che passò a massaggiarsi la palpebra,
il Conte le sfilò accanto. E vide la stessa chiave
triangolare che aveva visto al collo di sua madre la notte in cui aveva
visto i suoi genitori per l’ultima volta. Piccola, del colore
del ferro, legata malamente a un cordoncino di canapa. Un colpo di
tosse l’aveva fatta spuntare fuori dallo stesso mantello in
cui si era rituffata un attimo dopo, quando il Conte l’aveva
prontamente afferrata per rimetterla al suo posto.
Ma a Porpora era bastato per accorgersene.
Rimase ferma tra la folla, lasciando che il breve corteo la superasse.
Immobile, cercò di ricordare, sebbene ogni memoria di quella
notte fosse stata accuratamente riposta lontano dalla sua mente.
«Ehi, ragazza.»
La voce di un uomo la riportò alla realtà,
aiutandola a rendersi conto di essersi letteralmente bloccata in mezzo
alla strada.
Ai suoi piedi, seduto accanto al muro della casa su cui si era
appostata, sedeva un uomo dalla carnagione scura. Vestiva in modo
eccentrico, con una giubba color del mare ricamata con dei bordini
dorati, e sorrideva alla giovane in modo enigmatico.
Porpora lo guardò inarcando un sopracciglio castano.
«Sì?», chiese, sbuffando.
«Ti senti male?»
Aveva un forte accento dell’est, farsi, probabilmente.
Ottomano, quindi. Forse turco.
«Che t’importa?», gli rispose, tirando su
col naso. «Fatti gli affari tuoi, vecchio.»
Fece per allontanarsi, ma l’uomo la fermò di
nuovo, stavolta ridendo.
«Sei quella che gironzola qui intorno come un cane
randagio?»
Porpora strinse le spalle.
«Può essere», ribatté,
accigliandosi. «A te cosa ne viene?»
«Ho visto come guardavi quella chiave. Le tue mani la
bramano.»
«Non sarebbe difficile prenderla.»
«Non saresti così rapida.»
Porpora guardò l’uomo con sguardo seccato.
Sapeva il fatto suo ed era molto più veloce di quanto ci si
potesse aspettare.
«Scommetto che riuscirei a prenderla ancor prima che il Conte
si accorga della mia ombra.»
L’uomo sorrise, allargando le braccia per invitarla ad
avvicinarsi.
«Scommetto che le tue mani verrebbero tagliate entro la
sera.»
Porpora scosse il capo.
Conosceva fin troppo bene quel tipo di persone: gli affamati, quelli
che per il tozzo di pane che portava nella borsa l’avrebbero
volentieri affogata in un secchio d’acqua piovana. E lei non
era certo tipo da farsi prendere in giro.
«Non impicciarti, turco», sentenziò
quindi, ficcando le mani in tasca. Gli voltò le spalle e
iniziò a camminare verso la piazza.
«Ani ohevet
otcha, yeled sheli», insistette
l’uomo, senza scomporsi. «Quella chiave ti ricorda
lei, vero?»
Porpora sbottò, senza fermarsi.
«Fatti i fatti tuoi!», ribadì,
scrollando le spalle. Non si voltò, sebbene ne avesse
davvero voglia.
La risposta le giunse così lontana da risultare quasi
impercettibile.
«Ci rivedremo, lo sai? A Roma.»
Quando si voltò, furibonda, per protestare, lo strano
individuo era già sparito dalla sua postazione. Come fosse
riuscito ad alzarsi e ad allontanarsi tanto velocemente era un vero
mistero.
Stizzita, Porpora rimase ferma un istante a contemplare la strada.
Aveva gli occhi grigi sgranati sulla folla del mercato, il respiro
pesante e il pugno alzato pronto a colpire
quell’importunatore nel caso si fosse avvicinato.
Scrutò la strada con attenzione, dopodiché si
mise composta e tornò a camminare verso la piazza,
sbuffando, di tanto in tanto, al ricordo dell’incontro appena
avvenuto.
Quell’uomo l’aveva infastidita talmente tanto che
le era passato l’appetito.
Decise di mangiare comunque, rannicchiata in un vicolo.
Perdere la borsa non era poi difficile e quello che aveva tra le mani
poteva essere l’unico pasto della settimana.
Assaporò a fondo il pane, ingoiando un boccone dopo
l’altro, dopodiché si diresse verso la fontana per
buttare giù il nodo allo stomaco con un sorso
d’acqua.
Bevve poco.
Di acqua se ne trovava in abbondanza e non era il caso di riempirsi la
pancia di liquidi, non se c’era il rischio di dover scappare
da chissà chi durante il sonno.
Lasciò che il getto della fontana le bagnasse la fronte,
pulendo un poco i capelli appiccicati alla pelle sporca del viso,
dopodiché si concesse qualche sorso.
Quando si rimise dritta sulle ginocchia, sul muretto della fontana
trovò un pettirosso.
Di primo acchito si ritrasse per non spaventarlo, timorosa di vederlo
volare via in preda al panico. Capì subito che
ciò non sarebbe accaduto.
L’animale era stecchito, imbalsamato nell’esatta
posizione i suoi compagni ancora in spiccavano il volo. Le piume
lucidissime e brillanti sotto i raggi del sole, il becco aperto, gli
occhi spalancati.
Dire che pareva vivo sarebbe stato sminuire la realisticità
di quel lavoro.
Sgomenta, Porpora allungò la mano verso
l’uccellino, accarezzandogli il petto con la punta delle dita.
Conosceva quel pettirosso imbalsamato: era stato il suo primo
giocattolo, il primo dono che suo padre aveva fatto a lei e a suo
fratello.
Lo pensava perso negli anni e invece eccolo lì,
più reale che mai, lucido e ben sistemato sul marmo della
fontana della piazza di Imola.
Porpora prese un grosso sospiro, dopodiché
afferrò l’uccellino e lo chiuse tra i palmi delle
mani, portandoselo al petto quasi fosse il più prezioso dei
tesori.
«Orso», sussurrò.
Improvvisamente, nella sua mente non vi fu altro che
l’immagine di suo fratello gemello trascinato lontano dalla
folla mentre cercavano di scampare alla morte.
Come quell’uccellino fosse giunto fin lì era
mistero, eppure significava una cosa: Orso era ancora vivo e, da
qualche parte, probabilmente la stava cercando.
Tra sé e sé, Porpora sorrise.
Avrebbe dato qualunque cosa per ritrovarlo.

|
Ritorna all'indice
Capitolo 5
*** parte prima – femore, I Vallesanta: la scommessa ***
|
polverenera
Per
continuare(?)
Ce l'ho fatta! :D Temevo di non riuscire ad aggiornare prima di tornare
a casa dai genitori e invece ...
D'accordo, d'accordo, ho
benevolmente abbandonato il manuale di storia contemporanea per un
pomeriggio e mi sono dedicata esclusivamente alla scrittura per finire
le bozze che mi mancavano. And
I regret nothing.
Comunque sia, oggi ho le idee un
po' più chiare delle volte passate e voglio fare qualche
conteggio. La prima parte, quella dedicata ai Vallesanta,
sarà composta più o meno di altri 3-4 capitoli
(cinque al massimo), dopodiché ci sarà una parte
tutta dedicata a Firenze :D In cui, per la felicità delle
mie amate fangirl (vi amo, donneh<3), presenzierà un
pomposissimo Levi.
Concludo queste note ringraziando
la mia multitaskingissima betareader
Chemical Lady, che anche con 38 di febbre legge e
corregge. Ti amo di beneh<3
Un bacio a tutti,
Lechatvert
Saremi
morte già dolce paruta
Il prete, il prete è
in crisi.
È combattuto tra amore e Gesù.
Chi vincerà la guerra?
The Lumineers –Big Parade
Roma,
ventisei agosto 1475. Sedicesimo compleanno dei fratelli di Vallesanta
«E invece, caro amico, ti dico che quella testa calda me
l’ha chiesto davvero.»
Sospirando, Orso si coprì la fronte con la mano, schermando
così i raggi del sole che gli offuscavano la vista.
Quella mattina era particolarmente corrucciato, nonostante portasse
sulle spalle la consapevolezza di essere un anno più
vecchio, un anno più vicino alla morte.
Guardò il suo amico, tutto preso a raccontargli
dell’ultima missiva ricevuta da Firenze, saltellare sui
gradoni del Pantheon quasi il foglio che stringeva tra le mani fosse la
più bollente delle braci.
«Quindi ti unirai a Leonardo da Vinci?»,
azzardò, assai perplesso da tutta quell’agitazione.
L’uomo alzò le spalle.
«Per rimetterci la vita in uno dei suoi esperimenti da
pazzo?», ironizzò. «Vallesanta,
sarò anche coraggioso, sì, ma non fino a questo
punto!»
Orso ridacchiò, estraendo dalla borsa una pagnotta comprata
con gli ultimi denari che il nonno gli aveva lasciato.
«Zoroastro il codardo», commentò,
spezzandone una parte e portarla alla bocca.
Zoroastro si chinò su di lui per pizzicargli una guancia con
fare scherzoso.
«Vorrai dire: Zoroastro il saggio!»
Risero assieme, accomodati lungo i gradoni di Piazza della Rotonda.
Era una bella giornata d’agosto, tutto sommato neanche troppo
calda, e Orso compiva sedici anni. In più, avevano una
pagnotta con cui festeggiare e riempirsi lo stomaco, avvenimento non
così comune viste le condizioni di estrema
povertà in cui il ghetto si trovava.
Molto probabilmente, metà della gente che abitava in quelle
casupole li avrebbe volentieri uccisi per assicurarsi anche un morso di
quel ben di Dio.
Pensava a questo, Orso, quando spezzò la pagnotta in due si
alzò per consegnarla a un vecchio vestito di stracci che
gridava la misericordia divina sotto le colonne.
Ignorò volutamente l’occhiata sconvolta che
Zoroastro gli lanciò quando tornò al suo posto,
consegnandoli il resto del cibo e prendendo a lanciare sassolini nella
piazza, improvvisamente sovrappensiero.
«Sto cercando una persona», confessò,
guardando vergognosamente il terreno sotto ai suoi piedi.
Sentì Zoroastro schioccare la lingua contro il palato.
«Una delle tue giovani conquiste?»,
ironizzò il suo amico, prendendogli la spalla per scuoterlo
da quel vuoto in cui era caduto.
Sospirando pesantemente, Orso scosse il capo.
«Ma no», rispose. «Mia sorella.
È scappata anni fa dal convento in cui l’avevano
rinchiusa e da allora non se ne sa più nulla. Mi stavo solo
chiedendo dove stesse festeggiando il compleanno.»
Zoroastro fece spallucce.
«In un bordello, se è stata fortunata»,
commentò.
Orso aggrottò la fronte.
«Non credo», rispose. «Da bambina
mordeva.»
«A molti uomini piace essere morsi.»
Silenzio.
Con le braccia incrociate sul petto, Orso si fece improvvisamente
pensieroso. Era plausibile, l’idea di sua sorella in un
bordello di Roma? Dopotutto, di lei non ricordava che il viso colmo di
lacrime nel momento in cui si erano detti addio. Di lei, il fato poteva
aver fatto qualunque cosa.
«Dici che dovrei cercare nei bordelli?», chiese,
allora, guardando Zoroastro come se fosse la prima volta che sentiva
nominare quel genere di luogo.
Il suo amico alzò le spalle, ovvio.
«Non l’hai già fatto?», si
informò.
Orso scosse il capo.
«A dire il vero no.»
«Allora l’hai cercata nei conventi?»
«No.»
«Negli ospedali? A volte gli orfani vengono presi per lavare
gli appestati.»
«Nemmeno.»
«Nei cimiteri?»
«Non ci avevo pensato.»
«Hai almeno chiesto ai becchini delle fosse comuni?»
«No, direi di no.»
Zoroastro schioccò la lingua contro il palato, alzando le
braccia verso il cielo con un’espressione rassegnata.
«Buon Dio, ma dove l’hai cercata?»,
sbottò.
Orso strabuzzò gli occhi, offeso.
«In giro!», esclamò. «Per
strada, così, al mercato … poi sono tornato qui,
in caso qualcuno l’avesse indirizzata al Pantheon, e sono
rimasto ad aspettarla per tre giorni. E poi sei arrivato tu.»
Ora che l’aveva detto ad alta voce, il suo piano di accorata
ricerca sembrava molto meno ben studiato di quanto lo fosse nella sua
testa.
In fondo, chi gli assicurava che Porpora fosse a Roma?
Anche se, a dirla tutta, non c’erano poi molti altri posti
dove andare a cercarla. Di certo non si era messa in cammino per andare
a esplorare la penisola. Forse.
«Zoroastro, credi che la troverò?»,
mugugnò, affondando le dita nei capelli castano chiaro.
Affranto, si accarezzò le orecchie, seguendo con accuratezza
il contorno del loro destro, tagliato durante una lite in osteria e
ingegnosamente coperto da un cordoncino di piume colorate che lui
stesso si era preso la briga di tingere in verde e rosso.
Il suo amico ridacchiò, prendendogli una spalla per
scrollarla con vitalità.
«Se tu la troverai stando qui al Pantheon a poltrire, io me
ne andrò a far da assistente a quel matto di da
Vinci!», esclamò, sornione, caricandosi in spalla
il sacco che si portava appresso. Mosse qualche passo verso la piazza,
dopodiché si voltò a salutare Orso. «Ci
vediamo, mio buon amico!»
Orso sospirò.
«Non sei divertente», borbottò,
guardandolo andare via.
Stava perdendo ogni speranza e, man mano che osservava la folla passare
accanto all’enorme costruzione senza degnarla però
di uno sguardo, la fiducia che qualche giorno prima aveva riposto nella
sua buona stella andava via via affievolendosi, lasciando sempre
più spazio alla consapevolezza che non c’era
alcuna possibilità di ritrovare una ragazza
nell’immensità della Città Eterna, non
senza uno straccio di indizio.
Forse, era stato tutto un vagheggiamento dall’inizio, quando
aveva creduto di potersi salvare la pelle.
Che sciocco, era stato! Sarebbe dovuto scappare quel giorno stesso,
quando ne aveva la possibilità!
«Orso?»
La voce scocciata di una ragazza lo colse alla sprovvista,
costringendolo ad alzare il capo verso la piazza.
Davanti a lui, una giovane dagli occhi color della sabbia lo fissava
con le braccia conserte sul petto, le labbra storte in una smorfia
perplessa, il mento affondato nei lembi morbidi di una camicia sporca
di fango.
Orso balzò in piedi.
«Porpora», mormorò.
Lei roteò gli occhi.
«Grazie a Dio ti ho trovato», commentò.
«Sei il terzo vagabondo che fermo, oggi, e pensavo di dover
cercare ancora per –»
Non arrivò a finire la frase.
Orso le balzò al collo, abbracciandola così
stretta che quasi la sentì spezzarsi sotto le sue braccia.
«Un vecchio mi ha detto che mi cercavi», disse lei,
una volta libera da quelle effusioni. Frugò nella tasca e
mostrò un uccellino imbalsamato avvolto in un fazzoletto di
raso.
Orso sgranò gli occhi.
«Quello lo avevo venduto due mesi fa!»,
esclamò, sbigottito. «Dove l’hai
trovato?» Fece una pausa, cercando di rimettere ordine nella
sua mente. C’erano faccende più urgenti, di un
pettirosso. «Il nonno è morto»,
confessò, muovendo appena le labbra.
Porpora corrugò la fronte.
«Era ora che il Signore se lo prendesse», rispose,
tirando su col naso. «Tanto meglio. Un aguzzino in meno da
cui guardarmi le spalle.»
Orso annuì distrattamente.
«Che hai fatto per tutto questo tempo?», chiese.
Porpora lo fulminò con lo sguardo.
«Ho dormito sotto un portico con un coltello tra le mani per
evitare che mi tagliassero la gola», rispose, guardando il
fratello dritto negli occhi. «E tu?»
Lui sorrise appena, deglutendo.
«Andato a messa, lavorato nei campi, seppellito il nonno
… niente di che.» Dondolò il capo,
accarezzandosi le piume che portava legate attorno al capo. Come
parlare di ciò che gli era successo qualche giorno prima?
«Uno dei tirapiedi di Sisto è venuto a trovarmi al
Pantheon, due giorni fa.» Buttò lì,
abbassando il tono. «Era alla ricerca di uno scheletro,
quelli che papà nascondeva nella cripta. Non
sembrava molto intenzionato a lasciar perdere, quando gli ho spiegato
che non esiste più nessun modo di scendere
laggiù, non senza le chiavi, ma non si è
dimostrato troppo incline al dialogo.» Fece una pausa per
riprendere fiato. Le sue dita scivolavano così velocemente
sulle piume colorate che per poco non se le strappò via
dalla testa. «Ora che il nonno è morto sei rimasta
solo tu.»
Porpora si portò la mano destra al petto.
Orso sospirò.
«Hai ancora la croce d’osso della mamma?»
Lei annuì lentamente.
«È l’unica cosa che mi è
rimasta di casa.»
Orso sorrise.
Una croce per pregare negli inverni più freddi, nelle
giornate più piovose, che terminava negli intagli di una
piccola chiave della giusta misura per aprire la botola nascosta sotto
i tavoli del ghetto di Roma.
Suo padre ne aveva costruite tre, all’epoca.
Una per lui, una per il nonno, e una per sua moglie.
Dopo sette anni, evidentemente, quella che Porpora aveva al collo
doveva essere l’ultima rimasta.
«Non c’è altro modo?», chiese
sottovoce la ragazza. «Non puoi scassinare la
serratura?»
Lui strinse le spalle.
«È fatta in modo che tutto crolli nei canali sotto
al ghetto, nel caso si sfondi la botola», rispose, pacato.
«Non ti sto chiedendo di venirci con me, Porpora. Solo di
cedermi la chiave.» Fece una pausa, mettendo le mani sotto la
giacca. «Posso pagartela, se vuoi. Non ho molti soldi, ma non
ci sono scudi che valgano la mia vita. Per favore.»
Porpora sospirò, abbassando nuovamente il capo sulla sua
croce.
«Quanti soldi hai?», chiese, scrollando il capo e
strizzando gli occhi per impedire a un paio di lacrime di stizza di
rigarle le guance.
Orso ci pensò un istante.
«Dodici», rispose, serio. «Dodici scudi
per la tua croce.»
Porpora non perse neanche un secondo.
«D’accordo, affare fatto», disse, tutto
d’un fiato.
Orso le porse allora il taccuino, ma lei scosse il capo, prendendogli
il polso per impedirgli di consegnarle le monete.
«Tienili tu, me li darai dopo il lavoro»,
borbottò, incamminandosi verso le porte della
città. «Finito con quella botola non voglio
più rivederla.»
Fece qualche passo senza aspettare il fratello, ma la voce di Orso
parve bloccarla.
«Quindi vieni anche tu? », le chiese lui, senza
nascondere un tono di sorpreso sollievo.
Porpora alzò le spalle.
«Bé, ormai sono a Roma. E poi, non ho un posto
dove andare a dormire», disse, voltandosi verso il fratello.
«Andiamo?»
Lui le sorrise, sistemandosi la borsa a tracolla e affrettandosi a
raggiungerla.
Orso e Porpora di Vallesanta compivano sedici anni proprio quel giorno
e, dopo quattro anni passati in solitudine, erano finalmente tornati
assieme.

|
Ritorna all'indice
Capitolo 6
*** parte prima – femore, I Vallesanta: la botola ***
|
polverenera
Per
continuare(?)
Sono tornata! Lo so, mi sono presa le ferie di Pasqua
senza avvisare ma ehi, concedetemelo P:
Prometto
di non sparire più così, sì <3
Dunque,
che dire di questo capitolo? Botole, morti e amore fraterno a
secchiate. (Credeteci finché potete)
Nel
prossimo, vi prometto il Papa!
Bacini baciotti,
Lechatvert
Saremi
morte già dolce paruta
No, non ero io sulle scale della
chiesa.
Il vento nei miei capelli soffiava nell'aria della notte.
Beriut – Guymas Sonora
Roma,
ventisette agosto 1475. 1888 anni dopo l'assedio di Siracusa.
Giunsero in prossimità della vecchia taverna dove loro padre
aveva lasciato i suoi cimeli che un improvviso temporale li aveva
inzuppati fino all’osso.
Guardando i suoi capelli zuppi gocciolare nelle pozzanghere per strada,
Orso sospirò, stringendosi nella vecchia giacca che aveva
aperta sulle spalle. Di certo quel bagno fuori programma gli sarebbe
bastato per almeno un mese.
«Non vedo l’ora di buttarmi su un letto»,
dichiarò, allegro, coprendosi i capelli con il berretto
giallo che sua sorella gli stava porgendo. «Sono talmente
stanco che potrei addormentarmi anche qui.»
Porpora sospirò, legandosi la treccia dietro la nuca con un
fazzoletto dello stesso colore del berretto.
«Abituati all’idea di dormire per strada,
allora», rispose, guardando verso la taverna.
«Questo non è un bel posto dove lasciare i soldi e
chiudere gli occhi. Molto meglio far finta di essere morti di
fame.»
Orso non rispose, continuando a camminare per la strada costellata di
pozzanghere. Non aveva voglia di mettersi a discutere e, in
realtà, era molto più interessato da quel luogo
che da una banale chiacchierata. Erano anni che non metteva piede nel
ghetto, eppure niente era cambiato. La gente continuava a muoversi in
silenzio, schiva, guardandosi attorno con circospezione e i toni di
voce erano bassi, lievi, quasi impercettibili. Tutto attorno alle
abitazioni vi erano squadre della guardia cittadina che tenevano
l’ordine, se di ordine si poteva parlare. Rispetto al resto
della città, il quartiere ebraico era di gran lunga il
più sporco, condannato a marcire sotto la grandezza di Roma.
Scosse il capo, sforzandosi di focalizzarsi sui pochi ricordi che aveva
di quel luogo. Sarebbe riuscito a ritrovare la botola? Non ne era tanto
sicuro.
Guardò sua sorella sparire dietro la porta della taverna e,
quasi senza accorgersene, si ritrovò a pensare a quella
notte in cui tutto era in fiamme e sua madre lo aveva preceduto
all’interno, lasciando troppo presto quella porta che gli
aveva fratturato la mano.
Solo in quell’istante notò quanto Porpora le
somigliasse. Aveva i capelli più scuri e gli occhi
più chiari, ma il viso, tanto tondo da apparire perennemente
imbronciato, era lo stesso.
Si affrettò a seguirla all’interno della taverna e
subito fu investito dal calore di almeno venti corpi umani ammassati in
un quadrato di terra palesemente troppo piccolo per contenerli. Tra
tutti quei berretti, il fazzoletto giallo che Porpora aveva intrecciato
nei capelli era facilmente individuabile.
Si sbrigò a raggiungerla al banco, dove aveva già
preso a parlare con l’uomo che ripuliva le pinte.
«Siamo Orso e Porpora di Vallesanta», disse, quando
Orso fu abbastanza vicino da udire la sua voce ferma tra gli schiamazzi
della taverna. «I figli di Giovanni.»
L’uomo li scrutò a lungo, tanto a lungo che Orso
credette che quel discorso non sarebbe mai andato oltre le
presentazioni.
«In giro dicevano di avervi trovati affogati nel
Tevere», rispose d’un tratto l’uomo,
grugnendo mentre posava lo straccio. «Ma non
c’è dubbio che siate i figli di Giovanni. Avete
gli stessi occhi da brutta canaglia.»
Porpora non batté ciglio.
Orso non poté fare a meno di chiedersi quante volte, nei
sette anni che li avevano separati, la gente le aveva affibbiato quel
genere di nomignolo.
La vide sospirare, scostandosi una ciocca di capelli castani dietro
l’orecchio.
«Siamo tornati a riprenderci la cripta», rispose,
seria.
L’uomo scoppiò in una grassa risata.
«Arrivate in ritardo, Vallesanta!»,
esclamò. «Sono tre anni che nessuno si fa vivo a
pagarmi l’affitto! Se la rivolete indietro, avete prima da
saldare prima il conto.»
Porpora si accigliò.
«Laggiù c’è roba che vale ben
più di un misero affitto. Scommetto che vale persino
più di questa vecchia topaia»,
considerò. Guardava l’uomo dritto negli occhi,
senza distogliere l’attenzione dalle sue pupille.
«Ma, anche solo provando a scassinare la serratura, tutto
finirebbe a marcire nelle fogne che scorrono sotto la
città.»
L’uomo alzò le spalle.
«Allora la cosa non mi tocca. Che saldiate o meno il conto,
quella roba è intoccabile. Dio me ne scampi dal dover tirar
su i morti da quel buco!»
Di scatto, Porpora si voltò verso Orso.
«Quanti scudi hai detto di avere?»
Lui deglutì.
«Dodici», balbettò. «Ieri ne
abbiamo spesi due, quindi …»
La ragazza annuì, tornando a guardare il taverniere.
«Abbiamo dieci scudi, che ti bastino!»,
gridò, battendo la mano sul tavolo.
Lui scosse il capo.
«Trenta, e ritenetevi fortunati.»
«Quindici.»
«Venticinque. Pagate o butterò i vostri preziosi
morti in fondo al fiume.»
Porpora si portò una mano alla fronte, mostrandosi
pensierosa. Per un istante, parve sul punto di esplodere, poi si
calmò.
«Venti», disse, decisa. «Dieci ora, dieci
tra tre giorni. Se non ti sta bene, dà pure al Tevere
ciò che ti pare.»
L’uomo ammutolì. Arricciò il naso un
paio di volte, trafficando con un piatto di patate arrosto che
buttò sul bancone in attesa che chi le aveva ordinate
venisse a prendersele. Si accarezzò la barba per qualche
minuto, poi parve acconsentire con un lieve cenno del capo,
così Orso si affrettò a tirare fuori il sacchetto
con gli ultimi dieci scudi che il nonno gli aveva lasciato per campare
e pagò, seppur poco convinto, quell’affitto.
«Stanotte, quando se ne saranno andati via tutti,
lascerò la porta socchiusa», disse il taverniere,
facendo sparire il sacchetto con le monete. «Farete meglio a
essere discreti, Vallesanta. Se le guardie svizzere vi seguiranno anche
una sola volta, con me avete chiuso. Ora via, per carità, ho
abbastanza sventure, in questo posto!»
Alzando le spalle, Porpora diede all’uomo un lieve sorriso e
si allontanò.
Orso la seguì silenzioso, mentre uscivano dalla taverna
così come erano entrati, senza rivolgere la parola a nessuno
degli uomini ai tavoli che li fissavano con sguardo vacuo.
«Siamo senza soldi», le ricordò, una
volta in strada.
Lei annuì con un cenno del capo.
«Già.»
«E senza un posto dove dormire.»
«Lo so. Hai fame?»
Solo in quel momento, Orso si accorse che Porpora teneva le mani
strette lungo i fianchi. Quando aprì i palmi, rivelandone il
contenuto, scoprì due pugni di patate arrosto ancora fumanti.
Orso si accigliò.
«Quando le hai rubate?», chiese, stupito.
«Quando non stava guardando», gli rispose Porpora.
«Ne vuoi? Ho visto un portico, laggiù.»
Improvvisamente, Orso si sentì affamato. Da quando si era
ritrovato sua sorella, non aveva ancora messo in bocca nulla; quindi
annuì, silenzioso, e si tolse la giacca per fare da riparo
alla sorella in quel breve tratto che li separava dal porticato.
La loro cena consistette in due morsi di carne essiccata e delle patate
arrosto che riscaldarono i loro
stomaci più di quanto un qualsiasi caminetto avrebbe potuto
fare.
Rimasero sotto la pioggia battente per quasi quattro ore, dormendo a
turno l’uno sulle spalle dell’altra, contando ogni
uomo che usciva dalla taverna in piedi o strisciante nel suo stesso
vomito.
Quando le ultime luci all’interno della taverna vennero
spente, Porpora si era appena addormentata, raggomitolata su se stessa
nel suo mantello fradicio.
Delicatamente, Orso la scrollò.
«È ora», mormorò, alzandosi
in piedi. «Andiamo.»
Stavolta, fu lui a precedere la sorella nel locale. Era stato colto da
un barlume acceso nei suoi ricordi, quando aveva visto le finestre
oscurarsi. Anni prima, quando si recava lì con suo padre,
quello era il segnale che potevano entrare, percorrere quelle due
tavolate sulla destra e infine aprire la botola.
Sapeva dove andare.
Si trascinò dietro sua sorella per i tavoli e le sedie della
taverna, studiandone bene i particolari. La cripta era sotto la gamba
marcia di una delle bancate.
Non gli ci volle molto per individuarla.
In silenzio, spostò il tavolo alzandolo da terra e
liberò l’entrata della botola alzando la lastra di
granito che la ricopriva. Sotto ai suoi piedi, piccola e scura,
c’era una serratura.
Annuendo, guardò Porpora, la quale stava già
sfilandosi la croce d’osso dal collo.
«Prega che funzioni», commentò,
infilandola nella serratura.
Ruotando la chiave, si udì un lieve sibilo metallico, poi il
coperchio di ferro si abbassò e cadde nel buio con un tonfo
secco.
Immediatamente, un odore di marcio invase la taverna.
Porpora si coprì il naso con un lembo del mantello, mentre
Orso nascose il viso nella giacca.
«Siamo state le ultime due persone a metterci
piede», commentò, sporgendosi per guardare nel
buio. «Mi domando quanto marciume possa essersi accumulato,
in tutti questi anni .»
Porpora aggrottò la fronte, estraendo una candela dalla
borsa.
«Ti lascio il piacere di scoprirlo», rispose,
porgendogliela assieme a dei cerini. «Non ho intenzione di
scendere là sotto.»
Orso sospirò.
Non faceva di certo i salti di gioia all’idea di calarsi in
quel buco, ma d’altronde erano arrivati fin lì e
non poteva certo permettersi di tirarsi indietro.
Afferrò quindi i cerini e vi accese la candela, sedendosi
sul bordo e lasciando che le gambe penzolassero nel buio.
Guardò la sorella.
«E se mi faccio male?»
Lei alzò le spalle.
«Ti arrangi.»
Deglutendo, Orso tornò a guardare verso il buco.
Contò fino a tre, dopodiché si lasciò
cadere.
Il salto fu molto più corto di quanto ricordasse.
Atterrò in piedi, affondando leggermente in uno strato di
qualcosa di morbido e viscido che, a giudicare dall’odore,
poteva essere il vomito o l’escremento di qualche animale.
Mettendo da parte la questione per un istante, Orso decise di avanzare
senza illuminare il pavimento. Procedette un passo dopo
l’altro, mentre gli stivali affondavano sempre più
nel terreno infermo. Sotto di lui, stando ai ricordi che aveva,
scorrevano le fogne della città.
Sapeva che nella stanza c’era un caminetto, una specie di
fornace che suo padre utilizzava per sciogliere la cera, ma non
riuscì a ricordarne l’ubicazione esatta fino a
quando non andò a sbatterci contro.
Una volta illuminata, la cripta assunse tutto un altro aspetto.
Vi era un tavolo di marmo posto al centro della stanza, circondato da
una fessura che doveva fungere da canale di scolo. Sopra il tavolo,
appeso a delle corde, vi era un gran numero di pinze e seghetti
accuratamente ripuliti e disposti in ordine crescente man mano che si
avvicinavano al camino. La corda più vicina, lasciava
pendere un paio di quanti di pelle scura.
Sulle pareti tutte attorno alla stanza, erano disposti gli scheletri e
gli animali impagliati della collezione di famiglia, circondati dalle
fate crudeli, la firma che suo padre dava a ogni lavoro.
Cere e colle erano accatastate dall’altro lato della cripta,
dove una scala di corda scendeva nelle fogne.
Tutto sommato, quello era un ambiente spazioso, ben costruito.
Ora che lo vedeva senza gli occhi della paura, Orso non poteva fare a
meno di scorgere un ricordo a ogni dettaglio che notava. Le incisioni
sulle pareti di legno che aveva lasciato da bambino, le vasche dove suo
padre lasciava alle larve il compito ingrato di rosicchiare la carne,
gli animali impagliati che tanto amava osservare …
Si guardò attorno, in cerca dello scheletro che il prefetto
gli aveva commissionato. Se non si trovava tra quelli appesi alle
pareti, difficilmente era sopravissuto agli anni.
Lo trovò poco più in là, a dare bella
mostra di sé nella collezione accanto alla scala,
già cerato e lavorato con l’asta di ferro che lo
teneva ben dritto sul suo piedistallo.
Lo spostò con cautela, portandolo fino alla botola sul
soffitto con il passo più lento di cui fosse capace.
Lasciarlo cadere a quel punto, gli sarebbe costato la morte.
«Porpora?», chiamò, avvicinandosi il
più possibile all’apertura.
La voce di sua sorella arrivò calma e squillante.
«Sì?»
«Mi serve una mano. Ecco, sta’ attenta.»
Le mani della ragazza scesero prontamente ad afferrare il piedistallo,
trasportando il prezioso artefatto in superficie.
«Dio … che schifo!»,
commentò, una volta che lo scheletro fu interamente fuori.
«E lo vogliono mettere in bella mostra in Vaticano? Che se lo
tengano, dovremmo essere noi a pagare loro perché ci
liberino di questo affare!»
Orso riemerse dalla botola arrampicandosi malamente sul muro.
«Non dirlo neanche per scherzo», tuonò,
afferrando il piedistallo per ammirarlo alla luce che Porpora aveva
acceso nella taverna. «È bellissimo!»
Lo scheletro era quello di un normalissimo infante, forse un
po’ più piccolo del solito, ma da bacino partivano
due spine dorsali che terminavano in un paio di spalle decisamente
troppo larghe e, particolare decisamente più agghiacciante,
due teschi perfettamente formati. Dovevano essere appartenute a un
bambino non neonato, ma di almeno quattro o cinque anni.
Estasiato, Orso lo accarezzò con le dita.
Gli piangeva il cuore a pensare di liberarsene.
Veloce, afferrò il mantello che Porpora aveva abbandonato a
terra, avvolgendoci delicatamente lo scheletro, e lo ripose con cura in
un ulteriore involucro fatto con la sua giacca.
Tornò poi a recuperare il coperchio della botola, e la
chiuse con un giro di chiave, riconsegnando la croce a Porpora.
«Mettiamo a posto e andiamo via», disse lei,
prendendo in custodia lo scheletro. «Prima che qualcuno noti
che la porta è aperta.»
Si avviò verso l’uscita, ma Orso non la
seguì subito.
Col fiato corto a causa di tutte quelle novità, rimase
qualche passo indietro ad aggiustarsi la camicia sul petto. Si diede
una rapida sistemata ai pantaloni e infine passò a
controllare le stringhe degli stivali con qualche colpetto di mani.
Quando si guardò i palmi, li trovò cosparsi di
larve intente a mangiare quello che rimaneva della carne putrefatta di
un animale, forse un topo.
Chiuse la bocca, sforzandosi di non pensare a cosa aveva appena
toccato, e passò le mani sui pantaloni nella vana speranza
di potersi togliere di dosso l’odore di morto.
La notte dopo gli sarebbe di certo toccato sgobbare per ripulire la
cripta dai resti marci delle bestie arrivate lì dentro in
cerca di calore.

|
Ritorna all'indice
Capitolo 7
*** parte prima – femore, I Vallesanta: il corridoio dei santi ***
|
polverenera
Per
continuare(?)
Fine della prima parte! L'introduzione dei fratelli di
Vallesanta e del loro sporco business italiano è
ufficialmente finita ;D
Tanto
per rendervi partecipi della mia preparzione, non ho la più
pallida idea di come chiamare la seconda parte. Maaaaa va tutto bene.
Più o meno.
Vi lascio e torno ai
miei deliri, che sarebbe anche ora.
Vollemossebbene<3
Un abbraccio,
Lechatvert
Saremi
morte già dolce paruta
I fantasmi che ululano riappaiono
tra le montagne che si addossano per la paura.
Ma tu sei un re e io un cuordileone
Of Monsters and Men –King And Lionheart
Roma,
tredici settembre 1475. Giorno della nascita di Cesare Borgia.
Orso di Vallesanta tossì, lasciando che il suono secco del
suo catarro si propagasse con l’eco dei corridoi vaticani. Di
tutti i posti in cui aveva mai immaginato di mettere piede, quello era
decisamente l’ultimo. L’ultimo e il meno gradito, a
dirla tutta, ma fuori pioveva a dirotto e quei corridoi erano caldi e
asciutti, quindi non si azzardava a lamentarsi.
Silenzioso, osservava le alte architravi stagliarsi su di lui, i volti
ritratti dei santi guardarlo con astio, quasi non fosse benvenuto in
quella che, a detta di tutti, era la vera casa del Signore.
Decisamente, quello non era un posto in grado di metterlo a suo agio.
Nervoso, si voltò verso la sorella, di gran lunga
più rilassata e serena di lui, intenta a rimirare il suo
grazioso profilo nel riflesso di una finestra.
Si era lavata come meglio poteva, facendo sparire almeno le croste di
terra che aveva in viso, e aveva trovato chissà dove una
camicia di un colore vagamente più simile al bianco della
casacca che indossava di solito. Così, messa più
o meno in ordine, appariva quantomeno piacente.
«Porpora, credi che ci faranno entrare negli
archivi?», le chiese, sovrappensiero.
Ogni tanto gli piaceva fantasticare.
La ragazza si voltò appena, inarcando un sopracciglio
castano.
«Non fare lo stupido.»
Orso strabuzzò gli occhi.
«Non si sa mai», si giustificò.
Porpora aprì la bocca per ribattere, ma la voce di un uomo
la bloccò.
Dietro di lei, la figura massiccia del capitano delle guardie svizzere
oscurò un poco la stanza, mentre egli si avvicinava con
passo pesante.
«Gli imbalsamatori?», esordì con tono
seccato, incrociando le braccia sul petto.
Orso lo guardò, attento.
Era alto poco più di lui, ma estremamente più
massiccio. Lo conosceva bene. Tutti lo conoscevano, a Roma. Capitano
Grunwald, spalla del nipote del Papa, non esattamente il tipo di uomo
con cui valeva la pena scherzare. Una volta, Orso lo aveva visto
spezzare una porta con un solo pugno.
«Sì», gli rispose quindi, a voce bassa,
avvicinandosi alla sorella. «Porpora e Orso di
Vallesanta.»
Lui li scrutò attentamente, soffermandosi sulla cassa di
legno che Porpora portava tra le braccia.
Scosse poi il capo, quasi a scacciare un qualche pensiero, e
voltò loro le spalle.
«Da questa parte», li chiamò, prendendo
a camminare lungo il corridoio. «E vedete di non
perdervi.»
Orso lanciò un’occhiata a Porpora.
Difficile dire chi, tra sua sorella e Grunwald, apparisse
più seccato. Era una gara che non avrebbe visto un vincitore.
Sospirò, quindi, e iniziò a camminare in silenzio.
Avanzarono senza parlare per qualche minuto, accompagnati soltanto
dagli occhi dei dipinti, che Orso non perdeva mai di apprezzare. Con il
polso appoggiato all’elsa della sua spada, sfilava
affascinato lungo quell’esibizione di Santi. Era una
ricchezza che sua sorella non poteva comprendere, quella.
Sospirando, si voltò verso di lei, studiandone
l’espressione.
Mostrava il volto stanco di chi ha decisamente dormito troppo, ma era
ben dritta sulle gambe, con il mento alto e lo sguardo superbo che
l’accompagnava ovunque andasse. Portava i capelli legati
sulla nuca con un pezzo di corda, una camicia meno sporca del solito e
una lama al fianco, che dava mostra di sé ondeggiando ad
ogni passo.
Orso non poté fare a meno di chiedersi se l’avesse
rubata a qualcuno nel tragitto o se, piuttosto, l’avesse
sempre avuta con sé, nascosta sotto il mantello per
difendersi da qualche aggressore nelle serate più buie.
Si sentiva irrequieto. Gli sembrava di essere nel posto più
bello del mondo con un coltello puntato alla gola pronto a conficcarsi
nella giugulare al primo sgarro.
In effetti, realizzò, quella visione del suo stato non era
poi troppo lontana dalla realtà.
Si sforzò di buttare da parte quei pensieri, seguendo
Grunwald per i corridoi.
Quel castello doveva essere un vero labirinto: svoltarono a destra un
paio di volte, percorsero scale in salita e in discesa, attraversarono
almeno tre diversi colonnati, tutti decorati con sfarzose
raffigurazioni di santi e scene bibliche.
Infine, sbucarono in un piccolo cortile interno illuminato appena dai
pochi raggi di sole che avevano fatto capolino dalle nubi di quella
mattina.
Evidentemente, nel tempo che lui e Porpora avevano trascorso
all’interno di Castel Sant’Angelo, il temporale si
era allontanato, lasciando spazio a qualche attimo di pace.
Sollevato all’idea di non dover passare un’altra
notte sotto la pioggia battente, Orso osservò il
giardinetto.
Esso si apriva sotto un colonnato rettangolare, con due alberi di pesco
ormai spogli e qualche erba aromatica piantata con ordine accanto alle
colonne. Vi erano anche dei cipressi, tenuti bassi, a delimitare il
perimetro del giardino, e un’aiuola di primule sistemata
accanto a una panchina in marmo.
Sospirò, obbligandosi a seguire Grunwald nel biancore che
era il groviglio di corridoi di Castel Sant’Angelo. Avrebbe
veramente pagato oro per potersi godere un istante tra l’erba
di quel cortile.
* * *
Starnutendo, Porpora ruppe il
pensate silenzio che era caduto nel corridoio quando, una volta giunti
dinanzi a una maestosa porta in mogano, si erano accorti del fatto che
Orso fosse rimasto indietro.
Il Capitano Grunwald si era limitato a un pensate sospiro, portandosi
una mano alle tempie come per raccogliere la pazienza che gli era
rimasta per evitare di esplodere.
Lei, invece, non era stata così controllata. Aveva prodotto
una serie di insulti che si era fermata soltanto quando, di corsa, Orso
non aveva fato capolino da dietro l’angolo, preceduto dallo
stridere dei suoi stivali sul pavimento di marmo.
Porpora lo raggiunse con uno scatto, stringendo le mani contro il
bavero della sua giacca e scuotendolo appena.
«Maledizione, possibile che tu ti debba perdere
ovunque?», sbuffò, seccata.
Orso aprì la bocca per rispondere, ma non uscì
alcun suono. Sembrava perso in una specie di stato incosciente, lontano
miglia e miglia dalla realtà.
«Per Dio, Orso!», lo richiamò Porpora,
adirandosi ancora di più di quanto già non fosse.
«Rispondimi!»
Fece per scrollarlo di nuovo, ma le mani del Capitano Grunwald
l’afferrarono per la treccia e la alzarono di qualche
centimetro, costringendola a mollare la presa attorno al fratello.
«Finitela con questo chiasso!», ruggì
l’uomo, allontanando Porpora dalla figura di Orso.
«Cercate di ricordare dove siete e datevi un
contegno!»
Ancora sotto la presa di Grunwald, Porpora non osò
controbattere. Lasciò che le braccia le cadessero molli sui
fianchi e attese di essere lasciata andare, con ogni singolo capello
che le doleva per la presa.
Si stupì, comunque, della delicatezza con cui
l’uomo la depositò a terra, lanciandole
però uno sguardo severo che le fece incrociare le braccia
sul petto.
Fu in quell’istante che le porte della sala si aprirono,
lasciando uscire due maggiordomi vestiti di bianco che li annunciarono
con pomposità, quasi si trattasse di pronunciare il nome di
chissà quale nobile anziché quello di due
ragazzini venuti dalla campagna.
Porpora li superò senza degnarli di uno sguardo, recuperando
velocemente la cassa di legno in cui avevano riposto lo scheletro.
«Orso, stammi dietro», disse, evitando di voltarsi
per controllarlo. «Non perdiamo altro tempo.»
Entrò nella sala che suo fratello l’aveva ormai
raggiunta e le camminava affianco, reggendo la borsa in cui aveva
raccolto il raccoglibile lasciato nella cripta. Due monete di una
valuta che non conoscevano e qualche pinza che Orso si era voluto
portare dietro per sicurezza e che pesavano molto più di
quanto la loro grandezza lasciasse a intendere.
Gli prese il braccio, affondando le dita nella sua giacca.
«Sta’ tranquilla», le disse lui,
dondolando appena il capo.
Sembrava sicuro di sé, ma Porpora notò che gli
tremavano le gambe.
«Agitato a conoscere il Papa?», gli chiese, tirando
fuori un sorrisetto di scherno.
Lui annuì, divertito.
«Spero si sia sistemato», rispose, guardando il
trono piazzato al centro dalla sala. «Non capita tutti i
giorni di incontrare Sua Eminenza, gradirei serbarne un ricordo
piacevole.»
In realtà, Porpora dubitava molto che quel primo incontro
sarebbe stato in alcun modo piacevole, ma non disse nulla, chiudendo il
discorso con una risatina prima di rivolgere l’attenzione
alla sala e ai presenti.
Se avessero messo assieme tutti i corridoi che avevano attraversato,
probabilmente non sarebbero arrivati a toccare la metà dello
sfarzo presente in quell’ambiente. Soffitto affrescato,
grandi finestre oscurate da delle pesanti tende di velluto rosso,
pavimenti in marmo recanti lo stemma papale e, al centro, il grande
trono dorato su cui sedeva Sisto IV.
Nel sudiciume del suo unico paio di pantaloni, Porpora dovette
ammettere che persino il papa, in quel luogo, era avvolto da uno sfarzo
pacchiano.
Aveva addosso la veste bianca e si riscaldava con un pellicciotto del
pelo chiaro di chissà quale animale esotico. Era ricoperto
di gioielli dalla testa ai piedi, talmente luccicante che Porpora si
ritrovò a constatare di non aver mai visto tanto oro addosso
a una sola persona.
Per forza,
si corresse mentalmente, roteando gli occhi verso il
soffitto. È
il Papa!
Alla destra del trono, un uomo dall’aspetto saccente stava in
piedi a fissarli con un mezzo sorriso sul volto. A giudicare
dall’aria compiaciuta con cui guardava Orso, doveva essere il
famoso tirapiedi che l’aveva trovato ad oziare al Pantheon.
Sospirando, Porpora pizzicò il braccio di suo fratello,
facendogli capire, con un cenno della testa, che forse era il caso di
esordire con un saluto.
Riluttante, Orso la guardò, poi congiunse i polpastrelli
delle mani e mosse un passo avanti, malfermo sulle gambe tremanti.
«Vostra Santità», salutò
chinandosi in una profonda riverenza mentre si schiariva la voce.
«Desidero porgervi i miei più sinceri
omaggi.»
Si leccò le labbra, rivolgendosi poi all’uomo alla
destra del pontefice.
«Prefetto Mercuri, buongiorno.»
Di rimando, il prefetto chinò appena il capo.
Orso deglutì.
«Ho portato mia sorella Porpora», disse,
indicandola. «Spero la sua presenza non sia di intralcio. Io
e lei … collaboriamo.»
Mercuri gli fece cenno di andare avanti.
«Avete ciò che vi abbiamo chiesto?»,
esordì, avanzando in un passo verso di lui.
Orso sorrise.
«Assolutamente», rispose, tirando fuori un lato
teatrale che Porpora non ricordava di avergli mai visto addosso.
«Dritto dalla cripta di famiglia. Aspettava soltanto che
qualcuno lo andasse a tirare fuori.»
Mercuri si accigliò.
«Ebbene?»
Orso sbuffò, senza nascondere una certa soddisfazione.
«Ebbene, eccolo.»
Fece cenno a Porpora di avanzare e portare la scatola di legno che si
portavano appresso, senza perderla di vista nemmeno per un secondo.
«Apparteneva ad un bambino morto pochi anni dopo la
nascita», continuò, mentre lei apriva con calma la
cassa. « Ricordo il giorno in cui mio padre lo
acquistò, a Firenze.»
A dire il vero, Porpora ricordava alquanto bene la filosofia che
impediva a suo padre di comprare i morti ai banchi del mercato nero.
Filosofia che però non gli aveva mai impedito di andare a
scassinare il sarcofago di qualche vecchio, ma in fondo erano dettagli.
Se quello scheletro era nella cripta, l’unico modo in cui
aveva potuto finirci era stato il furto dal cimitero, cosa che di cui,
per altro, suo padre si occupava sempre personalmente.
Non era una bella storia da raccontare in Vaticano, però.
Scosse la testa e, una volta rimosso il coperchio della cassa, si
drizzò sulle ginocchia e mosse un passo indietro, lasciando
che i presenti potessero ammirare il contenuto.
Due teste, due spine dorsali, un solo piccolo bacino dalle ossa
talmente minute da apparire quasi come dei piccoli gioielli.
Il Prefetto Mercuri aggrottò la fronte, prendendo un
profondo respiro.
«È senza dubbio un falso ben studiato»,
commentò, osservando lo scheletro. «Non posso
credere che un essere tanto stravagante sia esistito non molti anni
orsono.»
Orso scrollò le spalle.
«Mio padre non ha mai venduto nulla che non fosse stato
donato lui dal Signore», affermò.
Porpora storse il naso.
Giovanni di Vallesanta era famoso per le sue chimere, animali
mitologici che lei stessa gli aveva visto fabbricare unendo pezzi di
cadaveri di vari animali morti di freddo in campagna. Orso stesso, da
bambino, ne era un abile costruttore.
Di nuovo, si astenne dal commentare.
«Non vi venderei mai qualcosa di cui non conoscerei
l’esatta provenienza», continuò suo
fratello, prendendo un grosso respiro. «Inoltre, non credo
voi siate di venuto di persona in cerca dei miei servigi per un falso,
sia pur esso ben costruito.»
A quelle parole, Porpora vide i volti del Papa e di Mercuri illuminarsi
di un sorriso compiaciuto.
Aggrottando la fronte, guardò lo scheletro, poi
guardò Orso, poi di nuovo lo scheletro.
Già, perché disturbarsi tanto quando non si aveva
nemmeno la certezza di ricevere un’opera autentica?
Dopotutto, le voci su Giovanni di Vallesanta erano tante, a Roma.
C’era persino chi diceva che le ossa che vendeva in
realtà erano quelle dei suoi stessi figli.
Arricciando il naso, guardò verso Orso, cercando il suo
sguardo grigio.
Non appena lo intercettò, lui parve illuminarsi.
«Oh», mormorò, voltandosi verso Mercuri
con un’espressione sorpresa.
«C’è dell’altro,
quindi?»
Il prefetto sorrise, ondeggiando lievemente sulle punte dei suoi
stivali scuri.
«Siete arguto, Vallesanta», disse loro, portandosi
la mano destra al mento. «In effetti sì,
c'è dell'altro. Siete mai stato a Genova?»
Orso alzò le spalle.
«Mai.»
«Ho sentito di uno scheletro, laggiù, dalle ossa
talmente corrose dalla sifilide da apparire sciolte come la cera di una
candela.»
Porpora storse il naso. Genova non le piaceva, anzi, a dirla tutta
nessuna città le piaceva. Niente era come Roma, dove il
potere del clero era forte abbastanza da insinuarsi nelle menti di chi
la abitava e da tenere la gente lontana dal mestiere di tombarolo.
Nessuna concorrenza, a Roma.
Sospirando, guardò di nuovo Orso, il quale appariva
pensieroso, assorto in chissà quale considerazione.
«Non serve andare molto lontano, allora», disse,
trattenendo a stento una risata. «Nostro nonno è
morto di sifilide due settimane fa. Prendete le sue, di ossa!»
D'istinto, anche Porpora si scompose in una piccola risata,
più divertita dell'idea di dare a suo nonno una fine del
genere, piuttosto che dalla battuta in sé.
Il Papa e Mercuri, però, rimasero impassibili.
Orso dovette accorgersene immediatamente, perché
soffocò il suo divertimento con un colpo di tosse,
ricomponendosi all'istante.
«Naturalmente, ci recheremo immediatamente a
Genova», assicurò, accennando una riverenza.
Papa Sisto si sporse sul trono, piegando leggermente il capo in avanti.
«Lavorerete per noi, Vallesanta», disse, lieve.
«Come vostro padre fece per Papa Pio II, viaggerete dove
sarà necessario che viaggiate, occupandovi di realizzare
ciò che vi sarà commissionato. Ogni lavoro vi
sarà pagato anticipatamente con cinquanta scudi.»
Orso ringraziò con un inchino e porse i suoi saluti, Porpora
rimase immobile in mezzo alla sala. La sua mente si era fermata ai
cinquanta scudi. Non era sicura di aver mai sentito nemmeno parlare di
una simile cifra, figurarsi stringerla tra le mani.
Si affrettò a fare una riverenza e girò sui
tacchi, raggiungendo suo fratello.
Cinquanta scudi non andavano sprecati. Se dovevano spenderne la
metà per dei cavalli, come minimo quella sera avrebbero
risparmiato su un letto al caldo, dormendo sui tavoli della taverna.
Cinquanta scudi.
Ancora non riusciva ad abituarsi al dolce suono che quelle due parole
assumevano, una volta messe vicine.
Una volta sul corridoio, si voltò verso Orso per
congratularsi, ma venne immediatamente zittita quando la mano di lui si
strinse attorno al suo polso.
Aveva il palmo sudato e freddo.
«Stringila, ti prego», le disse lui, paonazzo in
volto. Non aveva quasi più voce, tanto tremava.
«Non sono sicuro di riuscire a camminare da solo.»
Porpora roteò gli occhi.
«Sei davvero una donnicciola», commentò,
accostandosi a lui per fargli riprendere il fiato che la paura gli
aveva tolto. «Si può sapere cosa c'è,
che ti spaventa tanto?»
Lui la guardò disperato, mentre a passo spedito si
allontanavano sui corridoi di Castel Sant'Angelo.
«Credo che ci sia dell’altro»,
confessò.
Porpora rise, senza abbassare la guardia una volta che furono lontani
dalla sala.
«E come mai, donnicciola?»
Orso prese una grossa boccata d'aria, guardandosi intorno con
circospezione mentre abbassava il tono di voce a un sussurro.
«Non lo so. Ma il Papa ha gli occhi cattivi.»
Per risposta, lei gli sorrise, fingendo una preoccupazione che, dopo i
cinquanta scudi, non aveva modo di avere addosso.
«Non s’è mai sentito parlare di un
pontefice dagli occhi buoni.»
Si allontanò in fretta, isolandosi mentalmente da Orso e
dalle sue paranoie.
Per la prima volta nella sua vita, aveva in tasca più di tre
scudi. Tutto quello che le andava di fare era, in uno sprizzo di
improvviso buonumore, festeggiare con quanta più birra
poteva tenere in corpo.

|
Ritorna all'indice
Capitolo 8
*** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: il tasso ***
|
polverenera
Per
ricominciare
Ed eccoci tornati con la seconda parteeee *canzoncina
della vittoria
Dunque,
prima precisazione sull'ileo e la figura che ho scelto ... lo so,
l'ileo non è tutto il complesso delle ossa del bacino, ma
non ho trovato un disegno migliore eve E poi mi quasipiaceva l'idea
di mettere "ossa del bacino" come titolo della seconda parte. Poi
l'ileo ha vinto. Yuhu.
Ad
ogni modo, per chi l'ha voluto e per chi lo ha odiato, un piccolo
assaggio di Levi. Non temete, anche se per ora è apparso due
volte, a brevissimo arriverà per restare. E non ve lo scrollerete
più di dosso.
Per
chi invece è una "new entry" di questo scapestrato
personaggio, qui potete trovare la sua indegna
fine, anche se la storia non è la sua. Arriverà
anche una fanfiction tutta per lui, ve lo prometto <3
Enniente, colgo
l'occasione di questa nuova "fetta" di storia per ringraziare chi
segue, chi legge, chi preferisce, chi spamma la fanfiction alla zia,
chi ne parla al gatto e anche chi la ignora. Serve anche quello. In
particolare, un grazie alla mia dolcissima beta che mi fa compagnia
nelle notti in bianco pre-esame<3 Grazie, Chemical Lady!
Bene,
ora scappo °v°/
Un bacione,
Lechatvert
Saremi
morte già dolce paruta
E non saremo mai reali
Non scorre nel nostro sangue
Quel tipo di lusso non fa per noi
Lorde – Royals
Isola
di Bergeggi, Savona, 25 maggio 1476 – Un anno prima della
morte di Ottaviano Maria Sforza
L’acqua del golfo era gelida, così come il vento
primaverile che stizzoso soffiava sui prati del monastero.
Uscendo dal mare in una nuvola di schizzi e gocce volanti, il Conte
Levi di Fonterossa saltellò fino al valletto più
vicino, afferrando l’asciugamano che gli venne porto per
legarselo frettolosamente alla vita.
Superò fischiettando una fila di monaci intenti a seminare
nell’orto e si infilò la casacca che
trovò abbandonata a ridosso dello stesso muro dove
l’aveva lasciata.
Sistematosi anche il cinturone sui fianchi magri, si calcò
un bizzarro cappello bordato d’oro sul capo e si
avviò di buon passo verso la corte interna del convento.
«Tempesta in arrivo», constatò, puntando
il naso verso il cielo scuro quando si fermò ad afferrare
una mela da un canestro sistemato dinanzi alle cucine.
Il monaco lì accanto alzò le spalle e
continuò il suo lavoro di pelapatate.
Con uno sbuffo poco soddisfatto, il Conte di Fonterossa
addentò la mela e si addentrò nei corridoi
dell’imponente casale, rabbrividendo quando i suoi piedi nudi
entrarono a contatto con il marmo gelido del pavimento.
Spedito, camminò fino alla biblioteca, entrando nella sala
senza curarsi di chiudersi la porta alle spalle.
Là, sprofondato in una poltrona di raso, un giovanotto
dall’aria arguta era ben concentrato nella lettura di un
volume dall’aria tanto antica quanto trasandata. Accanto a
lui, su un tavolino, un tasso impagliato dava mostra dei suoi denti
bianchi e appuntiti.
«Quell’affare mi inquieta»,
esordì Levi, alzando un braccio per indicarlo.
Lo studioso non interruppe la sua lettura, dando una lieve alzata di
spalle come a voler sottintendere di aver recepito il
messaggio.
«Regalo di mio zio ai monaci di Bergeggi»,
spiegò, atono. «Visto che ci stanno ospitando da
quasi tre settimane.»
Levi storse il naso e si avvicinò, picchiettando con le dita
sugli occhi di vetro dell’animale.
«Tasso», mormorò, pensieroso.
«Tasso: simbolo di predominio. Deprimente.»
«Simbolo di forza usata con saggezza», lo corresse
subito lo studioso.
«Resta deprimente.»
Vi fu un istante di immobile silenzio, dopodiché Levi
sospirò, prendendo posto in una delle poltrone disposte
lungo gli alti scaffali. Portò una mano al mento,
riflessivo, ma non staccò gli occhi dal tasso.
«Raffaele Riario Sansoni», chiamò, poi,
calcando con teatrale pomposità ogni sillaba di quel nome.
Il ragazzo immerso nella lettura decise finalmente di staccare gli
occhi castani dal suo libro.
«Sì?»
«Tuo zio regala spesso animali impagliati ai suoi
monaci?»
Raffaele ridacchiò.
«No», ammise. «Ma ultimamente prova
diletto nel commissionare questo genere di lavori al suo
imbalsamatore.»
«Sua Santità il Papa ha un
imbalsamatore?» Levi strabuzzò gli occhi,
sobbalzando. «E chi potrà mai essere?»
«Tale Vallesanta.»
«Giovanni? Mio padre gli commissionò
l’imbalsamazione del nostro cane da caccia.»
Raffaele scosse il capo.
«Orso, da che so è il figlio.»
Stavolta, Levi balzò giù dalla poltrona,
reggendosi ai braccioli quasi fossero le sue due sole ancore di
salvezza in un mare in bufera.
«Vallesanta non bastava», borbottò,
aggiustandosi il cappello sul capo con uno sbuffo disordinato.
«Per giunta Lysimachus. Lo dicevo io, che sta arrivando una
tempesta.»
Si tirò in qualche modo in piedi, impettendosi un poco nella
casacca, dopodiché partì a passo spedito verso la
porta spalancata.
«Raffaele!», esclamò, voltandosi poco
prima di varcare l’uscio.
Lui lo guardò di sottecchi.
«Levi?»
«Sto andando in Toscana a incontrare un amico.
Sarò di ritorno prima di domenica.»
Raffaele mollò il libro che stringeva tra le mani.
«Non ti fermi qui, stanotte?», domandò,
offeso. «L’hai detto tu stesso che sta arrivando
una tempesta!»
Levi sgranò gli occhi più di quanto
già non avesse fatto.
«Mi pare ovvio che abbia da fare!», rispose,
agitando freneticamente le braccia quasi stesse per esplodere.
«Parleremo quando sarò di ritorno.»
Si buttò sul corridoio e prese a camminare frettolosamente
verso il porticato dal quale era venuto, senza attendere alcun saluto
od ossequio. Alle sue spalle, udì soltanto le esclamazioni
di Raffaele.
«Levi!», gridava il giovane, ormai distante dalla
concentrazione che qualche minuto prima lo vedeva concentrato su vecchi
tomi colmi di polvere. «Levi, torna qui!»
Ma il Conte di Fonterossa era già arrivato alla corte e, una
volta recuperati gli stivali, non ci mise poi molto a raggiungere il
molo che si apriva sul panorama delle coste liguri.
Lasciò l’isola di Bergeggi così, senza
vezzeggiare la sua partenza né ossequiare i monaci tanto
gentili nell’ospitarlo all’interno delle loro mura.
Vittore, il suo paggio più anziano, gli si
affiancò una volta che la modesta imbarcazione con cui erano
arrivati fu sufficientemente lontana dal molo per non potervi fare
ritorno a causa del vento.
«È da quando Vostra Grazia il vescovo Riario
Sansoni vi ha cacciato dalle sue stanze, che non vi vedo
così affannato», esordì, accompagnando
quella sua affermazione con un sorriso tanto tirato quanto nervoso.
Levi gli lanciò un’occhiata asciutta.
«Bando alle tue insinuazioni, Vittore!», rispose,
appoggiandosi con la schiena all’albero della nave.
«Salpiamo per un’importante destinazione!»
Il paggio sospirò.
«Quale, mio Signore?»
«Pisa.»
«A pregare nel duomo, mio Signore?»
Ridacchiando, Levi diede una lieve pacca sulla spalla
dell’uomo.
«Molto meglio, Vittore», rispose, seppur serio.
«Andiamo a porgere gli ossequi di nozze!»
«A chi, se mi è concesso?»
«Alle due persone più buone che io abbia il
piacere di conoscere.»

|
Ritorna all'indice
Capitolo 9
*** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: riccioli neri ***
|
polverenera
Per
ricominciare
Stavolta sono stata lunga, prolissa e assolutamente
inscusabile per il mio essere logorroica.
Che
posso dire? Si parte per Firenze °v°/ E francamente ne
sono pure felice, visto che è lì che inizieranno
tutti i casini *ammicca
La
pace è bella finché dura poco, no? Mi suonava
diverso, ma fa nulla.
Fuggo.
Un bacio,
Lechatvert
Saremi
morte già dolce paruta
Un giorno, tesoro, saremo
vecchi
Oh, tesoro, saremo vecchi
E penseremo alle storie che avremmo potuto dire.
Asaf Avidan – One day/Reckoning song
Roma,
fine agosto 1477. Due anni dopo la prima udienza dei Vallesanta con
Papa Sisto IV.
Arrivarono alla torbiera poco prima dell’alba, carichi delle
borse e dei mantelli fradici dopo l’acquazzone che li aveva
volti di sorpresa sulla via per Orvieto.
Porpora era silenziosa, chiusa in uno strano mutismo che non sapeva del
solito broncio ma di qualcosa ben più profondo. Era appena
tornata da Genova, l’unica meta capace di toglierle anche
quel poco buonumore che di solito possedeva e, da quando si era
ricongiunta con Orso dopo una settimana di lontananza, non aveva detto
una parola. Se n’era semplicemente rimasta in disparte, con
lo sguardo perso nel vuoto e le mani chiuse a coppa su una ciocca di
riccioli neri riposta in un fazzoletto di seta.
«Passerà», le disse Orso, quando la vide
sedersi sulla riva della torbiera. «Non vi è
niente di più innocuo del mal d’amore,
Sorella.»
Porpora rispose con un’alzata di spalle.
«Non sono affatto innamorata», replicò,
secca.
Orso ridacchiò.
Cos’altro poteva mai essere, a impensierirla così
tanto? Da quando si erano recato a Genova per la prima volta e avevano
tirato su qualche soldo imbalsamando un fagiano per il signore di un
borgo fuori città, Porpora non perdeva occasione per farvi
ritorno. Sola, senza accettare la grazia della compagnia di alcuno.
Tornava sempre scortata da una guardia del borgo, però.
«Mi sta bene, se hai l’innamorato»,
insistette quindi Orso, pacato. «Non ci vedo niente di male e
poi –»
«Tu ho detto che non c’è nessun
innamorato, stupido!»
Stizzita, Porpora si tirò in piedi, prendendo a frugare
nella borsa, alla ricerca di qualcosa.
Nel buio, Orso la immaginò rossa in viso, ma si astenne dal
commentare.
«Cosa stiamo cercando?», chiese, invece, mentre
Porpora trafficava con i cerini per accendere una lanterna.
«I santi», gli rispose lei. «Tre anni fa,
un gruppo di mercanti pisani è stato visto lasciare Roma da
Porta Pia, nella direzione di Orvieto», spiegò,
poi. «Non sono mai arrivati a destinazione, probabilmente
vittime dei briganti. Se ho ragione, i corpi non possono essere che sul
fondo di questa torbiera.»
Orso storse il naso.
«Come lo sai?», chiese.
Porpora alzò le spalle.
«Porca miseria, Sorella, non sarai stata tu
a–»
«Zitto. Arriva qualcuno.»
Rapida, la ragazza soffiò sulla fiamma nella lanterna e,
rimasta al buio, afferrò il fratello per la camicia,
acquattandosi dietro a un cespuglio.
Orso sentì il suo respiro lieve annullarsi, il suo fiato
divenire così impercettibile da non muovere neanche le
foglie tra le quali si erano nascosti.
Nel silenzio, stava per obiettare l’allerta di sua sorella e
tornare al suo lavoro, quando una fila di piccoli lumi prese a brillare
in cima alla collinetta che sovrastava la torbiera.
Dondolando, i fuochi discesero tutto il dorsale per lo stesso, ripido
sentiero che i due fratelli avevano percorso una manciata di minuti
prima, superandoli di qualche passo prima di fermarsi a ridosso
dell’acquitrino.
Orso si tappò bocca e narici con una mano, senza osare
emettere un suono quando degli uomini gli passarono accanto,
così vicini da muovergli l’unica ciocca di capelli
che sfuggiva al berretto che portava calcato sul capo.
«Lasciatelo qui», ordinò atono
l’uomo in testa al gruppo, scrutando la torbiera alla luce
della lanterna che conduceva.
Orso lo riconobbe immediatamente. Dopotutto, non ci voleva poi un genio
per leggere nel’oscurità lo spigoloso profilo del
Conte Riario.
I suoi compagni gettarono a terra il sacco che avevano tra le mani,
facendolo rotolare verso l’acqua e lui emise un mugugno in
segno di approvazione. Aveva un piccolo sorriso di scherno a
illuminargli il volto pallido e i suoi occhi scuri sembravano brillare
nella notte.
«Che le acque di Roma siano la sua casa», aggiunse,
poi.
Dopodiché, rimase in silenzio a guardare il sacco affondare
nella torbiera, illuminandolo appena con la lanterna.
Porpora si sporse un poco in avanti, accostandosi alla spalla di Orso
per osservare al meglio la scena. Si mosse un poco verso il bosco,
nascondendosi ulteriormente tra i cespugli in un fruscio appena
percettibile.
Gli uomini avevano cominciato a fare marcia indietro, allontanandosi in
religioso silenzio sul sentiero.
«Capitano Grunwald, aspettate.»
In un istante, Porpora ebbe addosso lo sguardo pungente del Conte, che
alzava e abbassava la lanterna nel tentativo di illuminare il cespuglio
dietro al quale si era nascosta.
Orso si strinse nel mantello, imponendosi di trattenere il fiato,
premendosi il palmo della mano sulle labbra secche. Pregò il
Creatore che l’oscurità fosse troppo fitta per
scovare una figura vestita di nero tra i rami del bosco.
Lentamente, la lanterna si allontanò.
«Avete visto qualcosa, Conte Riario?»
Un attimo di silenzio.
«No, è stata soltanto
un’impressione.»
Non vi furono santi che, in quell’istante, Orso
pregò abbastanza.
Con l’orecchio teso sugli uomini che si allontanavano,
guardò Porpora pettinarsi i capelli castani dietro le
orecchie e sgusciare di nuovo verso di lui, abbracciandolo forte con il
respiro ansimante.
«Mettiamoci al lavoro», gli disse lei, scrutando la
collina per assicurarsi che i lumi fossero scomparsi del tutto.
«Dobbiamo essere a Roma entro l’alba.»
«Vado io.»
Cavandosi giacca e camicia, Orso la superò a passo svelto.
Si fermò un istante sulla riva a osservare il vuoto dinanzi
a sé, pensieroso.
Forse, compiere quel genere di lavoro alla luce del giorno sarebbe
stato più facile.
Si legò una fune in vita, lanciando l’altra
estremità a Porpora.
«Non lasciarla andare», si raccomandò,
prima di tuffarsi.
L’acqua era gelata. Gelata e melmosa.
Il contatto delle alghe marce sulla pelle gli fece salire i brividi
lungo tutta la schiena, ma non lo scoraggiò nel raggiungere
il fangoso fondo dello stagno.
Cieco a causa della profondità e della notte,
tastò il terriccio sotto di sé con i piedi
scalzi, fino a che non incappò in qualcosa di più
solido e massiccio di un ciuffo d’erba bagnata. Si
slegò la corda dalla vita e la assicurò attorno
alla sua scoperta, slanciandosi infine verso la superficie.
Buttò la testa fuori dall’acqua, ormai senza fiato.
«Ho trovato qualcosa!», annunciò,
prendendo a nuotare verso riva.
Accoccolata contro il tronco di un albero, Porpora lo accolse con un
cenno del capo.
Se ne stava lì, rannicchiata sotto il suo mantello, con la
corda legata alla caviglia e le mani occupate a stringere il suo
prezioso fazzoletto di seta.
«Ci hai messo poco», mormorò, alzandosi
e sfilandosi la corda dal piede.
Orso alzò le spalle, soddisfatto.
«Sono stato fortunato.»
Estrassero il corpo dalle acque e lo portarono in silenzio sotto i lumi
accesi delle loro lanterne.
Orso era stato davvero fortunato.
Non aveva mai visto un cadavere così ben lavorato dai fanghi
e dalle correnti. Seppur in parte celata
dall’oscurità, quella mummia era perfetta. A
partire dalla pelle perfettamente conservata, mai strappata da un osso
fuori posto, per finire sulle due file di denti tutti dritti e
giallastri.
«Doveva essere un nobile», sussurrò
Porpora, sfilando il coltello che portava legato alla cinta per
tagliare la corda che stringeva la vita del cadavere. Ne
tagliò anche un’altra, più fina e
sfibrata, che invece gli stringeva il collo.
Orso aggrottò la fronte.
«Impiccato?», chiese, perplesso. «E
finito qui?»
«Non è il cappio di
un’esecuzione», spiegò Porpora.
«È quello del masso che l’ha fatto
annegare sul fondo.» Passò la lama del coltello
sulle vesti bagnate del morto e scese fino alle braccia, osservandole a
lungo prima di recuperare il seghetto dalla borsa con un grosso sospiro
di rammarico. «Andiamo; Mercuri ha chiesto le dita di San
Gervaso.»
Orso annuì.
«Del resto che ne facciamo?», chiese, rubando il
seghetto di mano alla sorella.
Lei tirò su col naso.
«Ributtalo dove l’hai trovato.»

«Guarda,
Sorella!»
Orso sorrise, facendo una rapida giravolta sul corridoio. La storia era
sempre la stessa, ogni volta che si ritrovava a percorrere quei
sontuosi appartamenti. Restava incantato dai meravigliosi dettagli che
trovava sui dipinti appesi alle pareti e si dimenticava persino di
camminare, tanto era preso.
«Ho trovato Sant’Antonio. »
Qualche metro davanti a lui, Porpora gli scoccò
un’occhiata severa, voltandosi appena per tenere il passo del
Capitano Grunwald, povero uomo mandato alle porte con
l’ingrato, solito compito di accompagnarli al cospetto di
Mercuri.
«Non ti perdere, Fratello», si
raccomandò. «Non avremo il tempo per metterci a
cercarti in giro per Castel Sant’Angelo!»
Sospirando, allora, il ragazzo si affrettò a raggiungerla,
dondolando goffamente la spada che teneva legata al fianco destro.
«Non fare la scorbutica», la rimproverò.
Lei fece una smorfia, scrollando le spalle.
«E tu non fare il bambino.»
Camminarono in silenzio per qualche minuto, accompagnati soltanto dagli
occhi dei dipinti, che Orso non perdeva mai di apprezzare. Con il polso
appoggiato all’elsa della sua spada, sfilava affascinato
lungo quell’esibizione di Santi. Era una ricchezza che sua
sorella non poteva comprendere, quella.
Sospirando, si voltò verso di lei, studiandone
l’espressione.
Mostrava il volto stanco di chi non ha dormito, ma era ben dritta sulle
gambe, con il mento alto e lo sguardo superbo che la accompagnava
ovunque andasse. Portava i capelli legati sulla nuca con un pezzo di
corda, la camicia candida e pulita che veniva indossata soltanto nelle
occasioni formali e un’insolita lama al fianco, che faceva
capolino soltanto quando si trovavano in Vaticano.
Di fronte a tanta cura, Orso non poté che sentirsi
inferiore. Aveva avuto il tempo per fare un salto nel Tevere e
liberarsi dall’odore di morto della torbiera, ma non quello
di comprarsi una camicia decente. In confronto a Porpora, era di ben
misera figura.
Camminarono fianco a fianco ancora per qualche minuto, sempre in
religioso silenzio alle spalle del Capitano Grunwald, fino a che
entrambi non furono in grado di riconoscere la maestosa porta della
sala delle udienze.
Porta insolitamente affollata, visto che ad aspettarli non vi erano
soltanto i maggiordomi del Santo Padre ma addirittura il Conte Riario
in persona, tutto impettito nel suo panciotto color della notte.
Parlava a bassa voce con un uomo poco più alto di lui ma dal
viso più bambino che invece vestiva di verde, decorata da
un’araldica recante due delfini su sfondo blu.
«È Francesco Pazzi», mormorò
Porpora, senza voltarsi. «Da Firenze.»
Orso alzò le spalle.
«Non sapevo che Riario s’intrattenesse con i
rampolli fiorentini», commentò, dando una gomitata
alla sorella dopo essersi assicurato di essere abbastanza lontano
dall’uomo per poter evitare di essere sentito.
«Brutto colpo, Porpora.»
Lei rispose alla cortesia pizzicandogli il fianco.
«Sei peggio di una comare», borbottò,
mentre si avvicinavano. «Un po’ di grazia,
Orso.»
«Strano, sentir parlare di grazia da ha voluto staccare la
mano a un morto.»
«Strano, sentir parlare di morti da quello che l’ha
staccata, la mano ».
Si scambiarono un’occhiata divertita, poi si voltarono verso
la figura di Riario, sfoggiando il loro sorriso migliore.
«Buongiorno, Conte Riario!», intonarono, chinando
appena il capo.
Curioso, Orso si sporse un poco oltre la sorella, osservando il profilo
di Francesco Pazzi.
Era giovane, aveva forse un anno o due in più di lui,
sicuramente più delicato e fine nei movimenti. Aveva un
strano sorriso a illuminargli il viso, cosa che convinse Orso a non
osare nemmeno rivolgergli la parola.
Restò fermo un istante a fissarlo, non del tutto conscio del
passare dei secondi, e fu in grado di risvegliarsi da quel suo stato
soltanto quando avvertì sulla schiena l’occhiata
furiosa di Porpora.
Allora si affrettò a togliersi il cappello, mostrando, suo
malgrado, l’orecchio tagliato coperto dalle piume, e a
tossire un poco per ricomporsi.
«Buongiorno a entrambi», farfugliò,
inchinandosi appena. «I miei omaggi a voi, Francesco Pazzi.
Sono Orso di Vallesanta, l’imbalsamatore.»
Fece una breve pausa, facendo scivolare lo sguardo su Riario che lo
osservava, impassibile, senza tradire nessuna emozione.
«E questa è mia sorella, Porpora.»
Porpora si fece avanti, superando Grunwald ad ampi passi, senza mancare
di lanciargli un’occhiata velenosa.
«Sono onorata», disse, sfoggiando il più
luminoso tra i suoi sorrisi.
Riario li squadrò, silenzioso. Aveva le mani dietro la
schiena e il suo volto era estremamente serio, quasi vi fosse qualcosa
di serio di cui parlare. Non era il suo modo di accoglierli, insomma,
che solitamente sfociava in qualche critica circa il loro lavoro
peccaminoso.
Francesco Pazzi non parlò, limitandosi a guardarli con quel
suo sguardo inquietante.
Ben presto, la stanza si appesantì di un irritante silenzio.
Orso deglutì, poggiando la mano sulla spalla della sorella.
«Dovremmo andare», la esortò,
sospingendola delicatamente verso la sala delle udienze.
«Il Prefetto Mercuri ci sta aspettando. Non vogliamo tediare
i signori.»
Osservò Porpora annuire, seppur poco convinta, e salutare
Pazzi con una piccola riverenza.
Quel castello era davvero abitato da personaggi inquietanti
«Vi auguro una buona giornata, cari signori»,
finì Orso, inchinandosi a sua volta. «A presto, mi
auguro.»
Evitò di rimettersi il cappello in testa, anche se avrebbe
tanto voluto nascondere il suo orecchio tagliato.
Con un sorriso, rivolse un’ultima occhiata a Pazzi e gli
voltò le spalle, seguendo Porpora all’interno
della sala delle udienze.
Papa Sisto sedeva, come al solito, sul suo trono al centro della sala.
Non era una novità, eppure Orso si sentì addosso
un peso più forte del solito, quando le porte della sala si
richiusero. Aveva sua sorella di fianco, il Santo Padre e Mercuri
dinanzi, il Conte Riario alle spalle. Non vi era nulla di diverso.
Pazzi si era ritirato.
Nervoso, respirò a fondo.
Attese che Mercuri lo invitasse a farsi avanti, lasciando
nell’ombra Porpora, che si andò a posizionare
accanto al Conte.
«Vostra Santità, Prefetto Mercuri, i miei
saluti», incominciò, senza mascherare una certa
incertezza. Era passato troppo tempo dall’ultima volta che
aveva parlato di fronte a un pubblico.
«Vallesanta, vieni avanti», lo incitò
Mercuri.
Aveva assunto un tono insolitamente curioso, più curioso del
solito, insomma.
«Cosa ci porti, quest’oggi?»
Orso mostrò un mezzo sorriso.
«Vengo da Ostia, miei Signori»,
incominciò, drizzandosi bene sulle gambe. «Vi ho
portato ciò che mi avevate richiesto.»
Si voltò verso Porpora, invitandola a raggiungerla con un
gesto della mano.
«Le dita di San Gervaso, direttamente dai venditori di Porta
Marina.»
Lupo Mercuri si accigliò.
«I venditori di Porta Marina sono notoriamente dei
ciarlatani», commentò, scettico.
«Non questi», spiegò Orso.
Attese che Porpora aprisse la scatola in cui riponevano abitualmente le
loro bizzarrie e si scostò appena, giusto per permettere ai
presenti di sbirciare.
Riposte tra le stoffe del contenitore, vi erano tre dita perfettamente
mummificate. Sul ciò che restava dell’indice, una
cicatrice a forma di croce rovescia rompeva la perfetta
lucidità della cera passata sulla pelle.
Orso ci aveva messo ore intere, a incidere il dito senza sbriciolarlo
sotto la forza del coltello. Aveva dovuto ricominciare il lavoro su
quattro dita diverse, ma il risultato era a dir poco soddisfacente.
Talmente perfetto da sembrare vero.
Ma quelle erano storie che non andavano raccontate, in Vaticano.
Curioso, Orso seguì lentamente lo sguardo dei presenti sulle
dita nella scatola, lanciando di tanto in tanto qualche occhiata alla
sorella, restando però in rigoroso silenzio.
Fu solo quando il suo sguardo incrociò quello di Mercuri,
che si decise ad aprire la compravendita.
«Sono vostre per trenta scudi», azzardò,
muovendo appena il capo.
L’uomo lo guardò a lungo.
«Sono dita di un morto, non possono valere tanto»,
ribatté, pacato. «Quindici scudi saranno
sufficienti.»
Orso guardò Porpora, che non batté ciglio.
«Venti. Sono le ossa di un santo, Prefetto», disse,
cauto.
Vi fu un istante di silenzio, poi Mercuri annuì, piano.
«E sia.»
Dopodiché abbandonò la sua postazione,
avvicinandosi ai due fratelli con passo spedito e sguardo indagatore.
Orso deglutì, muovendo un passo indietro verso Porpora che
lo osservava, stranamente serena. E dire che non si era mai sentita al
sicuro, lei, in quella sala.
Papa Sisto IV si alzò un poco sul suo trono, portandosi una
mano al mento, e parlò.
«Siete abili, fratelli di Vallesanta», disse senza
nascondere un sorriso soddisfatto. «I vostri tesori ci
tolgono sempre dai pomeriggi di tedio.»
Orso non rispose, sbigottito. Assai raramente, in due anni, aveva udito
la voce del pontefice, e la cosa lo turbò non poco. Si
voltò di scatto verso Porpora, che lo osservava stranita,
quasi quanto Riario che fissava il pavimento con occhi sgranati. Quando
si rivoltò verso il papa, la sua mano era tesa per invitarlo
a baciare l’anello.
«Servirvi è nostro piacere», disse,
quindi, affrettandosi a chinare le labbra sulla mano del pontefice.
«Avrete presto modo di farlo nuovamente, allora»,
continuò Sisto. «Firenze richiede immediatamente
la vostra presenza.»
Orso dondolò il capo.
«I Medici?», chiese.
«Seguite il Prefetto e vi verrà spiegata ogni
cosa.» Papa Sisto si sporse sul trono, piegando leggermente
il capo in avanti. «Mio nipote partirà per Imola
domattina», disse. «Lo seguirete fino a Firenze.
Sarà sua premura controllare il vostro operato in
città.»
«Per quanto concerne le reliquie che ci avete portato,
verrete pagati con trenta scudi», riprese Mercuri, invitando
con un cenno del capo i maggiordomi ad avvicinarsi per prendere in
consegna la cassa. «Che vi siano sufficienti per presentarvi
domani con un cavallo e quanto vi occorre per il viaggio.»

|
Ritorna all'indice
Capitolo 10
*** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: la mappa ***
|
polverenera
Per
ricominciare
Welcome da Vinci!
Che
non ci sarà spesso, ma un'apparizione gli era dovuta visto
che il telefilm è praticamente sotto il monopolio della sua
meravigliosa figura. (L)
Dal
prossimo capitolo vi spoilero tanta nudità. Je.
Tra
l'altro: la nominata Beatrice, è proprietà di
Chemical Lady e della sua conclusa No good deed. Ma tanto lo sapete
già *rotola
Bacini,
Lechatvert
Saremi
morte già dolce paruta
Un altro giorno,
Hanno aperto la scatola per giocare.
Guardandomi girare ancora e ancora fino a che la musica non rallenta e
sfuma.
Yael Naim – Puppet
Toscana,
agosto 1477. Sette anni prima della morte di Papa Sisto IV.
Fu il viaggio più silenzioso che Orso avesse mai compiuto.
Seduto sulla groppa di un vecchio cavallo acquistato quella mattina,
assonnato e affamato, con una misera focaccia nella borsa che doveva
bastargli per tutto il giorno e in testa ancora le due pinte di birra
che aveva buttato giù assieme a sua sorella per festeggiare
la riuscita della loro compravendita.
Per non rischiare di incappare nelle ire del Conte Riario, si era
mantenuto a debita distanza, nascondendosi dietro l’ampia
schiena di Grunwald e quella un po’ meno possente di Porpora.
Di tanto in tanto lo spiava, lanciandogli qualche occhiata di sfuggita,
ma gli mancava davvero il fegato di avvicinarsi per chiedere
informazioni circa la missione a Firenze.
Era rimasto piegato sul dorso del suo cavallo dall’alba fino
a pranzo, dopodiché era sceso per recarsi al torrente
assieme ai soldati, aveva riempito la borraccia e aveva fatto ritorno
alla sua postazione di eterno pentito. Per cosa covasse tanto
rammarico, poi, lo sapeva solo il Signore.
«Si può sapere che hai?», lo
chiamò a un certo punto Porpora, drizzandosi sulla schiena
per vedere oltre le spalle del Capitano Grunwald.
«È tutto il giorno che hai una faccia di uno che
è appena scappato da un funerale.»
Orso sospirò, afflitto.
«Non riesco a non pensare che ce l’abbia con
me», confessò, fissando le redini chiuse nei suoi
pugni. «Anche se, in tutta sincerità,
non ho proprio niente di cui dover sentirmi in colpa.»
Eppure, lo sguardo pungente di Riario gli era rimasto addosso per tutta
la giornata.
«Il Conte avrà talmente tante cose a cui pensare
che la tua faccia gli sarà già uscita dalla
testa», lo riprese Porpora, ridacchiando. «Sei
paranoico.»
«Ne sei sicura?»
La ragazza sbuffò.
«Sicurissima!», esclamò, spronando il
suo cavallo ad accelerare. Trottò un poco verso un ragazzo
della guardia che se ne stava da parte e si mise ad attaccare bottone
con lui, dimenticandosi completamente del fratello.
«Solo gli stupidi pensano che Girolamo Riario dimentichi i
volti di chi gli sta intorno», commentò il
Capitano Grunwald, lanciandogli un’occhiata fugace
dall’alto del suo cavallo bianco.
Affranto, Orso si sciolse in un gemito sommesso.
«Lo sospettavo», rispose, alzando le spalle.
«Questo per dare a mia sorella della stupida?»
L’uomo alzò le spalle.
«Più o meno.»
Rimasero per un istante in silenzio, avanzando lungo la strada
affollata di soldati, dopodiché Orso decise di ributtarsi
nella conversazione, senza mettere in mostra la sua agitazione.
«Quando arriveremo a Firenze?», chiese, alzandosi
un poco per accertarsi che stessero percorrendo la strada maestra. E
che il Conte Riario non stesse guardando nella sua direzione.
Grunwald rispose con un grugnito.
«Questa sera, se non acceleriamo il passo», disse,
seccato. «Siete fortunati, Vallesanta. A noi tocca
un’altra mezza giornata di cavalcata, per arrivare fino a
Imola.»
«Ci lascerete a Firenze?»
«Sta a me e al Conte controllarvi. Immagino staremo nei
paraggi per qualche mese, nel caso le cose andassero storte.»
Dal tono che la voce di Grunwald prese, Orso capì che non
era decisamente il caso di far andare storte le cose.
Trovare il cadavere, prendere le ossa, sparire da Firenze per non fare
mai più ritorno. Era un piano che suonava stranamente
semplice e conciso, nella sua testa. Prima di partire, si era premurato
di chiedere al proprietario della taverna qualche nominativo che
potrebbe esser stato loro utile nella Repubblica. Il tutto gli era
costato due scudi, ma almeno aveva le sue risposte.
Sorrise tra sé e sé, battendosi una mano sul
petto.
«Non avete di che preoccuparvi, allora», disse,
rivolgendo a Grunwald un sorriso soddisfatto. «Dei Vallesanta
non si deve mai dubitare!»
L’uomo gli scoccò un’occhiata seccata e
la conversazione finì lì, così come il
momentaneo buonumore che aveva rallegrato Orso per quei cinque minuti.
Il resto del viaggio, poi, continuò con il morale sotto i
tacchi.
Si fermarono che era ormai notte inoltrata.
Porpora si era raggomitolata sul petto di Orso e dormiva con la stessa
serenità di un bambino, mentre lui cercava di tenere buoni
entrambi i cavalli e di non essere disarcionato nel tentativo. Erano
bestie anziane, stanche e stremate, che come lui volevano soltanto
stravaccarsi su un pezzo di prato e chiudere gli occhi.
Discreto, svegliò Porpora, battendole qualche colpetto sulla
spalla.
Immediatamente, lei riemerse dalle pieghe del suo mantello.
«Firenze?», chiese, con la voce impastata dal sonno.
Orso scosse il capo.
«No», rispose. «Ma ci siamo
fermati.»
Lasciò che sua sorella scendesse da cavallo e che andasse a
recuperare le sue briglie, poi abbandonò la sella a sua
volta, raggiungendola a terra.
Si avvicinarono piano a Riario, sfilando silenziosi tra una guardia
armata e l’altra. Erano tutti stravolti, tanto che nessuno li
fermò per chiedere dove avessero intenzione di andare.
Tutto il campo, comandanti compresi, aveva l’unico, grande
desiderio di buttarsi per terra e dormire.
Il Capitano Grunwald arrivò loro incontro che già
avevano praticamente raggiunto Riario.
«Eccovi qui», disse, mostrando loro la via verso il
luogo in cui il Conte si stava concedendo un po’ di riposo
lontano dall’esercito. «Da questa parte; fate in
fretta.»
Quando Orso intercettò la presenza del Conte, rimase
volutamente indietro.
Si nascose dietro Grunwald, tanto vicino alla sua schiena da potergli
scostare il mantello con il fiato, e non si scostò da lui
neppure quando udì la voce di Riario salutarli con tono
stanco.
Porpora poteva prendersi cura della situazione. Era intelligente,
sapeva parlare, era coraggiosa. A differenza di lui, che invece
preferiva restarsene nascosto dietro una guardia svizzera, come se
Grunwald fosse suo alleato. Sapeva benissimo che, al minimo cenno,
l’uomo gli avrebbe staccato la testa per poi consegnarla a
Riario su un palo.
«Conoscete il greco?», sentì chiedere
dal Conte, mentre dentro di sé si dava del codardo.
La risposta di Porpora non tardò ad arrivare.
«Certo! Chi diavolo non conosce il greco?»,
ironizzò, alzando le spalle.
Orso si scostò da Grunwald per un istante.
«Io so scriverlo», mugolò.
Poi tornò al suo posto.
Il Conte sospirò a lungo.
«Ogni volta che desidererò parlarvi, i miei uomini
tracceranno la lettera omega in un luogo che sarò certo voi
frequentiate. L’incontro sarà fissato per la notte
successiva a quella della comparsa della lettera, in questo esatto
luogo, appena dopo il coprifuoco.»
Porpora incrociò le braccia sul petto.
«D’accordo», rispose. «Come
faccio a farvi sapere che ho recepito il messaggio?»
«Non sarà necessario, ci vedremo direttamente la
notte dopo.»
Deglutendo, Orso mise le mani in tasca. Aveva ancora le sue fate
crudeli.
Chiamando a raccolta quel poco di coraggio che gli era rimasto, si
scostò da Grunwald, tendendo il palmo aperto verso Riario.
«Prendete queste», disse, mostrandogli le sue
creazioni. «Ne troverete di simili in questo luogo, quando
avremo trovato il corpo. Varrà la stessa regola per la
lettera omega.»
Per tutto il tempo che pronunciare quelle parole gli prese, Orso si
preoccupò di fissare la punta dei suoi stivali.
Aspettò quindi che Riario prendesse in consegna le sue fate,
prima di richiudere il pugno e tornare al suo posto accanto al suo
destriero.
Augurò la buonanotte ai presenti con un inchino,
dopodiché montò in sella e attese la sorella.
Si allontanarono in fretta, prendendo la strada per Firenze ma
fermandosi poco prima delle mura cittadine, nascosti nel bosco che
andava via via diradandosi.
Non li avrebbero comunque fatti entrare in città nel cuore
della notte. Aspettare fino al mattino e sperare di confondersi tra i
mercanti era la scelta più saggia.
Si accoccolarono vicini sotto al mantello di Porpora, coperti anche da
qualche strato di foglie secche e muschio per tenersi al caldo.
Orso circondò in un abbraccio la sorella, stringendola forte
a sé.
«Davvero eri già stato a Firenze? », gli
chiese lei, sottovoce.
Lui annuì, piano.
«Con papà, sì.»
«Non mi ha mai portata con sé.»
Orso rimase in silenzio.
Di nuovo, il lieve tono di Porpora lo riportò nella
conversazione.
«Credi che la rivedrai?»
Orso trasalì.
«Parli di Beatrice?»
Pronunciare quel nome gli fece quasi male.
«Sì, parlo di Beatrice.»
Non rispose subito, non ce la fece. Rimase imbambolato a pensare che
forse sì, forse avrebbe ritrovato il suo perduto amore di
gioventù, che forse sarebbe persino riuscito a parlarle. O
che forse era stata data in moglie a qualche nobile pisano e che erano
ormai anni che ella non risiedeva più a Firenze.
Pensò davvero tanto a una risposta da dare a Porpora ma,
quando trovò qualcosa di intelligente da dire e
aprì la bocca per commentare, avvertì il lieve
respiro di sua sorella spegnersi sotto un suo gemito.
Si era già addormentata.

L’odore pungente dei
mercati fiorentini costrinse Orso a fermarsi nel bel mezzo della strada
per soffiarsi il naso in preda all’allergia.
Pensieroso, colse l’occasione per osservare la folla muoversi
con ritmo attorno a lui, quasi Firenze avesse una sua canzone da
seguire, quasi la gente non fosse mossa dalla fretta ma da un
improbabile spartito.
Sì, era tutto decisamente diverso dal disordine di Roma.
Soddisfatto delle sue scelte, lanciò alla sorella uno
sguardo contento, che venne però ricambiato con una smorfia
di puro astio.
Porpora detestava stare in mezzo alla gente, specie se la suddetta
gente era a lei sconosciuta. La metteva a disagio, in un certo senso,
sebbene non le impedisse di elevarsi al di sopra di qualunque popolano
incontrasse. Era sempre stato così, anche quando era
bambina, quando andavano al mercato mano nella mano assieme alla mamma.
Mostrava però una certa curiosità, mascherata
sotto il cattivo umore di essere lontana da Roma, e pareva interessata
a contare e ricontare i fiorini che avevano guadagnato, in quella prima
settimana, imbalsamando qualche animale. Probabilmente tale interesse
proveniva dallo scoprire se i profitti erano maggiori sotto i Medici,
ma pur sempre di curiosità si trattava, e Orso sapeva
accontentarsi.
Sospirando, accarezzò le due piume che portava legate al
capo.
«Sorella!», chiamò, raggiungendola con
un balzo davanti alla bancarella che la ragazza stava esaminando.
«Hai trovato qualcosa?»
Lei alzò le spalle.
«Tabacchiere, lame, inutili gingilli.
C’è ben poco di utile, in questa
città», considerò.
Orso scoppiò a ridere.
«Ti aspettavi forse un banco di santi?», la
schernì.
«Mi aspettavo qualcosa di utile, visto che sono sette giorni
che brancoliamo nel buio.»
«Sorella, smettila di parlare come una nobile. Finirai per
diventarlo, ti mariterai con un Duca o con un Conte e spenderai gli
ultimi anni della tua vita chiusa in un palazzo a ricamare
fazzoletti.»
Porpora gli scoccò un’occhiata scettica. Aveva
fama di essere particolarmente attaccata al denaro e ai suoi guadagni,
ma da qui a sognare la vita di una nobildonna ne correva, e Orso lo
sapeva. Inoltre, molto tempo prima, quando erano poco più
che bambini, si erano promessi di non abbandonarsi mai, qualunque cosa
fosse successa. Erano stati lontani sette anni, ma alla fine si erano
ritrovati.
Sospirando, Orso estrasse dalla sua borsa un foglio di
cartastraccia.
Porpora lo indicò con un cenno del capo.
«Che cos’è?», chiese.
Lui la guardò, alzando le spalle.
«Il nostro contratto.»
Avevano recuperato un teschio mangiato dalla sifilide due giorni prima,
in un cimitero appena fuori città. Non era in ottime
condizioni, ma Orso sapeva fare miracoli con la cera e così
aveva acquistato una forma decisamente più presentabile. La
notte prima, però, Riario lo aveva rifiutato, affermando che
il corpo di cui andavano alla ricerca non era quello che avevano tra le
mani.
E non era di certo cosa facile, trovare un morto di sifilide in una
città come Firenze! Ma sia lui che Porpora si stavano
impegnando a raccogliere quante più informazioni possibili,
alternando le ricerche a qualche occasionale vendita di reliquie in
città.
«A chi dobbiamo mollarlo?»,
s’informò Porpora, assicurandosi che la borsa che
portava a tracolla fosse ben ferma sulla sua spalla.
Orso si sforzò di leggere la minuscola calligrafia sul
foglio.
Mossa inutile, poi, visto che sapeva esattamente chi andare a cercare.
«Un vecchio amico.»
Porpora storse le labbra.
«Te lo sei immaginato o posso saperne il nome?»
«No, no. È reale.» Orso
corrugò la fronte, sospirando. «Sta’ a
vedere!»
Porpora roteò gli occhi, ma si astenne dal commentare.
Girarono ancora un po’ a vuoto per il mercato, Orso
osservando l’ambiente con curiosità, Porpora
alternando gli sbuffi alle lamentele.
Non fecero invero molta strada, bloccati un po’ dalla folla,
un po’ dalle bancarelle che prepotentemente li chiamavano a
guardare la loro mercanzia, ma provarono ad avanzare almeno fino alla
piazza principale.
Allorché, giunti nei pressi di un piccolo slargo, una voce
alta e dal timbro studiato attirò con prepotenza la loro
attenzione.
«Signore e signori! Quest’oggi, vi offro le
incredibili ossa del martire Bartolomeo, scuoiato vivo, e quelle della
bellissima Agnese, uccisa da un coltello alla gola!»
Impietriti, sia Porpora che Orso si voltarono verso quello che per loro
non era che un richiamo.
Appollaiato su una vecchia cassa di legno, un uomo sorrideva sornione
alla folla. Aveva il volto abbronzato, coperto da una barba forse un
po’ troppo incolta, e vestiva con fare senza dubbio troppo
eccentrico per trattarsi di un comune venditore.
Porpora lo osservò a lungo attraverso i suoi occhi scuri
fissi sulla figura dello sconosciuto. Il corpo si era mosso in una
posizione di difesa posta a proteggere la borsa, ma il viso restava
quello limpido e calmo di chi sa nascondere ogni emozione.
Orso si chiese se qualcuno fosse mai riuscito a scorgere, sul volto di
sua sorella, una qualche piccola traccia d’amore o di
compassione. E dire che le donne, a detta degli abitanti di Roma, erano
tutte volubili ed eloquenti.
«Che ci fa un tartaro a Firenze?», gli chiese
subito lei, dopo un istante di silenzio.
Lui rise.
«In un certo senso, ce l’ho spedito io!»
Si aggiustò la camicia sul petto e, con fare formale, si
avvicinò all’abile oratore armato di un sorriso a
trentadue denti che avrebbe illuminato persino la più buia
delle cantine.
«Zoroastro, mio vecchio amico!», salutò,
alzando la mano con fare amichevole. «Fammi indovinare,
quell’artista ti ha piantato due giorni dopo averti
assunto?»
L’uomo lo guardò, stranito. Poi, come
un’onda improvvisa, un largo e brillante sorriso gli
illuminò il volto con una fila di denti bianchissimi,
ammalianti.
«Orso!»
Il ragazzo non fece in tempo a prepararsi che l’uomo gli fu
letteralmente addosso, abbandonando il suo palchetto per dedicarsi
unicamente a un abbraccio fin troppo caloroso.
«Quanti anni!»
«Lo dici bene! Ma che t’ha fatto da Vinci? Sei
ingrassato!»
Si strinsero l’un l’altro fino a che a Orso non
mancò il fiato, allorché si costrinse a scostarsi
dall’amico con una pacca sulla spalla, tossicchiando prima di
piegarsi sulle ginocchia e riprendere a respirare. Indicò
sua sorella con un cenno del capo, facendole segno di avvicinarsi.
«Questa è mia sorella Porpora.»
Porpora incrociò le braccia sul petto, sbuffando con il suo
solito fare seccato.
Zoroastro, invece, allargò maggiormente il suo sorriso.
«Quella che andavi cercando per le vie di Roma?»,
chiese, sornione.
Orso annuì.
«L’unica che mi è
toccata!»
Risero ancora, Zoroastro talmente forte da far tremare il mercato
intero, Orso molto più contenuto. Porpora fu
l’unica a restarsene con le braccia incrociate a fissare in
cagnesco qualunque essere vivente del raggio di tre leghe.
«Veniamo alla ricerca di informazioni»,
sbottò alla fine, tirando suo fratello per il bavero della
camicia talmente forte da farlo sbilanciare in avanti.
Con un colpo di tosse, Orso si ricompose.
«Già, un affare assai strano», disse,
aggiustandosi il berretto sul capo. «Da Roma ci mandano per
un morto di sifilide.»
Zoroastro schioccò la lingua sul palato.
«A Roma non ce l’avete, la sifilide?»
Porpora sospirò rumorosamente.
Orso sorrise appena. Non voleva far alterare sua sorella, sempre che
tutto quel riconciliarsi non l’avesse già fatto.
«Ti racconterò ogni dettaglio più
tardi, Zoroastro», disse quindi, bonario. «Ma prima
è di vitale importanza che tu ci guidi attraverso Firenze.
Dimmi, c’è qualche persona che conosce esattamente
i cimiteri della città?»
L’uomo soffocò una risatina.
«A parte me, intendi? Conosco i campi santi meglio di casa
mia, ormai!»
Porpora roteò gli occhi.
«Siamo in due», commentò.
Orso sorrise, vittorioso.
«Siamo fortunati, allora», rispose. «Ce
ne servirà una descrizione esaustiva.»
«Lungi da me rifiutare», concesse Zoroastro.
«Ma andiamo in un luogo più calmo. Il mercato di
Firenze non è certo luogo per vendere i morti.»
Camminarono in silenzio per qualche minuto, in rigorosa fila indiana
per le vie affollate della città, quasi senza osare parlare.
Zoroastro li guidava con sveltezza attraverso i vicoli, Porpora lo
seguiva a piccoli balzi, attenta a non farsi travolgere data la sua
minuta statura, mentre Orso, grande e grosso com’era, faceva
un po’ più fatica, arrancando tra la folla e
facendosi strana a gomitate.
Arrivarono alla meta che ormai i due fratelli avevano il fiatone.
Si trattava di una bottega d’arte alquanto affollata da
scultori e pittori intenti a lavorare sui loro capolavori. Vi erano
modelli distesi sui piedistalli, ragazze danzanti attorno ad un
cavalletto, e tutto sembrava essere così fresco e spontaneo
che Orso non poté che aprire la bocca in
un’espressione di pura meraviglia.
«È … bellissimo!», disse a
sua sorella, sorridendo con curiosità.
A Roma non avevano niente del genere.
Porpora alzò le spalle.
«Non ci vedo niente di bello», rispose, seccata.
Mosse qualche passo in avanti, raggiungendo le alte spalle del tartaro,
e gli batté un pugno sulla schiena.
«Abbiamo del lavoro da fare», sentenziò,
acida come al solito. «Dunque?»
«Porpora, non essere cattiva», rise Orso,
prendendola per un braccio. «Andiamo, cerca di andare
incontro a Zoroastro.»
Lei ruggì di risposta, scrollandosi dalla presa.
Orso la guardò drizzarsi sulle spalle e si lasciò
sfuggire un sospiro divertito. Porpora era sempre così
negativa con il mondo che la circondava, eppure era in grado di tirarlo
su di morale, di dargli quella forza di andare avanti, di spronarlo
verso avventure in cui lui mai si sarebbe buttato a capofitto. Era un
po’ la sua energia, nonostante avesse un temperamento
decisamente cattivo.
Sorrise, scollando il capo.
«Dove siamo, Zoroastro?», chiese.
Non fu la voce del suo amico, a rispondergli, bensì quella
di un totale sconosciuto.
«Alla bottega del Verrocchio!», trillò
qualcuno.
I due fratelli si voltarono, sorpresi, osservando un ragazzo
dall’aria eccentrica scendere una delle scalinate che
conducevano al piano superiore.
Era un giovane uomo sulla ventina, con la barba e i capelli ben curati,
un fisico asciutto ma atletico.
«Mi chiamo Leonardo da Vinci», annunciò
subito, pomposo, battendo sul tempo qualunque tentativo di
presentazione. «E voi, a giudicare dai vostri abiti sporchi
di cenere, e dalle vostre facce sporche di sabbia, siete i colleghi di
Zoroastro.»
Orso sorrise, sorpreso da tanto spirito di osservazione.
Gli erano sempre piaciute, le persone intelligenti.
«Chiamarci colleghi è offensivo»,
ribatté invece Porpora, incrociando le braccia sul petto.
«Non siamo certo degli sciatti profanatori di tombe. Le
nostre imbalsamazioni sono famose fino a Napoli.»
Lanciò un’occhiata carica d’astio a da
Vinci, poi allungò la mano in segno di saluto.
«Porpora di Vallesanta. Questo è mio fratello,
Orso.»
Assecondandola, Orso alzò appena il cappello.
«Tanto lieto», commentò.
L’artista li guardò entrambi con un mezzo sorriso
dipinto sul viso, poi batté le mani, facendosi curioso nei
confronti della borsa che Porpora portava a tracolla.
«I Vallesanta», disse, quindi. «Ho
sentito parlare della vostra famiglia. Pensavo foste tutti
morti.»
«Lo pensavano un po’ tutti, a Roma»,
rispose prontamente Porpora.
Da Vinci annuì piano.
«Per quale motivo li hai portati qui, Zo?», chiese
poi.
Zoroastro aprì la bocca per parlare, ma Porpora fu
più veloce.
«Una mappa, il più dettagliata possibile, di ogni
morto e sepoltura in città dell’ultimo
mese», rispose, fulminea.
«Vi costerà una fortuna!», rise a gran
voce Zoroastro.
Da Vinci alzò un sopracciglio e fermò la risata
del suo compagno con un gesto della mano.
«In cambio?», si informò, interessato.
Orso mosse un passo avanti, aprendo il pugno nel quale aveva raccolto
tutte le fate crudeli che gli erano rimaste in tasca. Aprì
la mano dinanzi al giovane e sorrise, piegando appena il capo.
«Sono certo che possiamo trovare un accordo.»

|
Ritorna all'indice
Capitolo 11
*** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: di morti è piena la via ***
|
polverenera
Per
ricominciare
Eccomi di nuovo!
Stavolta
è tutto un capitolo dal punto di vista di Porpora, visto che
se ne sentiva la mancanza magari
no.
Per
gli affezionati, è finalmente giunto il momento: dal
prossimo capitolo, Levi sarà una presenza fissa e petulante!
*festeggia* Direttamente da quel buco di vigne che sono le terre di cui
è Conte.
Infine,
visto che queste note d'autore sono sempre corte e mi piace essere
prolissa e logorroica ... volevo presentarvi i personaggi
così come li ho immaginati nella mia testa.
Porpora
è Emily Browning, mentre Orso, nella
mia mente, è un baldissimo Hayden Christensen. Levi, infine,
è un giovanissimo Liam Aiken.
Chiudo
queste note scusandomi con coloro che aspettano una mia recensione alle
loro storie: è un periodo pieno di impegni, fidanzati ed
esami, ma sto cercando di mettermi in pari con ogni lettura! *^*
Perciò aspettatemi: sto arrivando!
Abbracci,
Lechatvert
Saremi
morte già dolce paruta
Acqua fangosa,
sii la mia tomba.
Sii mia maestra,
sarò tuo schiavo.
Mark Lanegan – Bleeding Muddy Water
Firenze,
28 settembre 1477. Un mese prima del ventiquattresimo compleanno di
Giuliano de’ Medici.
L’acqua del torrente era gelida, scaldata appena dai rari
raggi solari che rischiaravano i campi in quegli ultimi istanti prima
dell’alba.
Ammollo in una delle conche che il corso creava con le zolle di terra
più aride, Porpora sonnecchiava, trasportata dalla
solitudine e dal ritmico rumore della corrente che gorgogliava contro
le rocce. Sarebbe di certo rimasta lì altri dieci anni,
senza pedanti presenza a interrompere la sua pace e con solo la
sensazione del gelo ad intorpidirle le dita dei piedi.
Non c’era nulla che potesse valere quanto un paio
d’ore di bagno dopo una nottata intera di caccia alla lepre
nelle campagne. Caccia che, per altro, non aveva fruttato che un misero
coniglio neanche troppo in carne.
Porpora si era quindi concessa un po’ di riposo prima di
tornare in città e riprendere le ricerche del morto. Si
sentiva frustrata, da tutta quella storia: erano passati quasi due mesi
da quando erano giunti a Firenze e non ne avevano cavato un ragno dal
buco, nonostante avessero setacciato letteralmente ogni cimitero della
città, fossa comune e sanatorio compresi.
Sbuffò, sforzandosi di allontanare quei magri pensieri da un
momento così pacifico come quello del bagno. Avrebbe di
certo avuto modo di riprenderli in mano una volta tornata a casa.
Si impose di tornare a godersi l’acqua fredda del torrente al
contatto con la pelle, ma il rumore di un ramo spezzato la costrinse ad
aprire gli occhi e ad acquattarsi contro l’erba della riva.
Qualche piccolo passo dal luogo in cui aveva acceso un modesto fuoco di
sterpaglie la convinse definitivamente ad abbandonare l’acqua.
Conosceva quel genere di rumore.
Se era fortunata, l’ultima trappola che aveva costruito prima
di assopirsi aveva catturato un colombo.
Silenziosa, si avvicinò al ramo d’albero sui cui
aveva minuziosamente impilato tutti i suoi vestiti e passò a
vestirsi velocemente, nonostante i pantaloni di cuoio le stridessero
sulle cosce umide e la camicia intrisa di sudore le prudesse sulla
pelle. La lasciò aperta sul seno minuto, abbandonando la
giacca per afferrare il coltello.
Immaginava di non trovare che le braci del modesto fuoco che aveva
acceso per scaldarsi, perciò rimase non poco stupita quando,
al posto di cenere e fumo, trovò un’allegra fiamma
danzante attorno ai profili dell’uomo che la stava curando.
Porpora sospirò, facendo scivolare il coltello nella cintura.
«Non sapevo sapeste tenere un focolare»,
esordì.
Afferrò i baveri della camicia a la chiuse con lentezza,
avvicinandosi per prendere posto dinanzi al fuoco.
Aveva ancora i capelli bagnati.
«Siete un uomo ricco di sorprese, Conte Riario.»
Il Conte sorrise appena, celando il suo viso emaciato dietro lo
scoppiettare del fuoco.
«Dopo due settimane senza che voi e vostro fratello ci deste
notizie, temevo di dovervi venire a riprendere al camposanto.»
Porpora sospirò pesantemente.
«Non è colpa nostra, se i morti di Firenze non vi
aggradano», rispose, scrollando le spalle. «Abbiamo
passato al setaccio ogni cimitero, ma la sorveglianza
s’è fatta più fitta. Non è
facile, superare i cancelli.»
Cadde il silenzio.
Riario annuì, tirando fuori una smorfia tagliente come una
lama.
Se fosse divertito o semplicemente sarcastico, era impossibile dirlo.
Prese a sbucciarsi una mela, tagliandola con delicatezza e offrendone
il primo spicchio a Porpora con un cenno delle mani.
Lei accettò, incerta, e prese a masticare il frutto.
«Siete un po’ come le mele, voi
Vallesanta», considerò poco dopo il Conte, con lo
stesso tono con cui un padre racconta le fiabe ai figli.
«Quando vi si trova, siete duri e aspri come un frutto
acerbo, ma siete veloci a maturare e a imparare a farvi dolci. La cosa
più divertente, però, resta sempre il momento in
cui morite: siete così teneri e molli che vi si spezza in un
istante. È come chiudere il pugno su una mela troppo matura:
l’unico sgradevole inconveniente è la mano che
resta sporca della vostra insulsa poltiglia.»
Porpora lasciò cadere ciò che restava
del frutto, sussultando.
«Stiamo cercando in ogni dove», si
giustificò. «Non è facile trovare le
ossa di un morto di sifilide corrose al punto di non sciogliersi nella
tomba e quelle poche che recuperiamo non sono mai di vostro gradimento.
Senza indicazioni precise su cosa stiamo andando cercando, non ci
è possibile procedere più velocemente.»
Ed era vero.
Intrufolarsi nei cimiteri non era affatto facile e in più
una volta dentro disponevano di un tempo assai limitato prima che le
guardie li scorgessero. Un cadavere a notte, se andava bene, e la
maggior parte delle volte non era neanche quello giusto.
In più, le ossa corrose che avevano trovato fino a quel
momento non erano mai andate bene.
«Non vedo perché affannarsi», riprese,
stavolta con tono più calmo. «Di morti
è piena la via, Conte, e se c’è una
cosa che ci prende tutti è la morte. Non vale la pena
affannarsi tanto per qualcosa che prima o poi arriverà. Se
il morto non è già al cimitero, nel giro di
qualche mese ce lo spediranno i figli.»
Di colpo, il Conte si alzò, lasciandola da sola accanto al
fuoco.
«Parlate troppo, Porpora di Vallesanta», le disse,
atono, in piedi in mezzo alla rada campagna. La fissava con sguardo
vitreo, restando però a distanza. «Il Santo Padre
mi ha incaricato di portare voi e vostro fratello a Firenze per farvi
svolgere le vostre mansioni, ma non ha fatto parola circa il vostro
ritorno. Fossi in voi, reputerei saggio non spingersi oltre e
assicurarvi un rientro a Roma in sicurezza. La strada è
piena di briganti, incolpare uno di loro per la vostra morte non
sarà di certo un problema.»
Porpora ridacchiò nervosamente, alzandosi in piedi a sua
volta.
«Vi è un luogo in cui finora non ci siamo
spinti», confessò.
Riario la esortò a parlare con un cenno del capo.
«Il cimitero ebraico, appena fuori città. Secondo
Orso sarebbe disonesto vendervi le ossa di un eretico, io dico che,
ebreo o cristiano, sono comunque ossa messe sotto a della carne marcia.
È ciò di cui siamo fatti tutti; persino me,
persino voi.»
«Eseguite il vostro dovere senza chiedervi cosa il Signore ci
ha fatti», rispose pacato Riario. «Ci
sarà un tempo in cui voi e il vostro indecente fratello
potrete interrogarvi su ciò che distingue voi impure anime
dai giudei del ghetto, ma ora è bene che vi concentriate
sulle vostre mansioni.»
«E voi sulle vostre», ribatté Porpora,
velenosa. «Le città devono essere governate. Noi
anime impure possiamo staccare le ossa dalla carne senza la vostra
supervisione.»
Riario rise sommessamente, e fu una risata divertita e sincera, ma non
per questo meno inquietante o minacciosa delle precedenti.
Porpora indietreggiò, più che intenzionata a
tornare sui suoi passi senza dare le spalle all’uomo.
«Lascerò le fate quando avremo trovato il prossimo
corpo. Buona giornata.»
Mosse qualche altro incerto passo nell’erba, ma la voce del
Conte la bloccò.
«Un giorno potreste finire per pagare la vostra impertinenza,
Porpora», le disse, ancora immobile dinanzi al fuoco che
ormai pareva sul punto di spegnersi.
Lei annuì.
«Lo faremo tutti», rispose. «Ma occorre
vivere finché c’è tempo. Né
a me né a voi sarà concesso di vedere la nostra
tomba.»
E detto questo se ne andò definitivamente, diretta
all’albero dove aveva lasciato la giacca e il coniglio morto.
Teneva le labbra serrate in uno strano ghigno, gli occhi fissi sul
torrente dinanzi a sé, le dita strette alla cintura. Le
gambe, invece, le tremavano, prese dalla paura cieca che
l’aveva assalita quando Riario aveva riso.

«Mamma ci
sgriderebbe.»
Camminando ben dritta davanti a suo fratello, Porpora alzò
le spalle.
«Mamma ci farebbe un sacco di cose, ma è
morta», puntualizzò, laconica.
Tirò su col naso e accelerò la marcia lungo le
mura del cimitero ebraico, stringendo le dita attorno al nodo del sacco
di iuta che portava sulle spalle.
Avrebbe tanto voluto dire che le mancava, sua madre, ma non ne era
tanto sicura. Da che era tornata a Roma, non aveva sentito una sola
persona parlar bene di Celia Lysimachus. A volte, dai racconti del
ghetto, pareva addirittura una donna completamente diversa da quella
che li aveva cresciuti, o forse era del tutto uguale, Porpora non
sapeva dirlo con esattezza. Di Celia, dopo quattro anni di latitanza,
non ricordava che gli schiaffi leggeri e le tremende sgridate.
Sbuffando, si fermò dinanzi ai cancelli chiusi del cimitero.
Niente guardie, bensì delle alte punte di ferro da
scavalcare senza ferirsi: tutt’altro da ciò che
lei aveva sperato di trovare.
«A Roma non si prendono tanto disturbo per i giudei da
costruire loro un cancello», commentò Orso,
imbronciandosi appena dietro la luce della lanterna.
Porpora roteò gli occhi.
«Tu sei un giudeo», gli ricordò.
Orso alzò le spalle.
«Anche tu.»
Passandosi una mano sulla fronte, Porpora sospirò.
Scavalcare quello stramaledetto cancello pareva impresa ben
più ardua che scavalcare il muro di un normale camposanto.
Occorreva ingegnarsi.
Svelta, prese a camminare lungo il perimetro del cimitero.
Sperò che Orso non la seguisse, ma il ragazzo pareva in vena
di conversazioni fastidiose, tanto che la pedinò fino a che
non si trovarono ai piedi di una vecchia casa a ridosso del muro
scostato.
«Io conosco una persona che non è
giudea», stava appunto blaterando, quando Porpora gli fece
cenno di avvicinarsi. «Gregorio. Gregorio è
cristiano.»
«Piantala di parlare di morti e fammi da scala.»
Corrucciato, Orso si chinò per prenderla per i fianchi e
alzarla fino alla prima fila di tegole del vecchio casolare.
«Non sai per certo di parlare di morti finché non
li hai davanti», rispose, sbottando. «Che hai
intenzione di fare?»
Dal punto in cui Porpora si trovava, in piedi sul tetto più
basso, non c’era comunque modo di superare la fila di punte
di ferro che seguivano il profilo dell’alto muro del cimitero.
«Vado da sola», rispose lei, prendendo a scalare la
torretta del casolare. Si voltò verso Orso quando ormai era
a metà della sua impresa. «Tanto non volevamo fare
che un sopralluogo, no? Torneremo domani con un piede di porco per il
cancello.»
Da terra, la voce di Orso le giunse flebile come quella di un bambino
in preda alla paura del buio.
«Sta’ attenta, Sorella!»
Porpora ridacchiò, chiedendosi se Orso avesse la minima idea
di quanti muri avesse scalato, negli anni, per sfuggire alla guardia
cittadina. Qualche vecchio mattone di campagna, per lei, non era certo
un problema.
Si aggrappò con entrambe le mani a due ferri sporgenti e si
tirò su con la sola forza delle braccia, appendendosi poi a
una nicchia nel muro per proseguire la sua scalata. Una volta
sufficientemente in alto, appoggiò il petto contro la
facciata e scivolò verso destra, superando in altezza la
fila di punte di ferro che ostruivano il passaggio. Si
voltò, guardando dritta dinanzi a sé.
Oltre il muro, proprio davanti a lei, si ergeva un vecchio mausoleo di
famiglia in marmo, il cui apice terminava con una colonna un poco
più alta delle altre.
Porpora trattenne il respiro.
Non era uno dei salti più lunghi che avesse mai dovuto
compiere, ma doveva ammettere che non le era mai capitato di rischiare
di venire infilzata da una recinzione in ferro battuto.
Riuscì a trovare la forza di buttarsi contro la colonna
soltanto quando sentì la voce di Orso implorarla di lasciar
stare.
Si buttò letteralmente contro il marmo, battendo entrambi
gli avambracci sulla colonna e finendo a terra con un tonfo secco.
Da dietro il muro, la vocina di Orso arrivò tempestiva.
«Tutta intera?»
Porpora si drizzò in piedi, battendo le mani sulle ginocchia
per liberare i calzoni dalla polvere.
«Sì, sì», rispose, vaga.
«Ma sono bloccata qua dentro. Fa’ il giro del
casolare e cerca una corda o una scala. Io intanto mi occupo del
morto.»
Un istante di silenzio.
«Sicura di non aver paura?»
Porpora roteò gli occhi, frugando nelle tasche alla ricerca
dei cerini.
«Devo venirti a prendere a calci?»
«Per carità, no.»
Stizzita, si sistemò il colletto slabbrato della camicia e
procedette verso le tombe dei poveri, pestando qua e là
nell’erba umida della notte.
Di certo, l’indizio lasciatole dal Santo Padre non avrebbe
potuto aiutare meno. Le ossa di un deforme la cui unica caratteristica
pareva l’essere orribile. Un ago in un pagliaio, a contare
tutti i morti che c’erano sotto la terra di Firenze.
Prima di partire per il cimitero ebraico, però, Zoroastro li
aveva indirizzati verso i sarcofagi di pietra che normalmente venivano
addossati lungo le mura a sud: morti facoltosi ma dimenticati le cui
tombe erano generalmente già state aperte dai tombaroli in
cerca di ori.
Porpora non ci mise poi molto a trovarli.
Senza chiamare suo fratello, impiantò qualche cerino nel
terreno morbido, creando una piccola scia di luce attorno alle bare.
Le scoperchiò una a una, adoperando tutta la forza che aveva
in corpo per muovere il marmo, e constatando come, una dopo
l’altra, quelle tombe si rivelavano essere case di morti uno
più normale dell’altro.
Stava per abbandonare ogni speranza quando, raccogliendo
l’ultimo cerino, non si accorse di un vecchio sarcofago in un
angolo. Era stato costruito in pietra nera, perciò passava
del tutto inosservato dinanzi ai suoi compagni immacolati.
Rapida, Porpora gli si avvicinò, usando le sue ultime
energie per dare una forte spinta al coperchio per farlo scivolare
verso il muro.
Una volta dinanzi alla salma, un largo sorriso si dipinse sul suo viso
sporco di terra.
«Orso!», gridò, senza però
ricevere risposta. «Orso, l’ho trovato!»
Tornò a guardare il morto, pronta a fare marcia indietro per
tornare quando avrebbero avuto modo di scassinare la serratura del
cancello, ma qualcosa la bloccò.
Un brivido freddo la percorse, quando la fioca luce del cerino acceso
si specchiò sulla superficie lucida e metallica del
pendaglio che quelle ossa deformi portavano ancora al collo.
Porpora la riconobbe immediatamente.
Testa rotonda e decorata da strani e ricorrenti motivi, gambo
triangolare, l’intagliatura più strana che avesse
mai visto su una chiave.
Il nome di sua madre le scivolò dalle labbra così
velocemente che non ebbe nemmeno il tempo di pensarlo.
«Celia», disse, e in un istante la sua mano
volò sul mucchio d’ossa che aveva dinanzi per
strappare il cordoncino e appropriarsi di quell’oggetto.
Rimase a guardarlo a lungo, girandoselo e rigirandoselo tra le mani
quasi avesse appena trovato il più prezioso dei tesori.
Poi, dei passi alle sue spalle la misero in allarme.
Fece appena in tempo a far scivolare la chiave nella tasca della giacca
che una mano pensate cadde sulla sua spalla, afferrandola per
trascinarla a terra.
«Ti ho presa, tombarola!»
Un uomo alto almeno il doppio di lei la scrollò, prendendo a
camminare verso il cancello con la sua spalla in una mano e la lanterna
nell’altra.
«Il tuo compare è già in gabbia. Vi
spedirò dritti dalla guardia cittadina!»
Una volta uscita dal cimitero e portata al cospetto di un Orso tenuto
fermo da un uomo della medesima stazza, Porpora non poté
fare a meno di strabuzzare gli occhi.
Ma come avevano potuto essere così stupidi da non
considerare la presenza dei custodi, visto l’assenza di
guardie?
Si diede dell’imbecille, dopodiché si rivolse
all’uomo che inesorabile la stava spintonando verso il muro
del casolare.
«Per favore», piagnucolò, cadendo in
ginocchio. «Abbiamo soltanto fame!»
«Già», intervenne con un grosso sospiro
l’aguzzino di Orso. «Guardateli, padre: sono magri
come chiodi.»
L’uomo però non demorse.
«Dovessimo tener d’occhio solo i grassi, figlio,
dormiremmo tutti sonni più lieti!»
Porpora sbuffò.
«Non cercavo che delle monete», insistette.
«Che se ne farebbe un morto?»
Di nuovo, il figlio del custode arrivò in suo soccorso.
«Qui i tombaroli hanno già ripulito ogni
cosa», disse, pacifico. «Padre, non avrebbero
comunque potuto rubare nulla. Non sono che ragazzi!»
«E sia, Paolo», concesse infine l’uomo,
lasciando finalmente la presa su Porpora. «Ma ricorda che se
domani notte saranno ancora qui a elemosinare sarai tu stesso a
portarli a Firenze!»
Porpora non udì mai la risposta di Paolo.
Non appena fu libera, scattò in avanti e afferrò
Orso per la collottola, trascinandoselo dietro mentre correva verso i
campi più rapida di una freccia.
Non le importava di aver lasciato indietro la borsa con la sega e le
pinze. Non le importava neanche di aver lasciato più della
metà dei suoi cerini al cimitero.
La chiave che aveva in tasca pesava più di qualunque
bagaglio e, a ogni rimbalzo che compiva sulla sua coscia, la carne
pareva ardere sempre di più.
Arrivarono a Firenze che le porte erano ancora chiuse, controllate
dagli uomini del Capitano Dragonetti che però non pareva
essere nei dintorni.
«Pare che dovremo aspettare l’alba»,
considerò Orso, piegato in due dal fiato corto della corsa.
Porpora non poté far altro che scivolare a terra, stremata.
Il cuore batteva forte e la gamba pulsava contro
quell’oggetto che aveva appena rubato a un morto.
Sconvolta, si portò il polso alla fronte, asciugandola del
sudore raggrumato sulla frangia.
«La mamma ci avrebbe sgridati»,
sussurrò, più a se stessa che a suo fratello.
Dopo gli schiaffi, era l’unica cosa che ricordava di Celia.
“Mai rubare ai morti”, diceva sempre, quando con
Mastro Giovanni si recavano al cimitero per gli ossequi ai defunti.
Saltando tra l’erba alta, Orso chiedeva sempre
perché. Allora Celia si incupiva e si accovacciava su di
lui, sgranando gli occhi chiari e scompigliando i capelli del suo
figlio più giovane. “È semplice, yeled sheli”,
rispondeva, seria. “Perché i morti ritornano
sempre a prendersi ciò che è stato loro
sottratto.”

|
Ritorna all'indice
Questa storia è archiviata su: EFP
/viewstory.php?sid=2522622
|