Ablaze
(/viewuser.php?uid=197501)
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** Prologue. ***
Capitolo 2: *** 1. Cigarette. ***
Capitolo 3: *** 2. Coffee. ***
Capitolo 4: *** 3. Who's that boy? ***
Capitolo 5: *** 4. Pain. ***
Capitolo 6: *** 5. I'm happy to see you again, tiger. ***
Capitolo 7: *** 6. He can hurt me yet. ***
Capitolo 8: *** 7. I'm a disaster. ***
Capitolo 9: *** 8. I see that guilt beneath the shame. ***
Capitolo 10: *** 9. Moods that change the speed of light. ***
Capitolo 11: *** 10. You're such a fuck-up! ***
Capitolo 12: *** 11. Don't let bastards get you down ***
Capitolo 13: *** 12. We are the results of what we have been led ***
Capitolo 14: *** 13. My head says 'who cares?' but then my heart whispered 'you do, stupid' ***
Capitolo 15: *** 14. He's just a memory ***
Capitolo 16: *** 15. The worst things in life comes free to us. ***
Capitolo 17: *** 16. We try to escape but this life is like a fuckin' tapis roluant! ***
Capitolo 18: *** 17. Breathe. It's just an another bad day. ***
Capitolo 19: *** 18. Yesterday will last forever. Tomorrow never comes. ***
Capitolo 20: *** 19. Sorrow is a part of package. ***
Capitolo 21: *** 20. The evil that I've got inside I mask it well. ***
Capitolo 22: *** 21. Issues and fury. ***
Capitolo 23: *** 22. No way out. ***
Capitolo 24: *** 23. No one ever really goes away and nobody stays forever. ***
Capitolo 25: *** 24. Switch back. ***
Capitolo 26: *** 25. Sometimes light sheets cut off your fingers, and you see the blood but not the wound. ***
Capitolo 27: *** 26. Epilogue. ***
Capitolo 28: *** SEQUEL. ***
Capitolo 1
*** Prologue. ***
| ‘Con questo mi scritto, pubblicato senza alcuno scopo di lucro, non intendo dare rappresentazione veritiera di questa persona ne offenderla in alcun modo .’ Una piccola nube grigiastra s’innalzò dalle labbra sottili del ragazzo dai capelli biondi - tinti accuratamente -, per poi andarsi a scontrare bruscamente contro l’aria gelida di quella insolita e fredda serata di metà Agosto.
________________________________________________________________________________________________
Charachters:
Demi Lovato as Carter Harvey  Justin Bieber as himself.  Matt Bomer as Elia Harvey  Kellan Lutz as Dante Harvey  Holland Roden as Leanne Harris 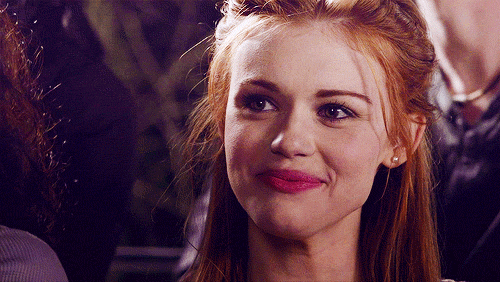 Keegan Allen as Keaton Haig  Alex Pettyfer as Cole Harris  Lucy Hale as Baja Fisher  Douglas Booth as Ian Harding  Zac Efron as Blake Fay 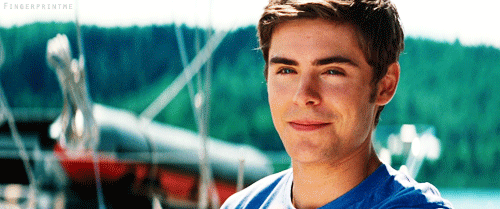 Chad Michael as Jared Grant  Paul Wesley as Sal Davis  Chris Hemsworth as Travis Roden  Tyler Hoechlin as Tyreek Hughes  ________________________________________________________________________________________________
Author's corner: E' mezzanotte passata oramai e dopo mesi di insicurezze e ripensamenti sono riuscita finalmente a convincermi a pubblicare questo breve, anzi brevissimo, prologo che dovrebbe, teoricamente, introdurre questa mia nuova ff. Non so come commentarlo, davvero. Insomma, comprendo che ci si possa capire davvero poco ma, per come la mia mente ha deciso di sviluppare il resto, ammesso che questo incuriosisca qualcuno a tal punto da convincerlo a lasciare qualche straccio di recensione e a dirmi cosa ne pensa, anche negativamente , questa 'introduzione' servirà per un'eventuale continuazione della storia. So che non è granché come inizio, nonostante ci abbia impiegato un infinito lasso di tempo per scriverlo o a farmelo risultare perlomeno decente, e che possa sembrare banale come trama ma in realtà non è davvero così e ci tengo anche a chiarire che qui il ruolo che ho affibiato a Justin non è associato ad un assassino né tantomeno a una qualche gang, alla droga, spaccio o roba simile; diciamo che nonostante risulterà più tranquillo la cosa sarà comunque anche abbastanza complicata. E personalmente ci tengo davvero a questa ff quindi spero davvero di cuore di avere la possibilità di continuarla. Beh, in realtà non so cos'altro ci sia da dire in merito, anche perchè è abbastanza tardi e non voglio rompere ancora, quindi lascio nelle vostre mani il destino di 'Ablaze' (?) Come la faccio tragica lol Prima di dileguarmi ringrazio ancora trubel per aver realizzato il meraviglioso banner qui sopra♥ E poi boh, recensite, please(?) Un bacio,C ♥ |
Capitolo 2
*** 1. Cigarette. ***
‘Con questo mi scritto, pubblicato senza alcuno scopo di lucro, non intendo dare rappresentazione veritiera di questa persona ne offenderla in alcun modo .’ 1. Justin
[Tre anni dopo]Parcheggiai la macchina in mezzo a due delle tante vetture che occupavano il secondo piano del parcheggio, togliendo lentamente le chiavi dal cruscotto. Allungai il braccio destro sui sedili posteriori alla ricerca del mio maglione - che mi sbrigai ad infilare subito dopo aver sfiorato con le dita la superficie morbida della lana. Compressi il filtro della sigaretta nel bicchiere del caffè comprato quella mattina e, sollevando di poco il sedere, afferrai il pacchetto dalla tasca posteriore dei jeans. Soddisfatto, tentai di allungare le gambe sotto il volante per quanto lo spazio ristretto mi permettesse in realtà di fare. L’aria all’interno dell’abitacolo era talmente impregnata di fumo che a stento riuscivo ad intravedere la punta delle mie scarpe blu. Ciò non mi impedì ovviamente di accendere l’ultima sigaretta del pacchetto, che poi accartocciai e lanciai nervosamente all’indietro; l’ammasso di plastica e carta si andò a depositare in mezzo agli altri tre consumati precedentemente. “Amico, davvero, questo sarà il terzo pacco da venti che ti sei fumato nelle ultime tre ore” mi rimproverò la voce meccanica e poco chiara di Blake, dall’altro capo del telefono, con uno sbuffo esasperato. “Ti verrà un accidente se non la smetti!” Indifferente scrollai le spalle, dimenticandomi per un istante che lui non poteva vedermi; spostandomi sul sedile socchiusi le labbra per lasciar uscire un’altra nuvoletta biancastra di fumo, che andò ad infrangersi contro il vetro del finestrino. In realtà lui sapeva perfettamente di stare dando aria alla bocca inutilmente; perché a me, delle possibili conseguenze sulla mia salute, - soprattutto in quel preciso momento - mi importava poco o niente. Un altro sbuffò mi arrivò alle orecchie, questa volta molto più soffocato del precedente. Buttai fuori un’altra nuvoletta di fumo, e quando mi accorsi che mi rimanevano soltanto uno o due tiri prima che anche quella finisse, mi pentii all’istante di non aver aspettato qualche altro minuto prima di accenderla. E come se avesse percepito la mia riluttanza nel fare qualunque movimento, Blake si schiarì la gola. “Fotterti i polmoni non ti eviterà di entrare in quella stanza, Bieber.” Quella volta fui io a buttare fuori l’aria dal naso. E non tanto per l’esasperazione o la noia, piuttosto perché - per quanto quelle parole potessero risultare vere alla mia coscienza -, mi avevano urtato particolarmente i nervi. E in quel momento avere un diavolo per capello era l’ultima cosa che mi serviva per affrontare al meglio la persona che mi aspettava, rinchiusa in una cella. Tentai di portarmi nuovamente la sigaretta alle labbra, ma quando la sentì bruciare contro la mia carne, mi accorsi che non era rimasto altro che quello tra le mie dita. Buttando il mozzicone nel bicchiere, lasciai andare la testa sul poggiatesta in pelle, osservando perso un punto indefinito nello specchietto retrovisore - per metà appannato dal mio respiro. Insofferente, levai di nuovo il maglione - per la ventesima volta -, rimanendo di nuovo per lo stesso numero di volte in canottiera. Lanciai l’indumento sul sedile del passeggero di fianco a me e spostai la mia attenzione sull’orologio al mio polso, notando che lo schermo segnava di già le quattordici e quarantacinque. Di nuovo un’altra ora persa, sprofondata nel nulla. Riluttante a qualunque movimento, poggiai comunque una mano sulla leva dello sportello, con una gamba sollevata e lo sguardo ancora fisso sul cellulare, certo che Blake fosse ancora in linea. E probabilmente mi stava insultando mentalmente in tutti i modi da lui conosciuti – che non erano pochi. Senza dire niente, trovando un briciolo di volontà nella più remota parte del mio cervello, levai la batteria al telefono e saltai giù dalla macchina - accompagnato dalla nuvola di fumo che iniziò a disperdersi lentamente nell’aria. Senza aspettare che quella all’interno dell’auto fosse tornata pulita chiusi lo sportello e aprì quello adiacente, rimettendo per l’ennesima volta il maglione, certo che sarebbe stata la cosa migliore. Infilai poi portafoglio e chiavi nelle tasche dei jeans e chiusi le sicure, rimanendo fermo lì, di spalle, facendo dei lunghi e rumorosi respiri. Quel susseguirsi di espirare ed ispirare si ripeté per altre tre minuti, prima che mi decidessi a risalire le scale del parcheggio e attraversare velocemente la strada - facendo anche poca attenzione al guardare entrambi i lati della strada. Affondai bruscamente le mani nelle tasche - iniziando a giocherellare con l’orlo dei boxer attraverso il tessuto dei pantaloni - mentre osservavo l’enorme edificio grigiastro sfilarmi di fianco, come ad accompagnare ogni mio passo e ricordarmi dove ero. Come se potessi realmente fingere di trovarmi semplicemente nella casa di un vecchio amico che non vedevo da tempo; come se potessi fingere che quella fosse una semplice visita di cortesia e che lui avesse deciso di sua spontanea volontà di rinchiudersi lì dentro, tra quelle tre mura ammuffite che erano diventate la sua camera da tre anni a questa parte. Senza accorgermene, troppo immerso nel seguire il corso nostalgico dei miei pensieri, mi ritrovai già spoglio di tutti gli oggetti di ferro o potenzialmente pericolosi in mio possesso. “Mi segua” accennò un omone tozzo, ruotando goffamente la cintura che gli pesava sotto la pancia sporgente; imboccò un lungo corridoio dal pavimento impolverato, riempito qua e là da qualche altro uomo in divisa sull’attenti. Al contrario di ciò che mi aspettavo, e che aveva contribuito a dare leggermente una calmata ai miei nervi, il corridoio non si rivelò più lungo di una cinquantina di passi. Già, li avevo contati. Poi, Homer Simpson – l’omone irritato -, si fermò dinanzi ad una fila di sbarre che separavano l’accesso ad un’altra stanza; facendo un cenno d’assenso all’altro collega - sicuramente più giovane e più in forma - , quello mi aprì la porta e tornò sull’attenti aspettando una mia mossa. “Quindici minuti, ragazzo” mi sussurrò velocemente Homer, prima di spintonarmi rozzamente all’interno della stanza, come fossi anch’io uno dei carcerati. “Fanculo stronzo” ringhiai a bassa voce, sistemandomi il maglione sulla spalla colpita così rozzamente. Fosse stata un’altra situazione gli avrei risposto per le rime come mio solito; forse, molto probabilmente lo avrei fatto anche in quel momento se due occhi ghiacciati non m’avessero inchiodato lì, in mezzo a quella sala piena di uomini in tute arancioni o grigie che scambiavano parole d’amore - e a volte di rabbia - con i loro interlocutori. Ingoiai rumorosamente la bile che mi era risalita in gola, iniziando ad avvicinarmi a passo lento verso l’unico tavolo non occupato da un visitatore, - sotto lo sguardo curioso di qualche spettatore indesiderato. Che si facessero i cazzi loro. Ma pensarlo, o anche provare a dirlo,non avrebbe certo cambiato il mio stato d’animo, mentre i miei occhi passavano in rassegna il volto del ragazzo che avevo seduto di fronte: i capelli cortissimi erano tornati della loro tonalità normale di marrone, il fisico ben messo si poteva intravedere anche da quell’orribile sottospecie di pigiamone arancione che era costretto ad indossare. La barba che gli circondava il mento gli dava qualche anno in più e gli occhi, sempre di quell’azzurro intenso, quasi spettrale, che mi trapassavano da parte a parte, sembravano gli stessi. Tutto sembrava lo stesso, in lui. Appunto, sembrava. Perché, nonostante il suo aspetto risultasse uguale a quando andavamo al campo da basket, i suoi occhi mostravano tutto tranne che benessere. Tristezza, malinconia, rancore, delusione, amarezza, rabbia. Un mix di emozioni distruttive e ingestibili a lungo termine che ero certo lui potesse leggere nei miei, di occhi. “Ciao Justin” accennò un sorriso in mia direzione, nonostante stesse fissando tutto fuorché i miei occhi; io ovviamente mi ero già preoccupato di spostarli sulle macchioline nere che occupavano gran parte della superficie del tavolo, trovandole improvvisamente interessanti. L’aria era pesante; la sentivo, come se gravasse tutta sulle mie spalle incurvate contro la circonferenza del tavolo. “Quanti pacchi di sigarette hai fumato prima di venire qui, Biebs?” continuò lui, inclinando un angolo della bocca all’insù. Inarcai le sopracciglia, alzando divertito lo sguardo su di lui. “Un paio …” Lui ridacchiò semplicemente, mentre scuoteva la testa per spostare qualche ricciolo color cioccolato che gli era scivolato sulla fronte, colpendomi al cuore. Aveva riso. Aveva ancora la forza di farlo; ed io mi maledicevo ogni volta che mi capitava, mentre ripensavo a me e lui prima della sua stupida scelta, che io, da stupido quale ero stato, avevo appoggiato molto stupidamente. “So che non ti piace venire qui, e sai che nemmeno a me piace che tu ci venga” parlò a bassa voce, sporgendosi leggermente sul tavolo e lanciando varie occhiate di ammonimento agli impiccioni attorno a noi. Gli occhi dell’omone di colore che gli stava con il fiato sul collo, con delle chiavi che gli pendevano da un passante della cintura, scattarono velocemente a perlustrare lo spazio alla ricerca di qualche particolare sospetto. Quelle chiavi dovevano essere quasi sicuramente quelle delle sue manette; e per un breve ed inteso momento, valutai la possibilità di strappargliele da lì in qualche modo strategico per aiutare il mio migliore amico ad evadere da quel buco cui era costretto. Idiota, mi apostrofai mentalmente, scuotendo la testa. Allora mi sporsi a mia volta sul tavolo sperando che quell’altro tornasse a farsi i fatti suoi, tappandosi le orecchie. “Ma..?” lo incitai, vedendolo indeciso sul da farsi. “Ho bisogno che tu mi faccia un favore” sospirò, abbassando la testa. “E sai che non te lo chiederei se non ne avessi davvero bisogno.” ____________________________
Buttai il mozzicone della sigaretta nel bicchiere del caffè, sporgendomi poi verso il pacchetto sul sedile del passeggero per afferrarne un’altra, infilandola in bocca. Dopo aver tenuto la fiamma dell’accendino vicino al capo della sigaretta - abbastanza al lungo perché si accendesse - lo rilanciai all’indietro; atterrò silenzioso tra gli altri pacchi ammucchiati ed il maglione. Quando notai una lucina rossa avvicinarsi sempre di più a me inchiodai bruscamente sul freno, distogliendo l’attenzione dal flusso dei miei ragionamenti e ringraziando Dio che non ci fosse nessuno dietro di me. Nonostante con quel gesto improvviso mi fossi guadagnato alcune occhiatacce dai guidatori delle auto che affiancavano la mia corsia. “Fanculo! Fanculo!” sbottai inferocito. Sbattei in malo modo le mani sul volante, in uno scatto di rabbia e frustrazione. Sentendomi osservato, notai l’occhiataccia che un’anziana donna mi stava lanciando dalla macchina affianco - sotto lo sguardo ammonitore del marito che probabilmente le intimava di farsi gli affaracci suoi. E faceva bene, perché un istante dopo, - quando la conversazione con Dante mi si ripresentò davanti agli occhi, come un cortometraggio mal riuscito - preso dall’ennesimo scatto d’ira alzai la mano mostrandole il dito medio e rivolgendole parole poco carine. Sbuffando, richiusi il più velocemente possibile il finestrino, evitando così di sorbirmi i suoi rimproveri da nonnetta ottantenne quale era. Riportai lo sguardo sulla strada di fronte a me, notando una ragazza attraversare con molta comodità le strisce, impegnata in un’animata conversazione telefonica. Notai avesse le cuffie alle orecchie, e per quanto ne sapessi io poteva star semplicemente cantando una canzone a squarciagola senza accorgersi che qualcuno potesse fissarla insistentemente - come me in quel momento. Improvvisamente, cogliendo il corso insensato dei miei pensieri, con un altro scatto d’ira battei un altro pugno sul volante. Pigiai con foga l’acceleratore, ingranando la marcia, non appena la lucetta rossa e fastidiosa fu sostituita da quella verde. Fanculo! ____________________________________________________________________________________ Author's corner: Ma salve ragazzuole(?) ☺ [Prima di tutto, se siete riuscite ad arrivare a leggere fin qui, GRAZIE, non so come abbiate fatto lol] Sono tipo le 01:13, questo è diciamo il primo vero capitolo di questa sorta di FF e io non so spiegarmi per quale contorto motivo quando aggiorno lo faccio inevitabilmente a questi orari da pipistrello lol Okay, lasciamo stare. Tornando a noi, ecco il primo capitolo che è, come avete potuto vedere, dal punto di vista di Justin ouo Ovviamente, non si è capito esattamente ancora molto riguardo a tutta la trama della storia, ma se così fosse stato che gusto ci sarebbe, no? In realtà, non so di nuovo cosa dirvi di più. Credo piuttosto che dobbiate dirmi voi cosa ve ne è sembrato o magari cosa vi aspettate da questa storia? Che idea vi siete fatte? Ovviamente se ci sono errori di ortografia potete segnalarmeli tranquillamente e provvederò ad aggiustarli. Inoltre, prima di dileguarmi, ci tenevo a ringraziare le tante visite che ha ricevuto il primo capitolo hjdksh *-* cioè, per me sono tante più che altro, quindi GRAZIE ♥ E poi, boh, recensite(?) Un bacio, C♥ |
Capitolo 3
*** 2. Coffee. ***
'Con questo mio scritto, pubblicato senza alcuno scopo di lucro, non intendo dare rappresentazione veritiera di questa persona né offenderla in alcun modo'
 2. Carter
La CNN interruppe il servizio mattutino sui leoni che stavano trasmettendo tre minuti prima che esso terminasse definitivamente, per delle importanti notizie dell’ultima ora. Levai la cuffia dal mio orecchio destro, interrompendo momentaneamente la musica, per passare il cavo sottile attorno al collo lasciandolo penzolare sul petto. Si preannunciava una classica giornata di gravi notizie: un terremoto da qualche parte in Sud America, un rapimento politico in Medio Oriente e il ritrovamento di un probabile sirial killer a Portland. Il servizio terminò con una foto poco nitida dell’individuo in questione, ai tempi dello scatto con una lunga e folta barba scura, dalla quale distolsi poco dopo l’attenzione. “La cronaca in città sarà più leggera” commentò un uomo sulla cinquanta in compagnia della sua compagna, lanciando una veloce e nostalgica occhiata al giornale sotto la borsa ingombrante della donna. Un urletto isterico mi costrinse a riportare l’attenzione sulla ragazza di fronte a me; era talmente verde di rabbia che temevo davvero avrebbe potuto trasformarsi nella versione in gonnella di Hulk. “Oh, basta, dannazione. Me ne vado” ringhiò contro il ragazzino dietro al bancone, girando i tacchi per imboccare la porta - continuando a imprecare a bassa voce tra sé e sè. “Dalli a me quei caffè che stavi facendo” mi affrettai a dire, notando il biondino pronto ad abbandonare la macchinetta per servire una ragazza seduta già da una quindicina di minuti vicino al bancone. Sembrava quasi impaurito di fare qualunque tipo di movimento; si muoveva con estrema lentezza e accuratezza mentre riaccendeva la macchinetta del caffè - che iniziò a fare un rumore abbastanza fastidioso. Quasi temesse di fare qualcosa di irrimediabilmente sbagliato. Spostando lo sguardo per tutta l’area, alla ricerca di qualche possibile adulto che potesse correre in suo soccorso, notai con dispiacere che nessuno oltre a lui occupava quella postazione. Purtroppo per il biondino, io non ero esattamente un tipo molto paziente. Soprattutto a quelle ore del mattino quando non avevo ancora nemmeno ingerito la mia dose giornaliera di caffeina, visto che quel mentecatto di mio fratello nel fare la spesa aveva comprato tutte le schifezze possibili e immaginabili e si era dimenticato proprio il pacco di caffè. E glielo avevo scritto a caratteri cubitali, sulla lista, con addirittura un pennarello rosso brillantinato. Ed io, senza caffeina, diventavo insopportabilmente acida; anche più di quanto non lo fossi solitamente – ed era tutto dire, cavolo. Levai il cappello degli San Diego Padres, - comprato Da Elia quando era andato, grazie alla sottoscritta, a vedere una delle loro ultime partite del campionato - osservando distrattamente le punte delle mie scarpe mentre cercavo di attaccarmi i capelli. Il campanello attaccato sopra lo stipite della porta tintinnò, segnando l’arrivo di un altro cliente, ed una folata gelida di vento mi investì in pieno facendomi rabbrividire. Mi strinsi nel mio maglione, notando solo allora che il biondino aveva poggiato un bicchiere di caffè sul bancone; la macchinetta sembrava avere qualche problema tecnico vista la nuvoletta di fumo che fuoriusciva dal retro dell’aggeggio. Il ragazzino si era rannicchiato in un angolo con il cellulare all’orecchio, forse in cerca di aiuto da parte di qualcuno più esperto di lui. O poteva aver già provveduto a chiamare i pompieri per prevenire un’eventuale peggioramento della situazione. Scossi divertita la testa, allungando la mano verso il caffè, con l’altra infilata nella borsa alla disperata ricerca del portafoglio. In realtà, avendoci buttato dentro unicamente il libro di storia, il pacchetto di sigarette e gli occhiali pensavo sarebbe stato più facile individuarlo. Ma ovviamente avevo sbagliato i miei calcoli – non per niente facevo schifo in matematica. Abbandonai il bicchiere per un secondo e frugai con entrambe le mani nella borsa, fino a trovare ciò che mi serviva; ma quando alzai lo sguardo, trionfante e pronta ad andarmene da quell’inferno di posto, notai con disappunto che il mio bicchiere di caffè era sparito. Il. Mio. Caffè! Strabuzzai gli occhi, girando velocemente la testa alla ricerca del possibile cretino che avesse potuto confondere la mia ordinazione con la sua, nonostante fossi quasi certa di non aver sentito parlare nessun altro dopo di me. E solo allora notai un ragazzo che mi affiancava, con il mio bicchiere alla bocca e una mano che frugava insistentemente nelle tasche dei pantaloni, dai quali fuoriuscivano due pacchetti di Marlboro. Tossicchiai infastidita, picchiettando l’unghia laccata di bianco sulla sua spalla, cercando di attirare la sua attenzione. “Scusami, amico …” Lui si voltò, visibilmente irritato, spostando poi interessato lo sguardo sul mio corpo, con un sopracciglio che era schizzato in alto increspandogli la pelle della fronte. E prima che potesse fare chissà quale commentino - notando lo sguardo alquanto eloquente che aveva lasciato al mio abbigliamento -, gli lanciai un’occhiataccia ammonitrice. In effetti, nonostante avessi impiegato tutte le mie forze e la buona volontà possibile per cercare di raggiungere almeno un minimo di decenza, il cipollotto blu che mi spuntava sulla nuca ed il maglione, che dopo tutte le tirate inflittegli era aumentato di quasi una taglia, mi facevano somigliare più ad una spacciatrice dei ghetti che ad una studentessa liceale. O, anche più generalmente, ad un essere umano di sesso femminile. Non che lui fosse conciato meglio di me: con un pantalone largo che gli arrivava fin sotto al ginocchio che metteva in bella mostra un tatuaggio; una felpa rossa dalla quale si potevano intravedere i suoi boxer bianchi, Nike del medesimo colore e un cappello nero che gli copriva tutti i capelli. “C’è qualche problema, tesoro?” mi domandò sorridente, costringendomi ad abbandonare il flusso dei miei pensieri. Inclinò la testa di lato, fissandomi senza alcuna vergogna. “Si” affermai decisa, iniziando a battere la punta del piede a terra; osservai insistentemente il bicchiere di caffè tra le sue dita - gesto che attirò ulteriormente la sua attenzione. “Quello era mio.” Spostò divertito la testa verso l’oggetto in questione e poi tornò su di me, ridacchiando. “Tecnicamente era della ragazza che se n’è appena andata, ma siccome l’ho preso prima io, adesso è mio” precisò. Sobbalzai leggermente alla sua affermazione, chiedendogli esplicitamente con lo sguardo se fosse serio o gli occhialoni scuri che portava gli creassero qualche impedimento alla vista. “Senti, stronzo, o mi dai quel caffè o mi dai quel dannato caffè” sbuffai inviperita, allungando la mano sotto il suo naso, in attesa. “Io mi chiamo...” Sbuffai di nuovo, questa volta più rumorosamente, interrompendolo. “Non mi interessa come diavolo ti chiami. Io rivoglio indietro il mio caffè” sentenziai, marcando ulteriormente l’aggettivo possessivo che avevo usato. Afferrai brutalmente il bicchiere dalla sua mano tornando a concentrarmi sul ragazzino dietro al bancone, che ora fissava me e il mio interlocutore contenderci quella benedetta bevanda. Sentivo ancora lo sguardo scioccato dell’energumeno di fianco a me sulla mia faccia; dopo un istante di esitazione sbatté energicamente la mano sul bancone lasciandovi sopra dei soldi. Inarcai le sopracciglia, osservandolo. Che avesse capito di aver sbagliato e volesse offrirmi il caffè per farsi perdonare? Si avvicinò ulteriormente a me, e non potevo nemmeno vedere l’espressione che aveva assunto visti gli enormi occhiali che gli coprivano quasi metà della faccia. Un attimo dopo sentì l’aria che si infrangeva contro la mia mano, ancora modellata sulla forma rotonda del bicchiere; prontamente lo sollevò in aria con un ghigno sulla faccia, visto il suo probabile metro e ottanta a confronto del mio scarso metro e sessanta. Poggiò una mano sull’incavo tra il mio collo e la spalla, muovendo lentamente l’indice sulla mia pelle, per tenermi ferma. “Scusa tigre, oggi vinco io.” “Stronzo” ringhiai a bassa voce, incrociando nuovamente le braccia accompagnata da alcune risatine - che dovevano venire dalla coppietta di cinquantenni che prima avevano commentato le notizie del telegiornale. “Ci si vede tesoro” ammiccò soddisfatto lo stronzo, infilando il resto nei jeans prima di uscire tranquillamente dal negozio, sotto lo sguardo divertito di chi aveva assistito al nostro breve ed intenso scambio di battutine. Rimasi ferma a fissare il punto in cui era sparito, a bocca aperta, mentre la ragazza che aveva il turno dopo il mio faceva la sua ordinazione. Io ero uscita di casa alle sette di mattina per prendere due dannati caffè, per me e Leanne,- che mi aspettava fuori in macchina, dove quasi probabilmente si era addormentata - e cosa ci avevo guadagnato? Un litigo, come quelli che fanno i bambini dell’asilo per l’ultima caramella rimasta, in un bar nel centro di San Diego, di prima mattina, per un caffè che mi spettava di diritto, con uno sconosciuto irritante, ladro di caffè oltretutto, vestito come Lil Wayne? Perché non ero andata al Supermercato vicino casa? ____________________________________________________________________________________ Author's corner: Sono esattamente le 15:38. Olè. Ho aggiornato ad un orario decente. Ma vabbè, dettagli. Tornando a noi, ecco il secondo capitolo e questa volta dal punto di vista della nostra Carter OuO Non so esattamente da dove mi sia uscito questo capitolo che non saprei nemmeno come definire lol In realtà tempo fa avevo scritto il prologo di una storia, che aveva a che fare con il caffè, e quando mi è capitato sotto naso, l'ho riletto e ho pensato di poter riportare l'idea anche qui, anche perchè a me una volta è capitata una cosa simile lol, sperando che non sia uscita una cosa così merdosa. E' un capitolo di passaggio, più che altro, anche per far capire un pò com'è il carattere della protagonista, in parte. Giuro che il capitolo successivo sarà molto più interessante di questa cacatella qui :') Inoltre volevo ringraziare tanto voi che avete inserito la storia tra le seguite/preferite/ricordate e anche le recensioni del capitolo precedente, che sono state troppo carine jkhfdk :3 E vabbè, niente. A voi che ve ne pare? Si può considerare almeno passabile? lol E so che starete pensando che il tizio che le ha fregato il caffè sia Justin, ma, ne siete davvero sicure? Potrebbe anche essere qualcun'altro OuO Alour, la lasciate un piccolapiccola recensione anche qui(?) ☺ Bacioni, C ♥ |
Capitolo 4
*** 3. Who's that boy? ***
 3. Carter “Quindi questo tizio ti ha fregato il caffè …” ripeté pacato Keaton, facendo scivolare il suo zaino sul pavimento; si lasciò cadere rovinosamente su una sedia girevole, vicino a una delle poche finestre rotte della stanza.
Infilò le mani nelle tasche dei pantaloni grigi, per poi estrarne una bustina bianca che appoggiò sulle ginocchia. La aprì velocemente e ne pescò una cartina, iniziando a posizionarci al centro il tabacco, concentrato nel fare qualcosa come mai lo avevo visto a scuola. “Ecco perché oggi sei particolarmente cinica” ghignò soddisfatto; passò la cartina sulle labbra per poi arrotolarla con un gesto secco, alzando innocentemente lo sguardo su di me, seduta sul davanzale della finestra che affiancava. Spostai lo sguardo dalle crepe che correvano sull’intonaco dell’angolo nell’aula a lui, accennando un sorriso forzato prima di mostrargli, poco educatamente , il mio dito medio - che come risultato ebbe unicamente l’aumentare della sua ilarità. “Calmate gli spiriti ragazzi” ci ammonì divertita Leanne, esuberante come suo solito, facendo il suo ingresso nell’aula abbandonata con una lattina di Coca Cola in mano. Si mise a sedere su un banco incrociando le gambe a mo’ di indiano, lanciando uno sguardo addolcito nella mia direzione ed ignorando prontamente Keaton. “Solo tu puoi bere questa roba alle dieci del mattino” la apostrofò lui, roteando esuberante come un bimbo sulla sedia, di quel orribile colore verde melma che era un pugno nell’occhio. Lei, dal canto suo, lo dileguò con un veloce gesto della mano; rivolse la sua attenzione in parte a me ed in parte ai suoi capelli di quel bellissimo colore aranciato che io adoravo troppo; iniziò ad allisciarli ossessivamente, passandosi la mano tra le punte alla ricerca di qualche inesistente nodo. In realtà non ero mai riuscita a comprendere lo scopo di quel gesto, e molto spesso mi domandavo se non lo facesse unicamente per la sua incomprensibile ricerca della perfezione in qualunque cosa facesse. In quel caso sarebbe stato spiegato l’assurdo scatto d’isteria che aveva avuto quando mi ero presentata a casa sua, nel bel mezzo di una Domenica mattina senza darle alcun preavviso, con le punte dei capelli blu. In seguito aveva tentato di tutto, per una buona settimana, pur di convincermi a tornare dal parrucchiere e farmi levare quel colore ‘osceno’ dalla testa. Dopo averci fatto l’abitudine, però, aveva deciso di abbandonare i suoi propositi iniziando a ritenerli perlomeno passabili ai suoi occhi critici. “Comunque, tornando alle cose serie” parlò finalmente Leanne, continuando a muovere insistentemente la linguetta della lattina di Coca Cola avanti e indietro, fissandomi. “Ho parlato con Tyreek poco fa. Ha detto che probabilmente Sabato dovrebbe aver bisogno di noi due; Hayden gli ha chiesto la giornata libera e non è certo di poter coprire il bar.” “Non può chiamare qualche suo amico?” intervenne Keaton, anticipandomi. Poggiò bruscamente una mano sulla mia coscia per reggersi all’impatto che la sedia ebbe non appena i suoi piedi inchiodarono violentemente a terra. “Perché dovete accorrere in suo aiuto ogni volta che vi chiama? Nemmeno vi paga, quello!” “Ti ricordo che è grazie a lui che hai l’ingresso libero ogni volta” borbottai, riuscendo ad entrare nella conversazione e dandogli un colpetto sulla mano. “E smettila di fare lo stronzo ogni volta.” “Devo ricordarti chi ti copre il culo dagli idioti, Ter?” sbuffò lui, rammaricato, lanciandomi un’occhiataccia di fuoco. “Se il tuo intento era quello di irritarmi, Keaton, sono felice di annunciarti che ci sei riuscito perfettamente” ringhiai acida, cercando di non aggiungere altro sul ridicolo nomignolo che aveva usato, - che lui sapeva benissimo io detestassi trovandolo ridicolo e senza alcun senso – per non fare la figura della bimba infantile. “E, inoltre, nessuno ti ha mai chiesto di venirci, lì” s’intromise piccata Leanne, che era finalmente riuscita a staccare quello stupido pezzo di alluminio, concentrandosi seriamente su me e Keaton. “Scusa tanto se cerco di proteggere la mia migliore amica” ringhiò lui aumentando notevolmente il tono della voce; si alzò di scatto da quella stupida sedia, che a causa del gesto brusco cadde all’indietro facendo sobbalzare la rossa. Dopo la sorpresa iniziale si ricompose e tornò a fissarlo, infastidita. “Perché devi fare questo teatrino ogni volta, Keaton?” domandò, scuotendo con disapprovazione la testa. Lui boccheggiò qualche istante, quasi sconcertato dalla sua affermazione. “Teatrino? Davvero, Leanne? Teatrino?” A quel punto, quando notai i muscoli delle sue spalle tendersi, capii che se la conversazione fosse andata oltre sarebbe scoppiato - e vedere Keaton davvero arrabbiato non era esattamente un bello spettacolo. Tentai di ricacciare dentro il mio orgoglio, mentre allungavo la mano per appoggiarla delicatamente sulla sua spalla destra; speravo che si rendesse conto dell’assurdità della sua reazione e si desse finalmente una calmata. “No” urlò, scrollandosi bruscamente la mia mano di dosso, per piegarsi e afferrare il suo zaino da terra. “Vaffanculo!” “Tutte e due” sottolineò, lanciandoci un’occhiata a vicenda prima di camminare a passo spedito verso le scale d’emergenza, sparendo lentamente dalla nostra visuale. Mi morsi violentemente il labbro trattenendo l’impulso di corrergli dietro e prenderlo a sberle. Solo in quel momento iniziai ad assimilare ciò che era realmente successo tra di noi. Mi passai una mano tra i capelli, tirandoli leggermente alla radice. Scesi dal davanzale, sotto lo sguardo attento di Leanne; prendendomi sotto braccio mi sorrise rincuorante, uscendo insieme a me da quella stanza ancora impregnata dell’odio che Keaton da solo era riuscito a sprigionare pochi istanti prima. “Mi dispiace, Carter” sussurrò, fissando il corridoio gremito di studenti. ____________________________
Mi buttai contro il seggiolino del dondolo, lasciando che la polvere prendesse forma attorno al mio peso. Lanciai un’occhiata dubbiosa al libro di storia dell’arte che avevo portato fuori con me, restia all’idea di dovermi mettere a studiare i due capitoli che la professoressa Hernandez ci aveva assegnato la settimana scorsa; stranamente, avevo il presentimento che appena lette le prime righe la mia mente sarebbe volata da tutt’altra parte. Portai comunque il libro sulle ginocchia e lo aprì sul capitolo che avrebbe dovuto interessarmi, restando ad osservare distrattamente il contenuto del testo – non credevo di ricordarne l’argomento. Erano all’incirca le sei e mezza, il cielo aveva iniziato a scurirsi e di Keaton non c’era nessuna traccia da quella mattina. In mensa non si era fatto vedere e all’uscita della scuola era salito in macchina con qualche ragazzo che non avevo mai visto ed era sparito alla velocità della luce, - il che voleva semplicemente dire che questa volta avrebbe impiegato più del solito per sbollire la rabbia, mettere il suo stupido ed inutile orgoglio da parte e chiedere scusa. Sia a me che a Leanne. Anche se avesse telefonato, comunque, non ero ancora certa che avrei risposto senza prenderlo a parolacce con l’eleganza che ha uno scaricatore di porto. La vibrazione del cellulare, sul cuscino di fianco a me, mi riportò alla realtà. Lo afferrai senza pensarci due volte, ignorando chi potesse avermi chiamata, portandolo all’orecchio e chiudendo lieta il libro. “Ti prego, dimmi che sapevi della sospensione di Keaton” borbottò affannata Leanne, senza darmi il tempo di dire anche solo ‘pronto’. “Keaton cosa?” per poco non urlai, strabuzzando gli occhi, con la mascella che un altro po’ e avrebbe toccato terra. “Pare che abbia avuto un ‘diverbio’ con Austin Wright, all’ultima ora” mi spiegò, e riuscì a sentire in sottofondo il letto scricchiolare, segno che si era alzata. “Tre giorni ciascuno, così almeno mi ha detto Camille.” “Non posso credere che sia stato così idiota da reagire alle provocazioni di quel cretino proprio a scuola” sussurrai, sistemandomi meglio sul dondolo, che si mosse leggermente avanti e indietro. “Si può sapere che cosa si sono detti?” “Nessuno ne ha idea per il momento” rispose lei. “Ma stai pur certa che per domani si saprà tutto, nei minimi particolari.” “Lo sai che domani il tutto sarà già stato ingigantito a dismisura” borbottai infastidita, lasciando correre lo sguardo dall’altro lato della strada, dove due ragazzi si tiravano il pallone in perfetta armonia. Aguzzai lo sguardo mentre Leanne iniziava a parlare dello sgambetto che aveva fatto a Rebecca Brown - la ragazza con cui il suo ex l’aveva tradita - senza accorgersi minimamente del mio completo disinteresse. Portai le gambe al petto e vi appoggiai sopra la testa, con lo sguardo ancora fisso sui due ragazzi che mi fronteggiavano; grazie alla villetta che troneggiava alle loro spalle - che poteva appartenere solo al signor Harding - ero riuscita automaticamente ad identificare suo figlio Ian, il ragazzo con i capelli biondicci. “Carter, mi stai ascoltando?” gracchiò Leanne nel mio orecchio, facendomi sobbalzare. Scossi la testa, ancora imbambolata, e tornai a prestarle un minimo d’attenzione - senza però mai perdere il contatto visivo con Ian ed il suo amico. “Si, si, certo. Jared. Continua pure” borbottai, ricordando vagamente che aveva accennato a quel nome una ventina di volte negli ultimi due minuti. Le bastò quella mia vaga risposta, come speravo, e riprese a parlare animatamente sprizzando gioia anche dal cellulare. In realtà non credevo di aver mai visto una persona che riuscisse a sorridere e parlare contemporaneamente più di lei. Ma per quanto mi sforzassi di trovare una qualche possibile spiegazione al suo costante ed elevato tasso di felicità non trovavo mai nessuna motivazione particolare, ed ero giunta alla conclusione che fosse così sin da quando era piccola. Non per niente in ogni foto che la ritraeva aveva sempre un enorme sorriso che le arrivava da un orecchio all’altro. “Hey, Carter” urlò qualcuno, di nuovo, costringendomi a tornare alla realtà. Controllai allarmata il telefono, scoprendo che Leanne continuava a parlare indisturbata, e che quindi non poteva essere stata lei a fare il mio nome. Passai in rassegna il vialetto di casa trovandolo vuoto come pochi minuti prima, quindi neanche mio fratello poteva essere stato. C L’unica opzione rimasta era quindi quella di alzare la testa e smettere di fare figuracce. Come se avesse potuto leggere i miei pensieri, Ian si sbracciava dall’altro lato della strada, salutandomi con un enorme sorrisone sulla bocca. Ancora imbarazzata sventolai la mano all’aria ricambiando sia il sorriso che il saluto; mi vietai categoricamente di urlare come lui il suo nome, invitandolo così a continuare la conversazione come se fossimo ad un mercato - con la differenza però che lì nessuno avrebbe fatto caso a noi. E quando Ian diede una gomitata al suo compagno per costringerlo a voltarsi, tornai a far finta di prestare attenzione alle parole di Leanne – pur rimanendo con gli occhi incollati alle figure abbronzate dei due. Il tipo con le scarpe rosse si voltò verso di me, fissandomi incuriosito, mentre Ian aveva ricominciato a passargli il pallone alternando il piede con il ginocchio. Da quella distanza riuscivo a distinguere vagamente i suoi capelli chiari, scompigliati e bagnaticci a causa del sudore, le labbra piene, le guance scavate e gli occhi di uno strano color nocciola. E nonostante non fosse esattamente il tipo di ragazzo che attirava solitamente la mia attenzione, potevo affermare con certezza di trovarlo estremamente bello – e dall’aria a me stranamente familiare. Fu il biondo il primo a distogliere lo sguardo, tornando a concentrarsi sul gioco di gambe che stavano facendo. Ian - come Leanne d’altronde -, avevano continuato a parlare per tutto il tempo. Dal canto mio, non riuscivo a staccare gli occhi da quel ragazzo misterioso, ancora avvolta dall’alone di mistero e al contempo familiarità che mi aveva lasciato sulla pelle in quei brevi secondi di contatto visivo. “Stronza, lo so che stai guardando quel figaccio del tuo vicino e il suo amico” borbottò Leanne, spaventandomi per il tono di voce accusatorio che aveva assunto. Inarcai le sopracciglia guardando lo schermo del cellulare. “Che diavolo stai dicendo?!” “Sono qui vicino a te, cretina” esclamò divertita, per poi scoppiare a ridere. Confusa e disorientata ispezionai con attenzione le mie spalle, l’entrata di casa e, per sicurezza, i cuscinetti vuoti del dondolo, prima di notare la figura snella della mia amica avvicinarsi sempre di più al vialetto di casa mia, ancora sorridente. “Smettila, idiota” bofonchiai, stringendo le mie cose ed alzandomi per andarle incontro, sentendo improvvisamente gli sguardi di Ian e il suo amico addosso. E per qualche strano motivo, non era una sensazione particolarmente piacevole. “Anch’io ti voglio bene tesoro, lo sai” mi sfotté lei, abbracciandomi velocemente prima di seguirmi all’interno di casa. “Bei pantaloni, comunque, coniglietta” A quelle parole mi fermai ad un passo dalla cucina, abbassando allarmata lo sguardo sulle mie gambe, fasciate da un enorme pantalone rosa con una alquanto imbarazzante fantasia a coniglietti. Oh cazzo! ___________________________________________________________________________ Author's corner: Okay, avevo detto che questo capitolo sarebbe stato più interessante, ma ho cambiato idea ed ho scritto di nuovo una cacatella lol Ma però, questa volta per davvero, giuro che nel prossimo capitolo inizierà ad esserci un pò di trambusto, diciamo, e sarà anche molto probabile che lo scriva dal punto di vista di Justin ouo Tralasciamo il fatto che in questo momento sono un pò rincitrullita visto che ho terminato una decina di minuti fa di ripassare l'intero programma di storia dell'arte dell'anno scorso, perchè sono certa che non appena quella vipera entrerà in classe al posto di dire un bel 'Ciao ragazzi, come sono andate le vacanze?' se ne uscirà con 'Buongiorno. In piedi. Seduti. Iniziamo con le interrogazioni' -.- quindi meglio prevenire che curare, no? Ma perchè vi sto annoiando diecndovi questo? Lasciatemi perdere va lol Anyway, tornando al capitolo,boh, c'è un primo strano litigio e 'l'incontro', chiamiamolo così, tra Justin e Carter e il suo piagiamino a coniglietti, che non ci crederete sto indossando anche io :') E poi boh, evviva Ed Sheeran fdshkd :3 Yay. Okay, mi dileguo. Sciao racazzuole(?) ☺♥ |
Capitolo 5
*** 4. Pain. ***
 4. Justin “Justin, per favore, cerca di lasciarmi spiegare” mi implorò per l’ennesima volta, con la voce bassa e impastata, facendo l’azzardato gesto di mettermi una mano sulla spalla.
“No” mi affrettai a scrollarmela bruscamente di dosso, sentendo la mia voce insinuarsi prepotentemente anche nelle mie orecchie, facendomi rabbrividire. “Non voglio più stare a sentire le tue stronzate, il mio limite è arrivato.” Mi abbassai al livello del letto, sfatto, e scostando leggermente il lenzuolo che sporgeva riuscì ad individuare la valigia che stavo cercando. La trascinai sul materasso, ignorando la coloratura grigia che aveva assunto a causa della muffa; la aprii il più velocemente possibile, scaraventandovi dentro il pacco di sigarette che avevo dimenticato sul comodino - come se quel gesto bastasse a farle capire che facevo sul serio, quella volta. “Tesoro, lo sai che posso sistemare tutto, lo sai che ne sono capace” riprese il suo discorso, accennando ad avvicinarsi ulteriormente. “Devi solo essere paziente ancora un po’, devi fidarti di me un’altra volta.” Mi scostai dal bordo del letto, giusto in tempo per evitare che le sue braccia tentassero di avere un altro approccio con me, sentendo poi il tonfo sordo con il quale - non riuscendo a reggersi ulteriormente in piedi - era atterrata sul letto, facendo rimbalzare anche la valigia. “Ma guardati, non ti reggi in piedi” sbottai improvvisamente, aprendo le ante del vecchio armadio in legno - scricchiolarono fastidiosamente a causa della poca cura ricevuta; iniziai ad afferrare quei pochi vestiti che vi tenevo ancora dentro, buttandoli dentro la valigia, scaricando in quei gesti tutta la mia rabbia. “Sei già ubriaca alle cinque del pomeriggio, cazzo. Come diavolo dovrei fare a crederti? Pensi che mi sia fottuto il cervello, per caso?” urlai quella volta, allargando il braccio destro e usando l’altro per scaraventare un pantalone dentro la valigia. “No, io con questa merda non ci voglio più avere niente a che fare!” “Justin, ti prego, non lasciarmi anche tu” continuò imperterrita nel suo, decisamente inutile, tentativo di tenermi a casa con lei. Cercò di darsi un minimo di dignità alzandosi la spallina della vestaglia leopardata che indossava - e che lasciava decisamente poco all’immaginazione. “Lo sai che è difficile per me, lo sai che ci sto provando per davvero, questa volta.” Afferrai un paio di scarpe nere, buttando anch’esse sopra il resto degli indumenti, lanciandole un’occhiata sprezzante. “Non abbastanza, a quanto mi sembra” ribattei acidamente, chiudendo l’armadio prima di fiondarmi con foga sul comodino dei boxer, bisognoso di avere altra roba tra le mani da lanciare - per non usare altri oggetti meno consigliabili. Lo aprii velocemente, notando con disappunto che era una di quelle parti che avevo già svuotato completamente, - come il cassetto sottostante dei calzini. E così come lo doveva essere il comodino che affiancava l’altra sponda del letto. Alzai lo sguardo, passando velocemente in rassegna la stanza, cercando di ricordare qualche possibile cosa che avessi dimenticato di prendere con me; ma l’unica cosa che i miei occhi riuscirono a scorgere fu la sagoma immobile e rilassata del corpo, molleggiato sul letto, di mia zia. Era così da sempre, con lei; sin dal primo giorno in cui avevo lasciato che mi spedissero a San Diego per viverci insieme. Quando ad aspettarmi in aeroporto, al posto di una bellissima donna quarantenne che la mia testa ricordava, avevo trovato gli avanzi di un dopo-sbronza mastodontica. E dopo l’infinitesimale quantità di ‘ti prometto che mi lascerò aiutare’ e di ‘è difficile, lo sai’ che erano usciti dalla sua bocca, che ormai sembrava vivere solo per quella stupida imboccatura delle bottiglie di alcolici che si scolava come fossero acqua, mi ero stufato. Mi ero stancato di alzarmi la mattina e trovarla priva di sensi sul divano - mezza nuda molto spesso -, circondata da preservativi e bottiglie vuote; mi ero stancato di rivestirla, farla stendere nel suo letto e prepararle quantità industriali di caffè ed aspirine per farla ‘stare meglio’. E se poi la vedevo uscire in uno di quei stomachevoli ‘vestiti’ - che nemmeno una quindicenne con il corpo di Beyoncè avrebbe osato indossare -, per poi rincasare con un aspetto che andava peggiorando di volta in volta, quello voleva solo dire che lei, di provare a stare meglio la mattina dopo, non ne avrebbe mai voluto sapere. E allora, io, di starci in quella merda che si trascinava dietro e che prima o poi avrebbe provato a convincermi non fosse così male, non ne volevo più sentir parlare. Mi passai una mano sulla faccia, distogliendo la mia attenzione da quella visione; infilai una mano nella tasca dei jeans e ne estrassi il cellulare, che proprio in quell’istante iniziò a vibrare insistentemente. Il nome di Blake era impresso a grandi lettere sullo schermo. “Ci sei?” domandai appena accettata la chiamata, ignorando i soliti preamboli ai quali le altre persone accennavano prima di arrivare al nocciolo della conversazione. L’unica risposta che arrivò alle mie orecchie fu un flebile mugugno d’assenso prima che la chiamata terminasse improvvisamente. Infilai il cellulare in tasca, guardandomi lentamente intorno alla ricerca anche di un solo e minuscolo motivo per il quale disfare quella valigia e non sbattermi quella porta dietro le spalle, definitivamente . Ma quando i miei occhi si soffermarono nuovamente sul corpo immobile, immerso nel sonno, di mia zia, tutti i dubbi che come sempre mi assalivano si volatilizzarono in qualche secondo, lasciando spazio alla fermezza che avevo usato nel prendere quella decisione - che quella volta avrei portato avanti. Mi chinai verso il letto, non curandomi di fare rumore visto che lei comunque non avrebbe sentito niente, chiudendo la valigia con un giro secco della cerniera. La poggiai a terra sulla mia gamba, per avere le mani libere di portare il lenzuolo sul suo corpo infreddolito, sistemandolo meglio che potessi così da tenerle caldo almeno fino a suo risveglio. Frugai tra i cassetti del bagno ed afferrai un pacco di aspirine, poggiandolo sul comodino di fianco al letto assieme ad una bottiglietta d’acqua. Infilai la mano sotto il manico della valigia e scesi il più velocemente possibile le scale, prima che quello stupido sentimento chiamato ‘compassione’ prendesse il sopravvento sulla mia razionalità e mi convincesse a restare. Sulla porta di casa afferrai la chiave che portavo al collo - che avevo fregato da sotto al tappetino all’entrata per riuscire ad entrare in casa quando lei mi ci chiudeva fuori per non essere vista con i suoi ‘fidanzati’ - , per poi staccarla con un gesto secco e rimetterla sotto allo zerbino bordeaux. Lanciando un’ultima occhiata all’enorme villa che mi stava di fianco, visibilmente poco curata dopo la morte dello zio, mi portai dinanzi al bagagliaio della macchina di Blake; aprendo il cofano ci gettai dentro la valigia prima di entrare in macchina, sui sedili posteriori che profumavano di fresco e menta. Allungai i piedi, per quanto mi fosse possibile, ed appoggiai la schiena allo sportello; lasciai scivolare la testa sul finestrino mentre con le mani tastavo la stoffa dei miei jeans, alla ricerca delle sigarette - che solo dopo ricordai avevo dimenticato in quella maledetta valigia. “Fanculo” bofonchiai frustrato, sporgendomi in avanti tra i due sedili in pelle; sottrassi a Blake il suo pacco di Merit, fregandogli due sigarette e l’accendino. “E’ okay, amico” tentò di rincuorarmi il moro, cercando di intravedere qualcosa della mia espressione attraverso lo specchietto retrovisore, che era contor0nato da una sottospecie di verme di peluche multicolore con la faccia più sorridente che avessi mai visto su un pupazzo. Annuì distrattamente - non preoccupandomi di assicurarmi se Blake mi avesse visto o no -, infilando la sigaretta tra le labbra e chiudendo gli occhi, sperando che ad avvolgermi, quella volta, fosse finalmente solo il nero. ________________________________________________________________ Appoggiai bruscamente la bottiglia di birra sul bancone, spaventando la ragazza dai capelli aranciati che me l’aveva servita poco prima. Mi lanciò un’occhiata ammonitrice, grazie alla quale mi accorsi del liquido che avevo fatto cadere sul piano in legno – e che probabilmente sarebbe stata lei a pulire. Ma di quello poco m’importava, sinceramente. Con altrettanta velocità schiacciai con il palmo della mano i soldi che le dovevo per l’ordinazione sotto il naso, e senza aspettare quei pochi spiccioli di resto che mi sarebbero spettati mi alzai dallo sgabello alla ricerca di un posto qualunque. Purché mi tenesse lontano da Jared e dalle sue frecciatine, che con l’aggiunta dei quattro o cinque bicchieri di drink super alcolici che aveva bevuto risultavano particolarmente irritanti. Senza nemmeno rendersene conto, mi stava con il fiato sul collo da quella mattina. Ma, nonostante ne avessi perfettamente intuito il motivo, non ero completamente certo che sarei riuscito a non esplodere fino al termine della serata; la massa di persone sudaticce e disattente che si spintonavano l’un l’altra di qua e di là, tra l’altro, non contribuivano di certo a migliorare la situazione. Sentì la voce di Jared dietro di me confondersi con il volume troppo alto della musica, che fece risultare ciò che stava dicendo un semplice mix di parole inesistenti. Il mio cervello offuscato dall’alcool, però, non ci impiegò molto ad ipotizzare almeno una parte di ciò che fosse uscito dalla bocca del biondo. Strinsi i denti contro l’urgenza che mi faceva desiderare di arrestare i miei passi e prenderlo a pugni lì in quell’angolo buio, dove quasi nessuno si sarebbe potuto accorgere di niente - e quei pochi che comunque ci avessero fatto caso avrebbero semplicemente pensato ad un’innocua scazzottata tra amici ubriachi. Nonostante sapessi che fosse solo ed unicamente grazie all’alcool che la piccola e remota parte di lui che credeva fossi stato uno stronzo ad abbandonare mia zia, fosse riuscita a prendere il sopravvento. Mi infilai tra un paio di ragazzine visibilmente fuori luogo, infrangendo prontamente il piccolo prototipo di catena umana che avevano formato nel stringersi l’una all’altra; non prestai nemmeno troppa importanza all’apparire uno stronzo patentato - anche perché quasi certamente lo ero stato; ma anche di quello m’importava ben poco. Lasciai la mia camminata assumere un’andatura più lenta mentre salivo la quindicina di scale in acciaio che portavano al piano di sopra, che doveva essere diventato una sottospecie di area fumatori. Lì ricordavo d’aver visto esserci vari balconcini quando, un paio di giorni prima, avevamo aiutato Tyreek a fare qualche modifica al locale. Dopo la partenza improvvisa di suo padre per Lisbona assieme alla sua nuova fidanzata Finlandese ed il cane di quest’ultima, Chanel, era stato lui ad assumere il ruolo del capo in tutto e per tutto. Infilai una mano nella tasca del jeans estraendone il pacco di sigarette e l’accendino giallo di Blake, che avevo dimenticato di restituirgli un paio di giorni prima; a pensarci bene, avevo perso di vista lui ed i ragazzi da un paio d’ore ormai. “Justin.” Sobbalzai leggermente nel sentire la voce di Jared così vicina a me. Lasciai scivolare l’accendino in una tasca a caso, lanciandogli una veloce occhiata. “Cazzo, Jared, dammi tregua” borbottai, senza alzare di troppo il tono di voce, sapendo che sarebbe riuscito in qualunque caso a sentire le mie parole. Voltandomi verso il balcone, pronto a mandarlo via anche a pugni se necessario, mi trovai costretto a bloccarmi sulla soglia. Osservai ammaliato la figura esile di una ragazza che sedeva sulla ringhiera del balcone, con una birra che faceva dondolare tra le gambe leggermente divaricate ed una sigaretta tra le labbra piene, tinte di viola. Scossi la testa lasciando fuoriuscire dalla mia bocca una piccola nuvoletta di fumo che s’infranse contro i suoi improbabili capelli, procurandole una smorfia appena accennata mentre con la mano sventolava l’aria di fronte al naso. “La mia vita non è affar tuo, Grant” continuai, poco disturbato dalla sua presenza lì in quel momento. Spostò i capelli scuri, assurdamente tinti di blu per metà della lunghezza, su una spalla, inclinando la testa in direzione di un punto aldilà della mia spalla dove sicuramente c’era ancora Jared. Potevo sentire il suo respiro pesante sulla nuca. “Nemmeno la mia lo era, Bieber” ribatté lui, acido. Riuscì a voltare la testa giusto in tempo per ricambiare l’occhiataccia rancorosa che mi aveva lasciato, prima che girasse i tacchi e sparisse tra la folla. Nonostante ciò, la dura consapevolezza che lui avesse effettivamente ragione si fece largo un istante dopo in me, lasciando indietro rabbia ed irritazione. Ma io ero troppo orgoglioso e lui troppo ubriaco perché una nostra eventuale e successiva conversazione potesse definirsi effettivamente tale, perciò non lo rincorsi come lui aveva fatto con me. Sbuffai rumorosamente passandomi una mano tra i capelli, sentendomi addosso lo sguardo di Carter. Ricordavo perfettamente quando ieri Ian me l’aveva indicata, seduta su un dondolo in un ridicolo - e alquanto adorabile su di lei - pigiama a fantasia di coniglietti. Ricordavo come mi fosse sembrata dannatamente bella e tenera con le guance rosse per l’imbarazzo. E ricordavo perfettamente la sensazione che mi aveva lasciato addosso, come se l’avessi già vista, come se la conoscessi da tempo. Una sensazione di familiarità che mi aveva seguito per le ore successive sino a quando non l’avevo ricordata: Carter Harvey. La più piccola degli Harvey. La sorellina stronza di Dante, dannazione. Lì, nel realizzare ciò, mi ero reso conto che la mia permanenza a San Diego si sarebbe prolungata più del previsto. All’improvviso l’atmosfera serena e rilassante che avevo trovato sul quel balconcino assieme alla piccola Harvey dai capelli blu si guastò, costringendomi ad abbandonare il ricordo. Il rumore dal piano inferiore arrivò improvvisamente, come un lampo a ciel sereno, alle nostre orecchie; quelle che inizialmente avrei potuto scambiare per risate di qualche ragazzino che non reggeva abbastanza l’alcool, in seguito si rivelarono per ciò che erano in realtà - grazie alla musica che stava diminuendo gradualmente: urla. Carter strabuzzò gli occhi lasciando che il collo della bottiglia di vetro le scivolasse tra le dita, rotolando vicino alla punta delle mie scarpe. L’istante dopo sentì il suo corpo oltrepassarmi velocemente diretto verso il punto in cui si concentrava la maggior parte della ressa. “Che diamine di intenzioni hai, eh ?” le urlai dietro capendo al volo quello che stava pensando davvero di fare, iniziando - per qualche indefinito ordine da parte del mio cervello - a seguirla giù per le scale, costretto a saltarne tre alla volta per non rischiare di perderla in mezzo alla folla. La maggior parte delle ragazze si stava rifugiando, chi abbracciata alla propria borsa, chi all’amica e chi alla prima persona o cosa a portata di mano, ai lati della pista. Nel frattempo una folla di persone - uomini precisamente - continuavano a spingersi l’uno contro l’altro come onde del mare sugli scogli, provocandosi con spintoni e piccoli schiaffetti che sapevo perfettamente in cosa si sarebbero trasformati di lì a pochi istanti. “Justin. Diavolo, amico, dove cazzo vuoi andare?” mi urlò allarmato Sal, piazzandosi completamente di fronte a me e spezzando la linea visiva che avevo tenuto per tutto il tempo con il corpo di Carter - che adesso avevo perso. “Dannazione, Sal” urlai, cercando di sorpassarlo. “Lasciami passare, cazzo!” “Devo ricordarti che cazzo è successo l’ultima volta che ti sei immischiato in cose che non ti riguardavano?” mi ringhiò lui in risposta, poggiando la mano sulla mia spalla, stringendola più forte che riuscisse per cercare di farmi stare fermo. In quel momento, però, non riuscivo nemmeno ad assimilare correttamente ciò che mi stava urlando, perché l’unica cosa che riuscì a cogliere fu un pugno in aria ed il corpo di un uomo dai capelli scuri arretrare di qualche passo, barcollando. Questo si riprese qualche secondo dopo, scuotendo la testa prima di stringere le mani, pronto a contrattaccare; e lo avrebbe davvero fatto, lo sapevo, se non fosse stato per il corpo piccolo ed esile di quella stupida ragazzina dai capelli blu che si frappose tra di loro. Urlò qualcosa, lanciando ad entrambi occhiate rabbiose, probabilmente sperando che ciò bastasse per calmare gli spiriti. Questo non sembrò funzionare perché un istante dopo varie urla riempirono l’aria ed un ragazzo dai capelli biondi, sui venticinque anni, e che mi risultava vagamente familiare, si fece avanti con il braccio teso e le mani strette. E poi tutto successe talmente in fretta che dovetti sbattere gli occhi un paio di volte prima di riuscire ad assimilare che l’urlo di dolore che aveva gelato l’aria fosse di Carter. I Carter che in quel momento era distesa a terra, con la testa girata di lato e il volto coperto dai capelli, mentre la folla ricominciava a spintonarsi, questa volta con più decisione ed ignorando la ragazza. “Cazzo, lasciami Sal. Lasciami” urlai, divincolandomi dalla sua presa, ed iniziando a correre verso il punto in cui era ancora immobile lei. Capì che Sal aveva seguito il mio sguardo, comprendendo la situazione, solo quando lo udì urlare a gran voce i nomi di Ian, Tyreek, Sal e Blake. Ma oltre a ciò non riuscì a sentire nient’altro mentre mi fiondavo sul corpo inerme di Carter, piegandomici sopra per accertarmi delle sue condizioni. E feci probabilmente il miglior gesto avventato della mia vita perchè nello stesso istante un ragazzo inciampò all’indietro, rotolandomi sulla schiena mentre atterrava con una scarpa sulla mia mano, calpestandola. Mi morsi il labbro trattenendomi dall’alzarmi e prendere a pugni chiunque mi capitasse sotto tiro, rimettendomi in piedi e trascinando Carter con me. La avvolsi con entrambe le braccia facendomi spazio attraverso un paio di ragazze che ci guardavano - visibilmente preoccupate; la portai dietro al bancone della zona bar, dove la feci sedere su una sedia mal ridotta. Iniziai ad aprire ogni cassetto o anta alla ricerca di un qualche strofinaccio, che trovai qualche attimo dopo appeso su un chiodo al muro. Lo aprì per bene afferrando poi il contenitore del ghiaccio e buttandocelo sopra, in abbondanza, richiudendolo con un nodo. “Mettilo sulla guancia” ordinai alla ragazza, allungandole l’improvvisata ‘borsa del ghiaccio ’ - speravo che si decidesse finalmente ad alzare la testa e permettermi di osservare quando grave fosse il danno, anche se non ero completamente sicuro di volerlo sapere per davvero. Una cosa, però, la sapevo già: un gancio di quelli avrebbe lasciato il segno, e per un bel po’ anche. Carter afferrò prontamente ciò che le stavo porgendo iniziando a tamponarsi il volto, ancora nascosto dai capelli, mordendosi le labbra per non lasciarsi sfuggire qualche gemito di dolore. In realtà, non si era lasciata sfuggire niente; una lacrima, una smorfia di dolore o un qualche tipo di parolaccia contro il ragazzo che le aveva tirato il pugno. E io dovevo ancora capire se quello fosse un bene o meno. “Vieni” sussurrai, facendole segno con la testa di seguirmi. Iniziai a farmi largo tra le poche persone rimaste attaccate contro i muri, alla ricerca dell’uscita d’emergenza, che trovai quasi immediatamente dietro alle scale che portavano al piano superiore. Le aprì la porta e la condussi verso la macchina di Blake, continuando a farle scudo con il mio corpo; si appoggiò sul cofano, tenendo ancora l’impacco ghiacciato sulla guancia, fissandosi le scarpe bianche piene di borchie. Continuai ad osservarla, non sapendo cos’altro fare per lei; in realtà dovevo ancora capire per quale assurdo motivo avessi avvertito quell’urgente bisogno di impedire che qualcuno le facesse del male. Avrei cercato di aiutare qualunque altra ragazza si fosse trovata al suo posto, ovviamente, ma la rabbia e lo smarrimento che avevo provato nel vedere quel pugno colpirle la faccia, facendola cadere rovinosamente a terra, mi avevano sorpreso più di quanto mi sarei potuto aspettare. E davvero non ne capivo il motivo. Un rumore sordo, precisamente lo sbattere di una porta, mi fece sobbalzare costringendomi ad abbandonare il flusso dei miei pensieri; voltai la testa osservando stranito il ragazzo dagli occhi chiari avvicinarsi, barcollante e visibilmente ubriaco, con lo sguardo fisso sul corpo della ragazza che stava dietro di me. “Ter, Dio, che ti hanno fatto?” borbottò, incespicando nei lacci delle sue scarpe, tenendosi la pancia con la mano. E ne dedussi che sicuramente si conoscessero già, ma in quel momento non mi interessava; non volevo nessuno in mezzo ai piedi. “Senti, amico, è meglio che tu te ne vada” lo avvisai, indietreggiando di qualche passo così da coprirgli la visuale su Carter; le sentì stringere la mia maglietta, ma non riuscì a capire se per ordinarmi implicitamente di darmi una calmata o come cenno d'assenso nel volerlo mandare via. Non le avrei comunque dato retta, quindi perchè perdere tempo a cercare di capire? Il ragazzino scosse la testa, facendo qualche altro passo in avanti; continuava a borbottare di cose a prima vista insensate, alle quali però lui sembrava seriamente dare un senso logico. Era sbronzo marcio, e forse voleva solo fare il simpatico, o forse ancora non si rendeva nemmeno conto di ciò che stava facendo. Ma io mi stavo comunque innervosendo; sentivo che tutta la rabbia repressa per Jared, mia zia, Dante, quella serata, Carter, me stesso, stavano venendo lentamente a galla nonostante cercassi in tutti i modi possibili di fermare la sua avanzata. E prima che potessi anche rendermene conto la mia mano si alzò velocemente, scontrandosi con lo stomaco morbido del ragazzo, che si piegò in avanti per il dolore. Io iniziavo a sentirmi già meglio però, così riuscì ad impedire a me stesso di continuare il lavoro. Mi voltai verso Carter, che mi guardava a bocca aperta con un’espressione che era un misto tra rabbia ed irritazione. Quello con cui mi scontrai, però, mi lasciò senza parole: la sua guancia era gonfia e del colore del fuoco, le labbra avevano assunto lo stesso colore luccicante, anche a causa del sangue che le colava da un taglio sul labbro inferiore. Le gocciolava giù lungo il mento, per poi annidarsi sulla sua canottiera bianca, creando un contrasto di colore che mi diede alla testa. Impegnata però com’era ad ammonirmi con lo sguardo, non sembrò nemmeno accorgersi di quel ‘piccolo’ particolare. Probabilmente il biondino doveva essere il suo ragazzo, ma anche di quello mi importava ben poco. Volevo solo recuperare i miei amici, portare a casa la ragazza così che fosse al sicuro, e andare a dormire. “Entra in macchina” le ordinai, porgendole le chiavi. Sfilandole dalle mani l’asciugamano con il ghiaccio, lo portai sul suo volto. Con la mano libera estrassi il mio telefono dalla tasca dei jeans e glielo infilai in mano. “Dammi il tuo. Se hai bisogno di qualcosa o qualcuno ti importuna, chiamami e arrivo” aggiunsi. Passò qualche istante in assoluto silenzio, fissandomi la faccia come se stesse avendo a che fare con un fantasma. Quello però non era il momento di ricollegare il passato con il presente; ce ne sarebbe stato, di tempo, per domandarsi cosa diavolo ci facevo di nuovo nei paraggi. Stufo, infilai gentilmente la mano nella tasca posteriore dei suoi jeans – maledettamente aderenti, tra l’altro – facendola così ritornare bruscamente alla realtà. Le sfilai il telefono e, afferrando per il braccio il marmocchio, imboccai di nuovo il portone in metallo. “Entra in macchina e chiuditi dentro” le ordinai un’ultima volta, prima di rituffarmi nella confusione del locale. Alla prima occasione, abbandonai il suo amichetto su una ragazza dai capelli rossi, raccomandandomi di farci ciò che voleva. E solo dopo essermi liberato di quel peso, mi dedicai alla ricerca di Sal e gli altri. Qualcuno stava ancora cercando di opporre resistenza scalciando l’aria, mentre i buttafuori che finalmente si erano decisi ad intervenire avevano provveduto a liberare la pista, che in quel momento era occupata solo da qualche bottiglia rotta e un mazzo di chiavi abbandonato, stretto ad un portachiavi a forma di scarpa. Le finestre erano tutte spalancate e l’aria era diventata gelata, tutto il contrario del mio corpo ancora accaldato e contornato da un leggero strato di sudore, che rabbrividì improvvisamente; lanciai una veloce occhiata all’enorme orologio digitale appeso al muro che segnava le quattro del mattino, e spostai in seguito lo sguardo sul bancone, dove riuscì a scorgere ciò che cercavo, o meglio chi. Mi avvicinai velocemente incontrando lo sguardo di Ian prima di tutti. “Dov’è?” domandò, guardando dietro di me cercandola, mentre continuava a sorseggiare una birra ormai al termine. “Sta bene?” “E’ in macchina” risposi, afferrando un bicchiere pieno che Sal si rigirava tra le mani e bevendone il contenuto tutto in una volta, scuotendo la testa. “Vogliamo andare?” continuai, sbattendo il bicchiere sul bancone, facendolo tremare un po’ per l'impatto brusco e violento. Sal fu il primo ad alzarsi, facendo strisciare lo sgabello sul pavimento, seguito poi a ruota da Ian e Blake, che aveva un piccolo ma visibile graffio sul sopracciglio. Strinsi i pugni e accennai un saluto con la testa a Tyreek, che continuava a fare avanti e indietro mentre discuteva con un’agente, troppo nervoso per poter dire altro. Tutto quel casino solo perché una stupida ragazzina voleva fare l’eroina della situazione. E cosa ne aveva guadagnato? Metà faccia viola per una settimana, o nel caso peggiore, due al massimo tre. “Justin” mi richiamò Sal, facendo sembrare il mio nome più che altro una domanda incerta; mi posò una mano sulla spalla e la strinse tra le dita per convincermi. Eravamo ormai di fronte alla macchina, e da quella distanza riuscivo ad intravedere il corpo di Carter molleggiato sui sedili posteriori, con il cappuccio della mia felpa tirato su ed il cellulare stretto saldamente tra le mani. Sospirai rassegnato, passandomi una mano tra i capelli; sentivo che finalmente stavo iniziando ad assimilare ciò che realmente era accaduto nell'arco, non solo delle ultime ore, ma di tutta la giornata. Mi voltai verso Sal, mentre i ragazzi prendevano posto in macchina facendo attenzione a non fare troppo rumore nello sbattere le portiere - cosa vana ovviamente -, in attesa che mi dicesse ciò che doveva. Ma, quando finalmente si decise a parlare, iniziai davvero a sperare che non lo avesse fatto. “Era Travis, il ragazzo che l’ha colpita.” ________________________________________________________________________________________________ Author's corner: Okay, sono decisamente in ritardo, perdono. Avevo intenzione di pubblicarlo già Domenica, ma ho avuto problemi con la connessione, poi ieri è ricominciata la scuola e per colpa di un guasto al treno sono arrivata a casa decisamente tardi, ho mangiato e sono crollata, quindi eccomi qui, oggi, fresca come una rosa(?) lol Beh, in realtà anche adesso andrei un pò di fretta. E più che altro mi interessa sapere cosa ne pensate voi di questo capitolo(?) che è dal punto di vista di Justin, del quale abbiamo scoperto un altro pò ouo ovviamente come gli atri ci sono alcune cose poco chiare, ma con l'andare avanti dei capitoli, sperando, si chiariranno. E probabilmente, d'ora in poi, vista la scuola, dovrei aggiornare più che altro ogni fine settimana, tra Sabato e Domenica. E ci tengo a precisare che io sono assolutamente contro la violenza sulle donne, questa è solo una storia. Ora, però, devo davvero andare ç.ç E boh, che ve ne pare(?) Sciao ☺♥ |
Capitolo 6
*** 5. I'm happy to see you again, tiger. ***
 5. Carter Sentii un rumore sommesso riempire la mia camera, irrompendo bruscamente nel sogno che stavo facendo. Collegai il cervello senza però aprire gli occhi, cercando di capire se quel rumore fosse unicamente frutto della mia immaginazione o invece reale.
Impiegai qualche istante prima di rendermi conto che il cellulare stesse effettivamente squillando da cinque buoni minuti. Scostai il piumone nell’alzare la mano verso il comodino di fianco al letto, tastandone la superficie alla ricerca di quell’aggeggio che non smetteva di suonare. Quando lo trovai, qualche attimo dopo, lo portai sul lato della mia faccia che non mi doleva e ce lo appoggiai sopra con uno sbuffo. Chiusi gli occhi, aspettandomi per l’ennesima volta la voce squillante di Leanne. Lo aveva fatto – chiamarmi - nelle ultime cinque ore ad intervalli regolari di mezz’ora, quindi in quel momento dovevano essere all’incirca le nove e mezza dato che la sua ultima chiamata risaliva a trenta minuti prima. Ed io ero sempre più tentata di non risponderle più. “Ci sei?” mi richiamò la voce dall’altro capo del telefono, interrompendo i miei pensieri. E mi sorpresi di sentire una voce maschile. “Uhm … si?” mugolai, sentendo la guancia destra ricominciare pulsare fastidiosamente. Allungai la mano sul comodino ed afferrai la sacca del ghiaccio, avvolta in una maglietta, poggiandomela sulla faccia. “Spero che tu sia a casa, perché dovrei essere lì tra cinque minuti, più o meno” parlò ancora il mio interlocutore, sciuro che stessi capendo ciò che stava blaterando. Allontanai il cellulare dall’orecchio, richiudendo gli occhi a due fessure osservando confusa il mio numero apparire sullo schermo illuminato dell’iPhone che stringevo tra le dita; e che io ricordassi il mio cellulare non era né color oro né del valore di più di seicento dollari. Poi le immagini della notte precedente - o più che altro di un paio d’ore prima - tornarono a galla, susseguendosi come quelle presentazioni che i negozi di fotografia mettono in vetrina per pubblicizzare ciò che fanno e attirare nuova clientela. “Come diavolo hai fatto a sbloccarmi il telefono?” bofonchiai in risposta, passando le dita sull’enorme livido violaceo sul ginocchio, strizzando gli occhi non appena una fitta di dolore mi attraversò da testa a piedi. “Amici” rispose lui, semplicemente. “Ci vediamo tra qualche minuto” e riattaccò, senza lasciarmi controbattere. Lanciai il telefono sul cuscino che avevo di fianco e sospirai, sentendo la guancia ormai fredda; levai il ghiaccio e alzai il busto, guardandomi intorno, indecisa su cosa fare. Normalmente avrei avuto almeno la decenza di alzarmi, darmi una sciacquata alla faccia e rendermi perlomeno presentabile. Ma in quel momento, con metà faccia viola, non ne avevo esattamente voglia - e comunque il mio aspetto non avrebbe subito nessun miglioramento in qualunque caso, quindi perché prendermi tale disturbo? Dopo un altro attimo di esitazione, nel quale avevo iniziato a prendere seriamente in considerazione l’idea di tornare a dormire lasciandogli il cellulare sullo zerbino davanti alla porta, mi alzai dal letto. Infilai l’enorme felpa extra large che Keaton aveva dimenticato un paio di mesi prima - e che io non gli avevo ridato -, scendendo in cucina. Mi alzai sulle punte per prendere la macchinetta del caffè, mettendoci acqua e caffè in abbondanza prima di lasciarla sul fuoco in attesa che andasse ad ebollizione. Mi appoggiai sul divano, sintonizzando la Tv su un canale a caso, mentre raccoglievo il plaid rosa da terra e me lo avvolgevo intorno raggomitolandomi al bracciolo del divano. Era davvero il caso di fare un punto della situazione. Avevo litigato con Keaton, il quale da un certo punto di vista si era anche meritato il pugno che Justin gli aveva dato; si era scatenata una rissa nel locale e mi ero beccata un bel pugno in faccia da un energumeno che era quattro volte me, e Justin, Ian e altri due ragazzi che non conoscevo mi avevano aiutato. Infine, Leanne mi aveva svegliata alle sette per sapere come stavo e Justin, che rivedevo dopo un lasso di tempo molto lungo, stava arrivando per riprendersi il suo stupido cellulare da seicento dollari. La cosa peggiore, però, era che avrei dovuto trovare una veloce e credibile scusa per giustificare a scuola il color melanzana della mia pelle, non potendomi assentare per più di una settimana senza destare preoccupazione - ed io ero sempre stata una merda a raccontare frottole, sin dall’asilo. Raccontarlo a mio fratello, poi, sarebbe stata un’impresa dieci volte peggiore. E di certo non potevo salutarlo e dirgli, come se niente fosse, che avevo sbattuto la faccia contro la porta o un qualche palo mentre andavo a scuola; cosa che, tra l’altro, sarebbe potuta benissimo succedere visto il mio equilibrio che si poteva dire praticamente inesistente. Il rumore del caffè mi riportò alla realtà, nello stesso istante in cui dei colpetti alla porta si susseguirono velocemente, costringendomi a cambiare traiettoria ed avvicinarmi all’ingresso. Aprì la porta d’ingresso impedendomi di guardare il mio riflesso nello specchio che troneggiava sul muro, per non prestare attenzione allo stato obbrobrioso in cui mi dovevo sicuramente trovare. Questo fino a quando non incontrai la faccia - un mix tra stupore e spavento - che assunse Justin quando mi vide, spalancando la bocca in un piccolo e perfetto ovale. “Stai bene?” domandò preoccupato - lo sguardo fisso su di me -, mettendomi ancora più in soggezione di quanto non lo fossi nel trovarmi di fronte a lui nel mio enorme e giallo pigiama con la trama a scimmiette e banane. “Che c’è? Hai paura delle scimmie?” ribattei acida. Mi stropicciai gli occhi con le dita, ancora intorpidita dal sonno, sentendo i residui ruvidi del mascara attaccarsi alla mia pelle; ignorandolo mi diressi in cucina con l’unico obiettivo di bere il mio caffè bollente. Lui senza farsi problemi mi seguì, chiudendosi la porta alle spalle con un piccolo tonfo. Afferrai la tazza bianca sul ripiano della cucina e senza troppi convenevoli ne versai all’interno tutto il caffè possibile, senza la minima intenzione di chiedere al ragazzo che avevo alle spalle se ne gradisse anche lui. Ero troppo scombussolata per dare fondo al poco di bon ton che mi era stato insegnato da mia madre, e sinceramente fare quattro chiacchiere con lui non mi entusiasmava particolarmente - soprattutto in quel momento e nel mio stato, sia fisico che mentale. Quindi: prima si riprendeva il cellulare, prima andava via e prima io sarei potuta tornare a dormire. Senza aggiungere altro, notando Justin comodamente seduto su uno degli sgabelli bianchi che circondavano il tavolo al centro della stanza, uscì dalla cucina e mi affrettai a salire le scale per arrivare in camera mia - stando però attenta a non fare cadere il caffè mentre la tazza mi dondolava tra le mani. Aprì la porta della mia stanza e, fortunatamente, notai il cellulare in bella vista sulle lenzuola bianche, dove l’avevo lasciato prima; lo afferrai e tornai di sotto, trovando Justin nella stessa posizione in cui lo aveva lasciato, nella sua enorme tuta grigia, sembrando sprofondarci dentro. Mi fermai a qualche passo di distanza da lui e mi concessi una veloce occhiata al suo corpo, notando che dall’ultima volta che lo avevo visto, tre anni e mezzo fa più o meno, non era cambiato granché: i capelli erano sempre alzati all’insù, forse un po’ cresciuti, e il colore era sempre lo stesso color grano. Aveva messo su un po’ di massa muscolare in più, riuscivo a capirlo dal modo in cui la maglietta aderiva alle sue spalle. Era cresciuto di qualche centimetro e nel lembo di pelle libera, tra il naso e il labbro superiore, si intravedeva un leggero accenno di peluria che gli conferiva qualche anno in più rispetto alla ventina che doveva avere al momento - e che a mio parere non gli donava granché. Inoltre non sembrava aver perso il vizio di fumare, visti i due pacchetti di Marlboro che gli spuntavano dalle tasche del pantalone largo, che gli arrivava fino al ginocchio e al di sotto del quale scompariva un calzino lungo e bianco. Ed anche quella sua mania per i tatuaggi sembrava non essere sparita visto il suo braccio destro, dove la maglietta era arrotolata fino al gomito, e dove i tatuaggi sembravano fargli da secondo indumento per quanti ve ne fossero disegnati. Ne riuscivo a scorgere anche uno salire lungo il suo collo, fin sotto all’orecchio, in quello che doveva essere cinese o giapponese o anche un semplice scarabocchio, per quello che ne potevo scorgere. Ma comunque in quel momento gli somigliava in una maniera dannatamente impressionante e non riuscivo a non pensarci che al suo posto avrei tanto voluto ci fosse un’altra persona. “A te” borbottai, e presa da uno scatto d’ira - seppur non del tutto nei suoi confronti - poggiai bruscamente il telefono sotto la sua faccia, facendolo sobbalzare per lo spavento. Mi lanciò uno sguardo torvo prima di piegarsi con la faccia sullo schermo, iniziando a rigirarselo tra le mani, cercando qualche graffio o crepa - come se avessi potuto lanciarglielo dal balcone della mia camera. Raggirai il tavolo, afferrai il mio cellulare dal valore di novanta miseri dollari, e senza aggiungere altro tornai a raggomitolarmi sul divano. Puntai disinteressata lo sguardo sulla Tv, aspettando che lui si decidesse ad andarsene. Invece lo sentì avvicinarsi a me da dietro allo schienale del divano; riuscivo a vederne il riflesso nello schermo della televisione. Se si aspettava un ‘grazie’ uscire dalla mia bocca, in quel momento, avrebbe solo sprecato tempo. Non ero in grado di farlo e forse una parte di me, quella che vedeva il tutto dalla prospettiva di una Carter rancorosa ed arrabbiata, non pensava se lo meritasse per davvero. Tra l’altro lo avevo detto ad Ian quando, quella mattina presto, si era presentato davanti casa con una pomata per curare l’ematoma che avevo sulla faccia. Quindi, che lo dicessi all’uno o all’altro, doveva essere la stessa cosa. Più o meno. Dopo qualche minuto - che era passato sprofondando nel più totale silenzio da parte di entrambi - sentì il corpo di Justin muoversi verso la porta senza proferire parola, quasi fosse arrabbiato. Ma la persona che più di tutte poteva permettersi di essere arrabbiata e acida ero io. Così, prima che lui uscisse definitivamente da casa,- senza nemmeno sapermi spiegare il perché - lo richiamai, costringendolo a fermarsi. “Chi è Travis, Justin?” domandai impacciata, ricordando vagamente di aver sentito lui e i suoi amici accennare a quel nome in macchina, la sera prima. I quattro erano convinti che stessi dormendo, ma sarebbe stato oggettivamente impossibile farlo vista la delicatezza con la quale erano saliti nella vettura – che era parti a quella d’un elefante in una cristalleria. “Nessuno, non ti preoccupare” borbottò, lasciandomi uno sguardo schivo. Accennai un sorriso forzato verso di lui, al ricordo che quelle parole avevano scatenato nel mio cervello. “Lo diceva sempre anche Dante, di stare tranquilla” sussurrai, distogliendo poi lo sguardo e puntando la mia attenzione sul liquido nero che era avanzato nella tazza, facendolo vibrare con il mio respiro. “Ma poi è successo quello che è successo” La avvicinai alla bocca e lo bevvi in un sorso, lasciando sul fondo solo residui di zucchero ammassati. Sentivo la guancia ricominciare a pulsare, ma l’unica cosa che arrivò alle mie orecchie fu un flebile ‘lo so’ fuoriuscito dalle labbra di Justin prima che la serratura della porta scattasse, segno che se n’era finalmente andato via, lasciandomi sola. Ma lasciarmi sola, dopo un episodio del genere, significava solo lasciarmi libera di pensare. E ciò implicava automaticamente lasciarmi sprofondare nella consapevolezza più totale: ciò che era successo tre anni fa non era solo uno stupido incubo. E Dante non c’era più, da così tanto tempo, per davvero. E io non avevo voglia di ricordare. Così, svelta, mi alzai dal divano e mi catapultai in cucina lanciando la tazza nel lavandino, assieme a qualche altro bicchiere. Mi girai verso il tavolo – dove c’era la crema di Ian -, e con mia grande sorpresa vi trovai una bustina trasparente della farmacia, che sembrava contenere la stessa identica pomata dalla scatolina arancione che era poggiata lì di fianco. Allungai una mano e titubante ne estrassi il contenuto trovandoci dentro ciò che avevo immaginato, assieme ad una nuova e bruciante consapevolezza: Justin non era venuto per il suo stupido cellulare, non inizialmente perlomeno. Ma per portarmi quella crema. ___________________________________________________________________ Lo stato comatoso con cui vagavo per le strade poco trafficate di San Diego rispecchiava esattamente il mio stato d’animo. I miei capelli lunghi e crespi mi scivolavano sulla schiena, così come il pantalone di tuta informe e il maglione bordeaux della H&M, che mi aveva regalato Leanne, ormai scolorito dai troppi lavaggi. Avevo tentato, quel pomeriggio, di ripassare un altro po’ di storia dell’arte per l’imminente verifica che si sarebbe tenuta Mercoledì - e alla quale io non mi sarei potuta assolutamente permettere di mancare. L’unica cosa che ne avevo guadagnato era un colossale mal di testa e la riserva di caffè nella dispensa arrivata al capolinea. E quella consapevolezza era stata forse l’unica cosa che mi aveva convinta ad alzarmi dal letto e uscire alla ricerca di un qualche supermercato d’ultima categoria che fosse aperto anche di Domenica. Speranza vana, ovviamente, così ero dovuta risalire in macchina e viaggiare per una decina di minuti prima di trovare un bar non troppo affollato - e che facesse un caffè perlomeno decente. Sebbene l’unica cosa che ci avrei fatto con quel caffè, alle sette di sera, sarebbe stato abbandonarlo in frigorifero non appena rincasata. La verità era che avevo semplicemente bisogno d’aria fresca. “Ecco a lei” mormorò cordialmente il signore baffuto dietro al bancone, porgendomi la mia ordinazione con un enorme sorriso sulla faccia, coperto per la maggior parte dalla sua barba ispida e bianca. “Quanto le devo?” domandai, iniziando a frugare convulsamente nella borsa alla ricerca del portafoglio, prima che qualcuno non mi costringesse a fermarmi. “Pago io per lei” sussurrò un ragazzo dai capelli scuri che mi affiancava, sorridendo all’ uomo. “E un altro caffè corto per me” ordinò, levando gli enormi occhialoni scuri che gli coprivano metà faccia. Era bruno, con gli occhi piccoli e scuri come i capelli, pelle chiara, mascella leggermente squadrata e un enorme sorriso sulle labbra carnose e rosee mentre mi fissava visibilmente divertito. Mi sfregai la mano sul braccio destro mentre l’omone barbuto gli porgeva il suo caffè, con lo stesso identico sorriso che aveva rivolto a me in precedenza. Il ragazzo, decisamente bello, si voltò completamente verso di me con tra le mani anche la mia ordinazione, che mi stava gentilmente porgendo. “E’ un piacere rivederti tigre.” Wtiter's corner: Okay, come promesso sono qui ad aggiornare, ed anche a tempo di record oserei dire lol Anyway, tornando alla storia, il primo mistero è svelato: Justin e Carter effettivamente si conoscono di già, e qualcuna di voi potrebbe anche inturine il perchè almeno in parte. Secondo mistero: Carter e Dante sono fratelli, come qualcuna aveva inutito, ma per quanto riguarda quel famoso favore che Dante aveva chiesto a Justin ce ne vorrà ancora un pò. Terzo mistero: il ragazzo che le aveva fregato il caffè non era Justin, sorry OuO Come mio solito il capitolo non è molto 'limpido' (?) ma pian piano le cose verranno a galla ed inizieranno a farsi più interessanti, almeno spero lol E non credo ci sia altro da dire al riguardo, se non cosa ne pensate voi di come sta proseguendo la storia? Vi piace? O la trovate dannatamente merdosa(?) Probabilmente la seconda lol Ora, prima di dileguarmi, vorrei ringraziare davvero tanto quelle personcine tanto carine che continuano a recensire, io vi adoro gfdkh :3 Inoltre mi scuso per eventuali errori, ho riletto ma andavo un pò di fretta quindi probabilmente non ho notato qualcosa di sbagliato. E, infine, me la lasciate un recensioncina picolina anche qui se avete voglia(?) Ci rivediamo tra Sabato e Domenica , baci C. ♥ |
Capitolo 7
*** 6. He can hurt me yet. ***
 6. Carter Un’ora e mezza di detenzione.
Non riuscivo ancora a credere che Keaton ed i suoi stupidi aeroplanini di carta ripieni di scuse fossero riusciti a far imbestialire anche il professore di letteratura; e far perdere il controllo a uno che aveva il suo temperamento era davvero una grossa impresa, solitamente. Ma quella volta Keaton sembrava essercisi messo particolarmente d’impegno a rovinarmi la giornata - riuscendo anche, come ciliegina sulla torta, a trascinarsi dietro anche me. Ed avere quel bulldog della professoressa di trigonometria come sorvegliante alle tre e mezza del pomeriggio non era esattamente l’aspirazione di ogni studente - soprattutto se un Keaton parecchio insistente ti sputava nell’orecchio una montagna di scuse campate all’aria da una buona cinquantina di minuti. In realtà non riuscivo a capacitarmi di non avergli ancora lanciato addosso una sedia. Al di fuori dell’edificio si poteva perfettamente udire un temporale infuriare rumorosamente contro la città. Mi guardai intorno annoiata, continuando a scarabocchiare linee al centro del quaderno aperto che avevo sotto il naso. Le settantadue ore che si erano susseguite al piccolo scambio di parole con Justin, e che avevo trascorso tra casa e qualche eventuale passeggiata con Leanne e Baja, erano volate velocemente. E quel Mercoledì mattina non ero proprio riuscita a trovare una plausibile giustificazione da rifilare alla Hernandez per una mia eventuale assenza al suo compito. Il quale, tra l’altro, avevo svolto - con mio grande stupore - magnificamente. Ero riuscita, con quintali di fondotinta e cremine simili - che io davvero non avevo mai saputo sopportare - a camuffare e far passare il mio ematoma per un piccolo ed innocuo livido causato da una mia caduta dal letto. Perlomeno era quello che volevo fare credere alle persone che quella sera non erano presenti; per il resto la voce s’era già sparsa come un virus per i corridoi della scuola. Ma se avessi dovuto fare un quadro generale della giornata, tralasciando ovviamente la punizione, il risultato finale non era così grave come mi ero immaginata. Ma la continua insistenza di Keaton nel volermi parlare, visto che lo stavo ignorando dal ‘contrattempo’ avuto al Sanyo, stava mettendo a dura prova la mia sopportazione nei confronti della sua presenza. Ero consapevole che l’accaduto non fosse colpa sua ma se si fosse evitato quella scenata a scuola e non avesse deciso di scolarsi un’infinita quantità di alcool probabilmente io in quella rissa, nel quale come un cretino s’era fatto coinvolgere, non ci avrei messo il dito. E di conseguenza probabilmente avrei evitato sia un bel destro in piena faccia sia l’attenzione di Justin - che non avevo ancora nemmeno ringraziato. In effetti non avevo rivisto né lui né Ian dopo quella mattinata; mi ero anche affacciata spesso verso l’enorme struttura di casa Harding, trovandoci solo il padrone di casa che parlava al telefono da uno degli enormi balconi. O spesso la sua compagna biondissima impegnata a curare le sue amate rose gialle. Del figlio nessuna traccia, ma alla fin fine la cosa non doveva suonarmi così strana: Ian era solito fare queste piccole gitarelle con gli amici fuori città o in montagna, infischiandosene altamente del cumulo di assenze che il suo nome, sul registro di classe, si portava dietro. Era comunque un ragazzo brillante, avevo constato frequentando alcuni corsi insieme, e automaticamente ai professori andava bene così. D’altronde, il padre era uno dei maggiori finanziatori della scuola, quindi preferivano farsi gli affari loro - nonostante lui fosse un uomo davvero affabile e difficilmente influenzabile dai possibili capricci di suo figlio. La famiglia Harding, anche dopo il divorzio dell’uomo con l’ex moglie nonché madre biologica di Ian, Samantha, era l’incarnazione della famiglia perfetta. “Lo sai che non potrai continuare ad ignorarmi per sempre, Ter” mugugnò con disappunto Keaton. Rigirò rumorosamente la sedia nella mia direzione sedendocisi sopra a cavalcioni; concentrò tutta la sua attenzione su di me, anziché sull’irritata professoressa che lo stava praticamente uccidendo con lo sguardo, da dietro alla sottile montatura degli occhiali beige che le rimpiccolivano il volto pallido. Assottigliai gli occhi distogliendo l’attenzione dai miei pensieri, imprimendo più forza sulla matita. “Davvero?” accennai con sarcasmo, lanciandogli una veloce occhiata. “Perché è quello che ho intenzione di fare.” Era praticamente una routine ormai quella mia e di Keaton; Tyreek chiamava me e Leanne ad aiutarlo al locale, lui s’imbestialiva,litigavamo, poi si presentava al lavoro per tenermi d’occhio e ci mettevamo un po’ di tempo per smaltire la rabbia. Poi, tutto tranquillo e normale. Come se niente fosse successo. Ovviamente non era sempre stato così; quando la cosa avevo preso inizio Keaton era molto tranquillo al riguardo e, anzi, approfittava anche dell’ingresso gratuito per divertirsi con qualche ragazza - sempre però senza perdermi di vista. Le cose erano degenerate quando, una sera di luglio qualche giorno prima del mio compleanno, un ragazzo che reggeva decisamente male l’alcool aveva dimostrato uno strano interesse nel chiacchierare con me. Non ci avevo dato molta importanza, e così anche Keaton, quindi nel momento in cui Kyle - così si chiamava il ragazzo - s’era offerto di aiutarmi a prendere altre bibite nella cella frigorifera dietro al locale avevo accettato senza pensarci. Anche perché quel giorno Leanne era rimasta a casa con la febbre. Le cose, a quel punto, avevano iniziato a prendere una brutta piega: Kyle aveva tentato un approccio più spinto nei miei confronti, con la convinzione che solo perché ci eravamo scambiati qualche parola potesse ritenermi attratta in quel senso da lui. Quasi come se lo avessi esplicitamente invitato a saltarmi addosso. Aggiungendoci poi che anche allora non ero esattamente un tipo di ragazza che si fa mettere i piedi in testa da un ubriacone qualunque, avendo avuto a che fare, purtroppo, con qualcuno simile per ben otto anni, la situazione stava sfuggendo dalle mani ad entrambi. Fortunatamente Keaton era in modalità amico-super-geloso da quando ci conoscevamo quindi non era stato difficile per lui fare due più due e correre così ad aiutarmi. Da quel giorno era diventato leggermente più apprensivo nei miei confronti e quindi aggiungendo alla storia l’episodio di Sabato sera potevo giurare che le sue reazioni sarebbero andate peggiorando ad ogni chiamata di Tyreek. D’altronde non potevo biasimarlo. E nonostante mi desse davvero fastidio il suo essere protettivo, non riuscivo a smettere di ringraziare chissà chi, ogni giorno, di averlo al mio fianco. “Ouch, questa tua indifferenza mi spezza il cuore Ter” ridacchiò portandosi teatralmente una mano sul petto, calcando la voce, di nuovo, sul mio ridicolo diminutivo - a lui sembrava piacere particolarmente quel giorno. Gli colpì silenziosamente il braccio, non riuscendo a trattenere un sorriso divertito. “Smettila di fare l’idiota, la Gutierrez ti sta trucidando con lo sguardo.” Roteò gli occhi, accentuando con la fronte il piccolo taglio che vi si era cicatrizzato sopra. “Che si facesse una bella scopata quella e mi lasciasse in pace” bofonchiò infastidito, senza nemmeno tentare di non farsi sentire. Non gli era mai andata a genio quella professoressa, soprattutto da quando aveva saputo che era imparentata con la sua ex ragazza - io ci aggiungerei anche un bel stronza o zoccola come definizione - , Rebecca. Ridacchiai silenziosamente, portandomi una mano alla bocca per cercare di camuffare la mia espressione - sentendomi ancora addosso lo sguardo della donna. Richiusi il quaderno e lo infilai nello zaino, assieme al borsellino dopo averci rimesso dentro gomma e matita. “Così finirà che ti farai detestare ancora di più” lo rimbeccai, alzandomi dalla sedia e appoggiandomi con il sedere al banco, con Keaton di fronte che si aggiustava lo zaino sulla spalla. “Io invece credo che se andassi a dirle cosa la sua nipotina ha fatto con quello stronzo di Jared a quella festa, nei bagni, non le starei poi così antipatico” rispose scrollando le spalle. Lanciò un veloce sguardo all’orologio appeso sopra la testa della professoressa, cosa che feci anch’io costatando che mancassero circa tre minuti prima che la campanella suonasse. Scrollò le spalle e allungò lentamente una mano verso di me, appoggiandola sulla mia guancia e iniziando a massaggiarla delicatamente con il pollice. “Mi dispiace così tanto Carter. Mi sento una merda ogni volta che ti guardo” sussurrò abbassando notevolmente il tono di voce, così che lo sentissi solo io; accennò un sorriso amaro alla mia pelle tumefatta sotto il trucco. “Lo sai che t’ho già perdonato per aver fatto il cretino al locale” ammisi, cercando di confortarlo. Detestavo sapere che quel velo di tristezza che aveva coperto i suoi occhioni azzurri fosse a causa mia. “E mi dispiace per non aver fermato Justin dal colpirti senza alcun motivo” aggiunsi, sentendolo irrigidirsi al mio fianco. Scosse la testa, voltando lo sguardo verso la porta che era stata aperta da un ragazzo bassino e con i capelli biondi e lunghi. “Lo sai che tengo troppo a te per fare l’indifferente davanti a certe cose” esclamò, e quasi non riuscì a sentire le ultime parole quando la campanella trillò inaspettatamente, facendoci sobbalzare. Mi mise un braccio attorno alle spalle e mi trascinò fuori dall’aula, impedendo alla professoressa di passare per prima. “Smettila cretino” ridacchiai, stringendomi ancora di più al suo fianco per non sbattere contro uno dei ragazzi che avevano iniziato a correre verso l’uscita per sorpassarci. Keaton accompagnò qualcuno di loro con qualche parola poco carina mentre con il braccio destro frugava distratto nella mia borsa, probabilmente alla ricerca dell’ombrello. “E con quell’altro stronzo là me la vedo io” bofonchiò visibilmente irritato, strattonandomi dalla spalla per farmi fermare. Aprì la borsa bruscamente e qualche istante dopo ne estrasse fuori un ombrellino a pois bianchi e neri, sorridendo soddisfatto. “Preferirei evitare altre risse per un bel po’ ” lo rimbeccai, stringendogli la felpa. Di risposta lui annuì con la testa, guardando un punto fisso di fronte a lui. Incuriosita, e quasi sicura ci fosse Rebecca, voltai la testa e seguii il suo sguardo prima di imbattermi nella figura incappucciata di … Justin. Era appoggiato con la schiena ad un enorme SUV nero parcheggiato sul ciglio della strada, incurante della pioggia che stava scendendo sul suo corpo a fiotti. Afferrò la sigaretta dalle labbra e lo vidi voltarsi alle sue spalle, mentre il finestrino del passeggero si abbassava e ne spuntava fuori la testa biondiccia di Ian; gli sussurrò velocemente qualche parola prima che gli occhi di entrambi si puntassero su di me. Justin mi fissò neutro per qualche istante, alzando e abbassando le pupille sul mio corpo qualche istante, prima di alzare il dito e muoverlo verso di se, intimandomi esplicitamente di andare da lui. Mi passai la mano sotto ai capelli e lasciai le mie dita giocherellare con la chiusura dell’orecchino mentre rimuginavo sul da farsi. In realtà in quel momento non avevo una gran voglia di parlarci e non riuscivo davvero a trovare un valido motivo per eseguire i suoi ordini ed andare da lui - nonostante la sua espressione non promettesse niente di buono. In più per quanto ricordassi noi due non avevamo nessun tipo di discorso in sospeso per cui lui si potesse presentare davanti scuola alle quattro del pomeriggio. E probabilmente intuì anche lui la mia riluttanza nell’avvicinarmi perché dopo aver parlato qualche altro secondo con Ian quest’ultimo spuntò fuori dalla macchina e con una piccola corsetta me lo ritrovai davanti, con un enorme e rassicurante sorriso stampato in faccia. “Hey Carter” mi sorrise, sventolando la mano in aria. Di tutta risposta accennai un sorriso e incrociai le braccia, abbastanza curiosa di vedere con quale stravagante scusa m’avrebbe convinta a seguirlo. Ma, invece, mi sembrava piuttosto convinto nel non voler aggiungere altro se non quel breve saluto. Continuò semplicemente a fissarmi, alternando lo sguardo tra me e il ragazzo che avevo di fianco - che sembrava fare lo stesso. “Senti, Keaton, tu vai. Mi accompagna Ian a casa, ci vediamo domani” sbuffai lentamente, roteando gli occhi. Non sapevo esattamente spiegarmi perché avessi ceduto così in fretta; forse un po’ per il freddo, un po’ per la pioggia e un altro po’ perché morivo dalla curiosità di sapere cosa diavolo volesse Justin. Perché lo sapevo, ne ero certa, che quello che dovesse parlarmi era lui e non qualcun altro. “Carter..” provò a protestare Keaton, sciogliendo l’abbraccio sul mio corpo. Mi lanciò uno sguardo interrogativo ma mi imitai a schioccargli un rumoroso bacio sulla guancia prima di affiancare Ian e correre verso il SUV, con la pioggia che mi entrava nei pantaloni a cavallo basso che stavo indossando in quel momento. Li sentivo pesarmi sempre di più sulle gambe. “Tu.” Mi urlò contro Justin , non appena la distanza che ci divideva si accorciò a qualche metro. “Che cazzo t’ha detto Wes?” continuò, puntandomi un dito contro non appena riuscì, affannata, ad affiancarlo. Fumava dalla rabbia, lo si poteva notare lontano miglia dal modo in cui le sue narici erano dilatate e le sue gote arrossate. Lo guardai stranita, inclinando leggermente la testa. “Meglio che entriamo in macchina” s’intromise Ian, spingendomi gentilmente sui sedili posteriori, mentre lui affiancava Justin. Wes. Wes. Wes. Certo! Boccheggiai qualche istante, strabuzzando gli occhi quando una lampadina s’accese nella mia testa. Din. Din. Din. “Cazzo. Tu sei lo stronzo che mi ha fottuto il caffè” sbottai improvvisamente, facendolo quasi sobbalzare , ricordando perfettamente dove avevo già visto quegli occhialoni scuri che gli coprivano la faccia. Ma soprattutto dove avevo già sentito qualcuno chiamarmi in quel modo osceno. Tigre. Dio, era terribile perfino pensarlo. Gli strappai il mio caffè dalle mani, sentendone il liquido all’interno del bicchiere sbattere leggermente. Il ragazzo ridacchiò divertito, scuotendo la testa. “Ecco il resto” ci interruppe per qualche breve istante l’omone barbuto, dandogli gli spiccioli con un ghigno sulle labbra screpolate e nascoste dalla barba. “Ha già ordinato?” continuò poi, rivolgendosi ad un altro cliente. “Mi spiace per il nostro precedente ‘incontro’ ” affermò il ragazzo, mimando le virgolette sull’ultima parola con le dita, prima di tendere gentilmente la mano aperta verso di me. “Sono Wes, comunque. E mi spiace averti rubato il caffè, andavo di fretta ed ero parecchio irritato quel giorno” Inarcai le sopracciglia, stringendogli comunque la mano. “Nessun problema” mentì, evitando di proposito di dirgli il mio nome. In realtà avevo ancora un pizzico di voglia di prendergli quel dannato bicchiere dalle mani e versarglielo in testa, nonostante i suoi occhietti azzurri tentassero di trasmettermi tutto il suo presunto dispiacere. Ma sapevo che non era così; lo si capiva dal modo in cui le sue labbra erano arricciate all’insù. Comunque non m’importava, si poteva sempre giocare in due a quel giochetto. La suoneria rumorosa del mio cellulare mi costrinse a distogliere per un momento lo sguardo da Wes, così doveva chiamarsi, giusto il tempo necessario per leggere sullo schermo il nome di Elia e convincermi che era davvero arrivato il momento di tornare a casa. Appoggiai il cellulare sotto l’ascella e voltai nuovamente lo sguardo verso il moro, sorridendogli. “Non credo di aver voglia di dirti il mio nome” sghignazzai, iniziando a percorrere il breve tratto che mi separava dalla porta. “Ma comunque grazie per il caffè, eh, Wes.” “Diavolo, ti sei imbambolata?” urlò Justin, sbattendo le mani contro il volante. Sobbalzai sul sedile, riscuotendomi da quelle immagini e voltando confusa lo sguardo di fronte a me. Eravamo fermi dinanzi ad un semaforo rosso, con la pioggia che riempiva i finestrini. Justin doveva avermi posto sicuramente qualche altra domanda, che io mi ero prontamente persa facendogli perdere, a sua volta, la pazienza. Ma ancora non capivo dove volesse andare a parare con quella domanda, anche perché non ricordavo d’averlo visto nelle vicinanze di quel bar, sia quando vi ero entrata sia alla mia uscita. Probabilmente però, anche se ci fosse effettivamente stato, io ero comunque troppo impegnata a litigare con Elia per rendermene conto. Il fratello di Leanne, Cole, non aveva perso tempo nello spifferargli del mio piccolo ‘incidente’ al Sanyo. Avevo dovuto passare una buona mezz’ora al telefono per convincerlo a restare a New York per terminare la sua vacanza con gli amici e non fargli prendere il primo aereo per San Diego - nonostante la parte egoista di me, che era anche la maggioranza, avrebbe voluto mettere in scena un piccolo monologo strappalacrime per farlo tornare per davvero. Perché anche se non volevo ammetterlo mi mancava dannatamente tanto averlo in casa. “Carter.” La voce gentile di Ian mi riportò, nuovamente, alla realtà. Bofonchiai uno strisciato ‘scusa’ , tornando a guardare Justin. Aveva rimesso in moto la macchina e alternava lo sguardo dalla strada a me, nello specchietto retrovisore, in attesa di una mia risposta soddisfacente. “Non capisco cosa mi stai chiedendo Justin” esclamai, alzando gli occhi all’aria. “Pensavo non avessimo più niente da dirci.” “Beh, mi spiace per te, ma adesso dovrai parlare con me e dirmi che diavolo ci facevi con Wes in città” ripeté, scandendo lentamente e con irritazione le parole; come se lo stesse facendo con una bambina di cinque anni dura di comprendonio. Inviai uno sguardo d’aiuto a Ian che si limitò ad una scrollata di spalle esortandomi a rispondere. “Niente. Mi aveva fregato il caffè una o due settimane fa e l’ho re-incontrato per caso. Si è presentato, mi ha offerto il caffè e basta. Contento ora?” sbuffai, incrociando le braccia. “E nient’altro?” Ovviamente no, risposi da sola alla mia domanda vietandomi categoricamente di non mandarlo a quel paese istantaneamente e in maniera decisamente poco femminile. “Diamine Justin, io non voglio averci niente a che fare con quelle cazzate, tue e di Dante. Non farlo. Non mettermi in mezzo” ringhiai quasi, notando un istante dopo i muscoli delle sue braccia tendersi ulteriormente per chissà quale emozione tra rabbia e frustrazione. Ad essere sincera io sapevo decisamente poco del’amicizia che legava mio fratello e Justin, ma se quest’ultimo conosceva quel tizio e provava così tanto interesse nei suoi confronti io non volevo saperne né il motivo né cosa potesse essere successo tra loro. M’importava decisamente poco. Doveva non fregarmene. “Stai tranquilla ..” Lo interruppi, sbattendo violentemente le mani sui sedili. “Non dirlo, cazzo. Non dirmi di stare tranquilla dannazione!” sbottai, sull’orlo di una crisi isterica. In quel momento mi ricordava terribilmente Dante, con i suoi modi da stronzo menefreghista cinico; e io detestavo che fosse così. Che una qualche parola o frase detta senza pensarci da una persona qualunque potesse ricollegare il mio cervello ai ricordi che avevo di lui e che non lo vedevano dietro alle sbarre. Lo detestavo perché nonostante a dividerci adesso ci fossero delle stupide assi di ferro lui riusciva lo stesso a farmi del male. Io lo detestavo per davvero Dante. E non potevo farci nulla. “Hey, Carter” di nuovo la voce gentile di Ian attirò la mia attenzione, sorridendomi dolcemente. “E’ tutto okay, uhm? Siamo arrivati a casa tua.” Annuì distrattamente, senza preoccuparmi di guardare se effettivamente fossimo davanti casa; e se così non fosse stato poco m’importava. “Okay” mugugnai, raccogliendo dai miei piedi la borsa e mettendomela in spalla mentre aprivo lo sportello, pronta a sentire con molto piacere, come mai nella vita, la pioggia addosso. Avvertivo lo sguardo di Justin bruciarmi addosso, ma mi imposi di ignorarlo. Sbattei la portiera poco delicatamente e quando sentì la sua voce richiamarmi seppi che lui era dell’idea contraria. “Che vuoi adesso?” Il finestrino si abbassò per metà e lui si sporse di poco dal suo posto, fissandomi. “Al mio paese si dice anche ‘grazie’ ” esclamò, quasi serio in faccia. Inarcai le sopracciglia, guardandolo a mia volta. Cos’era quello? Un pretesto per auto-convincersi che aiutarmi quella sera non fosse stata una gran cazzata? Bollente di rabbia, un po’ per lui, un po’ per la pioggia e un bel po’ per Dante, iniziai a percorrere il piccolo tratto di strada che mi separava dal portico di casa all’indietro, tenendo incollato lo sguardo su di lui, annuendo ritmicamente con la testa. Lo vidi inarcare le sopracciglia, confuso, e lanciare uno sguardo di spiegazione all’amico che di nuovo scrollò le spalle, tirandosene apparentemente fuori. La pioggia mi era entrata ovunque, anche negli anfibi argentati che indossavo, quando le mie spalle toccarono il legno freddo della porta di casa. Infilai le chiavi nella serratura e quando fui certa che la porta dietro di me fosse aperta accennai una sorriso nella direzione del biondo. “Grazie” accennai, facendo bene in modo di attirare ancora di più la sua attenzione - così che potesse vedere il mio dito medio allungarsi all’insù nella sua direzione. L’ultima cosa che vidi, prima di chiudere la porta e lasciarmici scivolare contro, fu lo sguardo iroso che mi lasciò. Fanculo. Tutti e due. *Sanyo: Sarebbe il nome del locale  Ayeee, whatssssss up? Okay, tralasciando la parte truzza di Bieber; I'm back, yo! So che avevo detto che gli aggiornamenti ci sarebbero stati ogni fine settimana ma purtroppo per tutta la scorsa settimana sono stata alle prese con un disegno, di Jhonny Depp, si perchè io voglio complicarmi la vita ovviamente lol, e che dovevo consegnare entro oggi quindi non ho avuto decisamente tempo. Anyway, tralasciando questi dettagli futili che non interessano a nessuno, torniamo a noi. Insomma, non so nemmeno io come definire questo capitolo lol E in realtà credo di essere anche troppo stanca per avere davvero qualcosa di sensato da dire al riguardo, ammesso che ci si possa davvero fare un commento su questa cacchetta :') Però volevo precisare che la parte in corsivo sarebbe una sottospecie di flashback di Carter che ha a che fare con l'incontro del tizio che le ha fregato il caffè, che si chiama Wes e che io immagino così, e che a quanto pare potrebbe avere a che fare con Justin e Dante ouo Ma ovviamente io non dico altro. E poi boh, ci sono queste piccole parti che spiegano un paio di cosine dei capitoli precedenti e questi pensieri che per la prima volta si vedono in Carter e che riguardano suo fratello, che ancora non si è capito cos'ha fatto lol E vabbè, in poche parole è una piccola merduccia, non so nemmeno se qualcuna è riuscita a leggerla sino alla fine. :') E ora, prima che questo spazio autrice diventi il più lungo della storia, e dopo aver ringraziato chi ha continuato a recensire gli scorsi capitoli, grazie♥, devo dileguarmi e andare a ripetere chimica ._. Ma me lasciate un recensione anche qui, che sia anche per dirmi che sto andando di male in peggio(?) lol Mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate, comunque. So, a Domenica, probabilmente. Sciao bele ☺♥ |
Capitolo 8
*** 7. I'm a disaster. ***
 7. Carter Affondai la testa nel mio armadietto, osservando distrattamente il disordine che vi regnava sovrano all’interno, percorrendone ogni angolo alla ricerca del libro di storia. Quella notte non ero riuscita a chiudere occhio; un qualche gruppetto di ragazzi aveva deciso di appostarsi proprio vicino a balcone sul quale sporgeva la mia camera per fare chissà cosa, e non avevano levato le tende fin quando non mi ero affacciata minacciandoli con la mazza della scopa. Per non parlare poi del rubinetto in bagno che aveva iniziato a gocciolare e dell’orribile e pelosa gattina bianca dei vicini che aveva iniziato a miagolare, in un modo quasi osceno oserei dire, verso le quattro del mattino. Ero stata tentata di lanciarle contro qualche vaso ma poi, come se avesse colto le maledizioni che le stavo lanciando mentalmente, aveva smesso ed era scappata via. Quella mattina, poi, le cose sembravano andare peggiorando man mano che le lancette si avvicinavano al numero otto, che era l’ora in cui sarei dovuta presentarmi davanti scuola. Mi ero svegliata più stanca che mai e presa da uno scatto d’ira avevo lanciato il cellulare contro il muro per farlo smettere di suonare - e quindi riuscire a guadagnare altri cinque miseri minuti di sonno. Inutile dire che ci avevo impiegato meno di un nanosecondo a capire ciò che avevo fatto. Dopo essermi scaraventata fuori dal letto come una furia, per accertarmi che il danno non fosse grave quanto il mio cervello riuscisse ad immaginare, mi ero ritrovata con al posto della mano destra una sottospecie di scolapasta. E la maglietta che usavo per la notte - che nemmeno a farlo di proposito era di colore bianco -, schizzata di piccole goccioline rosse come se avessi passato la notte ad uccidere gente a caso. Per il telefono ovviamente non c’era poi molto che avessi potuto fare se non gettarlo nella spazzatura. Il peggio, però, sarebbe arrivato all’incirca verso mezzogiorno, con me ancora rinchiusa tra le quattro mura della mia classe di arte mentre Elia faceva il suo ritorno a casa. Solo allora si sarebbe scontrato con il pavimento della mia camera ancora sporco di sangue e la maglietta, in egual modo, nel lavandino a mollo nell’acqua. Avrebbe dato di matto. Potevo già immaginarmelo. E la cosa da un certo punto di vista mi avrebbe divertita particolarmente, se solo non mi fossi trovata con una mano dolorante e stretta come un salsicciotto nella fasciatura che avevo improvvisato in due minuti. Mi era già bastato far parlare di me per quell’enorme macchia viola, ormai tendente ad un bluetto, sulla faccia; non volevo la gente iniziasse a spargere ulteriori voci sul mio conto. Ma sapevo sarebbe stato inevitabile che questo succedesse e prima di uscire definitivamente di casa avevo seriamente preso in considerazione l’ipotesi di scrivere da qualche parte - facebook, whatsapp, sulla porta di casa, su qualche mio indumento o ancora meglio sulla mia fronte – il perché della mano mal ridotta. Giusto per chiarire le cose. Ma ero troppo pigra a prima mattina per fare una cosa del genere e che richiedesse un tale sforzo mentale, soprattutto dopo la notte insonne che ero stata costretta a passare. Degli stivaletti neri con il tacco piccolo e doppio, stile anfibio, accompagnate da delle Converse nere attirarono la mia attenzione; giusto il tempo di capire che si trattasse fortunatamente, o anche no, di Leanne e Baja. Quest’ultima era appena ritornata da una viaggio in Spagna con la famiglia, ma come già detto, ero troppo stanca per fare qualunque cosa richiedesse qualche tipo di sforzo, compreso saltarle al collo e stritolarla in un abbraccio. “Ma buongiorno splendore” urlò quasi Leanne, sbattendomi ripetutamente la mano sulla spalla. Con la testa ancora nell’armadietto avvistai finalmente il libro di cui necessitavo e tornai in posizione eretta, lanciando uno sguardo eloquente ad entrambe le ragazze di fianco a me. Leanne spalancò la bocca nello scorgere lo stato orribile della mia faccia, strabuzzando leggermente gli occhi chiari. “Okay, presumo che anche solo ‘buongiorno’ possa andare bene” ridacchiò, sfottendomi. “Fottiti Leanne” risposi atona, stringendomi il libro al petto, sentendomi libera di appoggiare la schiena all’armadietto dietro di me. “Lo sai che ti voglio bene anch’io tesoro” insisté ancora lei, suscitando una piccola risata da parte di Baja, che mi preoccupai di ammonire immediatamente con un’occhiataccia minatoria. “Ripeto, se per caso il concetto non ti fosse stato chiaro: fottiti Leanne.” Di tutta risposta la rossa mi si lanciò addosso, incrociando le braccia dietro alla mia schiena con il corpo che vibrava a causa delle risate - che sapevo cercasse di comprimere contro il mio collo. “Stronza” le dissi, ricambiando tuttavia l’abbraccio con la mano ‘sana’. Che nessuno sembrava ancora aver notato, per il momento. “ ‘Dio, che hai fatto alla mano?” Come non detto. Roteai gli occhi all’osservazione fatta da Baja, allontanandomi da Leanne mentre la mora mi analizzava circospetta la mano. “Piccolo incidente domestico” spiegai semplicemente, scrollando le spalle. Quando avevo pulito il palmo mi ero assicurata che dei pezzi di vetro dello schermo non ci fosse più alcuna traccia, ma probabilmente un salto in infermeria non me lo avrebbe evitato nessuno. Se non mi avessero costretto le mie due amiche lo avrebbe fatto Keaton. Che, parlando del diavolo, scorsi fare la sua entrata nei corridoi assieme a qualche ragazzo della squadra di football e qualche ochetta della squadra femminile di nuoto. Ovviamente la scuola non era a corto di cheerleader ma, per assurdo, in quella squadra le ragazze sembravano avere ancora meno neuroni intatti. Il che le rendeva automaticamente svampite e troie il doppio. Ma ciò che mi premeva di più in quell’istante era la reazione del ragazzo i cui occhi azzurri erano, improvvisamente, posati su di me. Speravo fosse ancora troppo assonnato perché il suo cervello non traesse subito conclusioni affrettate. E, sinceramente, se fosse successo ciò mi sarei semplicemente ‘limitata’ al prenderlo a parolacce. Keaton camminò per qualche altro secondo assieme ai suoi amici, giusto il tempo per arrivarmi di fianco. Salutò i suoi amici e si voltò sorridente verso di noi, dedicandoci la sua completa attenzione. “Questa sarà bella. Scommetto venti dollari che uscirà pazzo” ghignò alle mie spalle Leanne, ricambiando al saluto del ragazzo con un cenno della testa, continuando a tenermi a braccetto. Roteai gli occhi, pizzicandole il dorso della mano. “Allora, me lo dici da sola cos’hai fatto alla mano o devo tirare a indovinare?” esclamò pacifico Keaton, allargando le braccia attorno a me, facendomi quasi sparire dalla visuale di chiunque tanto era alto. In realtà visto il mio scarso metro e sessanta tutti potevano definirsi dei giganti al confronto. “Hai sentito Leanne, vero?” ridacchiai, nascondendo la testa nella sua felpa blu, profumata. Sentì il suo mento tremolare leggermente sulla mia testa, segno che in realtà stava ridendo anche lui. “Uhm … può darsi” disse solamente. “Ma voglio comunque sapere cos’è successo, non hai esattamente una bella cera Ter.” “Ti prego, stendiamo un velo pietoso sull’argomento” borbottai allontanandomi da lui nello stesso istante in cui la campanella suonò, richiamando l’attenzione degli studenti. “Lo sai che abbiamo l’ora di biologia insieme, Carter” mi avvisò lui, ricordandomi cos’era stato capace di fare l’altro giorno durante l’ora di detenzione, e anche prima. Roteai gli occhi, spintonandolo leggermente in avanti, nel verso opposto a quello mio e delle ragazze. “Io e te dobbiamo ancora parlare” mi avvertì Leanne, puntandomi un dito contro non appena la figura di Keaton fu abbastanza lontana da non poter percepire le nostre parole. Sapevo perfettamente a cosa si riferisse, purtroppo. Mi limitai così ad annuire, avviandomi verso la palestra – dove avremmo avuto le prime due ore di lezione. Che, a pensarci, io avrei benissimo potuto saltare solo mostrando la mia mano al professore. Sogghignai e tornai a concentrarmi su Leanne, pizzicandole il collo per attirare la sua attenzione. “Voglio i miei venti dollari, Harris.” _________________________________________________________________ Non appena udì il rombo del motore della macchina di Keaton fermarsi aprì velocemente la portiera, saltando fuori dall’abitacolo. Per tutta la mattinata non avevo fatto altro che desiderare di tornare a casa, anche con la possibile presenza dell’irritante gatta bianca dei vicini o qualunque altra possibile fonte di rumore. Qualunque cosa sarebbe stata meno fastidiosa del martellante mal di testa che mi aveva perseguitata per tutta la giornata. Tutto, però, pur di sdraiarmi su una qualsiasi superficie morbida. “Grazie del passaggio” sorrisi a Keaton, sporgendo la mano per lasciargli un pizzicotto sul naso. “Ci vediamo domani?” Lui storse il naso, strofinandoselo con la manica della felpa. “Ho la verifica di letteratura, quindi credo che salterò” ridacchiò, rimettendo in moto la macchina. “Ma se c’è qualche problema con Elia chiamami.” Strabuzzai gli occhi, lanciando una veloce occhiata alla porta di casa che trovai già semiaperta. “Elia! Oh cazzo!” sbottai, battendomi una mano sulla fronte. “Mi ero dimenticata di lui, merda. Adesso mi ammazza. Lo so.” Keaton ridacchiò, scuotendo la testa. “E’ meglio che entri prima che ti venga a prendere lui allora ..” “Già” annuì, abbandonando la presa sullo sportello e iniziando a camminare lentamente verso la porta. In quel momento l’idea di tornarmene a scuola, rinchiudendomi nei bagni, e rimanerci per le successive ventiquattro ore non mi sembrava tanto male se paragonata alla quasi sicura lite che avrei avuto con mio fratello. Sentivo già un accennato vociare provenire dall’interno dell’abitazione; e solo quando notai un enorme pezzo di vetro, nascosto tra l’erba, mi decisi ad affrettare il passo entrando in casa. Spalancai la porta lasciandola sbattere contro il muro, troppo impegnata a percorrere ogni centimetro della casa analizzandone lo stato: al lato del primo scalino della lunga serie che portava al secondo piano vi era ammucchiata una montagnella decisamente grande di cocci di vetro e legname. Qualche quadro era caduto a terra, rotto, e dalla mia posizione riuscivo anche ad intravedere qualche piatto nella stessa situazione sul tavolo. “Eccoti, finalmente!” esclamò rabbioso Elia, piantandosi improvvisamente sulla traiettoria del mi sguardo, seguito a ruota da Ian e suo padre, Oliver. Inarcai le sopracciglia guardandoli, spostando gli occhi alternativamente su tutti e tre. “Che diavolo succede?” domandai, facendo un passo in avanti, sentendo una protuberanza sotto alla suola delle scarpe. Alzai il piede e scalciai il pezzo di vetro affianco al muro, tornando ad esaminare ciò che mi circondava. Se il soggiorno era in quelle condizioni non osavo immaginare la mia camera. “Che succede? Che succede?” tuonò Elia, pronto ad avanzare verso di me. “Dovrei chiedertelo io, questo, cretina! Che cazzo hai fatto, eh?” “Calma, ragazzo” s’intromise il signor Harding, piazzandogli una mano sul petto. “Ricorda cosa ci siamo detti.” Elia in risposta scosse secco la testa, puntandomi un dito contro, verde di rabbia. “Come cavolo faccio a starmene tranquillo, eh Oliver? Guardala. Guarda come cazzo è ridotta la sua faccia. Eh guarda la sua fottuta … mano?” urlò ancora, lasciando il suo tono assumere più una nota interrogativa sulle parole finali, spostando lo sguardo sull’arto in questione. “Che cazzo hai fatto alla mano, ora? E’ per quello che c’era tutto quel sangue in camera tua oggi?” Fui tentata di nascondere la mano e far finta di niente, ma dall’occhiataccia che mio fratello mi riservò mi convinsi che non sarebbe stata una scelta saggia. “E’ stato tutto un incidente Elia, calmati” tentai di addolcirlo, provando ad accennare un sorriso senza lasciar trapelare il dolore che mi colpiva ogni qual volta tentavo di farlo, nonostante avessi iniziato ad abituarmici. “Incidente? Cazzo Carter hai metà faccia viola e la tua mano sanguina” disse, passandosi convulsamente la mano tra i capelli. “Diavolo! Che cosa c’è di sbagliato in te?” Strabuzzai gli occhi, stringendo i pugni alle sue parole. “Non credo sia questa la domanda giusta, fratellino” esclamai adirata, lanciandogli un’occhiataccia. Non c’era niente, assolutamente niente, di sbagliato in me. Io sarei stata la ragazza più normale che potesse esistere sulla faccia della Terra se non fosse stato per Dante. Già. Ormai ogni cosa si collegava automaticamente alla sua stupida decisione di fare l’eroe della situazione. E questo Elia lo sapeva anche meglio di me. Lo capì anche dal modo in cui i suoi occhi saettarono da me ad un punto ben definito a terra, affianco ai miei piedi. Seguì il suo sguardo e mi ritrovai a fissare un quadro, con la foto un po’ stropicciata e il vetro rotto, scontrandomi con la mia faccia sorridente. Come quella del ragazzo biondiccio che mi affiancava stringendomi la vita. Mandai giù il groppo che avevo nella gola, distogliendo l’attenzione da lì. In realtà non pensavo esistesse ancora qualche foto di me e lui che non mi fossi già curata di bruciare. Ma evidentemente Elia non era della mia stessa idea al riguardo. “La colpa non è sempre sua Carter” sputò acido, cogliendomi alla sprovvista. Quando usciva fuori l’argomento, lui reagiva anche peggio di me alle volte. “Anzi, la colpa non è mai stata sua. E questo lo sai perfettamente. Lui s’è solo limitato a fare quello che io non ho avuto il coraggio di fare e salvarci così il culo. A tutti e tre. Non è colpa sua se hai continuato ad andare in quel fottuto locale anche quando ti avevo esplicitamente impedito di farlo. Non è colpa sua se ti sei fatta dare un pugno per aiutare quel tuo cazzo di amichetto. Non è colpa sua se sei una totale idiota di prima mattina. E non è assolutamente colpa sua se siamo arrivati a questo punto. Dante non ha nessuna colpa, ed è meglio che tu te lo faccia entrare in quella testaccia!” “Cos’è, adesso vi parlate anche?” bofonchiai con il suo stesso tono, incrociando le braccia al petto non potendo fare altro se non trovarmi in ovvio disaccordo con ciò che aveva detto. Era tutta colpa di Dante. Lo dimostrava anche il fatto che quando la polizia s’era presentata davanti alla porta di casa della zia, alle tre del mattino, Dante gli era andato incontro con le mani già unite per agevolare la chiusura delle manette attorno ai suoi polsi. Lo dimostrava il fatto che al processo non avesse fatto niente per tentare di scagionarsi o, perlomeno, far chiedere il patteggiamento all’avvocato - che era il padre di Ian. Che fosse tutta colpa sua lo dimostrava il fatto che quando gli avevano elencato i capi d’accusa lui avesse sorriso leggermente alla parola ‘incendio doloso’ , guardando Elia. Lo dimostravano la tuta arancione che gli avevano fatto indossare quel giorno, i capelli tagliati, le manette ai polsi e alle caviglie che tintinnavano ad ogni suo passo, man mano che si allontanava da me. Per sempre. Che Dante fosse colpevole lo dimostrava l’orribile cumulo di cenere ed erba grigiastra che il fuoco s’era lasciato dietro, mangiandosi ciò che un tempo era stata casa nostra. Era semplicemente tutta colpa sua, e lo sapevamo tutti e tre. Scossi la testa cercando di scacciare l’alone umidiccio che mi si era formato sulle pupille, appannandomi la vista. Lasciai cadere i capelli sulla faccia e mi affrettai a sorpassare i tre uomini, pronta a chiudermi in camera. Prima che potessi anche solo salire un gradino, però, la mano di Elia circondò il mio braccio costringendomi ad arrestare i miei passi. “Che cosa direbbe la zia vedendoti così? Che balla dovrei raccontare agli assistenti sociali se dovessero farci una visita a sorpresa uno di questo giorni e ti trovassero in queste condizione, eh? Non ci hai pensato? No, ovviamente. Tu non ci pensi mai, cazzo. Per quale fottuto motivo non vuoi capire che se le cose vanno male, qui, con me, tu non ci potrai restare?” mi ringhiò contro, cercando di trattenere almeno in parte la rabbia. Ovvio che non ci avessi pensato, a niente di tutto ciò che m’aveva elencato. Ma non capivo perché si ostinasse a dare tutta la colpa a me; non ero io che avevo chiesto a quel tizio di darmi un pugno, non ero stata io a chiedere a Keaton d’immischiarsi in una stupida rissa e non ero stata tantomeno io ad avergli imposto di prendersi a carico la mia custodia ed abbandonare il suo sogno universitario. Ovviamente ci avevo sperato sin dall’inizio, quando le cose avevano iniziato a prendere una piega decisamente brutta, che non mi abbandonasse a me stessa in uno di quegli orribili istituti per orfani; e in fondo in fondo lo sapevo che non l’avrebbe fatto, ma non glielo avevo mai chiesto esplicitamente. Anzi, prima che firmasse i documenti gli avevo detto di fare esattamente il contrario e di lasciarmi dalla zia così che potesse fare ciò che in realtà desiderava per davvero. E lo sapevo perfettamente d’essere un’incredibile masochista senza speranza. Perché anche se dalla mia bocca uscivano certe parole che potevano quasi sembrare un invito a farlo uscire dalla mia vita, in realtà io morivo anche al solo pensiero che per qualche altra mia stronzata ciò potesse realmente succedere. Perché alla fine io senza Elia non sarei riuscita a sopravvivere. Lui era quel filo conduttore che mi teneva ancorata alla realtà e che m’impediva contemporaneamente di lasciarmi sprofondare nell’irrimediabile rudezza che si racchiudeva nei miei ricordi, che tentavo d’evitare come si faceva con la peste. Perché io mi conoscevo troppo bene e lo sapevo che lo avrei sentito subito quel vuoto lasciato da Dante, se mi fossi fermata anche solo un attimo a pensarci. Ma io ero brava ad essere acida, incazzarmi per nulla, odiare chiunque e averli tutti sui coglioni. Io ero fatta così. E mi piaceva anche, perché risultavo quasi immune a ciò che mi circondava e non dovevo più prendermi la briga di pensare a certe cose - come ad esempio allo stato d’animo che lasciavo nelle persone quando le trattavo come facevo io. Anche perché loro, a certe cose, non ci pensavano. Mentre io in passato avevo avuto la strana tendenza a farlo, ventiquattro ore su ventiquattro, con chiunque. Anche a uno stupido gatto randagio ci pensavo, prima; ci pensavo a come potesse sentirsi nei giorni piovigginosi e freddi, da solo e nel buio e senza cibo. E io odiavo i gatti. Ma poi ci ero arrivata a capirlo, che preoccuparsi era sbagliato. Ed era ancora più sbagliato pensare. Perché quando ti fermi troppo a pensare, realizzi quanto tutto sia fottutamente senza senso. Ti rendi conto di non sapere come sei arrivato dove sei, non sai dove stai andando e non sai cos’altro fare. Ma ad Elia, invece, ci pensavo. Continuamente. E avrei voluto dirglielo a mio fratello che a lui non ce l’avevo sui coglioni. Avrei voluto dirglielo di non andare via, di rimanere dov’era, vicino a me, anche se lui c’era restato lo stesso. Ma non ne avevo il coraggio. Non ancora, perlomeno. Tentai di scacciar via l’alone fastidioso che mi occupava la vista, scuotendo il braccio per fargli mollare la presa. “Ma se io non ci fossi tu saresti libero di fare quel concorso per la borsa di studio per le Belle Arti a Firenze” sbottai infastidita, lasciando prendere aria alla mia stupida bocca. Io non ero fatta per dirle certe cose alle persone, e quella mia uscita ne era la dimostrazione. Ero un disastro. Fui tentata di interrompere quella conversazione e saltargli addosso, facendo finta di niente, sperando che almeno a lui quelle parole non suonassero come un invito ad andarsene. Ma poi la sua mano abbandonò il mio corpo, ricadendogli sul fianco, mentre io aspettavo che rispondesse. Che lo dicesse quel maledetto ‘no’ che avevo bisogno di sentirgli uscire dalle labbra, e che m’avrebbe impedito di scoppiare a piangergli in faccia. Ma i secondi trascorrevano inesorabili e furtivi tra i nostri corpi immobili. Ed ogni secondo era come una pugnalata dritta al cuore. Ma io ero egoista e anche se la sapevo la sua probabile vera risposta, volevo sentirmela dire lo stesso quella piccola bugia. Anche a costo di crogiolarmi nei rimorsi per l’intero mese a seguire. Poi, però, fu Ian a prendere parola, poggiandomi dolcemente una mano sulla spalla. “Che ne dici di andare a farci un giro, eh?” domandò, spintonandomi verso la porta senza nemmeno aspettare una mia risposta. Lasciai cadere lo zaino a terra, pronta a seguire Ian ovunque mi volesse portare piuttosto che rimanere un secondo di più in quella casa dove il silenzio di mio fratello iniziava a farsi opprimente. Sapevo che fare da padre alla sorella minore non fosse esattamente l’aspirazione di ogni ventitreenne. Ma leggergliele scritte sulla faccia, quell’amarezza e quella frustrazione, rendeva il tutto più doloroso e difficile da sopportare - soprattutto quando qualche istante prima avevo intensamente sperato che la sua risposta fosse un’altra. Ian mi sorrise, circondandomi le spalle con le braccia, tenendomi la porta aperta. Non ci provai nemmeno a far finta di ricambiarlo quel sorriso mentre camminavo. Però, prima che potessi essere completamente fuori dal raggio uditivo del soggiorno, la voce di Elia mi fermò sul posto; con un piede sollevato e l’ansia che m’attanagliava la gola. Lo sentì sospirare rumorosamente, mentre si avvicinava.“ Tu riesci a compensarmi tutto, Carter: la morte della mamma, Dante in prigione, Riley, l’Università e Firenze. Anche se non lo sai” sussurrò attonito, mentre una sensazione di benessere ricomponeva i pezzi del mio cuore che erano andati rotti in quei minuti di silenzio. “Sei letteralmente tutto ciò che mi è rimasto. E non m’interessa delle tue stronzate o della tua faccia viola o del fatto che mi stessi supplicando mentalmente di dirti una bugia, prima. Perché non è una bugia questa. Perché io senza di te non sopravvivrei, qui, e fin quando ci sei tu di tutto il resto me ne importa decisamente poco. E te lo ripeterò tutte le volte che vuoi, se servirà a farti capire che non t’avrei mai lasciata nelle mani di qualcun altro, neanche della zia.” Mandai giù il groppo che avevo in gola quando terminò di parlare, mordendomi le labbra per non scoppiare a piangere. Tentai di divincolarmi dalla presa del braccio di Ian, ma lui me lo impedì, trascinandomi finalmente fuori casa. “Per oggi può bastare così, non credi?” mi sorrise dolcemente, prima di cambiare argomento e iniziare a parlare di cose di cui poco m’interessai d’ascoltare. Mi bastava l’amore di Elia. Writer's corner: Okay, sono decisamente in un ritardo mostruoso. Chiedo venia. Ma davvero non ho avuto tempo per mettermi a scrivere e pubblicare quindi il capitolo è stato un pò un parto, ma alla fine ne è uscito questo, a chi interessasse. E anche adesso purtroppo sono di fretta quindi mi scuso per eventuali errori che provvederò a correggere non appena un pò di tempo. E adesso, devo davvero andare, anche perchè ho tipo il collo bloccato quindi sono abbastanza disastrata di mio lol Spero che vi piaccia, davvero, e se c'è qualcosa che non vi quadra o che non va fatemelo notare, davvero. Ci terrei a sapere cosa ne pensate dell'evolversi della storia, anche se per questi primi capitoli non è successo poi molto. Ma comunque è già un qualcosa, no? lol Okay, e adesso davvero mi dileguo. Alla prossima ☺♥ |
Capitolo 9
*** 8. I see that guilt beneath the shame. ***
 8. Carter “Il tradimento non è un incidente, diamine!” sbottò irritata Leanne, facendo dondolare sulla sua gamba le varie buste che reggeva. “Cadere dalla bici è un incidente. Non puoi inciampare e cadere in una vagina, dannazione.” aggiunse, strizzandomi il braccio.
Inarcai le sopracciglia guardandola e non riuscì a trattenermi dal ridacchiare nel vederla così adirata con Ross, il suo ex, che aveva tentato un ultimo e disperato approccio con lei - dopo il suo tradimento - sperando che non terminasse come le ventidue volte precedenti. Cioè con schiaffi e gelati in testa per lui. “Ma tu non avevi un ‘qualcosa’ con quel tipo … uhm, com’era? Jamie? No. Jason? No, nemmeno. Jo … aspetta, si, ce l’ho. Jared! Si, lui!” s’intromise Baja, al mio fianco, accompagnando la frase con il suo strano e abituale modo di muovere le mani. Come se ciò servisse ad imprimere più peso e significato ad ogni sua parola. Leanne scosse energicamente la testa, indicando con il dito della mano libera un negozio, l’ennesimo probabilmente di vestiti. “Non ne hai abbastanza di svuotare la carta di credito di tuo fratello Ley?” bofonchiai, roteando gli occhi - in completa sintonia con Baja. Ma tutto ciò che ricevetti come risposta fu una sonora sberla sul braccio. “Diamine Leanne, sai che lo odio, quando fai così!” “Cretina, non devi guardare il negozio, ma chi c’è affianco all’entrata” mi rimproverò quasi, sbuffando; afferrandomi il mento mi costrinse a voltarmi. Il negozio occupava due grandi finestre candide. Da lì riuscivo anche ad intravederne le mura interne dipinte accuratamente di nero, e il soffitto ricoperto completamente da quelli che mi sembravano dei bicchieri illuminati. I manichini erano ‘rivestiti’ – per così dire – da alcuni completi intimi e l’enorme insegna bianca dai contorni neri portava scritto a caratteri cubitali ‘Tezenis’. La musica che proveniva dall’interno, che somigliava a qualcosa dei Green Day, copriva anche quella dei Muse del centro commerciale. Non abbastanza però, da impedire a delle urla femminili di arrivare dritte alle mie orecchi e, quasi sicuramente, anche a quelle delle mie amiche e dei passanti. Spostai la mia attenzione dai dettagli affascinanti dell’interno del negozio e la portai all’esterno, precisamente di fianco alla fine della vetrina e all’inizio di quella di un negozio di musica. Lì riuscì a scorgere la figura snella e trasandata di una donna che urlava a gran voce, senza preoccuparsi di far sapere le sue cose a così tante persone - e per fortuna era solamente mezzogiorno di sabato mattina. Era una donna abbastanza alta, dai capelli scuri che le ricadevano sulle spalle e gli occhi cerulei. Ma la bellezza del suo volto non era certamente compensata dalle restanti caratteristiche: i capelli in realtà erano secchi e lucidi, gli occhi rossastri e contornati dalle sbavature della matita che si erano mischiate al fondotinta, e le labbra colorate di un rosso fuoco decisamente troppo acceso per quell’ora del giorno. Le spalline del vestito leopardato che indossava le scendevano sulle braccia, scoprendo il reggiseno lilla. E la lunghezza - ammesso che potesse definirsi tale, in quanto le copriva a malapena il fondoschiena - lasciava decisamente poco all’immaginazione; alcuni uomini le lanciavano a sua insaputa delle occhiatine decisamente allusive. Una bottiglia di un qualche tipo di alcolico, che mi sembrò riconoscere come tequila, troneggiava imponente tra le sue mani e su tutta la sua figura. E lì lo capì per davvero cosa fosse che le dava quell’aria assente e scazzata. Cosa l’avesse convinta a vestirsi in quel modo decisamente poco consono per la sua età. Quella cosa che mi costrinse a spostare lo sguardo su qualcos’altro; o meglio, su qualcun altro. Quel qualcuno contro cui stava urlando lei. Quel qualcuno che scoprì avesse dei lucidi capelli biondicci e una catena dorata al collo che tintinnava ad ogni suo movimento. Quel qualcuno che scoprì fosse Justin. Justin che era figlio di Pattie. Pattie che era la sorella di Kate. Kate che era la donna che in quel momento gli stava urlando contro, sotto il controllo di alcool e chissà cos’altro. E quando lo realizzai, che lei fosse effettivamente sua zia, e che lui stesse provando sicuramente ciò che avevo provato io per sette anni, sentì il mio cuore aumentare di battiti. Continuò con quel ritmo per alcuni secondi, prima che mi rotolasse su per lo stomaco e poi ricadere giù, rompendosi in tanti e appuntiti cocci che potevo sentire come conficcati all’interno del mio corpo. Kate urlò di nuovo, facendomi sobbalzare questa volta, dando qualche spinta poco decisa al nipote. Lo spintonò ancora, sempre urlando, e ancora. E ancora. E ancora. E ancora di nuovo. E allora Justin sembrò perdere la pazienza. Le afferrò le spalle e la allontanò di qualche passo, immobilizzandola al suo posto e sussurrandole qualcosa con tono voce decisamente basso. Ma io lo sapevo, lo vedevo, che in realtà lui stava esplodendo dentro. E non per le braccia tese e la mascella rigida; o la schiena ritta e tremolante. Lo si capiva perfettamente dal modo in cui i suoi occhi cercavano di guardare tutto ed ovunque tranne che la donna che aveva dinanzi. Ed in quel momento, tra le due opzioni che mi si presentavano davanti per sfuggire a ciò in cui sarebbe potuta degenerare la situazione - la prima opzione, data dal mio lato ‘umano’ , quello che sapeva benissimo cosa era successo e cosa si provava in determinati momenti, mi suggeriva di fare qualcosa, di intervenire. Mentre la seconda, postami dal mio lato egoista e cattivo, quello predominante, quello che faceva finta di niente per poter vivre lo stesso, mi suggeriva esplicitamente di scappare via. Distogliere lo sguardo, entrare nell’orribile negozio di scarpe che avevo dietro o fare dietrofront e tornarmene a casa. Qualunque cosa, comunque, pur di scappare da lì. – feci la cosa che in quel momento il mio corpo sembrava fare meglio: rimanere ferma, immobile, con i piedi piantati al suolo e gli occhi su Justin, nel gesto più masochista ed irrazionale che avessi mai fatto fino a quel momento. Perché che io fossi un mix di acidità e sarcasmo era la sacrosanta verità, ma non avrei augurato a nessuno di essere me, di vedere anche per sbaglio quello che io avevo visto. Di sapere così tanto e non dire niente, quasi niente. E Justin in quel momento era me. “Carter, senti, andiamo a mangiare, dai.” La voce gentile di Baja arrivò forte e chiara alle mie orecchie mentre Leanne mi strattonava per il braccio nel tentativo di scollarmi da lì. Ma a quel punto avevo il timore d’essere io quella che da lì non volesse andarsene. Perché Justin, lì da solo, non ci riuscivo a lasciarlo - nonostante una parte di me mi ricordasse costantemente che lui era Justin. Che era un dannato uomo e che per natura sapeva difendersi da solo. Ma io no. Non sentivo nemmeno le ragioni di me stessa. Rimanevo lì, con lo sguardo fisso. Perché certe cose per capirle devi viverle dato che è impossibile sia spiegarle che scriverle. E io, quelle cose, le avevo vissute appieno. Contro la mia volontà, ma le avevo vissute. Tornai alla realtà quando un uomo dalla statura imponente, tarchiato, con una giacca di jeans strappata e un sigaro tra le dita si avvicinò a loro. Sorrise sghembo a Justin e circondò le spalle di sua zia, facendo scivolare la sua mano – in un modo a dir poco oltraggioso – sui suoi fianchi, accarezzandola. Le sfilò di mano la bottiglia scura e ne bevve svariati sorsi, prima di riportare la sua attenzione sul ragazzo che aveva di fronte. E poi fu un attimo. Le sue labbra si mossero velocemente ed in altrettanta velocità Justin si scagliò contro di lui, colpendolo sulla faccia raggrinzita. Scostò bruscamente con una mano sua zia e tornò alla carica, senza controllo, colpendo con i pugni vari punti del corpo di quell’uomo. Le guance, il naso, il collo, la pancia, le spalle, la testa, il petto e i fianchi. E lo si vedeva proprio che era amico di Dante. Perché quando lo colpiva ci pensava, lo faceva sul serio, a cosa diavolo stava facendo e a cosa automaticamente ciò avrebbe comportato. Se lo chiedeva ‘ma che cazzo sto facendo? Sto facendo la cosa giusta?’ e poi, mentre la sua mano lo colpiva, si rispondeva ‘si’ , perché si, lui lo sapeva cosa stava facendo. Lui voleva farlo, e lo sapevo anche io che se fosse stato per lui, quel pezzo di marcio se lo sarebbe portato via e ne avrebbe fatto un sacco da boxe sul quale sfogarsi quando ne aveva bisogno. Perché paura, dubbio, rabbia e odio fanno più danni di quanti ne faccia una bestia selvatica. E Justin, in quel momento, era un barattolo pieno di rabbia e odio. E quell’uomo era l’unico modo che avesse trovato per tentare di stappare il tappo di quel barattolo. “Gesù Carter, che diamine stai facendo?” urlò Leanne, strattonandomi in modo più deciso, smuovendomi di qualche passo all’indietro. “Sta arrivando la polizia, diamine. Andiamocene!” aggiunse allarmata, attirando l’attenzione di alcuni passanti che si erano fermati di fianco a noi e che a sentire quelle parole si dileguarono in un batter d’occhio. Ma ciò non sembrò scalfire minimamente Justin, che con un ultimo e deciso colpo assestato sulla bocca dell’altro lo fece rotolare rovinosamente all’indietro. Kate urlò, per quanto ciò le risultasse possibile, e si lanciò sull’uomo. Già, su di lui. Intravidi la faccia di Ian in lontananza richiamare Justin e solo allora, alla sua voce, lui osò guardarsi velocemente intorno per fare una breve panoramica della situazione. E per un attimo; un breve e fulminante attimo i suoi occhi incontrarono i miei. Ed io li vidi. Erano marroni. Erano lucidi. Erano rossi. Erano devastati. Ed erano i miei. _________________________________________________________________ Lanciai un’occhiata annoiata – l’ennesima – all’orologio, che segnava esattamente la stessa ora di cinque minuti prima, solo con cinque miseri minuti in più. Riportai lo sguardo sul libro di chimica che avevo sulle ginocchia e tentai, ancora, di farmi entrare in testa almeno un quarto di ciò che c’era scritto su quelle due pagine che m’erano state assegnate. Lessi distrattamente la definizione d’energia che riportava il testo e alzai la testa, pronta a ripetere le due righe, scoprendo che di nuovo m’erano entrate da un orecchio e uscite dall’altro. Non ci riuscivo. Era più forte di me. Afferrai bruscamente il libro e lo gettai di fianco a me sul dondolo, battendomi le mani sulla faccia. Justin. Justin era il mio pensiero fisso da quella mattina. Justin e la sua vita lo erano, più che altro. Più tentavo di distrarmi e più le scene del suo ‘diverbio’, chiamiamolo così, con sua zia mi tornavano in mente, come uno di quegli screensaver che aveva Leanne sul suo computer. ‘Non siete gli unici’ m’avrebbe detto qualcuno, in quel momento. Ma se davvero pensare ciò fosse servito realmente a qualcosa, in quel momento non avrei avuto tutti quei problemi. Perché molto probabilmente era vero che non eravamo gli unici, ma quando ci sei in prima persona dentro quel tipo di vita non ti viene proprio l’idea di pensare alle altre persone. Non servirebbe a niente, e comunque chiunque continuerebbe a pensare il contrario. Perché quando ci sei dentro ti sembra per davvero che nessuno sappia realmente cosa ciò comporti e ti senti dannatamente solo e frustrato; costretto al silenzio e all’indifferenza della gente. ‘Che la gente quello era, in quei casi: indifferente. E Justin era probabilmente il primo ragazzo, all’infuori di Dante, che avesse mai occupato per così tanto la mia testa nell’arco degli ultimi tre anni e mezzo - e la cosa non mi piaceva particolarmente, ma non riuscivo a farne a meno. Io volevo sapere. Io dovevo sapere. Dovevo sapere se quello fosse uno dei motivi per i quali Justin e mio fratello avessero legato così tanto in poco tempo. Perché se così fosse stato ciò stava a dire che Justin sapeva di me , di noi, e di ciò che era successo. E se sapeva ciò che era successo sarebbe stato anche in grado di raccontarmi dettagliatamente cosa diavolo fosse saltato in testa a Dante quando aveva fatto ciò che aveva fatto - questo sempre nell’ipotesi che lui fosse a conoscenza di ciò. Ma se così fosse stato allora perché diamine non aveva fatto niente per impedirglielo? O forse ci aveva provato ma senza risultati? Infondo Dante era cocciuto quanto me, se non di più. Ma se neanche quella poteva essere una risposta, allora doveva esserci per forza qualcos’altro sotto. E quel qualcosa doveva essere davvero molto valido perché lo convincesse ad appiccare il fuoco - altrimenti avrei davvero iniziato a considerarlo un piromane del cavolo e fuori di testa. Ma Justin era un suo amico e probabilmente non avrebbe spiccicato parola con me dei loro ‘affari’ , per così dire. Neanche se lo avessi pregato – cosa che ovviamente non sarebbe mai accaduta. Però lui restava sempre e comunque l’unica cosa che teneva me e Dante ancora legati. E comunque sia nella mia mente si erano già formate tutte quelle domande, che non sarebbero di certo sparite nel giro di qualche ora. Ed io detestavo pormi tutti quei problemi per una persona, lo detestavo davvero, quindi pretendevo delle risposte che potessero soddisfarmi appieno. Ed ero del tutto certa di voler sapere la verità. Decisamente. Qualunque cosa essa comportasse. In fondo, peggio di così decisamente non poteva andare. E se, per chissà quale scherzo del destino non fosse stato così, mi ci sarei adeguata. Del resto si fa l’abitudine a tutto. Anche al continuo peggioramento di ciò che già era ai limiti della sopportazione. Un fascio di luce mi accecò la vista per qualche istante, costringendomi a spostare la mia attenzione dall’erba alla BMW bianca parcheggiata sul ciglio della strada di fronte a me. “Hey bellezza!” gridò con enfasi Leanne, sporgendo all’infuori la testa, sorridendomi. Sentì anche la voce di Keaton seguirla, ma non riuscì a capire se la stesse punzecchiando di nuovo o stesse salutando me in un modo più contenuto. Scossi la testa ridacchiando ed infilai il libro nella borsa. Mi alzai dal dondolo, sistemandomi il vestito arancione che indossavo, accertandomi che la casa fosse chiusa. Tyreek c’aveva chiamate per una festa di diciotto anni, quella sera. Forse era meglio specificare che avesse chiamato Leanne, ma io non avevo voluto sentire spiegazioni e avevo costretto sia lei che Keaton e Tyreek a farmici andare. Elia era fuori per il turno di sera e sarebbe rincasato verso le sette della mattina successiva, quindi non ci sarebbe stato nessun pericolo che mi beccasse a disobbedirgli - quando m’aveva categoricamente imposto di barricarmi in casa a guardare Madagascar due. Detestavo mentirgli, mi sentivo una merda al solo pensiero, ma al contempo detestavo anche quando entrava in modalità ‘mamma orsa’ . Il pugno che avevo ricevuto era stato solo un incidente come conseguenza della mia stupidità; ciò non voleva dire che dovevo starmene chiusa in casa come fossi in un convento di suore. E lui questo lo sapeva troppo bene. Così avevo aspettato che uscisse fuori di casa per prepararmi ed aspettare che i miei due amici arrivassero a prendermi il più in fretta possibile, prima che qualcosa nella mia testa mi convincesse che stavo facendo una gran cazzata e tornassi in casa. “Coraggio amica. Muovi le gambe” mi rimbeccò Leanne, spronandomi ad aumentare il passo. La ignorai e con molta tranquillità attraversai il mio giardino. Arrivai sul marciapiede pronta ad attraversare la strada, sperando che nessuno mi investisse, ed andare a lavorare. Diedi uno strattone alla borsa sulla spalla per aggiustarla e feci per attraversare la strada, se non fosse stato per qualcosa che aveva trattenuto il mio braccio all’indietro. Confusa e abbastanza irritata mi voltai, pronta a prendere a parolacce chiunque fosse stato il geniaccio che era in vena di stupidi scherzetti alle nove di sera. “Non ti hanno insegnato a guardare la strada prima d’attraversare, piccola Harvey?” ammiccò divertito Justin, mentre gli angoli della sua bocca si arricciavano all’insù. Come non detto. Le parole mi morirono in gola e nel mentre sentì una macchina sfrecciarmi dietro, facendo svolazzare leggermente l’orlo del vestito. Aveva la faccia coperta dal cappuccio della felpa, verde, e dei jeans scuri che aveva calato quasi sulle ginocchia. “Uhm .. si, grazie tante” bofonchiai, scuotendo la testa per impedire alle immagini di quella mattina di ritornare a galla e convincermi così ad addolcirmi almeno un po’ nei suoi confronti. Cosa che poi io non volevo. Justin rimaneva sempre Justin, e io continuavo a non sopportarlo. Mi voltai e tentai di nuovo d’attraversare la strada, quando la sua mano circondò di nuovo il mio braccio, bloccandomi con un piede all’aria. Non avevo guardato. Cazzo. “Si, si, la strada. Ci ero arrivata” sbottai, avendo come unico risultato la sua risata divertita. E l’avrei trovata anche meno irritante se non fosse stato che era una presa in giro nei miei confronti. Quindi in quel caso la trovavo particolarmente irritante. Mostrai il mio dito medio al biondo dietro di me e, guardando attentamente la strada tentai per l’ennesima volta, e per l’ennesima volta invano, di attraversare la strada. Quella volta però Justin si spinse oltre al bloccarmi per il gomito. Appoggiò bruscamente le braccia sulle mie spalle, facendo ricadere gli avambracci sul mio petto, inchiodandomi a terra. Sentivo il suo corpo dietro il mio, separati solo da qualche centimetro che veniva riempito dal vento. “Te lo devi dimenticare quello che hai visto oggi, capito?” mi ordinò, avvicinando la testa alla mia così che Keaton, che era sceso dalla macchina con espressione poco amichevole, non potesse sentirci. “Io non ci sono mai stato lì al centro commerciale ‘stamattina, okay?” aggiunse ancora, con tono di voce che non ammetteva repliche o domande. Cosa che io ovviamente non avrei fatto. Strabuzzai gli occhi, appoggiando rigidamente le mani lungo i miei fianchi quando un’ondata di vento più violenta della precedente rischiò di alzarmi il vestito. “Che diavolo vuol’dire questo, eh?” domandai, intimando a Keaton di starsene fermo dov’era, in attesa che Justin mi desse una spiegazione. “Niente. Semplicemente che io non c’ero” rispose vago, sollevando le braccia ed allontanandosi da me. “Diamine Bieber, te l’ho già detto che non ci voglio avere niente a che fare con i tuoi casini!” gli urlai dietro. Lui mi ignorò semplicemente. Attraversò velocemente la strada, lasciando una spallata a Keaton, e sparì all’interno di casa Harding chiudendosi la porta alle spalle con un tonfo sordo. Dal canto mio mi feci avanti, pronta a seguirlo e prenderlo a pugni, ma una macchina mi sfrecciò velocemente davanti impedendomi di attraversare per riuscire a rincorrerlo. Altro che andarci piano. Rimaneva decisamente insopportabile. Attraversai la strada e raggiunsi Keaton, accompagnata dal suono prolungato del clacson di una macchina che ci sfrecciò di fianco. Mi ero dimenticata di guardare. ☻ *rullo di tamburi* I'm back, yeah! E non sono nemmeno in un ritardo mostruoso come l'ultimo. In realtà avrei voluto aggiornare ieri ma avevo ancora alcune cose da rifinire al capitolo e ho deciso di rimandare a oggi. E quindi eccomi qui ouo Prima di tutto qui sopra ci sono i presta-volto degli ultimi personaggi entrati in scena, così che possiate farcene un'idea. Poi, ci tengo a scusarmi in anticipo per qualche possibile errore d'ortografia ma siccome credo d'essermi rotta un dito (già, un dito lol) potrei aver sbagliato qualcosa nonostante abbia riletto più di una volta e mi sia sembratto tutto apposto, ma mi può sempre essere sfuggito qualcosa. Okay, e ora passiamo al capitolo. Cioè, boh, lo sapete che nemmeno io so come definirli e commentarli oramai lol Ma c'è Justin *olè* Anche se non è esattamente uno dei capitoli più felici che potessi scrivere. Lo so. Ma è così che deve essere, a mio parare, per come immagino la storia. E lo so che la storia sembra complicata e senza senso, e qalcuna si chiede anche con quale miracolo potrei far avvicinare questi due, ma davvero mi ci sto impegnando a non far risultare il tutto troppo pesante, noioso, stupido e senza senso. Perchè anche se può sembrare, in realtà la storia un senso ce l'ha eccome. Ed è anche abbastanza 'importante' come tematica. Quindi, non so, se siete munite di pazienza pian piano le cose inizieranno a farsi più chiare. E poi, boh. Resta sempre a voi la parola finale. Cosa ne pensate? Che dite delle new entries? E' una piccola merda questo capitolo? Non ne vale la pena di continuare la storia? O qualcuno la ritiene almeno decente? Non so, ditemi voi. Io comunque volevo ringraziare quelle personcine tanto care che continuano a seguire la storia, davvero siete l'amore gfjiod :3 E ora siccome ho il dito che è una melanzana credo di dover andare, anche perchè sto trasformando questo apzio autrice nel più lungo che possiate aver visto lol Chiedo venia :') Baci, alla prossima ☺♥ Kate Mallette
 Mr. Oliver Harding  Wes Anderson  |
Capitolo 10
*** 9. Moods that change the speed of light. ***
 9. Carter Mugugnai qualcosa di incomprensibile perfino a me stessa, mentre annuivo con foga al ragazzo biondo dall’altro lato del bancone; stappai la bottiglia di birra che m’aveva chiesto, facendola scivolare sul ripiano di granito verso la sua mano aperta e pronta a prenderla. La afferrò al volo e se ne andò, lanciandomi un’occhiata euforica. E nel mentre, prima che potessi anche rendermene conto, una ragazza bionda e stretta in una sottospecie di vestitino di pelle rosa mi si piazzò dinanzi; bloccò così la strada ad un'altra persona, della quale però non potevo vedere nessun particolare a causa dei capelli estremamente cotonati all’insù della tipetta. Osservai la sua bocca laccata di rosa aprirsi e chiudersi mentre urlacchiava un fiume di parole, che dovevano probabilmente essere la sua ordinazione, e che m’accertai d’ignorare. Il tipo di ragazze come lei, altezzosa e piena di se, erano esattamente quelle per le quali ogni sera pregavo nella speranza di non doverci avere a che fare. Non sapevo assolutamente come gestirle per non rischiare di prenderle a parolacce; era Leanne quella ad esserne in grado, ma in quel momento sembrava troppo assorta nella sua conversazione con Jared per prestare un minimo d’attenzione verso il lato di bancone che occupavo io. Solitamente lo faceva per accertarsi che non avessi effettivamente distrutto qualcosa come m’era capitato di fare qualche volta – due precisamente. Una volta, a causa di un ragazzino in preda ad una crisi ormonale che aveva cercato di scavalcare il bancone. Allora era toccato ad una bottiglia di Jack Daniel’s rimetterlo al suo posto. E l’altra, causa quella volta una biondina simile a quella che avevo dinanzi e che m’aveva dato della ‘prostituta’ - per dirla gentilmente -, ad un vassoio di bicchieri appena lavati. Con i ragazzi, invece, era tutt’altra cosa. Tralasciando il piccolo dettaglio della mia lingua appuntita e velenosa che riusciva a mandarli via in un batter d’occhio, solitamente tendevano a starsene lontani quando si accorgevano che c’era sempre Keaton che mi affiancava in ogni mia serata; così come stava succedendo alla mia amica in quel momento che serviva solo ragazze. Ma quella sera Keaton lo avevo perso di vista da una buona oretta in compagnia di una ragazza dai capelli rossi. Tyreek era a controllare il piano di sopra assieme a Gary, il buttafuori, e Hayden, l’altro ragazzo che lavorava solitamente lì si era perso in chiacchiere assieme a Trey - che era il Dj. E l’unica che sembrava avere dei ‘piccoli inconvenienti’ ero io, alle prese con l’orda di persone che s’era accalcata di fronte a me, quasi in preda a degli spasmi d’astinenza dall’alcool. Ed ero quasi certa che il mio livello di sopportazione, dal trenta percento di quel momento, sarebbe sceso sotto lo zero in meno di due o tre minuti scarsi. Mi passai una mano sulla fronte per ripulirla dal sudore, e lasciai vagare il mio sguardo sull’enorme orologio che troneggiava sul muro in fondo alla sala: segnava solo le dodici e mezza. La voce stridula e particolarmente fastidiosa della ragazza bionda mi arrivò improvvisamente alle orecchie, costringendomi a riportare la mia attenzione alla realtà. La musica mi rimbombava nelle orecchie e si ripercuoteva per tutto il mio corpo, che però sembrava sopportarla di gran lunga di più rispetto al mio apparato uditivo, che sentivo stesse per scoppiarmi da un momento all’altro. Portai le dita alle tempie ed iniziai a massaggiarle con leggeri movimenti circolari, tentando di mantenere il controllo su me stessa per non prendere quella cornacchia - che aveva anche iniziato a gridarmi contro cose poco carine - per i capelli. Capelli che ero certa fossero all’ottanta percento extentions. Non ero sempre stata quel tipo di persona della quale si poteva dire avessero la sopportazione e la pazienza sotto i piedi. Ma dire che ero entrata a fare parte di quel determinato gruppo di persone era quasi un eufemismo, dato che la mia calma era praticamente inesistente. Ed in quel momento mi stupivo perfino di me stessa per non aver inveito ancora contro qualcuno, quella sera, dove tra l’altro il locale sembrava anche più affollato del solito per essere un Giovedì sera. La voce trillante della ragazza tornò alla carica, superando anche con mio orrore il volume della musica e riuscendo ad arrivarmi chiara e ben definita. Richiusi gli occhi e, di spalle, mi appoggiai con il sedere al ripiano in metallo del lavello, respirando ed espirando rumorosamente. ‘Conta fino a dieci.’ Sentivo la voce di Leanne rimbombarmi nella testa, nonostante oramai avesse perso l’abitudine e la pazienza di ripetermelo. Nonostante avessimo potuto constatare che tale tecnica, con me, non funzionasse. Ma in quel momento stavo facendo di tutto pur di non cercare qualche pasticcio, quindi tentar non nuoce. Uno, due, tre, quattro … Sentì la ragazza dietro di me sbattere i palmi delle mani sul bancone, facendo sobbalzare qualche persona lì intorno, mentre continuava a buttarmi contro una serie infinita di parolacce che nemmeno io sapevo esistessero. Cinque, sei, sette … Uno strano formicolio mi si irradiò fastidiosamente per tutta la cute. Mi ci volle un secondo prima di capire finalmente che la tipa mi avesse tirato una ciocca di capelli, mentre continuava ad urlare. Otto, nove … “Oh, col cazzo” borbottai, abbandonando la mia posizione ed i miei propositi di pace e serenità. Aprì velocemente gli occhi, con le luci stroboscopiche che mi bloccarono per un istante; ma non quanto basta per impedirmi di afferrare il secchiello del ghiaccio, allargare per quanto possibile la scollatura del vestito della bionda e versarci dentro tutto il contenuto ghiacciato. Scossi leggermente la testa e misi su uno dei migliori sorrisi che potessi avere in quel momento, il che stava a significare una smorfia alla Eddie Murphy in Una bugia di troppo quando doveva comunicare con qualcuno senza però parlare. “Ecco la tua ordinazione, tesoro” ammiccai, riappoggiando bruscamente al suo posto il secchiello, sotto lo sguardo alquanto divertito dei pochi presenti che non distratti dalla musica si erano accorti del nostro piccolo scambio d’opinioni. La bionda lanciò un urletto stridulo, stringendo le dita delle mani e conficcandosi le unghie appuntite nei palmi. Ma io mi sentivo già un po’ meglio senza più la sua vocina irritante a trapanarmi i timpani, quindi poco m'importava del suo stato. “Diavolo, sei tremenda ragazza.” Una voce bassa e roca parlò sopra tutte, attirando la mia attenzione. Poco convinta mi voltai, trovandomi dinanzi un ragazzo dai capelli scuri e un enorme ghigno sulla bocca, vagamente familiare. “Mi piaci. Non immaginavo fossi così … uhm … divertente” azzardò, spostando di mezzo la bionda e prendendo il suo posto, sporgendo le mani sul bancone. Strappai un pezzo di carta dal rotolo, e mi pulì le mani, inclinando la testa in sua direzione. “E io non pensavo di conoscerti. Divertente anche questo, no?” bofonchiai, aguzzando la vista sul suo volto. Mi ricordava terribilmente qualcuno, ma non riuscivo a collegarlo ad un nome preciso. “Ma come, già ti sei dimenticata del tuo vecchio amico Wes?” ammiccò lui, senza lasciare che quel tono giocoso abbandonasse la sua voce. “Potrei sentirmi offeso, sai?” “Non è affar mio il tuo orgoglio maschile ferito” borbottai ancora in risposta, prima di voltarmi verso di Leanne, scontrandomi con il suo sguardo comprensivo. “Io vado da Jim a farmi una sigaretta. Non reggo più, avvisa tu Keaton in caso tornasse, per favore” le dissi, accennando un sorriso di saluto a Jared, che ricambiò gentilmente. Sembrava addirittura simpatico a primo impatto, nonostante la prima volta che lo avessi visto fosse in procinto di lanciare un cazzotto a Justin. “Certo. Prima, però, potresti portare fuori quelle buste? Non ho più dove metterle” mi domandò, indicando i sacchetti neri che affiancavano i cestinetti sotto i ripiani. Annuì e li afferrai, pronta ad andarmene da lì, ma qualcosa mi trattenne per i capelli sul posto. Mi voltai infastidita, pronta a prendere a schiaffi la bionda in caso fosse stata lei, ma al contrario trovai semplicemente la faccia colpevole di quel Wes, che mi sorrideva. “Davvero, cosa devo fare perché ti ricordi di me? Portarti un altro caffè, per caso?” Inarcai le sopracciglia in risposta, ripetendo la sua frase, accompagnata dal suo nome, più di qualche volta prima che una lampadina apparentemente fulminata s’accendesse nel mio cervello. Schioccai la lingua sul palato, alzando il dito. “Ah, certo! Wes. Il tipo del caffè. Giusto, come ho fatto a non pensarci” esclamai improvvisamente, facendolo sorridere. “Woah, devo davvero portarmi quel caffè sulla coscienza allora” ammiccò, scuotendo la testa. “Beh, direi!” Lui ridacchiò, scuotendo la testa. Nel guardarlo mi tornò in mente la furia di Justin quando mi aveva esplicitamente detto di stargli alla larga, ma in quel momento davvero non riuscivo a capire cosa potesse farmi di così cattivo da costringermi a dare ascolto alle sue parole - anche se tecnicamente lo stavo già facendo da cinque minuti. Era un tipo dannatamente carino e risultava anche abbastanza simpatico in quel momento, perlomeno abbastanza da farmi dimenticare il mio caffè rubato e la voglia che avevo di prenderlo a pugni. “Senti … uhm …” balbettò, lanciandomi un’occhiata persa chiedendomi silenziosamente il mio nome. “Carter …” “Si, ecco, Carter. Lo so che quell’idiota di Bieber ti ha proibito di vedermi..” ammise. Strabuzzai gli occhi, tossicchiando leggermente. “Se te lo stai chiedendo ero davanti scuola quel giorno quando è venuto a prenderti. Mio fratello studia lì, e mi ci è voluto qualche secondo per fare due più due.” “Lui non mi dice cosa fare o no.” “Lo so, per questo sono qui stasera” continuò, sorridendo. Infilò una mano all’interno della giacca e ne estrasse un foglietto bianco spiegazzato che mi porse, trascinandolo sul bancone. “E’ una gara. Sabato sera. Se ti va di venire .. uhm .. io gareggio.” “Una gara?” ripetei confusa, sfilandogli il foglietto dalle dita. Lo aprì, leggendovi attentamente le informazioni che cercavo. “Motocross? Cos’è, una di quelle gare illegali alla Fast and Fourious ma con delle moto?” ridacchiai, infilando però il foglio negli anfibi che portavo sotto al vestito. “Non esattamente. Ma mi piacerebbe se ci fos …” “Che diavolo vuoi fare, Anderson? Eh?” lo interruppe Jared, alzandosi rumorosamente dalla sedia e piazzandoglisi immediatamente di fianco, stringendogli con forza una spalla. Diavolo, perché tutti sembravano avercela con lui? “Niente di particolare. Ho invitato la mia amica alla gara,Sabato, ci sarai vero? Tu e ..” Ma di nuovo fu interrotto da Jared, che sbatté furiosamente una mano sul bancone. “Per quale cazzo di motivo lo hai fatto eh? Vuoi un fottuto pugno in faccia stasera?” ringhiò, spintonandolo lontano. Lasciò un’occhiata di scuse a Leanne e lo seguì, continuando a sussurrargli minacce di pestaggi o roba simile sottovoce. “Okay, cosa diavolo è appena successo?” ansimò Leanne, avvicinandosi. _________________________________________________________________ Facendo pressione sulla maniglia rossa e cilindrica la spinsi all’ingiù, facendo scattare la serratura che mi permise di aprire del tutto l’enorme portone di metallo che dava sul retro del locale. Una ventata d’aria gelida mi investì improvvisamente, mentre il freddo s’infilava ovunque nel mio corpo, facendomi rabbrividire piacevolmente. Lentamente iniziai ad avvertire tutta la tensione accumulata scivolare silenziosamente nei meandri più profondi e nascosti di me stessa, lasciando spazio solo ed unicamente al piacevole impatto che l’aria fresca aveva con la pelle scoperta. Mi era sempre piaciuto – stranamente anche – il retro del locale. Nonostante la decina di cassonetti scuri, sporchi e maleodoranti che costeggiavano le lunghe mura in mattoni; e la stessa quantità di sacchi neri e ammucchiati che li affiancavano costantemente ad ogni ora del giorno in attesa d’essere smaltiti. Nonostante le cicche delle gomme masticate sul cemento malandato, i mozziconi delle sigarette e qualche altra cosa non bene identificata che andavano a finire dinanzi all’enorme cancello che delineava il fondo della strada, e che senza la luce della luna si confondeva con il blu scuro del cielo di quella notte. Lanciai ad occhi chiusi, senza curarmi di dove finissero esattamente, i tre sacchetti di bottiglie contro gli altri che tintinnarono leggermente all’impatto. Restai in quella posizione di assoluto relax per un lasso di tempo indefinito, beandomi della fresca temperatura che stava invadendo il mio corpo. Mi piegai leggermente ed estrassi dall’interno delle scarpe, che essendo slacciate mi stavano larghe sulla caviglie, un pacco di Lucky Strike. Ne estrassi una sigaretta, che constatai fosse l’ultima, e la portai alle labbra accendendola altrettanto velocemente. Appallottolai il pacco vuoto e lo lasciai cadere a terra, mentre le immagini di qualche minuto prima mi si ripresentavano davanti alla mente. Il modo aggressivo con il quale Jared si era rivolto a Wes mi aveva lasciata a dir poco senza fiato. E ancora non riuscivo a capacitarmi del perché quei due, Justin e Jared, avessero avuto la medesima reazione alla vista del ragazzo – che a me tra l’altro iniziava a stare anche simpatico. Lo avevo capito che doveva esserci sotto qualcosa, ma non riuscivo ancora ad arrivarci. L’unica cosa di cui ero certa era che quell’idiota di mio fratello si era lasciato dietro più casini di quanti ne avessi immaginati; non poteva esserci altra spiegazione, altrimenti. Ed ero altrettanto riluttante sull’andare a quella gara a cui m’aveva invitata Wes. Sarebbe stato carino, ma d’altro canto se ci sarebbe stato anche Jared avrei rischiato quasi sicuramente di ritrovarmi Justin sotto casa a ripetermi la stessa scenata dell’ultima volta. E con Elia in giro erano cose assolutamente da evitarsi, essendosi lasciati decisamente in cattivi rapporti dopo l’arresto di Dante. C’era però da tener conto del fatto che di quello che pensassero Justin, i suoi amici o chiunque altro m’importava ben poco e magari, se proprio dovevo fare la brava ragazza, avrei potuto chiedere a Ian o Keaton o Leanne d’accompagnarmi – anche perché da sola non ci sarei saputa arrivare visto il mio scarso senso dell’orientamento, che era quasi paragonabile a quello di una talpa in superficie. Il che non era esattamente una buona cosa. Un rumore di passi, però, mi costrinse a riportare la mia attenzione alla realtà, nella quale io ero in uno stupido vicolo buio alla mercè di qualunque tipo di depravato. E la cosa di certo non era molto rassicurante, vista l’esperienza passata con Kyle. “Chi c’è?” Un altro rumore. E una bottiglia vuota mi rotolò di fianco, scontrandosi poco dopo contro il muro dietro di me, mentre una figura non troppo alta e ricurva si levava dal buio, avvicinandosi a me lentamente. Arretrai di qualche passo, lasciandomi scivolare dalle dita la sigaretta oramai quasi finita, mentre quella che prima era un’ombra stava iniziando a prendere forma sotto la luce di un lampione. Capelli chiari, alzati in una cresta lucida. Catena massiccia al collo. Occhi color nocciola. Poteva essere solo una persona. “Bieber! Dio, mi ha fatto venire un colpo!” Justin uscì completamente alla luce, ridacchiando leggermente. “Sai, un nome ce l’ho anch’io, piccola Harvey” borbottò, in un modo abbastanza impacciato; continuò ad avanzare traballante verso di me, con i piedi che strisciavano sull’asfalto come fa un serpente. “Ed è Justin. J–u–s–t–i-n. Ripeti con me: Justin” ammiccò, prolungando il suono sulle ultime lettere del suo nome, piantando bruscamente le mani ai lati delle mie guance e prendendo a muoverle e strizzarle circolarmente, tentando di farmi seguire la sua lezione improvvisata di dizione. Sobbalzai leggermente quando una fitta mi colpì la guancia destra, che non era ancora del tutto guarita dal pugno che avevo ricevuto, e lo scostai bruscamente colpendogli le braccia. Solo allora mi accorsi della bottiglia che aveva poggiato ai suoi piedi, ancora mezza piena di un liquido marroncino. “Dio, sei ubriaco Justin?” Ma la mia risultò quasi più un’affermazione che una domanda, che ebbe come risultato unicamente una sua risata. Si piegò, in un modo abbastanza impedito, e riafferrò la bottiglia prendendone un lungo sorso. “Già. Strano, vero?” Allargò le braccia, accennando un sorriso amaro. “Ho passato gli ultimi otto anni e mezzo della mia vita nel tentare di far smettere mia zia. E guardami adesso: sono come lei. Sono come loro, dannazione!” sputò fuori, scuotendo energicamente la testa. Loro. Aveva usato il plurale, e ciò stava a significare che lui sapeva. Lui sapeva di me, di noi. Dante glielo aveva detto per davvero, come m’immaginavo. Indietreggiai di un altro passo, imitando il suo movimento di testa. “Non credo tu voglia raccontarle a me, certe cose” lo avvisai, prima di allungare la mano verso di lui per farmi dare la bottiglia. “No! Dannazione, no!” urlò allora, alzando il braccio e lanciando la bottiglia contro il muro che ci fiancheggiava. Il rumore di vetro rotto mi riempì le orecchie, facendomi sobbalzare. “Io non voglio più tenermela dentro questa merda, cazzo. Ma nessuno sembra volermi ascoltare per davvero, nemmeno mia madre.” Sentì il suo tono di voce diminuire gradualmente sulle ultime parole, mentre abbassava sconsolato la testa. “Tutte quelle stronzate che senti in giro sulla comunicazione e l’esprimere i propri sentimenti, sono tutte delle palle colossali. A nessuno importa veramente cosa hai da dire.” Strabuzzai gli occhi, sentendo uno strano formicolio alla bocca dello stomaco, ricacciando giù il groppo che mi si era formato nella gola. Tentai di sussurrare il suo nome ma tutto ciò che mi uscì fuori fu un rantolo strozzato, che Justin non sembrò nemmeno sentire. Non ero pronta, dannazione. Non potevo affrontare un Justin ubriaco che cercava unicamente qualcuno che fosse pronto ad ascoltarlo, perché io ero l’ultima persona sulla faccia della Terra che fosse in grado di farlo senza scappare a gambe levate ancora prima che iniziasse a parlare. Non potevo rivivere tutto quello che avevo cercato di lasciarmi alle spalle attraverso i suoi occhi lucidi e persi, che in quel momento cercavano i miei - che ovviamente non c’erano. Avrei voluto abbracciarlo, dirgli che sarebbe andato tutto bene e che lo avrei ascoltato, come una persona normale avrebbe fatto, ma non ne sarei stata davvero in grado. Non con lui. Non dopo quello che avevo visto l’altro giorno. Non dopo che i suoi occhi mi avevano guardata in quel modo. E mi sentivo dannatamente stronza a starmene lì impalata, con le gambe molli in attesa di riuscire a trovare qualcosa da fare, come una cogliona. Che in fondo era ciò che ero. “E sai qual è la cosa peggiore?” continuò lui, alzando la testa come se improvvisamente si fosse ricordato che stava parlando con me. “Mi diceva che per capirla avrei dovuto ubriacarmi fino a non ricordare nemmeno più il mio cognome. Che solo allora avrei capito il senso di vuoto e felicità che la prendeva ogni volta per non pensare alla morte dello zio. Ma la vuoi sapere una cosa, piccola Harvey? Io non lo riesco a capire. Non la sento quella leggerezza. Quella spensieratezza che dice lei.” Richiusi gli occhi bruscamente, scuotendo la testa. ‘Non cedere proprio adesso Carter. Non farlo’ mi ripeteva una vocina nella mia testa. Ma come potevo non cedere? Se fosse stato qualche ragazzino qualunque probabilmente lo avrei lasciato lì, a riprendersi da solo dalla sua sbronza, ma quello che avevo davanti a me non era uno qualunque. Quello era Justin. E mio malgrado, per chissà quale sconosciuto motivo, non ci riuscivo proprio a far risalire il mio orgoglio a galla e lasciarlo lì a crogiolarsi nell’alcool. O meglio, non volevo farlo. Mi riscossi dal mio stato di trance e proprio nell’istante in cui una piccola parte di me aveva trovato il coraggio per avvicinarmi a lui, sentì il suo torace appoggiarsi comodamente alla mia spalla, con il braccio che gli penzolava sul mio petto. “Dio, se pesi Justin” bofonchiai, aggirandogli i fianchi con il braccio ed iniziando a trascinarmelo verso l’entrata dentro il locale. “Oh, ma allora lo conosci il mio nome” ridacchiò lui, pizzicandomi il collo con la mano libera. Una scia di brividi accompagnati dal dolore mi attraversarono, mentre lui sorrideva. “Pensavo di doverti fare di nuovo lo spelling.” “Certo che sei ancora più stronzo così” lo rimbeccai, schiacciandogli il piede. Abbassai la maniglia rossa di prima e aprì la porta, mentre un’ondata di calore e puzza di alcool ci avvolse completamente. Potevo sentire già la mia fronte tornare a riempirsi di goccioline di sudore. “Ti porto da Jared, dovrebbe essere tornato da Leanne.” “No. Da lui no” urlò Justin, stringendo il braccio penzolante attorno a me per fermarmi. Roteai gli occhi, sbuffando. “Non fare il bambino. Dove vuoi che ti porti? A casa tua? Beh, per tua informazione non ho la minima intenzione di farlo.” Lui mi pizzicò ancora il collo, quella volta in modo aggressivo. “Certo che sei proprio una stronza. Non capisco perché Dante abbia rischiato la sua libertà per una come te” sussurrò a bassa voce. Ma per sua sfortuna era abbastanza vicino perché lo sentissi, e perché tutto il mio rimorso e il senso di colpa sparissero in meno di un secondo, lasciando posto alla mia solita me. Quella cattiva e stronza con il mondo. Soprattutto con lui, in quel momento. Non avrei retto ulteriormente quella situazione e quel miscuglio di emozioni che mi stavano attanagliando lo stomaco. “Vaffanculo Bieber” gli urlai contro, scostandomelo di dosso e spintonandolo contro un paio di ragazze lì di fianco. Mi aggiustai il vestito e velocemente, prima che potesse afferrarmi, mi avviai a passo spedito nella folla con l’unica intenzione di trovare Keaton, interromperlo in qualunque cosa stesse facendo e farmi riportare a casa. Dove sarei stata libera di progettare tutti i modi possibili che avevo per uccidere quel pezzo di stronzo di ragazzo, che in quel momento sentivo urlasse il mio nome. Ma ubriaco com’era non sarebbe mai riuscito a prendermi. Per sua fortuna. Wrtiter's corner: E rieccomi qui. Qesta volta abbastanza puntuale, però. Come vi va la vita? Questa volta sono davvero di passaggio perchè non ho molto tempo. E poi comunque non saprei davvero come definire questo .. uhm ... capitolo(?) Insomma, le cose sono sempre complicate, sia per quanto riguarda la trama sia tra Justin e Carter. Ma le cose inizieranno a chiarirsi e ad andae meglio già dal prossimo capitolo, questo ve lo assicuro. Prima di andare, però, volevo precisare che nello scorso capitolo Justin non ha picchiato sua zia. L'ha solo afferrata per le braccia, niente di più. E adesso, a voi i pareri. Come sempre, che ve ne pare? E' una merda? O perlomeno ha qualcosa di decente? Ormai lo sapete che al momento della pubblicazione sono decisamente insicura su ciò che ho fatto, quindi ci tenevo a dire che tutte le cose belle che quelle care personcine mi dicono nelle recensioni sono davvero importanti, quindi grazie. ♥ E ora mi dileguo. Spero vi sia piaciuto e che ne valga la pena, questa storia. Alla prossima ☺♥ P.s : Cambierò nick in @stereohearts
|
Capitolo 11
*** 10. You're such a fuck-up! ***
 10. Carter Buttai con poca grazia lo zaino sul divano, scostandomi dalla porta per permettere a Keaton di entrare. Scalciai via con i piedi gli stivaletti rossi che indossavo, con il telefono compresso tra la spalla e l’orecchio, mentre ascoltavo il dettagliato resoconto della giornata della mia migliore amica – che sembrava essere stata particolarmente eccitante.
“Non posso credere che tu le abbia fatto davvero lo sgambetto” dissi a Leanne, che si era presa due ore e mezza di detenzione per aver fatto lo sgambetto a Rebecca Mills - la ragazza con la quale il suo ex si era fatto beccare in atteggiamenti che erano tutto fuorché innocenti, come li aveva definiti lui. Comunque tra le due non era mai corso buon sangue, a prescindere da Ross, quindi potevo facilmente dedurre dalla sua voce elettrizzata che il gesto le avesse procurato parecchia soddisfazione nei confronti di se stessa. “Senti, non è colpa mia se quella … quella … beh, quella non guarda dove mette i piedi” sbuffò, lasciandosi sfuggire una risatina divertita. “E comunque dovevi davvero esserci. E’ stato epico vederla stesa dritta per terra, ai piedi di Peter Collins, che detto tra noi pensavo stesse per avere un collasso quando le ha visto le mutande. Ah, io l’ho sempre detto che mettere le gonne a scuola è una scelta decisamente poco consigliabile.” Roteai gli occhi, spostando il cellulare nella mano destra per potermi sfilare la camicia. “Ma se tu sei la prima che la mette” la rimbeccai, scoppiando a ridere senza più riuscire a trattenermi. Lanciai l’indumento sul divano e sfilai anche la bandana che avevo in testa. Entrai in cucina, a piedi scalzi, dove Keaton si era già adoperato per preparare dei panini. Il ripiano di granito del tavolo era pieno di piattini o vaschette trasparenti con salame, formaggio, insalata, pomodori, carne e altre varietà di cibo da poter inserire nelle due fette di pane. Da poter sfamare un esercito, probabilmente. In realtà mi stupiva anche il fatto che Elia non si fosse spazzolato metà frigo dopo essere rincasato - cosa che era solito fare. “Chiudi quella cavolo di chiamata e presta attenzione al tuo migliore amico, Ter” mi apostrofò Keaton, probabilmente maledicendo – e non solo in quel momento – Leanne e la sua lingua lunga. “Hey! Ti ho sentito stronzo!” urlò la tirata in causa dall’altro capo del telefono, tanto che mi trovai costretta ad allontanarlo dall’orecchio perché non mi fischiasse. Keaton ridacchiò divertito, allungandosi con facilità sul piano del tavolo e strappandomi bruscamente l’apparecchio dalla mano. Se lo portò all’orecchio, mettendo l’altra mano aperta sul mio petto per impedirmi di riprenderlo. “Scusa Ley, ma per adesso la tua amica è tutta mia. Ciao, ciao” esclamò tranquillo, chiudendo definitivamente la chiamata – con ancora in sottofondo le minacce insignificanti da parte di Leanne nei suoi confronti – infilandosi il mio cellulare in una tasca del jeans. Alzò innocentemente lo sguardo su di me, mentre trafficava con il cibo infilando qualunque cosa avesse a tiro dentro al pane, sorridendomi sornione. “Purtroppo doveva davvero andare” si giustificò, ghignando. “Comunque sono certo che tu abbia fame. In caso contrario, allora, mangerò tutto io.” “Sei uno stronzo. Perché lo hai fatto?” domandai, ignorando il suo tentativo di fare dell’ironia. Sentivo il mio stomaco brontolare silenziosamente e uno strano retrogusto acido nella gola, il che stava a significare che avevo urgente bisogno di cibo. Appoggiai i piedi sulle assi di legno che tenevano unite le gambe delle sedie e mi issai con forza sul tavolo. Presi una delle bottiglie di birra che Keaton aveva tirato fuori dal frigorifero e la stappai versandone tutto il contenuto in due bicchieri di plastica lì di fianco, osservandomi silenziosa intorno. Il lavandino era lucido e sul ripiano che lo divideva dal forno vi erano poggiati, sopra un piccolo asciugamano nero, vari bicchieri e piatti che mio fratello doveva aver usato prima di uscire di casa. Sulla superficie liscia e lucida dello sportello del frigorifero vi era attaccato un blocchetto intero di post-it rosa acceso, vuoto, che era poi circondato dalla decina di calamiti che io ed Elia avevamo collezionato nei pochi viaggi che avevamo fatto. C’era quella a forma di tartaruga che avevo preso io a Taormina, in Sicilia, durante la gita di terza; poi quella quadrata con i bordi dall’effetto bruciacchiato che Elia aveva portato dalla sua recente scampagnata con il fratello di Leanne e un altro amico in una qualche località montuosa a me sconosciuta. E quella dalla forma stramba di un sole sorridente ed incredibilmente giallo, comprata per qualche centesimo in Spagna, nella breve settimana estiva che vi avevamo trascorso assieme a Leanne e alla famiglia Harris lo scorso Luglio per il mio compleanno. Keaton appoggiò le mani sulle mie ginocchia e mi trascinò delicatamente vicino a lui, mentre continuava a muovere le mani sul tavolo. “Ieri, in caso te lo fossi dimenticata, hai interrotto molto bruscamente una piacevole chiacchierata con la mia nuova amica Sasha giustificandoti con un misero ‘ti spiego più tardi’ che, vorrei ricordati, non è mai arrivato” bofonchiò, piegando per bene il pane prima di porgermi il miscuglio di formaggio, verdura e carne di tacchino che doveva essere il mio pranzo. “E adesso necessito di affetto.” Afferrò uno dei bicchieri di plastica e lo portò alla bocca, scolandosi in un unico sorso metà del suo contenuto. Scossi la testa e mandai giù il boccone, imitandolo. “Sei un’idiota” ridacchiai. “Non credo di aver mai affermato il contrario” ammise, con gli angoli della bocca tirati all’insù. “Ma le mie carenze affettive possono anche aspettare, per il momento. Adesso mi interessa sapere cos’è successo ieri sera.” “Non è successo niente di particolare ieri sera, Keaton” affermai, trascinandomi una sedia più vicina per poterci appoggiare sopra i piedi. Afferrai un fazzoletto di carta e lo poggiai in grembo con sopra il panino che gocciolava maionese dal fondo, tagliato malamente. “Al solito, lo sai che dopo un po’ non reggo più.” Portai il bicchiere mezzo pieno alla bocca e lo sorseggiai lentamente, sotto lo sguardo inquisitore del biondo che, era palese, non mi credesse. “Valle a raccontare a qualcun altro le tue balle” sbottò, appoggiando gli avambracci sul tavolo. “Lo sai perfettamente che con me non attaccano queste scuse da ragazzina dodicenne.” Strinsi le dita attorno al materiale debole del bicchiere, affondandovi le unghie. Ne ero consapevole, era ovvio che lo fossi, in fin dei conti lo conoscevo da una decina di anni e in egual modo lui conosceva ogni singola parte di me; anche a nove anni non riuscivo a nascondergliele certe cose. Ma per una qualche ragione a me sconosciuta sentivo di volerlo tenerlo all’oscuro di ciò che stava succedendo, in principal modo con Justin. Ammesso e non concesso che io avessi anche una vaga idea di ciò che stesse effettivamente succedendo. Spostai lo sguardo dalle mie mani alla finestrella che avevo dinanzi, socchiusa, che affacciava sul fronte della casa. E automaticamente sulla bella villa Harding. Non sembrava esserci traccia di nessuna macchina sul vialetto in quel momento, ed il garage aperto era vuoto - il che stava a significare che i coniugi erano partiti per un altro dei loro viaggi d’affari. In compenso, sul giardinetto ben curato si stagliavano le figure curve e ben delineate di due ragazzi - quasi sicuramente Ian e Justin – che si tiravano alternativamente un pallone bianco. Esattamente nello stesso modo con il quale lo facevano il giorno che avevo rivisto Justin, che era anche quello nel quale i problemi avevano ricominciato a farmi visita, quasi lo avessero accompagnato a braccetto ad entrare nella mia vita, di nuovo. Ian allungò la gamba in avanti e sfiorò con la punta del piede il pallone facendolo rotolare dall’altro lato della strada, che solo qualche istante dopo realizzai fosse proprio casa mia. I due ragazzi voltarono la testa seguendo il pallone rotolare verso di me, e nonostante sapessi che stessero guardando lui non riuscì ad impedire al mio corpo di rabbrividire. Se Justin e Jared avessero già avuto modo di parlare il primo avrebbe dovuto essere a conoscenza della chiacchierata che io e Wes avevamo avuto, ma se ciò fosse effettivamente successo secondo i miei calcoli avrei già dovuto avere avuto a che fare con un Justin furioso sotto casa che m’intimava di smetterla di fare l’idiota. Cosa che, ovviamente, non era successa. Il che, a quel punto, mi faceva presupporre che i due non si fossero ancora incontrati. Ma per quanto potevo saperne io tutto ciò poteva essere già successo e magari Jared – cosa decisamente improbabile – aveva deciso di tenersi la cosa per se; d’altro canto, però, non ero ancora riuscita ad inquadrare bene Justin quindi le opzioni plausibili erano due: nel primo caso magari Justin ne era venuto a conoscenza ma aveva deciso di mettersi il cuore in pace capendo finalmente che con me era una cosa impossibile darmi ordini. Nel peggiore, il secondo, magari la sua rabbia faticava a risvegliarsi e quando ciò sarebbe successo sarebbero state scintille. Se considerare ciò una cosa positiva o meno, dovevo ancora capirlo. Una cosa della quale però ero certa d’essere contenta era il non avere avuto a che fare con Justin per quasi ventiquattro ore. Il che era un bene più per lui che per me, in fin dei conti. La presa di Keaton sulle mie ginocchia aumentò, e ciò mi convinse a smettere di farneticare e tornare alla realtà dimenticandomi anche di controllare chi tra Justin e Ian si fosse offerto volontario per raccattare la palla. Le sue dita erano affusolate e pallide e scivolavano leggere sui jeans; le vene leggermente in rilievo sul dorso a causa della pressione e le unghie mangiucchiate all’estremo del possibile. “Mi è sembrato di intravedere Kyle” sussurrò, quasi non volesse farsi sentire. “Dovevano essere le dieci o giù di li, era assieme a qualche ragazzo che non ho mai visto, ma Sasha era un po’ una palla al piede e l’ho perso di vista. Comunque sono riuscito a parlarne con Jim e Tyreek che in teoria avrebbero dovuto risolvere la cosa, ma … non saprei, magari non era nemmeno lui. Tu .. uhm .. tu non ci hai avuto a che fare, vero Ter?” continuò, indeciso. Era da qualche tempo che non saltava fuori l’argomento ‘Kyle’ , - non che ci fosse mai stato il bisogno di parlarne ulteriormente - ma sentirglielo nominare riuscì ugualmente a far tendere qualche muscolo della mia faccia. E ciò non sembrò sfuggire al ragazzo dagli occhi chiari che mi affiancava. “Diamine, lo sapevo che questa storia di te che lavori lì dentro non avrebbe portato a niente di buono. Ecco perché non mi è mai andata a genio … tu e la tua testaccia, cavolo” continuò a borbottare, facendo su e giù con la mano sulla mia coscia, lasciandosi dietro una scia bollente. “Smettila Keaton!” lo apostrofai, posandogli una mano sulla spalla. “Non mi va che continui a tirare in ballo questa cosa ogni volta che succede qualcosa di ‘poco carino’ .” Scivolai giù dal tavolo reggendomi alla sedia, sotto lo sguardo fiammeggiante di Keaton. Afferrai i due panini sul tavolo e li gettai nella spazzatura, assieme a fazzoletti, bicchieri e vaschette vuote mentre lui rimaneva fermo, con le braccia incrociate al petto. “Davvero saresti capace di definire ciò che avrebbe potuto farti semplicemente una cosa ‘poco carina’?” mi rimproverò, accompagnando le ultime parole con un movimento delle dita che stavano a significare probabilmente delle virgolette sarcastiche. Roteai gli occhi, appoggiandomi con il sedere al ripiano del lavandino. “Ma non è successo niente. Niente, okay? Ho già Elia che scatta ogni volta anche per una stronzata, e sinceramente mi basta e avanza pure. Non ti ci mettere anche tu” bofonchiai, incrociando le braccia al petto. Abbassai lo sguardo sui miei piedi nudi, che contrastavano nettamente con il colore scuro del pavimento della cucina. “So badare a me stessa, e lo sai meglio di me.” Lui scosse la testa, lanciandomi un’occhiataccia torva. Sciolse le braccia e afferrò il giubbino che aveva lasciato sulla sedia, appoggiandoselo sulle spalle, pronto ad andarsene. “Certo. E vorrai anche dirmi che lì c’erano anche Tyreek, Hayden e Leanne. Che il Sanyo è un posto sicuro e bla bla bla” sbuffò, roteando gli occhi. “Ma devi seriamente smetterla di comportarti così, Ter” mi rimproverò, arricciando le labbra. “Così come?” Inarcai le sopracciglia, arrotolando le labbra per trattenermi dal urlargli contro. Affondai le dita nei jeans, mordendomi l’interno del labbro. Lui sventolò all’aria la mano con un gesto secco, lasciandomi un veloce bacio sul naso. La sua mano scivolò via dalla mia guancia e gli ricadde sul fianco, mentre indietreggiava verso la porta. “Come se nessuno sia più in grado di farti del male.” _________________________________________________________________ Lanciai un’occhiata disperata all’orologio: le lancette segnavano le dieci e quarantacinque. Esattamente tre minuti in più rispetto a tre minuti fa. La finestra in cucina era semiaperta e oltre alle leggere ondate di frescura che si facevano largo tra le mura di casa, riuscivo a udire perfettamente il suono sfuggente e stridulo che le ruote delle macchine producevano sull’asfalto, mentre passavano a gran velocità sulla strada. C’era probabilmente un cicala, nelle siepi dei vicini, che sembrava non riuscire a trovare pace, e la gatta bianca – sempre dei vicini – aveva ricominciato a miagolare fastidiosamente da una buona mezz’oretta. Ma per quella volta avrei potuto anche ignorarla e trattenermi dal lanciarle contro un qualche vaso. Ed il tutto si alternava con le vocette stridule di alcuni bambini che avevano trovato il coraggio di uscire con quel gelo a fare ‘dolcetto o scherzetto’ . A nessuno dei quali, ovviamente, io mi ero ben accertata di rispondere. Sullo schermo della Tv Eddie Murphy, in A Thousand Words, cercava di concludere un affare importante con una sottospecie di imprenditore senza però poter parlare – se non avesse voluto rischiare la pelle – usando le esclamazioni di gioia o disapprovazione di alcuni giocatori di baseball con la testa che dondolava. Mi sollevai di poco per afferrare un’altra manciata di popcorn, che infilai velocemente in bocca, prima di lasciare molleggiare la testa sul bracciolo morbido del divano. Come se per l’ora e mezza precedente non avessi fatto altro che spaccare sassi anziché tentare di studiare venti pagine di arte bizantina che la professoressa di storia dell’arte ci aveva assegnato come compiti extra. Ovviamente operazione di scarso successo visto che la mia mente continuava a posarsi ovunque tranne sui bizantini - che io tra l’altro avevo sempre trovato irrimediabilmente irritanti. Leanne aveva tentato di smuovermi dal divano per andare assieme a lei ad una festa di una compagna di classe, ma con scarsi risultati. Dopo la ‘discussione’ con Keaton, che susseguiva la scoperta di un possibile ritorno di Kyle e un’altra brutta lite con Justin, non ero esattamente la persona più accomodante sulla faccia della Terra. Anche meno del solito, probabilmente. Del mio migliore amico, poi, non c’era traccia da quel pomeriggio. Avevo tentato di chiamarlo svariate volte, sia sul cellulare che sul telefono di casa, ma tutto ciò invano. Sembrava irreperibile, o perlomeno per me voleva esserlo sicuramente. E ciò aveva contribuito ad aumentare maggiormente il mio livello d’irritazione, che non era esattamente nel migliore degli stati quando rimanevo sola in casa per lunghi lassi di tempo. Lo detestavo decisamente. Lasciare me da sola in una casa così piccola ma al contempo così grande significava solo una cosa: pensare. E io detestavo profondamente anche ciò, perché a sua volta stava a significare dolore. Che a sua volta significava Dante. E se per caso avessi avuto la malaugurata idea di mettermi a pensare a Dante sarei finita in bagno con una bottiglia di ginger a crogiolarmi nell’irrimediabile rudezza del mio passato. Perché era in momenti come quelli che mi rendevo effettivamente conto di quanto si percepisse la mancanza della sua presenza in quella casa. E detestavo me stessa anche per ciò. Perché potevo mettermi a lavare i piatti, pulire la mia camera, fare la lavatrice, studiare, cucinare, ascoltare musica, guardare la Tv o qualunque altro passatempo possibile per tenermi occupata, ma ero consapevole che mi sarebbe bastato fermarmi un attimo, un breve e unico attimo, perché quel vuoto che si era lasciato dietro s’insinuasse con inesorabile lentezza dentro di me. Ed era esattamente tutto ciò che stavo cercando di evitare succedesse da tre anni e mezzo a questa parte. Niente foto, video, lettere, vestiti, dopobarba con lo stesso profumo, programmi Tv che gli piacevano, articoli di giornaletti cittadini al riguardo o libri preferiti. Evitavo lui ed ogni suo ricordo come si faceva con la lebbra. Aaron, l’assistente rossiccio e paffutello aveva appena steso il suo capo Jack, - ovvero Eddie - con un gancio destro niente male quando dei leggeri colpetti alla porta mi fecero sobbalzare. “Smammate! Tanto non ve le do le caramelle, marmocchi!” esclamai ad alta voce , infilandomi un’altra manciata di popcorn in bocca, sperando che mollassero il colpo e andassero a scroccare dolciumi ai vicini. Se magari avessero deciso di prendersi anche la loro gatta bianca non avrei di certo fatto obiezioni. Ma quando altri colpi si susseguirono ritmicamente sulla porta, accompagnati da una leggera risatina, mi trovai costretta ad alzarmi. Avvolsi il plaid grigio e caldo attorno alle spalle e mi trascinai lentamente all’ingresso, con le gambe che rabbrividivano ad ogni passo. Afferrai saldamente la maniglia e la abbassai, dischiudendo di poco la porta; quel poco necessario perché i miei occhi si imbattessero in una massiccia collana d’oro prima di sbattergli bruscamente la porta in faccia. Dopotutto dovevo aspettarmelo. Lo sapevo che Justin sarebbe venuto a sapere di Wes e che non avrebbe di certo lasciato correre. Ma in quel momento non ero esattamente in vena di litigarci, o anche solo di tirar fuori una delle mie battutine acide e sarcastiche capaci di farlo tacere istantaneamente. L’unica cosa che volevo davvero fare era starmene sul divano, finire di guardare il film di Eddie Murphy in santa pace e rimpinzarmi di popcorn fino alla nausea. Scossi la testa e, lasciando cadere la coperta a terra, avanzai velocemente in cucina. Mi sporsi con il busto sul ripiano per chiudere la finestra, e nello stesso istante il mio naso si scontrò contro la faccia di Justin, apparso dal nulla con un espressione decisamente poco amichevole. Lo guardai adirata, allontanandomi dalla sua faccia. “Ehilà” ammiccò, sporgendo le mani in avanti, lasciandole cadere sulle mie spalle e costringendomi automaticamente a rimanere in quella strana – e alquanto scomoda – posizione. Sentivo le ginocchia nude sbattere contro il legno freddo delle ante in basso, e una scia di brividi mi percorse la schiena. “Che diavolo vuoi, Justin?” sbuffai irritata, alternando il peso del mio corpo dalla gamba destra a quella sinistra. Incrociai le braccia al petto e sfregai le mani sulla pelle, cercando di riscaldarmi un po’. Lasciai scivolare lo sguardo oltre alle sue spalle, dove riuscì a scorgere – nella penombra di un lampione della luce – la figura ricurva ed esile di Ian che chiacchierava con un altro ragazzo dal giubbino verde. Qualche volta entrambi si lasciavano sfuggire qualche occhiata nella nostra direzione ma poi tornavano a discutere fittamente tra di loro. “Oh, niente di particolare in realtà. Semplicemente volevo avvisarti che domani verrai con me” affermò convinto, facendomi quasi strozzare con la mia stessa saliva. Alzai di scatto la testa e gli lanciai un’occhiataccia confusa, inarcando le sopracciglia. “Oh, certo, ovviamente spero per te che tu non abbia già preso qualche altro impegno” ghignò, sollevando un braccio e pizzicandomi – per l’ennesima volta – il collo. Gli scostai bruscamente la mano, che lui invece tornò ad appoggiare sulla mia spalla nuda. “Dannazione, smettila!” lo rimproverai, massaggiandomi il collo. “E poi dov’è che dovrei venire io? Con te, per di più?” Notai la testa di Ian e del suo amico scattare verso di noi, quando il tono della mia voce si alzò di qualche ottava. Justin sembrava non notare il mio sguardo che si poggiava sempre sui suoi amici, e continuava a fissare invece me; gli angoli della bocca sollevati all’insù in un ghigno divertito. “Oh, in nessun posto specifico. Ci facciamo solo una passeggiata.” Strabuzzai gli occhi, iniziando a formulare tra me e me qualche tipo di ipotesi plausibile che potesse spiegarmi il perchè del suo comportamento: o soffriva di un qualche tipo di disordine di personalità multipla o – cosa più probabile – era talmente fatto da non ricordarsi nemmeno chi ero io e farmi, così, una proposta del genere. In entrambi i casi, comunque, io avevo ugualmente voglia di spingerlo da quella finestra e sbattergliela in faccia. Ma poi la parte razionale, buonista e docile di me si fece largo nella mia testa, e una stramba ed assurda idea si materializzò all’istante nel mio cervello: che fosse lì solo per scusarsi d’aver fatto lo stronzo la notte scorsa? Scacciai via quel pensiero ancor prima che potesse prendere forma. No, impossibile. Decisamente impossibile. “E se io avessi già preso qualche altro impegno?” lo sfidai, inarcando le sopracciglia. In realtà l’unica cosa che si sarebbe potuta esattamente definire un ‘impegno’ per quel Sabato era la gara di motocross alla quale Wes mi aveva invitata – e io non avevo ancora deciso se andarci o meno. “Beh, in tal caso temo che dovrai rimandarlo” rispose, bagnandosi le labbra con la lingua. I suoi occhi saettarono velocemente dai miei alle mie braccia che sfregavano violentemente contro la pelle. Nel momento esatto in cui vidi la sua felpa arancione scivolargli lungo le braccia e cadere sulle mie spalle, un campanellino sembrò risuonare insistentemente nella mia testa. La gara di motocross. E Wes. Come avevo fatto a non pensarci subito! I suoi erano solo dei modi ed un approccio più gentili nei confronti della situazione, ma le sue intenzione rimanevano le stesse: cioè farmi restare alla larga da Wes. E Justin sembrò percepire le mie riflessioni perché il sorriso che aveva disegnato sulle labbra si allargò, ma i suoi occhi rimasero fissi e imperscrutabili nei miei mentre mi abbottonava i lacci del cappuccio attorno al collo. “Sei davvero venuto qui solo ed esclusivamente per questo, Justin?” domandai incredula e con un vago senso di smarrimento addosso, tentando si sottrarmi dalla presa che le sue mani avevano ancora su di me. Ma lui, di nuovo, sembrò non farci caso. “Ti passo a prendere verso le sette e mezza, bimba” dileguò la mia domanda, sporgendosi verso di me con la bocca semiaperta – probabilmente per dire qualcosa – ma io prontamente mi spostai dalla sua traiettoria lasciando che la sua faccia si scontrasse con l’aria. Slacciai la felpa e la lasciai cadere a terra, sotto il suo sguardo vuoto. “Buonanotte, piccola Harvey” disse allora, pizzicandomi furtivamente il collo prima di abbandonare la presa sulle mie spalle e lasciarsi scivolare all’indietro permettendomi di sbattergli – teoricamente – la finestra in faccia. Mi lanciò un ultimo e severo sguardo prima di allontanarsi, scalciando un sassolino biancastro, verso i suoi amici. Ma io non mi sentivo meglio, come succedeva le altre volte quando lo vedevo andar via. In quel momento mi sentivo solamente stupida e avevo addosso una gran voglia di prendermi a schiaffi da sola. Perchè per la prima volta da quando Dante era stato arrestato mi era parso di sentire una vaga e flebile sensazione di irritazione e rabbia - che comunemente vengono chiamate delusione - verso un'altra persona che non fosse lui. Riaprii la finestra ed infilai una mano nella tasca dei pantaloncini, estraendone un pacchetto rosso e sgualcito di sigarette. Ne afferrai una e la portai con furia alla bocca, accendendola velocemente. Ne aspirai una generosa quantità, osservando come le tre figure irregolari dei ragazzi – che si stagliavano scure contro le luci aranciate dei lampioni – si stavano allontanando verso una macchina rossa fiammeggiante parcheggiata sul ciglio della strada. Non riuscivo a capacitarmi all’idea di aver seriamente e segretamente preso in considerazione l’idea che fosse venuto per scusarsi e non per raggirarmi e ordinarmi implicitamente cosa fare. Come era solito fare. Sullo schermo della Tv John osservava felice e soddisfatto l’albero magico che era tornato a brillare di fiori rosa – simili a quelli di ciliegio cinesi – e foglioline lucide e verdi, tornato finalmente in possesso delle sue capacità vocali e della sua vita. Attirai una sedia verso di me e mi ci buttai sopra, afferrando un’altra manciata di popcorn dalla padella che avevo di fianco, con lo sguardo verso lo schermo illuminato. Incredula. Davvero avevo rischiato di provare qualcosa di vagamente simile alla delusione per un qualcosa che aveva fatto Justin?  Chi è in ritardo, di nuovo?
Io, ovviamente. Come al solito. Mi spiace davvero tanto, ma ho avuto una settimana abbastanza impegnativa e in quei due giorni in cui non c'era scuola sono stata a casa di alcuni amici per festeggiare halloween, quindi non sono proprio riuscita ad aggiornare prima nonostante il capitolo fosse già pronto. Chiedo venia. Anyway, tornando a noi. Il capitolo - che come sempre non so come definire esattamente - è più che altro di passaggio. Il prossimo sarà quello con il 'boom' di scoperte ed informazioni riguardo Carter, Justin, Dante e Wes. Insomma, ce ne saranno delle belle. E poi, boh, i commenti finali vanno a voi. Come sempre sono le vostre opinioni quelle che m'interessano. Sperando che la storia non inizi a schifarvi. E comunque prima di andare - essendo che devo finire di studiarmi 20 pagine di storia dell'arte e chimica messe insieme - volevo ringraziare di nuovo quelle personcine gentiligenitli checontinuano a recensire ogni mia schifezzuola. Siete l'amore ♥ Quindi, me la lasciate una piccola recensione anche qui? :3 Love you all, alla prossima ♥☺ |
Capitolo 12
*** 11. Don't let bastards get you down ***
|
“Davvero amico, che cazzata è mai questa di andartene di casa?” La voce di Ryan mi arrivava oramai ovattata alle orecchie per quanto le sue parole fossero diventate un cliché che si ripeteva ad ogni telefonata che ricevevo da qualcuno della famiglia. Ero arrivato al punto di non rispondere nemmeno più alle chiamate che portavano il nome di mia madre sullo schermo del cellulare; e non l’avrei fatto nemmeno con quella che mi era arrivata da parte di uno dei miei amici storici di Stratford se avessi saputo che anche lui avrebbe tentato di tutto pur di ‘farmi tornare la ragione’ , - come si ostinava a dire mia madre - per convincermi a ritornare a vivere con mia zia. Tentativi ovviamente vani visto che non avevo la minima intenzione di fare una cosa del genere. Non dopo che il nostro ultimo incontro era terminato con me che prendevo a pugni un idiota con la quale sembrava aver intrapreso una relazione - durata una settimana e qualche ora, niente di più – e che si era ostinata a ‘difendere’ , il che consisteva più in un susseguirsi di respiri affannati e urletti strozzati dalla poca lucidità, quasi fossi io lo stronzo della situazione. Che poi lo fossi, stronzo, era una cosa palesemente vera ma in quel preciso momento l’unica cosa che avevo tentato di fare – da vero idiota sentimentalista quale diventavo quando c’era di mezzo lei – era semplicemente un ultimo e disperato tentativo di tenere ancora intatto quel briciolo microscopico di dignità che mia zia potesse dire d’avere ancora e che aveva perso nel esatto momento in cui si era lanciata terrorizzata su quell’uomo - che probabilmente aveva conosciuto in uno dei locali a luci rosse che frequentava solitamente – ignorando invece me. Sangue del suo sangue. Suo nipote. E forse l’unico uomo che nella sua vita l’avesse davvero amata, oltre a mio zio Ben. Ma ormai sembrava non avere importanza né per me né tantomeno per lei. Conficcai con rabbia la mano nei jeans strappati, iniziando a giocherellare violentemente con l’orlo dei miei boxer, facendo avanti e indietro davanti alla porta di casa Davis. Lanciai un’occhiata all’orologio che avevo al polso; il piccolo schermo rotondo segnava le quattordici e trentuno. Stavo facendo su e giù per il vialetto da una buona decina di minuti – probabilmente mi ero lasciato dietro qualche solco sul terreno, ma non avevo esattamente voglia di accertarmi se ciò fosse effettivamente vero o meno – ed ero anche in evidente ritardo per l’appuntamento con Sal. “Senti Ryan, io non lo so cosa ti abbia detto o meno Pattie, ma in ogni caso non m’interessa la tua opinione al riguardo” brontolai irritato, facendo strisciare fuori la mano dal pantalone per poterla portare poi sul collo, grattandomelo violentemente. “Devi, anzi dovete, smetterla di chiamarmi solo per dirmi che sono stato un bastardo a lavarmene le mani quando mi sembra di ricordare che in realtà l’unico che non lo abbia fatto sono stato proprio io. Non credo di essermi spedito da solo qui a San Diego undici anni fa, ne tantomeno che qualcuno ci abbia più messo piede dopo la morte dello zio. Quindi evitate di fare i moralisti del cazzo con me.” Riuscì a sentire il respiro di Ryan bloccarsi per qualche istante, mentre l’unica cosa che fuoriusciva dalle casse del cellulare era silenzio. “Senti, Justin, lo so che …” tentò ancora, con un tono di voce che mi parve anche leggermente irritato. “No, tu non sai un cazzo Ryan” sbottai, interrompendolo bruscamente. “Quindi dovete farmi il piacere, tutti, di lasciarmi stare. Non ne voglio sapere più niente di questa storia, okay? Ciao.” Riattaccai ancor prima di riprendere fiato, senza preoccuparmi che avesse sentito l’ultima parte del discorso o meno. E nello stesso istante in cui la mia voglia di gettare all’aria il cellulare era praticamente alle stelle, la porta di casa Davis si socchiuse lasciandomi scoprire un po’ alla volta la chioma aranciata – tinta – di una Jodi insonnolita e con degli aloni grigiastri sotto agli occhioni verdi. Appoggiò la testa allo stipite in legno, lasciandomi un sorriso gentile. “Che ci fai lì impalato Biebs?” mi domandò, portando una mano davanti alla bocca mentre le ultime parole si mischiavano ad un rumoroso sbadiglio. “Entra. Sal è in cucina” Lasciai scivolare il telefono nei jeans e appoggiandole una mano sulla schiena, che era ricoperta da una morbida coperta grigia, la seguì dentro casa. Casa Davis era la tipica casetta dallo stile British che andavano in voga di quel periodo: i mattoni scuri della facciata esterna si mischiavano in una varietà assurda di bordeaux e beige, che risaltavano ancora meglio alla vista grazie alla tonalità accesa di verde del giardinetto che il signor Davis si preoccupava di curare ogni Domenica. Stessa cosa per l’arredamento all’interno di entrambi i piani su cui si ergeva la struttura, dove mura interamente costruite con mattoni si alternavano a quelle verniciate di un colore che si spingeva molto ad assomigliare al nero. La maggior parte di mobili e mensole presenti erano di legno, e contrastavano nettamente con la scala a chiocciola in vetro e la cucina bianca e nera, in marmo e acciaio. L’unica cosa che probabilmente stonava in quel miscuglio di modernità e futurismo era la camera completamente rosa di Jodi, che però stava al piano superiore quindi per chi vi mettesse piede per la prima volta il tutto poteva perfettamente sembrar provenire da una di quelle riviste patinate di mobili che – sempre il signor Davis – collezionava. “Allora, come stai adesso?” domandai, appoggiando i gomiti sullo schienale del divano rosso scuro, dalla tipica forma ad ‘L’. “La temperatura è ferma sul trentotto, ma mi sento decisamente meglio rispetto a ieri” brontolò lei, lasciandosi cadere pesantemente tra la miriade di cuscini lucidi che lo occupavano. Alzò lo sguardo su di me, sollevando il busto e schioccandomi un veloce e rumoroso bacio sulla guancia prima di lasciarsi ricadere tra coperte, fazzoletti e calzini. “Vai da Sal adesso, lo sai quanto odia i ritardatari” sussurrò, squadrandomi seria. “E se dovete litigare, cercate di non urlare troppo” Il che, molto probabilmente, doveva stare a significare che suo fratello fosse abbastanza incazzato in quel momento. Spostai lo sguardo sulla porta chiusa della cucina, restio all’idea di dover avere a che fare con un Sal facilmente irritabile, più del solito probabilmente, quando in quel preciso istante ero stesso io quello poco incline ad avere un’altra lite con lui, – avevo sempre avuto la strana capacità di fargli saltare i nervi anche con un sorrisino o una semplice battutina ironica detta nel momento e nel modo, secondo lui, sbagliati. L’effetto contrario, invece, sembrava averlo lui si di me. Solo sentire il suo orribile profumo di qualche marca asiatica a me sconosciuta, nella mia stessa stanza, mi convinceva ad abbassare la guardia per un po’. E riuscivo quasi a non infastidirlo per più di un’oretta alle volte. Questo, ovviamente, quando il motivo dei miei scatti di rabbia non fosse proprio lui. C’era anche da dire che contemporaneamente a ciò l’idea di poter scaricare la mia rabbia stuzzicandolo un po’ mi sembrava perfettamente praticabile. Quella prospettiva mi convinse a spalancare – abbastanza brutalmente – la porta. Un forte odore di cocco mi s’insinuò immediatamente nelle narici, mentre con un salto, noncurante, mi mettevo a sedere sul ripiano in granito che affiancava il lavello. Sal era piegato sulla superficie del tavolo, a torso nudo e con solo un pantalone nero di tuta a coprirgli le gambe, intento a divorare un’enorme fetta di torta marrone e con una crema bianca luccicante in mezzo ai quattro strati dai quali era composta. Alzò la testa dal piatto, masticando silenziosamente ed educatamente il boccone che si era appena messo in bocca, puntando lo sguardo sulla punta delle mie scarpe ed iniziando una lenta, accurata ed irritante scansione del mio corpo. Potevo riuscire a vedere le sue pupille girare veloci da una parte all’altra – come se ne stessero disegnando nell’aria il contorno – per poi risalire con inesorabile comodità i polpacci sino ai pantaloni neri che avevo addosso; si soffermò qualche istante sulle stampe grigie della maglietta, sui braccialetti sottili al polso sinistro e sull’orologio rotondo a quell’altro. Risalì lungo il torace osservando la collana che mi circondava il collo, poi l’orecchino all’orecchio destro, i capelli scompigliati che mi ricadevano sulla fronte da sotto al cappellino di lana ed infine lasciò scivolare i suoi occhi nei miei, apparentemente indifferente. “Allora, come va?” mi domandò disinteressato, appoggiando i gomiti sul tavolo. Scrollai le spalle, abbandonando ogni mio proposito di fargli perdere le staffe. Avevo la strana sensazione che comunque, anche se ci avessi provato, non avrei ugualmente ottenuto il risultato a cui puntavo io. Sfilai una sigaretta quasi terminata dal pacchetto che avevo nella tasca e la portai alla bocca, accendendola. “Va” dissi semplicemente, buttando fuori il fumo. Lui sospirò di tutta risposta, scuotendo la testa. “Voglio solo capirci qualcosa di tutta questa situazione, Justin” sospirò. Lasciai scivolare il mozzicone della sigaretta terminata nel posacenere, sentendo la mia faccia irrigidirsi automaticamente quando compresi che il fulcro del resto della conversazione sarebbe stata Carter, e ne afferrai velocemente un’altra infilandomela tra le labbra. “L’unica cosa che voglio è tenere quel verme di Wes lontano da lei, tutto qui” Levai con la mano libera il cappello, buttandolo a casaccio su una delle sedie che avevo davanti. “Per questo siamo andati a casa sua ieri sera?” Alzai le spalle, lasciando uscire una nuvoletta di fumo grigiastra. Al riguardo, in realtà avevo la netta sensazione che si sarebbe presentata a quella stupida gara solo per fare un dispetto a me - che al contrario le avevo indirettamente proibito di farlo se non avesse voluto farmi arrabbiare. E se c’era una cosa che ero riuscito a capire perfettamente di lei, attraverso quelle poche parole che ci eravamo scambiati durante le ultime settimane, era che non fosse esattamente il tipo di ragazza che si lasciava mettere i piedi in testa da nessuno – soprattutto da quello che tecnicamente sarebbe dovuto essere il miglior amico di suo fratello ma che è sparito nel momento esatto in cui quello veniva incarcerato. Non sarebbe rimasta a guardare mentre m’insinuavo con forza nella sua vita, senza nemmeno chiederle il permesso – e non la biasimavo minimamente per ciò. A pensarci, però, non riuscivo ancora a spiegarmi per quale assurdo motivo mi ero presentato a casa sua per informarla dei miei piani nei suoi confronti, quando sapevo a prescindere che non sarebbe servito a niente se non ad irritarla ulteriormente con la mia presenza. “Tu non sei niente per lei, Justin. Ed essere il miglior amico di Dante non ti conferisce automaticamente un qualche particolare diritto sulla sua vita o sulle sue scelte, benché siano sbagliate” affermò lui. Si alzò dalla sedia e si avvicinò ai fornelli, iniziando a trafficare con la macchina del caffè. “Questo lo so, ma non m’interessa” “Io ti lascio entrare nella mia vita perché mi fido di te. Ma tu ti devi fidare di me. E’ un patto Justin, entrare a far parte delle vite altrui, soprattutto in questa precisa situazione parlando di una ragazza fragile come Carter” continuò, con un rumore sferragliante in sottofondo. “Non puoi semplicemente fare avanti e indietro a tuo piacimento dicendole cosa o non fare in alcune determinate situazioni. Lei lo sa, per questo non ti permette di avvicinarla” “Odio quando te ne esci con questi discorsi alla Charles Bukowski, Sal, lo sai” brontolai, benché avessi perfettamente compreso ciò che volesse dirmi: o me ne stavo buono, buono per i fatti miei senza immischiarmi – cosa assolutamente da escludere a prescindere – o entravo al cento percento nella sua vita permettendole di fare lo stesso con me – cosa particolarmente spaventosa, per entrambi probabilmente. “Ma è la verità, idiota!” sbottò lui, allargando le braccia. “Non puoi giocare a fare il fratellino iper protettivo con lei, Justin. Se vuole uscire con quel ragazzo lo farà, a prescindere da ciò che pensi tu al riguardo, e questo lo hai capito già. Allora perché non lasci perdere?” “Perché non voglio che le faccia di nuovo del male, okay?” ringhiai a bassa voce, cercando di mantenere il controllo su me stesso. Sal inarcò le sopracciglia, guardandomi. “Ma lui non le ha fatto del male, Justin!” “Si che lo ha fatto” sbottai, arrabbiato. “Se per caso avessi qualche vuoto di memoria, vorrei ricordarti che è stato quello stronzo a dire al padre che io e Dante eravamo nei dintorni della casa quando ha iniziato a bruciare. Ed è per questo che quei dannati mozziconi di sigaretta con la sua saliva sopra sono stati considerati abbastanza compromettenti per essere usati come prove contro di lui. Ed è sempre per questo che è stato condannato e adesso è dietro alle sbarre, quando se Wes si fosse fatto i cazzi suoi lui adesso sarebbe potuto essere qui con noi. E magari adesso sua sorella non penserebbe che suo fratello oltre ad essere un fottuto piromane sia in qualche modo colpevole della morte di sua madre, quando tutti sanno perfettamente che è stato quel bastardo di Rick ad ammazzarla!” Fissai inespressivo un punto indefinito perfino a me stesso al di sopra delle spalle di Sal, con il respiro rotto e le guance surriscaldate. Tentai di portarmi alla bocca la sigaretta per poter cercare di riprendere, in qualche modo, il controllo, ma l’unica cosa che sfiorò le mie labbra fu una linea sottile e calda. Abbassai lo sguardo, sentendo solo in quel momento quanto il mio corpo fosse rigido, notando che avevo stretto talmente tanto la sigaretta da ridurla ad un mucchietto di tabacco e cartina bianca. Mi sentivo stranamente impedito, in qualunque movimento tentassi di fare; il fiato corto e pesante mi si disperdeva per tutta la bocca dello stomaco per poi risalire bruscamente all’insù, come una miriade di spilli. Sentivo i denti scricchiolare l’uno contro l’altro ed una vena sul collo pulsarmi fastidiosamente. “Justin .. senti..” tentò Sal, alzando le mani, quando l’unica cosa che avrebbe dovuto fare in quel momento era stare zitto. “No, cosa cazzo devo sentire ancora? Grazie a quel bambinetto del cazzo adesso la sua famiglia è distrutta! E sai cosa starà facendo adesso quel nullafacente di suo padre?” urlai, quella volta, sentendo la faccia pizzicare. “Starà sicuramente riscaldando la sua nuova sedia d’ufficio, che gli hanno procurato per aver concluso il caso così in fretta, mangiando ciambelle dalla mattina alla sera anziché chiedersi per quale fottuto motivo Dante avrebbe voluto uccidere sua madre! E nel frattempo Rick sarà già dall’altra parte del mondo a spassarsela. E tu cosa vorresti che facessi? Stare a guardare mentre Wes ci prova spudoratamente con lei per chissà quale contorto motivo? No, mi dispiace, non ci sto. Dovrà passare su di me prima di potersi permettere di avvicinarsi ulteriormente a Carter!” Stavo urlando, più di quanto pensassi di riuscire a fare, con una Jodi malata dall’altro lato della stanza; ma poco m’importava in quel momento. Sentivo i battiti del mio cuore martellarmi nelle orecchie, le mani erano intorpidite e la testa mi ronzava leggermente. Sal tentò di fare un passò verso di me, ancora a mani alzate, ma ancora prima che potessi rendermene conto il posacenere che avevo di fianco era volato dall’altro lato della stanza, rimbalzando ai suoi piedi. La sigaretta che avevo lasciato cadere a terra fumava ancora. Ed improvvisamente quella casa così grande mi stava troppo stretta. Sistemai la garza sul dorso della mano prima di attraversare a grandi passi il breve tratto di strada – più terriccio che altro – dove mi avevano detto si fosse tenuta l’esibizione cui aveva preso parte Wes e dove avrei teoricamente dovuto trovare anche Carter. I vari tipi di veicoli presenti erano incolonnati uno dietro l’altro lungo le ‘strade’ che circondavano sia il crossodromo in generale sia i vari percorsi presenti. Una piccola calca di persone si stava radunando dinanzi ad uno dei capannoni ai confini dell’area che distribuiva vari tipi di birre per festeggiare il ventiduesimo compleanno di uno dei corridori poco conosciuti del posto. Infilai la mano nella tasca del jeans alla ricerca dell’accendino; mi lasciai sfuggire un grugnito di dolore quando il dorso si scontrò contro il tessuto ruvido dei pantaloni mentre con le dita riuscivo ad individuare ciò che stavo cercando. Dopo essermi letteralmente catapultato fuori casa Davis avevo girovagato per quelle che mi erano sembrate delle ore attorno al quartiere residenziale dove si trovavano rispettivamente le case di Carter ed Ian, consumando pacchetti di sigarette ad intervalli di mezz’ora che intervallavo ulteriormente prendendo a pugni qualunque cosa trovassi a tiro – in quel caso un vecchio albero spoglio. Con il fiatone, la mia risorsa di sigarette finita e le mani grondanti di sangue – in alcune parti incrostato ed in altre fresco e caldo – che iniziavano a pulsare, mi ero lasciato rintracciare da Sal. Mi ero fatto trascinare dal dottore della loro famiglia per farmi medicare ed avevo subito il suo susseguirsi di urla e imprecazioni per un’altra buona oretta prima di salire in macchina e farmi sessanta minuti di macchina a centottanta all’ora per arrivare al Milestone MX Park – dove tra l’altro, per mia fortuna, mi aspettava Jared che aveva seguito la sua nuova fiamma, Leanne, e Carter - che con mio sollievo aveva saggiamente deciso di farsi accompagnare. Era pieno di gente, anche se ero arrivato di proposito alla fine della maggior parte delle gare; nonostante ciò, però, riuscì perfettamente ad identificare la testolina con metà capelli blu che mi interessava, appoggiata di spalle ad un fuoristrada nero. Aumentai deciso il passo dando spallate a destra e a manca per riuscire a non rimanere bloccato in mezzo a quella piccola ma soffocante folla, stando attento a non bruciare nessuno con la sigaretta. Riuscì a scorgere Jared alzare il collo nella mia direzione ma gli feci chiaramente capire che non dovesse avvisare della mia presenza. Lui annuì impercettibilmente tornando a chiacchierare vogliosamente con la rossa, circondandole le spalle con il braccio. Quando finalmente fui in grado di muovermi liberamente, cercai di alleggerire il più possibile i miei passi contro la terra, avvicinandomi furtivamente alle spalle di Carter. Trasportai la sigaretta tra il dito indice ed il medio prima di lasciar penzolare entrambe le braccia sulle sue spalle nude, facendola sobbalzare per lo spavento. Indossava una canottiera nera, con l’incrocio ad ‘X’ sulla schiena; un paio di pantaloni a cavallo basso color kaki che aveva alzato fino al polpaccio e delle Dr. Martens rosse ai piedi che la facevano somigliare dannatamente tanto ad una piccola versione femminile di Dante. “Non pensavo di averti detto che il nostro appuntamento si sarebbe tenuto qui, tesoro” le sussurrai, inclinando la testa così da riuscire ad arrivare al suo orecchio ed evitare che la sua amica o Jared mi sentissero. I suoi capelli sapevano di menta e sudore, al contrario mio che sapevo solo di sangue e disinfettante. La sua schiena si rilassò impercettibilmente, mentre inclinava la testa passando le dita sopra le mie mani; riuscivo a scorgere le caratteristiche della pelle d'oca sulle sue braccia sottili. Mi sfilò velocemente la sigaretta portandosela alla bocca prima di voltarsi verso di me con uno sguardo che era un mix tra irritazione e curiosità, squadrandomi attentamente. Con la mano libera afferrò la mia ferita, posizionandola tra la mia pancia e la sua, così che non si potessero più toccare ulteriormente – al contrario delle sue gambe tremolanti che cozzavano tremolanti contro le mie ginocchia. “Che hai fatto?” mi domandò a bassa voce, soffiandomi addosso il fumo. “Odori di .. sangue e terra ..” Scrollai semplicemente le spalle, ritirando la mano dalla sua presa. “Perché lo hai fatto?” “Fatto cosa?” Inarcò le sopracciglia, spostando i capelli su una spalla. “Venire qui” risposi, socchiudendo gli occhi. “Ero serio quando ti ho detto che saresti dovuta uscire con me” “E’ inutile che continui ad inventarti balle, Bieber” grugnì infastidita, tentando di fare qualche possibile passo all’indietro, finendo solo per attaccarsi maggiormente al mio torace. Riuscivo a sentire perfettamente il suo fiato caldo e regolare scontrarsi con l'incavo tra il mio collo e la parte superiore del petto, riscaldandomi. “Lo so che lo hai detto solo per non farmi venire qui. Ma, notizia dell’ultima ora: tu non mi dici cosa devo fare o no. Né tantomeno chi frequentare” puntualizzò, lanciandomi un’occhiata di sfida. Al che sentì nuovamente il mio corpo irrigidirsi e i denti dell’arcata superiore scontrarsi contro quelli di quella inferiore. “Lo hai visto? Perché diavolo non capisci che devi stargli alla larga, per il tuo bene?” sbottai, appoggiando le mani al cofano della macchina, circondandola da entrambi i lati che avrebbe potuto perfettamente - ed ero certo che avesse preso in considerazione la cosa - come via di fuga dalle mie lamentele sul suo comportamento. “Devi darmi una buona motivazione per stargli lontana, Justin. Lui non mi ha fatto niente.” Lasciò cadere il mozzicone a terra, schiacciandolo con la punta delle scarpe, indifferente. Mi passai una mano tra i capelli, alzando il collo alla ricerca dell’attenzione di Jared. “Lo ha visto?” gli domandai, ricevendo una scossa di capo come risposta, lasciando che la mia bocca si piegasse all'insù per un breve istante di soddisfazione nel vedere la sua espressione contrariata. “E’ difficile avere a che fare con te, piccola Harvey” ammiccai, riabbassando lo sguardo su di lei; aveva le labbra arrotolate all’interno ed i suoi occhi leggermente spalancati vagavano impediti nei miei. Se non fosse stato per quel poco di chiarore che offrivano le luci e che ne sottolineavano alcune sfumature cioccolato avrei quasi potuto credere fossero neri. “Ma, come vedi, ho i miei modi di sapere le cose.” “Sei solo un fottuto spaccone” sputò poco divertita, cosa che m’insinuò il dubbio che ce l’avesse ancora con me per qualche possibile motivo. Non che ce ne fossero pochi, ma doveva essere sicuramente qualcosa di recente perché prima del nostro battibecco dietro al Sanyo non sembravano esser ... Dietro al locale, certo! Mi ero quasi dimenticato di quel piccolo particolare che era stata la frase decisamente poco gentile che le avevo sputato addosso, quando l’unica cosa che lei aveva tentato di fare in quel momento era aiutarmi - ed io sapevo perfettamente che se ne avesse avuto voglia sarebbe stata perfettamente in grado di mollarmi lì, conciato com'ero, tra i bidoni immondi della spazzatura ed i gatti randagi. E sicuramente limitarmi a dirle che il suo modo di detestarmi mi stava mandando in tilt il sistema nervoso non sembrava esattamente il tipo di scuse che si sarebbe aspettata - e principalmente meritata - uscissero dalla mia boccaccia. Scuotendo la testa riportai nuovamente l’attenzione su di lei, pizzicandole il collo – come d’abitudine oramai. In realtà non riuscivo ancora a capirne il perché, ma mi piaceva particolarmente quel tipo di contatto con la sua pelle – attirando anche la sua su di me. “Sei uno stronzo” sibilò, massaggiandosi il punto colpito. "Davvero, finirò con il ritrovarmi il collo di un ippopotamo se non la smetti con questa cosa del pizzicarmi ogni volta" “Mi dispiace” “Per cosa?” ribatté guardigna, quasi pensasse che fosse un modo per prenderla in giro o sputarle qualche altra merdata addosso. Percepivo perfettamente l'indecisione nei suoi occhi scuri su di me. Mandai giù la bile, strizzando gli occhi. “Per tutto” sussurrai flebilmente al suo orecchio, con l’intenzione di rimanere nascosto tra i suoi capelli per i cinque minuti a seguire se non fosse stato che una mano pesante si fosse poggiata sulla mia spalla sinistra, strattonandomi poco delicatamente. Mugugnai qualcosa di incomprensibile perfino a me stesso, voltandomi – quasi grato a Jared, quasi – per aver interrotto quel momento leggermente imbarazzante. “Che c’è?” grugnì, incrociando le braccia. Lui scrollò ripetutamente la testa di lato, indicandomi un punto indefinito alla mia destra. Un piccolo puntino nero che si avvicinava, diventando man mano sempre più chiaro e ben visibile fin quando non riconobbi - in quella figura immersa nella tuta scura che usavano i corridori sotto alla maglietta ed il pantalone - la faccia arrossata e vittoriosa di Wes. Mi concessi di seguire per un momento il suo sguardo; giusto il tempo di capire che fosse rivolto interamente su Carter prima che i miei nervi ricominciassero a pulsare. Estrassi il mazzetto di chiavi dalla tasca dei jeans e lo ficcai pesantemente tra le mani di Carter, graffiandole i polsi. “C’è un SUV nero dall’altro lato della pista. Vai, entraci, ed aspettami lì” le dissi, spintonandola nella direzione giusta. “Ed e' un ordine questo, Carter. Sono serio” aggiunsi, notando che fosse quasi più propensa nel rimanere dov’era. Non l'avrei fatta assistere ad un'altra possibile scazzottata, soprattutto se uno dei tiratori sarei molto probabilmente stato io. Ero certo che la sua faccia viola per quasi tre settimane di fila fosse bastata a tutti - a me di certo. “Dai, andiamo. Forza” intervenne a quel punto l’amica dai capelli rossicci, tirandola per il braccio con foga, sussurrandole un'ulteriore sfilza di parole d'incitamento. “Justin, non vorrai dare spettacolo qui in mezzo, vero?” mi domandò preoccupato Jared, affiancandomi. Riportai lo sguardo su Wes, che oramai distava solo qualche passo da noi. “Se lui non rompe le scatole me ne starò buono, ti do’ la mia parola” “Oh, grazie. Questo si che è rassicurante amico” ammiccò ironicamente, incrociando le braccia. In verità avevo una voglia matta di tirare un pugno in faccia a Wes e non aspettavo altro che una sua provocazione, una parola di troppo o che aprisse semplicemente bocca per poter sfogare tutta la rabbia repressa che ancora non ero riuscito a scaricare quel pomeriggio, con l’albero – che avrei anche dovuto trovare un modo per sradicare non potendolo certamente lasciare lì tutto insanguinato in un quartiere da cui bambini e adulti particolarmente paranoici sbucavano da tutte le parti – o anche nel corso degli anni passati dall’incarcerazione a causa sua di Dante. Quell'ultima mi sembrava una motivazione abbastanza plausibile perchè scattassi anche all'istante verso di lui. Lo ricordavo perfettamente, seduto al banco dei testimoni, durante il processo mentre ammetteva semplicemente di averci visti girovagare intorno a casa Harvey quella fatidica sera, tra lo sgomento di tutti. Che fosse vero ciò che aveva detto, poi, era tutta un’altra storia. Perché Dante era stato spinto a fare ciò che aveva fatto per un motivo che andava ben oltre ad una dimenticanza di un ragazzino a malapena diciannovenne, mentre ciò che aveva spinto quell’idiota a spifferare tutto era stata la semplice voglia di vedere il padre – che era un gran deficiente francamente ed obbiettivamente parlando - ricevere un innalzamento del suo grado e della sua carica nella stazione di polizia di San Diego. Ciò che poi era effettivamente successo alla fine del processo – che se lo si guardava più attentamente faceva buchi da tutte le parti. Ma la consapevolezza di Dante che sua sorella l’avrebbe odiato anche se non fosse rimasto in carcere lo aveva spinto ad accettare il capo d’accusa di incendio doloso senza alcuna protesta. Da lì, poi, l'unico ricordo che avevo era la porta massiccia del tribunale che si richiudeva rumorosamente alle mie spalle. Il moro si fermò dinanzi a me, con il casco nella mano ed un insopportabile ghigno disegnato sulla faccia mentre continuava a tenere lo sguardo puntato sulle due ragazze alle nostre spalle. “Sei venuto a trovarmi, allora, Bieber” ammiccò, allargando le braccia – emulando ironicamente un probabile abbraccio che avrei dovuto dargli. “Oh, ma dov’è che sta andando la mia amica Carter?” “Hey, amico, lo dico per il tuo bene: è meglio che la smetti di parlare se non vuoi trovarti senza lingua” intervenne, con un certo divertimento nella voce, Jared. Allungò la mano all’indietro alla ricerca del mio braccio - probabilmente intuendo ciò che sarei stato effettivamente di combinare sentendo ulteriori battutine da parte sua. Prima ancora che me ne rendessi conto io stesso, però, ero già arrivato di fronte al ragazzo ed il mio pugno si era abbattuto automaticamente sulla sua mandibola, facendolo ruzzolare all’indietro per la sorpresa. “Porca troia Justin! Avevi detto che facevi il bravo!” mi urlò contro Jared, afferrandomi una spalla e spintonandomi verso la macchina mentre un piccolo gruppetto di ragazzi accerchiava Wes. “Cazzo, siamo nella merda se non ce ne andiamo subito!” Roteai il polso, ignorando le fitte di dolore che provenivano dalle nocche – che probabilmente dovevano essersi rotte di nuovo, vista la garza che stava iniziando a macchiarsi di nuovo del colore rosso acceso del sangue - seguendolo. “Ma io mi sento meglio” affermai convinto. Perché davvero mi sentivo effettivamente più leggero. "Cristo, sei un fottuto idiota Bieber" mi inveì contro ancora, attraversando a grandi falcate il breve tratto di strada che ci divideva dalle nostre vetture. Non appena riuscimmo a raggiungere le due ragazze, - che stavano discutendo animatamente sotto voce - Jared si affrettò a trascinarsi dietro la rossa, borbottando qualcosa di vagamente somigliante ad un 'ho bisogno di bere' - accompagnato ovviamente da qualche altra parola un po’ meno carina nel mezzo. “Justin …” Aggirai facilmente la macchina, saltando al posto del guidatore, ignorandola. "Justin ..." insisté, entrando con qualche difficoltà nel sedile di fianco al mio. Si sfilò le scarpe, scoprendo degli orrendi calzini a righe gialle e nere, portando le ginocchia al petto ed appoggiandovi sopra il mento, stranamente silenziosa per i suoi standard. "Dammi le chiavi, per piacere" domandai gentilmente, allungando il braccio di lato. Titubante appoggiò il mazzetto sul palmo aperto della mia mano; tornò a circondarsi le gambe con le braccia, fissando pensierosa il terreno che si muoveva tutt’intorno a noi mentre ingranavo la retromarcia, per immettermi nella strada secondaria che ci avrebbe riportati su quella principale per San Diego. Buttai il pacco di sigarette al di sopra del cruscotto dopo averne accesa l'ennesima della giornata, mentre con la mano libera abbassavo il finestrino e accendevo la radio; non particolarmente interessato a ciò che ne trasmettevano piuttosto a coprire quell’assurdo silenzio che si era creato tra noi due. Cosa che non pensavo possibile succedesse, vista la lingua biforcuta e tagliente di entrambi. In realtà mi stupiva già di per se il fatto che non mi fosse saltata addosso urlandomene contro di tutti i colori per essermi presentato lì - nonostante sicuramente lo avesse già previsto - , o anche solo per averla ignorata in quel modo. E non sapevo se ciò fosse un passo in avanti nel nostro ‘rapporto’ o una cosa decisamente negativa. Del resto con lei tutto era possibile - quella era un'altra cosa che avevo capito. “Perché lo hai fatto?” mi domandò flebilmente, dopo un lungo lasso di tempo passato in silenzio a giocherellare con l'Arbre Magique rosa e scolorito che dovevo avere lì da qualcosa tipo un annetto e qualche mese, appeso allo specchietto retrovisore. Frenai al semaforo rosso e voltai un secondo la testa verso di lei, confuso; una ciocca di capelli le ricadeva sul naso con la quale giocherellava soffiandola lontano. “Fare cosa di preciso?” “L’albero ... le tue mani ...” Il verde scattò e lasciai il mio piede scivolare sull’acceleratore, incredulo. “Come lo sai?” domandai, muovendomi sul sedile, agitato. “Dante aveva fatto la stessa cosa prima che .. uhm … lo portassero via, sai …” sussurrò, mordicchiandosi il labbro, già arrossato da sé. “La sera prima era tornato a casa verso le tre, con le mani insanguinate e scorticate. In realtà lo faceva già da un paio di sere antecedenti a quella; lui pensava nessuno se ne accorgesse, ma ogni voltai che gli chiedevo di intrecciarmi i capelli io lo vedevo come si dimenava quando un capello si fermava sul dorso della sua mano. Alla fine, rimuginandoci su quando non volevo dormire, sono arrivata ad una teoria che avesse un senso: credo che, nelle serate in cui in casa tutto degenerava, infliggersi dolore da solo lo aiutasse a reggere meglio quello che gli procuravano gli altri; era una sorta di sfida alla sopravvivenza con se stesso. Sembrava quasi volesse rendersi immune a qualunque tipo di dolore pensasse di poter provare ...” spiegò, con una nota di insicurezza nel corpo che non pensavo le avrei mai visto addosso o che forse, più semplicemente, non le si addiceva per niente. "Poi, ripensando a quando la polizia si è presentata a casa della zia e a come lui gli era andato incontro ... beh ... ho capito perchè aveva voluto costruirsi quella sorta di 'corazza' " Lui sapeva che, in un modo o nell'altro, qualcosa sarebbe comunque andato storto - sua sorella lo avrebbe detestato, in un certo senso, in entrambi i casi; contemporaneamente però, se non avesse tentato di porre fine a tutta quella sofferenza che provavano tutti loro ogni sera, ci avrebbe pensato qualcun altro in un modo decisamente più brutale e doloroso - e allora aveva preferito scegliere perlomeno il modo meno doloroso possibile per i suoi fratelli - Carter specialmente. Soffiai una nuvoletta di fumo contro il vetro, annuendo impercettibilmente con la testa, stringendo la presa sul volante in pelle. Mi era effettivamente capitato di notargli le mani fasciate nelle ultime settimane passate assieme, ma inizialmente avevo pensato fosse solo una conseguenza della boxe che aveva iniziato a praticare quotidianamente da poco. Poi, una sera, mentre ciondolavo per le strade vuote della città - in una delle tante volte in cui mia zia aveva comunque trovato il modo di tenermi fuori casa per sbrigare i suoi 'affari' con i suoi 'uomini' - lo avevo trovato accasciato con la testa contro ad un albero. Ed anche lì non mi era sembrata una cosa poi così anormale; ma poi avevo notato qualcosa di scuro e denso scivolargli lungo la gamba ed allora, avvicinandomi, lo avevo visto: insanguinato fino ai gomiti, arrabbiato, frustrato e visibilmente furioso con se stesso, che prendeva a pugni quell'albero. Dopo quella volta avevo tenuto costantemente sotto controllo lo stato delle sue mani, nonostante lui mi tirasse un pugno in faccia ogni volta che lo facevo. Per un certo lasso di giorni avevo anche creduto avesse smesso di autopunirsi per delle colpe che si addossava e che oggettivamente parlando non erano sue, ma effettivamente mi ero sbagliato. Ma nel fare la stessa cosa quel pomeriggio non mi aveva nemmeno sfiorato il ricordo di lui che lo faceva, anche se probabilmente era più colpa mia, dato che tentavo di evitare ad ogni costo qualsiasi momento in cui si sentisse anche minimamente la sua presenza. Avevo chiuso a chiave quel cassetto del mio cervello nel esatto momento in cui mi aveva parlato delle sue intenzione perché, forse, sapevo fin dall’inizio che quella ‘cosa’ non sarebbe finita bene per nessuno dei due, indipendentemente dalla partecipazione messa in ciò. Era un modo come un altro che avevo adottato per non autodistruggermi con la consapevolezza che se solo fossi stato abbastanza convinto e sicuro che ciò che aveva in mente fosse assolutamente sbagliato, avrei potuto fermarlo. Ma il problema, in tutto quella situazione, era proprio quello: non ne ero abbastanza convinto. Frenai nuovamente ad un altro semaforo rosso, scorgendo la macchina di Jared immettersi nella mia stessa corsia. Lasciai cadere il mozzicone di sigaretta sull’asfalto, afferrandone immediatamente un’altra. “Per te” ammisi, arrendendomi a quel silenzio. La testa di Carter scattò nella mia direzione; occhi e bocca spalancati, incredula. “Come scusa?” “Questo” indicai le mie mani con un cenno della testa, svoltando a sinistra non appena il semaforo tornò verde, nonostante sotto quel 'questo' non ci fossero solo quei segni rossi. “Per te. Ecco perché.” HOLA 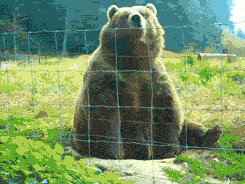 Sono tornata (yay) e questa volta ho aggiornto quasi in tempi record. Ed il capitolo è lunghissimo, davvero tanto. Volevo anche provare a dividerlo, ma poi non avrebbe reso a pieno l'idea di ciò che stava succedendo. A dirla tutta, in realtà, non so davvero cosa dirvene al riguardo. Perchè sono la prima a non essere sicura di come risulti tutto l'insieme. Se sia semplicemente 'orribile' o 'disgustoso' oppure 'passabile'. Ma comunque qualcosina in più su tutta la faccenda è venuta fuori, anche se non dettagliatamente, ma è pur sempre qualcosa che può aiutarvi meglio nella comprensione della storia. Insomma, sono sull'orlo di una crisi nervosa quindi è meglio che non mi dilunghi ulteriormente. Anyway, i commenti e le impressioni finali vanno come sempre a voi. Che siete sempre magnifiche, con me, forse anche troppo. Quindi, mentre decido se sia il caso di rimettere piede su efp per il prossimo capitolo, alla prossima, baci ☺♥ |
Capitolo 13
*** 12. We are the results of what we have been led ***
 12. Carter “Okay,sono agitata” ammisi, continuando a fissare il mio riflesso nel vetro oscurato del finestrino, che si mischiava con gli alberi e le case che ci scorrevano veloci di fianco.
Leanne ruotò gli occhi divertita, parcheggiando sul ciglio della strada di fronte casa mia. “Avresti dovuto pensarci prima di farti mettere le mani in testa da Miles” mi rimbeccò, allisciandosi i capelli con la mano. Quasi automaticamente – come d’altronde nelle ultime due ore – mi passai la mano sulla nuca, spostando la mia massa liscia e luccicante di capelli che avevo, sulla spalla sinistra. “Ti ricordo che sei stata tu ad incoraggiarmi questa volta” “Ecco, allora dov’è il problema?” domandò secca, aspettando che scendessi anch’io dalla macchina prima di poter mettere le sicure. “Elia è abituato ai tuoi colpi di testa, letteralmente parlando in questo senso, quindi da dove escono tutte queste paranoie?” “Dopo che sono tornata a casa con i capelli mezzi blu ci ha impiegato una settimana prima di capire che la ragazza che trovava nel mio letto la mattina, quando non volevo svegliarmi, ero effettivamente io e non un’allucinazione” bofonchiai, passandomi di nuovo la mano sui capelli. “E tu mi ha perseguitata per un’altra settimana nel tentativo di tagliarmeli” “Ti sto inseguendo con delle forbici in mano, per caso, in questo momento?” ribatté piccata Leanne, ridacchiando. “No, ma perché questa volta ti ho avvisata in anticipo e sei anche venuta con me” “Senti Ter, il colore ti sta da Dio e durerà solo un mese, o anche me. Ed Elia non ci farà nemmeno caso.” “Lo spero” annuì, muovendo su e giù la testa. “Ma sappi che il viola non è esattamente un colore che passa inosservato, soprattutto agli occhi di mio fratello” “Ed è anche per questo che lo hai scelto, no?” rise, scuotendo la testa. “Vero anche questo” ghignai, fermandomi dinanzi alla porta. Portai il ginocchio contro di essa – cercando di non perdere il mio equilibrio, che era già precario di per se – appoggiandovi sopra la borsa alla ricerca delle chiavi di casa. Ancora non mi capacitavo di non riuscire a trovarle anche quando dentro ci mettevo solo portafogli, sigarette, occhiali e qualche rara volta uno o due libri quando Leanne, che dentro ci buttava mezzo armadio, trovava anche un anellino minuscolo in meno di qualche secondo. “Comunque devi ancora spiegarmi cosa sta succedendo tra te e Justin” domandò, scrollando le spalle e sorreggendomi per un braccio. “Se lo sapessi, te lo direi molto volentieri” accennai, infilando le chiavi nella serratura, facendola scattare. “E di Wes che mi dici? Che so … vi state frequentando .. o roba simile? Ti piace, ad esempio?” “No, macché. Mi ha scritto per chiedermi come mi era sembrata la gara, ma poi non mi sono dilungata ulteriormente nella conversazione.” Spalancai la porta, lasciando cadere la borsa a terra. In realtà mi aveva anche invitata a ‘bere qualcosa’ Giovedì sera, ma per una qualche ragione sconosciuta anche a me non ero riuscita ad accettare la sua proposta – neanche solo per irritare ulteriormente Justin. C’era qualcosa nel modo in cui mi parlava – quasi come se ci conoscessimo da una vita – che aveva fatto accendere in me un campanellino d’allarme e improvvisamente il disprezzo spropositato con il quale lo guardavano Justin e Jared iniziava a non sembrarmi più tanto privo di significato e crudele. Ed ero certa che quella sottospecie di riluttanza che provavo nei suoi confronti non derivasse dal mio essere acida, fredda, scostante e strafottente o dalla poca fiducia che avevo nelle persone. C’era qualcosa di molto più profondo dietro ciò, ed io volevo capire cosa fosse, anche senza dover obbligatoriamente stare a contatto con lui – cosa che però mi risultava di già abbastanza complicata. Sfilai il giubbino lanciandolo a casaccio sul divano. “In realtà mi aveva anche chiesto di uscire ma ho rifiut … o mio Dio!” Quasi affogai nelle mie stesse parole nel notare la figura di Keaton fronteggiarne una leggermente più bassa che nonostante cappello e felpone nero riuscì ad identificare come Justin, nel mezzo del mio soggiorno. “Che diamine ci fate voi due in casa mia?” urlai stizzita, attirando la loro attenzione. “Sei affogata nel pavimento, per caso? Perché gli hai detto di n … che diavolo succede?” mi fece eco Leanne, scontrandosi con la mia schiena. Scuotendo i capelli mi si affiancò, alternando lo sguardo da Justin, a Keaton per poi finire su di me, visibilmente confusa. “Che diavolo ci fanno questi due, che tra l’altro mi sembrano sul punto di strapparsi a morsi a vicenda, in casa tua Ter?” mi domandò all’orecchio, mentre si issava con facilità sullo schienale del divano. “Non ne ho la minima idea. Ma so per certo che adesso voglio buttare fuori a calci entrambi” borbottai in risposta, scivolando furtivamente in mezzo ai due ragazzi puntando le mani sulla pancia di entrambi nel tentativo di allontanarli l’uno dall’altro. “Che cavolo state facendo? E come avete fatto ad entrare?” domandai brusca, alternando occhiatacce rabbiose ad entrambi, chiedendogli esplicitamente di trovare una scusa plausibile che potesse giustificare la loro presenza lì; ed in particolar modo quella di Justin. Il biondo riservò un’altra occhiata truce a Keaton prima di abbassare lo sguardo su di me, con aria pensierosa; come quella notte al Sanyo riuscì a scorgere i suoi occhi viaggiare lenti per tutto il mio corpo - dagli stivali bianconeri ai miei piedi su per le gambe, il maglioncino glicine che avevo deciso di usare, vista la mia ‘altezza’ , come vestito, i fianchi e il petto - prima di soffermarsi sulla mia faccia e strabuzzare leggermente gli occhi chiari, accennando un sorriso languido. “Allora eri seria quando me lo hai detto” sentì borbottare Keaton alle mie spalle, mentre mi spostava i capelli sulla schiena, tirandoli con un gesto delicato ricordandomi con quanta meno – molta meno – delicatezza usasse tirarmi le tracce nel periodo in cui le portavo, che risaliva a quando avevamo tra i sette e gli otto anni. “Avevi qualche dubbio?” ammiccai, pronta a voltarmi verso di lui e far finta che vederlo assieme a Justin non mi agitasse, in qualche modo. Ma il braccio di Justin affondò velocemente nei miei fianchi costringendomi a rimanere di fronte a lui, sotto lo sguardo divertito e curioso di Leanne e quello affatto divertito e probabilmente infastidito di Keaton. Non erano nemmeno passate ventiquattro ore dall’ultima imbarazzante e confusa volta che ci eravamo visti: in macchina, con quel ‘per te ’ che continuava girare per l’aria afosa nell’abitacolo e la mia lucidità offuscata da confusione e rabbia. Non riuscivo ancora a capacitarmi di tutto quel interesse verso di me da parte sua; essere amico di Dante non lo costringeva di certo a farmi da ‘guardia del corpo’ e di certo lui non glielo aveva chiesto - sapeva perfettamente che se lo avesse fatto la sua ‘posizione’ nella mia vita non avrebbe di certo fatto qualche passo avanti – quindi perché prendersi tanto disturbo per me, nonostante anche il nostro rapporto non fosse decisamente dei migliori? Parlargli – nonostante, anche con mia grande sorpresa, lo avessi fatto per davvero – o trovarlo dannatamente rassicurante in quel momento non stava a significare che avevo automaticamente riposto fiducia in lui. Quella parte di me che aveva l’odiosa abitudine di fidarsi di chiunque dal principio, con la strana convinzione che ‘se fai del bene ricevi del bene’ , l’avevo strappata via da me molto tempo fa e nemmeno per tutto l’oro del mondo avrei accettato di riaverla indietro – e aspettarmi il peggio dalla gente, per poi magari sbagliarmi, mi stava più che bene. E Justin lo sapeva, lo aveva capito, ne ero certa, quindi perché questa sorta di ‘affetto’ verso me e la mia vita? A quale scopo tutto ciò? Perché incasinarmi ulteriormente con il suo essere così dannatamente protettivo e – a modo suo – dolce? Per la seconda volta nell’ultimo mese da quando era tornato mi ritrovavo a pensare che Justin fosse il primo ragazzo – dopo Dante – a farmi avere così tanti ‘perché’ in testa. Ed io lo odiavo; detestavo pormi così tante domande, – su un ragazzo soprattutto – e detestavo che fossero senza risposta; detestavo il fatto che fosse stato proprio lui a farle sorgere e detestavo ancora di più che – nonostante tentassi di impedirglielo - in qualunque caso lui stesse riuscendo ugualmente ad intrufolarsi nella mia vita, con o senza il mio permesso. Ed odiavo ancora di più avere la consapevolezza che se ci fosse riuscito magari, al suo ritorno, Dante sarebbe stato capace di fare la stessa cosa con altrettanta facilità - una cosa che sicuramente non desideravo facesse. Sentire la sua mano intrufolarsi delicatamente nei miei capelli mi riportò alla realtà, dove i suoi occhi – che solo in quel momento mi accorsi erano contornati da un profondo alone grigiastro, quasi non dormisse da giorni – erano ancora fermi nei miei. “Perché Justin?” mi lasciai sfuggire, frustrata, soffiandogli sul collo. La sua mano si soffermò qualche istante sulla base del mio collo prima di lasciar scivolare le dita per tutta la lunghezza dei capelli, accennando un sorriso divertito alla mia espressione stizzita. Probabilmente doveva averlo capito anche lui che quel tipo di contatti tra il suo corpo ed il mio continuavano a lasciarmi interdetta ogni volta; ma comunque a lui sembrava importare decisamente poco visto che continuava a rifarlo ogni volta che la distanza di sicurezza tra di noi - che teoricamente avremmo dovuto mantenere - diminuiva. “Oh, Keaton. Te lo ricordi che dovevi ancora farmi vedere quella cosa che hai visto vicino al parco? Che ne dici di portarmici adesso, eh? Dai!” trillò improvvisamente Leanne, saltando giù dal divano con un balzo abbastanza rumoroso. Si avvicinò furtivamente a Keaton ed iniziò a trascinarselo dietro verso la porta, – sotto le sue proteste - strizzando un occhiolino nella mia direzione e ricevendo come risposta il mio dito medio alzato da sopra la spalla di Justin. La porta si richiuse velocemente con un colpo secco alle loro spalle, lasciando me e il biondo da soli. “Senti …” sospirai, passandomi le dita sugli occhi. “Che cosa ci facevate qui?” “Presumo che fossimo qui entrambi per te; quando sono arrivato mi ha aperto il tuo amichetto” asserì lui, inclinando di poco la testa. Riuscivo a sentire i suoi capelli solleticarmi la fronte. “E che vi siete detti?” insistei, tentando di fare qualche passo all’indietro, con la sua mano ancora tra i miei capelli. “Sembravate sul punto di prendervi a pugni” “Niente di cui tu debba venire a sapere qualcosa” ridacchiò, spostando la mano e afferrando una ciocca di capelli viola al lato della mia faccia, arricciandosela al dito. “Mi piaci così” ammise ancora, tentando di mantenere il contatto con i miei occhi. Aprì bocca per parlare, alla ricerca disperata di qualcosa di estremamente acido e stronzo da dirgli in risposta, ma l’unica cosa che ne uscì fu un respiro strozzato perché effettivamente, per quanto ci provassi, non c’era davvero niente che potessi dirgli per far sparire quella nota di imbarazzo e bruciore che si era estesa a macchia d’olio sulla mia faccia - che doveva essere diventata dannatamente rossa. Mi limitai a lasciar scivolare i miei occhi verso il basso, trovando improvvisamente interessanti i suoi pantaloni scuri che verso l’orlo sfumavano in un colore bianco spento. “Perché sei venuto qui, allora?” domandai dopo qualche attimo di esitazione, recuperando il controllo di me stessa. Sistemò accuratamente la ciocca sulla mia spalla, spostando la presa della mano sulla mia, iniziando a trascinarmi delicatamente verso la porta. “Devi venire con me” “Cosa? Ma che dici? Dove?” “Non importa, per adesso” “Woah, fermo, fermo!” protestai, strattonando il braccio per fargli mollare la presa. Piantai per bene i piedi a terra, incrociando le braccia al petto. “Io con te non vengo da nessuna parte se non mi dici dove, perlomeno” Lui alzò le sopracciglia, voltandosi. “Se ti dicessi che è una sorpresa?” tentò, allargando le braccia. “Io odio le sorprese” Roteò gli occhi, scrollando le spalle. “Come vuoi. Lo hai voluto tu” affermò ghignando, prima di avventarsi con uno scatto su di me; allungò le braccia sulle mie ginocchia e le piegò, trascinandomi sulla sua spalla con uno strattone brusco. Strabuzzai gli occhi nel ritrovarmi faccia a faccia con le sue mutande rosse Ralph Lauren che gli sbucavano dall’orlo dei pantaloni. “Dio, Bieber! Mollami!” urlai, pizzicandogli un fianco. Lui scoppiò a ridere, sbattendo la porta di casa per chiuderla. “Io userei quella mano per tenere il tuo vestito al suo posto, piuttosto che per tentare inutilmente di farmi male” “Oh, ‘fanculo Bieber!” ________________________________________________________________ Mugugnai qualcosa di incomprensibile perfino a me stessa spintonando la massa indefinita e calda che mi disturbava il sonno, voltando la testa dall’altro lato. Nonostante fossi ormai sveglia rimasi in quello stato di dormiveglia per un lasso di tempo a me indefinito, beandomi dell’assoluto silenzio che mi circondava prima che questo potesse finire. “Carter!” Per l’appunto. La voce bassa di Justin si fece sempre più vicina, fin quando non sentì qualcosa di freddo e pesante ciondolarmi sul collo. “Dai Bella Addormentata” domandò alzando esageratamente – perlomeno per le mie orecchie – il tono di voce, con un pizzico di divertimento al suo interno. “O per caso lo vuoi anche tu un bel bacino per svegliarti, huh?” ridacchiò, pizzicandomi il collo. Avvertì un calore quasi scottante salirmi – asfissiante e lento, come le colate di lava dai vulcani in eruzione – dal collo fino alla fronte, pizzicandomi le guance, che mi fece strabuzzare gli occhi in una maniera quasi disumana. “Taci, idiota!” gli urlai contro, improvvisamente affannata, colpendogli la spalla con una gomitata mentre mi sollevavo dallo schienale in pelle. Non che la possibilità di un suo bacio fosse praticabile con me, ma l’immagine della sua bocca rosea che scivolava con inesorabile lentezza verso la mia, – anche per un solo breve ed ipotetico attimo – e che il mio cervello aveva già pensato di elaborare, aveva fatto si che il mio cuore perdesse qualche battito, mandando il mio sistema respiratorio in stallo. Justin chiuse gli occhi mentre scoppiava in una fragorosa ed irritante risata divertita, tenendosi la mano destra sullo stomaco. “Dai, ti stavo solo prendendo un po’ in giro” “Beh, qui l’unico che si è divertito sei tu” accantonai il discorso acidamente, sventolando la mano all’aria. “Piuttosto, quand’è che mi sono addormentata? E dove siamo? E, cosa più importante, perché non ti ho ancora ucciso?” domandai, sistemandomi meglio sul sedile. Aggiustai l’orlo del maglioncino che era risalito di poco sulla gamba, guardandomi incuriosita intorno: uno strano rumore appena accennato – simile ad un ronzio – fuoriusciva dal cruscotto, quindi dalle piccole sferzate d’aria calda che mi arrivavano sui piedi ed in faccia potevo facilmente dedurre che Justin avesse acceso il riscaldamento – e anche da abbastanza tempo perché tutto l’abitacolo sembrasse quasi munito di termosifoni e stufette elettriche. Alcuni giubbini – tra i quali probabilmente anche il mio – erano gettati a casaccio sui sedili posteriori ed un bicchiere di caffè ammaccato e pieno di mozziconi di sigarette restava in equilibrio sul freno a mano - dove in quel momento la mano di Justin si appoggiò per non far cadere la cenere sui tappetini. I finestrini erano leggermente appannati – probabilmente all’esterno si doveva congelare – ma comunque la vista non era impossibile e riuscì a notare, all’orizzonte, i grossi nuvoloni fuligginosi che si erano stagliati sul cielo di San Diego facendo piombare la città nel buio più totale alle cinque e mezzo di pomeriggio, tanto che alcuni lampioni che costeggiavano i marciapiedi iniziavano ad accendersi uno ad uno, lanciando a terra fasci di luce aranciata ad intermittenza. “Oh, intendi dopo aver passato dieci minuti a prendertela con me ed altri dieci con i tecnici della stazione radio per aver passato una canzone di Taylor Swift?” ammiccò ghignante Justin, inarcando perfettamente il sopracciglio destro. “Hai preso il mio telefono, ci hai messo le cuffie, mi hai lanciato qualche altra minaccia per cinque minuti e poi, finalmente, ti sei addormentata” terminò, sventolando all’aria il suo iPhone dorato con le cuffiette ancora attaccate e sulla schermata il video di Beyoncè e Jay-Z in Crazy In Love, messo in pausa sull’immagine di lei che con un enorme pellicciotto sulle spalle girava sensualmente attorno al rapper gettandogli i capelli in faccia. “Preferirò sempre ascoltare tre interi CD di Beyoncè, credimi” lo sbeffeggiai, aguzzando lo sguardo per scorgere altro del paesaggio al di fuori del finestrino. “Piuttosto, dov’è che siamo? Fermi, tra l’altro?” Che fossimo ancora in California, o nei pressi di San Diego, era una cosa di cui ero assolutamente certa; non riuscivo, però, a ricollegare quel posto al nome di una qualche città, nonostante quelle stradine poco trafficate con le impronte degli pneumatici sull’asfalto mi risultassero terribilmente familiari. Una schiera di casette immacolate dai giardini ben curati occupava interamente il lato di strada opposto a quello sul quale Justin aveva deciso di parcheggiare, dove invece le case s’innalzavano su una minuscola sottospecie di collinetta, costeggiata in sottofondo da una fitta boscaglia scura di alberi le cui punte venivano sbattute violentemente dal vento a destra e a sinistra. Sui marciapiedi si alternavano vecchie panchine verdi a segnali di divieto di sosta ammaccati o ripiegati su se stessi; solo due o tre bambini più coraggiosi degli altri erano rimasti nel giardinetto di una casa a rincorrere un cagnolino nero mentre il resto del quartiere taceva. “Oh, beh, a proposito di questo” accennò Justin al mio fianco - schioccando le dita in modo teatrale – mentre si portava una sigaretta alla bocca. “Credo di essermi dimenticato di avvertirti che … uhm … beh, ci sia stato un piccolo imprevisto nel nostro viaggetto” A quelle parole spalancai completamente gli occhi, voltando del tutto la testa verso di lui e perdendo completamente interesse nel voler identificare il luogo preciso in cui ci trovavamo, o anche solo a capire dove avesse avuto intenzione di portarmi. “Che intendi dire con ‘piccolo imprevisto’?” Lui scrollò le spalle, accendendo la sigaretta. “Oh, niente di che. Siamo solo … uhm … a secco” ammise, per niente interessato, mentre buttava fuori una nuvoletta di fumo. “Siamo a cosa?” urlai stridula, sollevandomi sul sedile. “Giuro che sto per colpirti con una scarpa, Justin, quindi se è un fottuto scherzo faresti bene a dirmelo in questo preciso momento” lo minacciai, portando la mano verso le scarpe. “Ritira le unghie bimba” mi sbeffeggiò lui, puntando il suo sguardo sulle mie gambe. “Ho chiamato Jared, Ian e Blake. Stanno arrivando con la benzina” “Da quanto siamo fermi qui, Justin?” “Vuoi la verità? Circa un’oretta e mezza” Spalancai occhi e bocca, - di nuovo – fissandolo sconvolta. “Stai scherzando, vero?” “Perché dovrei ..” “Okay, ho bisogno d’aria” Voltai completamente il busto verso la portiera, sganciando la cintura e scendendo dall’abitacolo con un balzo. Una folata d’aria gelida – come avevo immaginato – mi colpì in pieno e dovetti mordermi la bocca per trattenermi dal saltare di nuovo in macchina e continuare ad arrabbiarmi con Justin per ogni sua parola. Ancora mi riusciva impossibile credere una cosa del genere. Davvero ero ferma nel bel mezzo della strada assieme a lui? Con il diluvio universale in arrivo e una scorta limitata di sigarette? Senza caffè e con la macchina morta? Come diavolo avevo fatto a cacciarmi in una situazione del genere? Con Justin, soprattutto? E, cosa ancora più importante, dove voleva portarmi precisamente? Speravo per lui, però, che non fosse stato solo un modo alternativo per farmi incazzare. Scuotendo la testa aggirai la macchina, appoggiandomi con il fondoschiena al cofano. Incrociai le braccia al petto, sentendo il freddo che s’inoltrava agilmente tra i buchi del maglione entrandomi nella pelle e spazzando via il calore che aveva regnato nella macchina fino a qualche istante prima. Feci per voltare la testa all’indietro, alla ricerca di qualche altra informazione sul posto, tanto per occupare la mente con qualcosa, ma Justin mi si gettò improvvisamente contro – e con dei movimenti talmente silenziosi che mi dovetti tappare la bocca con le mani per non urlare - costringendomi a tenere la faccia rivolta verso di lui. “Perché diavolo sei uscita?” mi domandò – stranamente allarmato – piantandomi le mani calde ed ancora fasciate con la garza bianca sulle guance. “Si gela qui fuori …” “Volevo evitare a me il disturbo di prenderti a pugni e a te quello di prenderli” bofonchiai irritata, scrollando le spalle. In realtà non capivo esattamente nemmeno io il motivo di quell’improvviso ‘rancore’ nei suoi confronti; in fondo Jared ed i ragazzi sarebbero arrivati tra meno di qualche minuto e saremmo potuti ritornare a casa. Per una qualche strana ragione, però, sentire il modo con cui il mio corpo reagiva ultimamente alla sua presenza – che si faceva ogni volta sempre più vicina – mi confondeva, soprattutto perché non mi era ancora ben chiaro se quella sua sorta di ‘affetto’ nei miei confronti fosse stata scaturita da una qualche ragione particolare e contorta a me sconosciuta o semplicemente dietro le sue attenzioni non c’era nessuna sottospecie di secondo fine ed ero io quella che si faceva decisamente troppe paranoie – cosa molto probabile. Dopo sette anni infernali, l’incendio, la morte di mia madre e l’incarcerazione di Dante mi veniva piuttosto difficile pensare ad una qualunque cosa senza andare a cercarne volontariamente la parte ‘marcia’ – vedere dei fiori per strada, ad esempio, per poi pensare che alla fine della bella stagione appassiranno; osservare i petali morbidi e sottili delle rose aprirsi leggermente alla luce del sole per poi lasciar scivolare automaticamente lo sguardo sul gambo lungo e pieno di spine minacciose pronte a pungere. Ed era così anche con le persone; avevo tentato di prendere la vita con una filosofia alla Jessie J1, ma dopo una undicina di anni passati tra dolore e rabbia mi riusciva un po’ difficile così preferivo non farmi più nessuna aspettativa. Non che fosse divertente o facile non fidarsi di nessuno – se non della mia cerchia storica e ristretta di amici – ma in quel momento mi stava bene così e di certo non avevo intenzione di buttare all’aria tutto ciò per fidarmi del primo che mi capitava dinanzi, soprattutto se quel qualcuno era Justin – nonostante si fosse dimostrato più che rassicurante ed amichevole nelle ultime settimane. Ma lui aveva il doppio delle possibilità di farmi del male rispetto a qualche altro estraneo qualunque ed io non ero esattamente certa di riuscire – all’evenienza – a sopportare ulteriore dolore quindi preferivo andarci con i piedi di piombo. Ed essere ferma nel bel mezzo della strada con lui, ed anche senza la minima idea di dove avrebbe voluto portarmi, non contribuiva di certo a migliorare la situazione. Quando sentì qualcosa di bagnato e freddo scivolarmi sul naso mi costrinsi a tornare alla realtà, riportando l’attenzione sulla faccia di Justin che distava ancora pochi centimetri dalla mia, immobile. “Sta per piovere, forza, entriamo” suggerì lui brusco, staccandosi da me. Aspettai pazientemente che muovesse almeno qualche passo in direzione dello sportello aperto prima di provare a voltare di nuovo la testa alle mie spalle e capire cosa non andasse. Tentare, però, per l’appunto. Le mani di Justin si piantarono bruscamente, di nuovo, sulle mie guance modificando la traiettoria della mia faccia e riportandola su di lui. “Sei disarmante, piccola Harvey” ammise, quasi divertito, muovendo su e giù il pollice tracciando scie immaginarie sulla mia pelle. Scrollai le spalle sentendo altre gocce cadermi velocemente addosso. “Che cosa mi nascondi Justin?” “Niente” affermò sciuro, aumentando la presa. “Niente, davvero, va bene? Adesso basta con le domande ed entriamo in macchina” Le gocce iniziavano a prendere velocità ed in un attimo il cielo si illuminava ad intermittenza grazie a lampi e tuoni che si susseguivano ritmicamente all’orizzonte, con la città che sembrava essere presa a secchiate da qualcuno. Sentivo l’acqua scivolarmi agilmente nei vestiti, attaccandosi alla pelle e scivolando lentamente, solleticandomi, verso il basso. Ma comunque non avrei mosso piede da lì, nonostante il fastidio che provassi nel sentire anche la mia biancheria inzupparsi lentamente – avevo sempre detestato la pioggia. Quella cosa del buttarsi in mezzo ad una strada deserta durante un temporale e lasciarsi colpire dall’acqua che qualcuno diceva di amar fare non ero mai riuscita a comprenderla; quelle sensazioni di libertà e freschezza delle quali si scriveva anche nei libri io non le avevo mai percepite, nemmeno quando l’anno scorso avevo dimenticato l’ombrello a casa ed il cappuccio del mio giubbino non era stato un granché utile a proteggermi dal temporale. L’unica cosa che per l’appunto sentivo alla perfezione durante la pioggia era unicamente l’acqua che s’infiltrava prepotentemente in ogni buco possibile, e lo detestavo. Justin, probabilmente intuendo le mie intenzioni, si lasciò sfuggire dalle labbra umide uno sbuffo rumoroso mentre si sfilava con un unico e fulmineo gesto la felpa. E quando afferrò delicatamente il mio braccio per infilarcelo nella manica la strana sensazione di battito cardiaco velocizzato di prima mi si ripresentò improvvisamente, facendo andare in ebollizione la mia temperatura corporea. Justin afferrò entrambi i lembi della felpa e la alzò fin sotto al mio collo, accennando un sorriso divertito mentre con la mano libera mi alzava il cappuccio sui capelli. Piegò la testa di lato, osservandomi silenziosamente.“Stai bene così. Sembri …” “Sembro..?” “Sembri … non lo so … sei carina e basta” brontolò, grattandosi la nuca. I capelli bagnati gli ricadevano pesantemente sulla fronte, i jeans erano scesi sui fianchi, appesantiti dall’acqua, e la maglietta a maniche corte nera gli era aderita al torace come una seconda pelle sottolineandone i muscoli contratti e leggermente prominenti del busto. “Ora possiamo entrare mentre aspettiamo i ragazzi, per favore? E senza che tu provi a rifare quello che hai in mente di fare?” domandò gentilmente, ruotando stranito gli occhi nel sentire lo strano gioco di parole che gli era venuto fuori. Non sapevo per quale preciso motivo Justin non volesse farmi voltare né tantomeno perché io volessi farlo, ma c’era un qualcosa di macabro e familiare in quelle stradine che mi spingeva a pensare di essere già stata in quel posto. Ma il perché, il quando, in quale occasione e il perché del comportamento strano di Justin non trovavano soluzione, rendendomi maggiormente più interessata a trovare una risposta soddisfacente al posto dei silenzi misteriosi del ragazzo. Ringraziando il cielo che fosse completamente buio e lui non potesse così vedere la probabile tonalità rosso pomodoro che doveva aver assunto la mia faccia per il secondo complimento della giornata che mi aveva rivolto, annuì semplicemente, sciogliendo le braccia. Feci un passo in avanti per fargli capire che facevo sul serio e non appena lui annuì con la testa m’immobilizzai sull’asfalto pronta a girare la faccia il più velocemente e silenziosamente possibile. Ma – sicuramente se lo era immaginato – Justin fu di nuovo completamente spalmato su di me con uno sguardo poco rassicurante dipinto in faccia. Aveva le guance arrossate, gli occhi oscurati fissi nei miei, la mascella contratta e l’acqua gli gocciolava da ogni parte del corpo a me visibile – ma imposi a me stessa di non considerarlo attraente, nonostante lo fosse dannatamente tanto. “Cazzo Carter, devi smetterla, diamine!” ringhiò, digrignando i denti. Riportò le mani ai lati della mia faccia, scuotendo con disappunto la testa. “No. Non fino a quando non mi dirai cosa c’è che non va in questo posto” protestai, tentando disperatamente di sciogliere la presa sulla mia testa per potermi voltare. Ma ogni mio tentativo sembrava aumentare sempre più la sua posizione nella situazione. Più aumentava la presa, più io tentavo di fare il contrario di ciò che mi chiedeva e più il mio corpo veniva compresso tra il cofano della macchina e quello appiccicoso e zuppo di Justin – il che non contribuiva di certo a migliorare la situazione, la mia perlomeno sicuramente. E poi, improvvisamente, così com’era arrivata la pioggia, successe. Justin serrò saldamente le mani sulle mie guance nel mio ennesimo tentativo di voltarmi, cercando di farmi il meno male possibile, e le sue labbra – lui - si gettarono impetuose sulle mie. Percepivo perfettamente ogni parte del suo corpo a contatto con il mio; petto contro petto, ginocchia contro ginocchia, labbra contro labbra. I suoi occhi sbarrati erano a pochi millimetri dai miei mentre la sua bocca si modellava sulla mia, con l’acqua che vi s’infiltrava dentro appena possibile. Ed io non ne sapevo nemmeno il motivo, ma le mie labbra seguivano come ipnotizzate le sue,- nonostante la parte ragionevole di me mi stesse urlando di fermarmi, di spingerlo via prima che le cose potessero ‘degenerare’ in qualche modo - morbide e con l’aroma del tabacco ancora impresso sopra; sentivo il suo cuore battere contro la cassa toracica, e in quel momento non riuscivo a capire se a correre più velocemente fosse il mio o il suo. E poi, lentamente, sentì l’aria prendere il posto delle sue labbra sulle mie mentre le nostre facce si allontanavano e una strana sensazione di vuoto mi avvolgesse la testa; i nostri corpi ancora attaccati e le sue mani ancorate sulle mie guance, che mi spostavano i capelli bagnati dietro alle orecchie. “Justin …” tentai, scoprendo di avere la voce strozzata ed affannata. Lui poggiò un dito sulle mie labbra, imponendomi silenziosamente di chiudere il becco e non dire nulla. I suoi occhi vagavano veloci dai miei alla mia bocca, avendo come risultato unicamente l’aumentare della mia probabile tachicardia mentre la consapevolezza di ciò che era appena accaduto iniziava a farsi spazio in me. Justin mi aveva baciata. Per quale assurdo motivo lo avesse fatto non lo sapevo, ma era successo. Ciò su cui una ventina di minuti prima lui aveva scherzato ed io avevo definito impossibile era appena accaduto, ed io non mi sentivo contrariata ed indignata come avrei dovuto. Anzi, riuscivo quasi a sentire una sorta di euforia mischiata ad eccitazione dilagarsi in una parte remota di me stessa, che però mi occupai di oscurare velocemente. Avrei voluto avere la sfacciataggine di tirargli uno schiaffo ed urlargliene contro di tutti i colori, ma c’era qualcosa nella reazione che il mio corpo aveva avuto che mi teneva inchiodata lì, tra le sue braccia e sotto la pioggia che stava iniziando a penetrare anche la sua felpa, a domandarmi se quel bacio fosse piaciuto ad entrambi. Perché una cosa di cui ero certa – andando contro me stessa - era che sicuramente sentire le sue labbra a contatto con le mie m’era piaciuto particolarmente, nonostante la confusione stesse iniziando ad offuscare lentamente quel momento. Un fascio di luce biancastra, però, si preoccupò d’interrompere quegli attimi carichi di imbarazzo e confusione, mentre un macchinone beige accostava di fianco al SUV di Justin. Il guidatore, che non riuscivo ad intravedere, suonò il clacson per attirare la nostra attenzione mentre uno degli sportelli si apriva bruscamente mostrando la figura slanciata di uno degli amici di Justin dirigersi a passo veloce verso di noi. Più si avvicinava più riuscivo a distinguere meglio ogni suo tratto: il mento leggermente squadrato ricoperto da un forte accenno di barba, la bocca piccola e carnosa, i capelli nascosti sotto al cappuccio nero di una felpa, dei pantaloni bianchi che iniziavano ad aderirgli perfettamente alle gambe lunghe ed un paio di occhi azzurri, che grazie alla pelle dorata risaltavano dietro alla luce bianca dei fari, fissi su di me - come del resto i miei su di lui. Improvvisamente un dolore appena accennato si distribuì sul mio collo, costringendomi a riportare la mia attenzione su Justin che mi aveva pizzicato di nuovo. “Entra in macchina” mi ordinò, lanciandomi uno sguardo ammonitore, prima di prestare la sua completa attenzione all’amico dagli occhi chiari, e che solo in quel momento – ricordando i tre nomi che prima aveva elencato – collegai come Blake. “Finalmente!” sbuffò, allargando le braccia. L’altro sussurrò qualcosa di breve a bassa voce mentre sollevava senza alcuno sforzo una damigiana contenente del liquido scuro, con lo sguardo ancora ancorato al mio. Il cappuccio gli era ricaduto sulle spalle rivelando una massa asciutta e scura che gli ricadeva sulla fronte mentre un sorriso sornione appena accennato sulle labbra mi accompagnava verso il SUV di Justin, nel quale mi rifugiai il più silenziosamente e velocemente possibile mentre i ragazzi armeggiavano con la benzina. Slacciai la felpa e la lasciai cadere sul sedile di fianco a me, arricciando i capelli sulla nuca e tenendoli fermi con una molletta che avevo dimenticato al polso. Avevo ancora il fiato corto ed il battito era irregolare; ad ogni sbattere di ciglia mi sembrava che le sue labbra tornassero con la stessa prepotenza sulle mie, per poi svanire un secondo dopo lasciando spazio al buio all’interno dell’automobile ed un paio di occhioni azzurri che facevano capolinea nel mio raggio visivo dal finestrino. Dall’altro lato del finestrino che affiancava lo sportello sul lato sinistro dell’auto, d’altronde, c’era uno Ian mezzo addormentato che mi salutava con la mano mentre aspettava che Justin e Blake finissero di fare il pieno. Quest’ultimo, dopo qualche attimo nel quale l’unico rumore percepibile era quello dello scrosciare della pioggia, sbatté con forza il cofano spolverandosi le mani e correndo verso la macchina beige; non prima di avermi lanciato un’altra occhiata curiosa. Justin si posizionò silenzioso sul sedile di fianco al guidatore mentre, con mia sorpresa, Jared prendeva posto su quello vuoto. “Ehilà” mi salutò entusiasta, lanciandomi un’occhiatina lasciva dallo specchietto retrovisore. “Sei uno schianto con questo colore, fattelo dire” Strabuzzai gli occhi a quel complimento urlato ai quattro venti, ancora troppo scossa per riuscire ad afferrare al primo colpo le parole. “Uhm .. si.. beh … grazie..” Il biondo si allacciò la cintura annuendo soddisfatto mentre eseguiva una perfetta e veloce inversione a ‘U’ , immettendosi nell’altra corsia della strada dietro a Ian e Blake. I due ragazzi iniziarono a parlottare animatamente di qualcosa che aveva a che fare con una casa o cose del genere, mentre indisturbata puntavo decisa il mio sguardo al di fuori del finestrino. E poi lo vidi, lì, dall’altro lato della strada, senza nemmeno volerlo, la causa dello strano comportamento di Justin, mentre il paesaggio scorreva velocemente – ma non troppo – sotto i nostri occhi. Ed improvvisamente il mio cuore sembrò fermarsi per un attimo, prima di cadermi rovinosamente nello stomaco, lanciando – come se si fosse rotto – piccoli pezzi appuntiti che rimbalzavano dentro di me come un pallone da basket tra le mani di Michael Jordan. Tra due case ben curate, tra le ultime del quartiere, si poteva perfettamente notare un enorme spazio vuoto, quadrato, nero e dall’erba bruciacchiata che troneggiava sul resto, degno di uno quei film splatter che trasmettevano in Tv per Halloween e che Dante si era sempre divertito a guardare. Era la mia casa. La mia vecchia casa. La casa a cui Dante aveva dato fuoco. 1Jessie J ha avuto problemi cardiaci, un ictus, e per la sua prima esibizione ai VMA si era rotta il piede ed è stata costretta a cantare con il gesso. Nonostante, ciò, però, lei è la positività fatta persona. Ha la convinzione che per chiunque, dopo queste situazione ‘delicate’, ci sia sempre una porta migliore ad attendere. Basta solo saperla aprire.
Quindi è una filosofia di vita che, in quella di Carter, non ha funzionato. Writer’s corner: Okay, sono imperdonabile. Tre settimane di assenza sono un sacco anche per me. Chiedo scusa. Purtroppo, però, tra la scuola, – che inizio a non reggere più – dei progetti che dovevo consegnare alla professoressa entro una certa data di scadenza e problemi con la connessione non sono riuscita a connettermi prima di oggi. Ma, tralasciando le mie scuse infinite, adesso sono tornata OuO E c’è anche il dodicesimo capitolo come avrete potuto constatare (che io sempre non saprei come definire) C’è questa piccola conversazione che Justin e Keaton hanno avuto e della quale si parlerà più in avanti. Voi credete si siano mai potuti dire? E poi, per la felicità di una personcina, c’è questa sottospecie di bacio tra Justin e Carter. Che però, ovviamente, non starà a significare che vivranno tutti felici e contenti con tanti bei bambini lol No, anzi, ho in mente un sacco di cose in quest’ultimo periodo e di fatti il capitolo 13 è già pronto. E poi c’è l’arrivo di Blake, e il posto non noto in cui Justin voleva portare Carter. Ed infine questa parte finale in cui il passato di Carter torna a tormentarla, questa volta in un modo più pesante e significativo dell’apparizione di Justin nei primi capitoli. Insomma, ce ne sono e saranno di tutti i colori, e spero sempre che almeno un po’ questa storia continui a piacere. E, come sempre, ci tengo ai vostri pareri. Cosa va bene, cosa no, è brutto, carino, errori. Ditemi tutto quello che pensate. E adesso, che mi sono dilungata oltremodo come sempre, me ne vado. Grazie a quelle personcine carine che seguono ancora questa storia♥ E, beh, alla prossima. Baci ☺♥ |
Capitolo 14
*** 13. My head says 'who cares?' but then my heart whispered 'you do, stupid' ***
 13. Era tutto esattamente come lo ricordavo, per quanto ironicamente ci fosse da ricordare, nonostante non mettessi piede in quel ‘lato’ di San Diego da più di tre anni. Il profilo seccato e bitorzoluto di un piccolo albero, l’unico superstite, che si piegava su se stesso alla forza irruente del vento che lo colpiva, l’odore marcio che si diffondeva nell’aria, – se ci si metteva a lavorare di fantasia lo si poteva quasi immaginare come una sottospecie di nebbiolina grigiastra che si spostava in circolo su quel pezzo scuro e bruciacchiato di terreno - l’erba talmente rovinata da non riuscire nemmeno più a distinguerla tra quel mucchietto ammassato di fango, cenere e terriccio. Nulla era cambiato, nemmeno il germoglio di un qualche fiore voleva farsi vedere lì attorno; neanche la piccola crepa sul marciapiede creata dal nome di Dante inciso con un coltello da cucina un’estate di una decina d’anni prima, quando era pressoché un quattordicenne. Quel esatto punto sul cemento, vicino all’ormai invisibile cassetta delle lettere, era in assoluto il suo posto preferito. Quando non riusciva più a reggere nessuno usciva di casa sbattendo la porta e vi ci si sedeva sopra, incidendo poco alla volta il suo nome nel materiale ruvido, scaricando così la rabbia. Riuscivo quasi a scorgere la sua figura in trasparenza seduta a terra; i capelli chiari al sole soffiavano in mille direzione a causa dell’aria che le macchine spostavano al loro passaggio, gli occhi cerulei, socchiusi – che li rendevano ancora più piccoli – concentrati sul lavoro delle mani, i due piccoli solchi che gli si formavano ai lati delle labbra mentre la sua bocca si piegava in un sorriso di soddisfazione, i denti bianchi che luccicavano alla luce ed un piccolo smile tatuato – senza nemmeno curarsi di nasconderlo – sul polso. Era impossibile per chiunque resistere a quell’aria da angelo che fioriva maggiormente con l’andare avanti negli anni – non a caso la maggior parte delle ragazzine tendeva a volermi essere amica per cercare di allacciare una qualche specie di ‘rapporto’ con lui – e che però aveva deciso di usare per distruggere tutto ciò che gli capitasse sotto mano. Strabuzzai spaventata gli occhi, subendo il dolore di una fitta improvvisa alla testa, mentre Jared chiamava di nuovo il mio nome guardandomi dallo specchietto retrovisore con aria pensierosa. “Tutto bene Carter?” domandò a bassa voce, spostando il braccio destro sulla manopola del cambio delle marce, accendendo contemporaneamente una freccia per segnalare alle macchine dietro che avrebbe svoltato. Annuì con foga, distogliendo velocemente lo sguardo dal suo, spaventata. Avevo lasciato che il corso dei miei pensieri prendesse una strada sbagliata, sterrata e piena di buche che sfociava in unico e grande buco nero sul quale convergevano le altre infinite strade sulle quali avrei rischiato di trovarci lui e che alla fine mi avrebbero riportata sempre nello stesso punto: una coltre fitta e scura di dolore, pesante come un macigno, tagliente, che ogni volta faticavo sempre di più ad attraversare e che sembrava invece spingermi sempre più in basso; faccia a terra, stanchezza infinita, lacrime agli occhi. Lacrime che avevo sempre tentato di non far cadere giù – ‘il dolore è solamente il periodo di tempo che impiega la tua mente nell’accettare il fatto che qualcuno se n’è andato’ mi aveva detto una volta la professoressa di letteratura, nel periodo che seguiva l’abissale inclinazione storta che aveva preso la mia vita, dandomi affettuosamente delle pacche sulle spalle, con le dita lunghe ed affusolate. Ma se davvero fosse stato così il mio dolore non sarebbe affatto sparito perché la mia mente, io, non avrebbe accettato che Dante fosse fuggito così vigliaccamente dalla mia vita e, in fondo, lui non se ne sarebbe mai definitivamente andato, per molto tempo ancora, e allora cosa diavolo ne sarebbe stato di me? – ma che in quel momento erano dannatamente dolorose e terribili da trattenere. Sentivo la mia saliva seccarsi velocemente nella mia bocca, rendendo ad ogni respiro la mia gola un albero in fiamme, il naso iniziava a riscaldarsi, nonostante in realtà fosse tutto fuorché caldo, come carbone ardente; ad ogni boccata d’aria mi sembrava di star ingoiando centinaia e centinaia di piccoli e sottilissimi pezzi di metallo che venivano usati per l’agopuntura, gli occhi sembravano star diventando della stessa densità dell’acqua marina e le uniche parole che il mio cervello riusciva ad elaborare correttamente erano ‘non ora, non qui’. Si ripetevano nella mia mente come le fermate dei treni sotto ai cartelloni elettrici, impossibili da fermare; come un mantra che magicamente avrebbe potuto d’improvviso risollevare le cose, se solo ci avessi creduto, mentre sentivo perfettamente i battiti velocizzati del mio cuore rimbombare da una parte all’altra del mio corpo; ne sentivo l’eco martellante e fitto nelle tempie, nelle orecchie, negli occhi, nelle guance, nel petto, nello stomaco e nelle gambe, molli. Le mani mi tremavano talmente tanto che mi piantai bruscamente le unghie appuntite nei palmi, sperando che servisse a far terminare quella reazione fastidiosa; sentì un dolore acuto espandersi per tutta la superficie arrossata dell’arto e mi morsi bruscamente il labbro inferiore per trattenermi dal grugnire, - ed attirare nuovamente l’attenzione di Jared su di me – sentendo il sapore metallico e salato del sangue scivolarmi lentamente giù per la gola. Ad ogni sbattere di ciglia, per quel brevissimo nanosecondo di buio che calava sulla mia vista, altrettanto fulminea scendeva – senza nemmeno darmi la tregua necessaria per permettermi di rimettere insieme i pezzi distrutti precedentemente - l’immagine di quello spazio quadrato nero con al centro la figura arrossata di mio fratello, distruggendosi in pezzi ancora più piccoli e appuntiti che si spargevano su ogni parte del mio corpo, come se qualcuno con la mira di Robin Hood stesse giocando a freccette ed io fossi il centro esatto dell’obiettivo, bruciandomi sulla pelle. Perché era quello che Dante si era realmente lasciato dietro oramai; non erano più il dolore o la rabbia, – non come prima almeno – non le centinaia di fogli nel cassetto del tribunale o la lunga e tortuosa ‘relazione’ con polizia ed assistenti sociali, non più una foto quando i capelli erano lunghi fino alle orecchie o un ricordo, – che non terminasse con lui dietro alla cattedra degli imputati, con le labbra serrate come se improvvisamente qualcuno gli avesse levato la voce come punizione – solo fuoco. Una scia ardente che scoppiettava tranquillamente attorno a me. E avrei potuto ignorarla, farci l’abitudine, convincermi che tra quelle quattro mura piene di urla e puzzo d’alcool non si poteva andare avanti diversamente, ma dimenticare no. Quello mai. Non ci sarei mai riuscita, neanche volendo, neanche se avesse continuato a fare così male per sempre – che poi non era un dolore vero e proprio, pur sempre dolore si, ma diverso. Quasi una malinconia. Ti veniva voglia di piangere ma non ce la facevi. Le lacrime che si accumulavano agli occhi c’erano, le sentivi e magari arrivavi anche al punto di volerle far uscire, ma non succedeva mai. Se ne stanno lì, ammucchiate, a punzecchiarti la pupilla. Ed era dieci volte più doloroso, così. Lo ricordavo perfettamente. – ed era esattamente lì il vero problema. Perché così, alla fine, Dante non se ne sarebbe mai andato, non sarebbe mai affievolito il suo pensiero; quello debole e appena accennato che lo raffigurava ancora con il corpo gracile e l’orlo dei pantaloni larghi che toccavano terra infilandosi sotto le scarpe da ginnastica strappate, e che io ricoprivo con strati e strati di rabbia per farlo andare via. Non m’avrebbe mai lasciata in pace e allora, automaticamente, a me avrebbe continuato ad importare di lui. Nonostante mi avesse fatta soffrire, nonostante mi avesse fatto così tanto male da sentirmi bruciare, nonostante se ne fosse andato così brutalmente buttando la mia vita in un pozzo abbandonato senz’acqua o luce; avrebbe continuato ad importarmi. Ed era quella la fregatura, con lui. Lo era sempre stata: non sapevo come lo facesse, se ne fosse consapevole, se lo facesse di proposito, ma riusciva sempre a lasciare se stesso dentro qualcosa, qualcuno. E allora iniziavo ad avercela con me; con me perché allora al suo ritorno mi sarei fatta trovare. M’avrebbe ritrovata esattamente dove m’aveva lasciata, e non c’era fregatura peggiore di quella. Mi sfiorai bruscamente la guancia cercando di lasciare meno residui possibili della piccola scia bagnata e fredda che mi ero inconsapevolmente lasciata sfuggire dagli occhi, allarmata dall’improvviso movimento di Justin sui sedili anteriori contro lo schienale in pelle, leggermente piegato all’indietro. Vi si appoggiò con le spalle sollevando di poco il sedere per poterci infilare la mano sotto, probabilmente per prendere un’altra sigaretta – in quel momento probabilmente con un qualcosa tipo birra, una sigaretta era decisamente ciò che mi ci voleva per tentare di scacciare via mio fratello dalla mia testa. Quello che però Justin tirò fuori dalla tasca, e che lanciò severo sul grembo di Jared, erano il suo cellulare e le cuffiette appallottolate. “Mettile e fatti i cazzi tuoi per una volta” borbottò lanciandogli un’occhiata truce. Il biondo scrollò le spalle, facendo però ciò che l’amico gli aveva poco gentilmente ordinato di fare, frenando dinanzi ad un semaforo rosso. E se momentaneamente avessi avuto una qualche tipo di perplessità su ciò che avesse in mente di fare Justin, quando lo vidi stringere con entrambe le mani i bordi scuri dei poggiatesta, voltandosi all’indietro verso di me, queste svanirono rimpiazzate da un’improvvisa agitazione dettata dalla consapevolezza dei suoi movimenti. Fece pressione sulle braccia – riuscì, anche nel buio, a notare i suoi muscoli tendersi al gesto – sollevandosi per riuscire ad infilare le gambe nello spazio tra i due sedili. Sbuffando, scocciato, si appoggiò per un secondo sulla cassa grigiastra del freno a mano; giusto il breve lasso di tempo necessario perché si sistemasse i capelli bagnati che gli infastidivano la pelle della fronte prima che con uno scatto repentino si appoggiasse comodamente sulle mie gambe. Piegò, con non poche difficoltà, i polpacci sotto al sedere stringendo le ginocchia sui miei fianchi, come se fosse una delle cose più normali che potesse venirgli in mente di fare in quel momento, con me, dopo avermi baciata per nascondermi la vista di quel pezzo nero di terra. Affondai maggiormente le unghie nei palmi delle mani – e mi sembrò quasi di sentire una sostanza liquida sgorgarmi da un punto imprevisto della pelle – sentendo il mio cuore rotolarmi nello stomaco prima di ricominciare i suoi salti velocizzati nella mia cassa toracica, quasi volesse entrare dentro Justin. “Cazzo, smettila” ringhiò sottovoce, infilando furtivamente le sue dite calde tra le mie così da impedirmi di ferire me stessa ulteriormente. Ma non ci riuscivo, nonostante la sua pelle risultasse dannatamente morbida sulla mia, così mi ritrovai ad infilzare automaticamente il dorso delle sue di mani. Si mosse gentilmente sulle mie gambe per non cadere, scostandomi così l’orlo del maglioncino sulle cosce, senza sembrare di rendersene conto. Spostò i suoi occhi nei miei, levando la sua mano dalla mia per accendere la lucetta sopra le nostre teste prima di farla tornare in mezzo alle mie dita, accennando un sorriso. “Sai, Blake fa sempre quell’effetto alla Edward Cullen quando scende dalla macchina, ma non pensavo anche tu gli avresti sbavato dietro aumentando così a dismisura il suo ego” mi disse, quasi fosse un rimprovero, fissandomi serio mentre faceva scivolare i pollici sulla mia pelle bagnata. Inarcai le sopracciglia, schiacciando la testa nel sedile per poter avere una visione più grande della sua faccia e capire se stesse scherzando o meno. La conversazione stava prendendo una piega decisamente strana e … divertente, in qualche modo. “Cosa? Che diavolo dici? E, poi, perché non avrei dovuto .. uhm .. guardarlo?” domandai stizzita. Blake, in realtà era esattamente il tipo di ragazzo che solitamente attirava la mia attenzione; non che avesse qualcosa di estremamente particolare, occhi permettendo, ma i ragazzi con i tratti più delicati e chiari non mi erano mai piaciuti particolarmente - non ero, diciamo, il tipo da principe azzurro; non lo ero mai stata nemmeno da bambina, in realtà – nonostante potessi quasi essere certa che Justin comportasse una particolare eccezione. Ma quella era sicuramente una cosa che mi sarei tenuta per me. “Quando hai visto me non hai fatto una piega, cavolo, ecco perché!” sbottò improvvisamente Justin, gonfiando le guance e roteando gli occhi, scocciato. “E’ il tuo ego ferito quello che sto ascoltando Bieber?” lo punzecchiai, inarcando le sopracciglia, piantandomi poi i denti sulle labbra per non scoppiargli a ridere in faccia. Lui strabuzzò offeso gli occhi, aprendo bocca per rispondermi a tono se solo un grugnito di disapprovazione non lo avesse anticipato, costringendo entrambi a puntare lo sguardo su Jared. Aveva la testa china sul telefono, la bocca abbassata in una smorfia, mentre attendeva che l’ennesimo semaforo diventasse verde. “Beyoncè, Beyoncè, Beyoncè, Beyon … Taylor Swift?” quasi urlò il nome della cantante, voltando la testa verso l’amico, con gli occhi sgranati. “Ma che merda è questa amico? Shake it off? Cazzo, ti sei drogato Bieber?” lo rimproverò, scuotendo con foga la testa. “Taci, idiota” esclamò Justin dandogli un colpetto sulla nuca. “Me l’ha scaricata Jodi” Jared scrollò indifferente le spalle, continuando a muovere le dita sullo schermo del cellulare. “Wayne, Drake, Eminem, B.O.B, Nicki Mina … Cazzo, adesso si che si ragiona fratello” esclamò entusiasta, schiacciando un’ultima volta sullo schermo prima di rimettere in moto la macchina. Justin ridacchiò, scuotendo scoraggiato la testa. Si voltò nuovamente verso di me, inclinando leggermente la testa mentre i suoi occhi si fissavano nei miei con una lucina divertita che li illuminava. “Sai …” iniziò, scivolando impercettibilmente sulle mie gambe, prima di avvicinare lentamente la sua testa alla mia, sfiorandomi la guancia. “Lui in realtà va matto per la Swift” ammiccò a voce abbastanza alta così che il biondo lo sentisse. “Cazzo, ti sento Bieber” lo apostrofò quest’ultimo, lanciandogli un’occhiataccia dallo specchietto retrovisore. “Vuoi farmi incazzare?” Justin affondò improvvisamente la testa nell’incavo del mio collo spostandomi i capelli di lato con una mano, - sentì la mia pelle rabbrividire leggermente al cambio di temperatura in quel punto preciso del mio corpo – mentre le sue labbra iniziavano a tremolare leggermente, segno che stava ridacchiando. Fece scivolare le braccia dietro alla mia schiena, strofinando il naso contro la mia spalla mentre Jared continuava a lanciargli contro minacce e sfottò, un’auricolare ancora nell’orecchio destro, battendo ritmicamente un dito sul volante sulle note di una canzone che – grazie al volume abbastanza alto – riuscì a distinguere quasi certamente come Super Bass. Sentì qualcosa di pungente e caldo attraversarmi la schiena mentre tentavo impercettibilmente di levarmi Justin di dosso, imbarazzata al contatto così ravvicinato dei nostri corpi. “Justin … levati” “Cosa …?” domandò confuso, immobilizzandosi contro di me. “No, dai, sei morbida” obiettò, continuando a far passare le mani su e giù per la schiena. “Justin, pesi” mentì, poggiando le mani sul suo petto per tentare di allontanarlo e fargli capire che facessi seriamente. “Macché, scherzi? Sono leggero come una piuma” “Justin!” Lo sentì sbuffare contro la mia guancia mentre, lentamente, si allontanava di qualche misero centimetro da me. Quello che però fece era lontano anni luce da ciò che gli avevo chiesto io in realtà. Si sollevò sulle ginocchia e, le mani ancora attorno alla mia schiena, mi trascinò con se lanciandomi un sorriso rassicurante. “Tranquilla” ridacchiò alla mia espressione allarmata, mentre allungava una mano di lato sistemando i giubbini vicino allo sportello a mo di cuscino. Il suo braccio scivolò di nuovo, lentamente, dietro alla mia schiena mentre si lasciava cadere delicatamente di lato, portando il mio corpo a fare lo stesso. Allungò le gambe, per quanto gli fosse possibile, per lasciare un po’ di spazio alle mie mentre sentivo il suo braccio scivolare sotto alla mia testa, come sostegno. “Justin, che diavolo stai facendo?” protestai, muovendo agitata le gambe contro le sue. Lui grugnì in disaccordo con la mia frenesia nel volerlo allontanare, tornando a tuffare la sua faccia nell’incavo del mio collo, nascondendosi sotto ai capelli. “Ti ho detto di stare tranquilla, cavolo” borbottò, allungando una mano sulle mie gambe per tenerle ferme. “Con questa pioggia ed il traffico ce ne vorrà di tempo per tornare a casa, rilassati dannazione” Rilassarmi, certo. Come se fosse possibile con lui schiacciato contro di me in uno spazio così ristretto dei sedili. Le sue ginocchia sfioravano impercettibilmente le mie, il suo petto si scontrava irrimediabilmente contro il mio ad ogni respiro che faceva – io stavo cercando di farne il meno possibile, anche perché con il groppo fastidioso che avevo in gola mi era quasi impossibile non farlo – e la mano ancora ferma sulla mia gamba. La pelle sembrava stesse bruciando, come piccoli geyser bollenti, in ogni punto in cui ci sfioravamo, anche se inconsapevolmente. Sentivo il suo respiro caldo atterrare brusco sul mio collo facendomi diventare man mano più insofferente all’improvvisa vampata di calore che mi aveva avvolta. Cavolo, cosa mi stava succedendo? Come era riuscito a far passare Dante e ciò che aveva fatto in secondo piano, senza che nemmeno me ne accorgessi, risollevandomi gentilmente dal mio imminente crollo psicofisico? A meno che … “Justin ..” lo richiamai, ruotando il mio viso verso il suo, ancora nascosto nei miei capelli. “Uhm?” “Questo è stato un modo carino per distrarmi …?” domandai incerta, capendo solo dopo che le parole avevano preso possesso dell’aria all’interno dell’abitacolo, di quanto tutto ciò potesse suonare ridicolo e senza senso, perfino a me stessa. Infilzai il labbro inferiore con i denti, sentendolo bruciare quasi da subito, mentre Justin muoveva impercettibilmente la testa contro di me, depositando bruscamente il suo braccio sul mio fianco. “Non saprei … ma se così fosse, hai funzionato?” ribatté vago, e potevo giurare di aver sentito sulla pelle la sua bocca che si piegava all’insù. “Si” “Bene” sussurrò solamente, muovendosi leggermente sul sedile per non rotolare giù a causa di una fermata brusca di Jared. “Sai, mi sa che ho sbagliato prima …” “Eh?” “Jared preferisce di gran lunga John Legend alla Swift” ghignò, e non riuscì a non trattenermi dallo scoppiare al ridere, consapevole che Jared fosse ancora in ascolto, pronto a ribattere, come un leone con la sua preda. “Cazzo, ti ho sentito brutto stronzetto!” _____________________________________________________________________________ “Lo sai che mi piaci, piccola Harvey, ma se dovesse succederti di nuovo una cosa simile non ci vengo a prenderti se c’è lui” bofonchiò contrariato Jared, alzando il freno a mano, mentre continuava ad alternare il suo sguardo – tranquillo e dolce – da me a Justin – infuocato e offeso. Afferrai la felpa, stropicciata, dal sedile per infilarla prima di scendere dalla macchina. “Tranquillo, non succederà” ridacchiai, avvicinandomi al suo orecchio, sotto lo sguardo divertito di Justin al di fuori del finestrino che mi aspettava. “E comunque, Leanne ama John Legend” Lui alzò gli occhi su di me, con un ghigno di soddisfazione in faccia. “Alla faccia tua Bieber, le donne mi amano!” urlò vittorioso, alzando di poco la mano stretta a pugno contro il biondo. “Okay, grazie del passaggio Jared” ridacchiai, saltando giù dalla macchina. Justin mi affiancò velocemente, alzandomi il cappuccio della felpa sulla testa. Dopo esserci appisolati sui sedili della macchina, la pioggia sembrava non aver smesso di cadere nemmeno per un secondo, e al nostro risveglio la situazione non sembrava essere migliorata, nemmeno di poco. “Questa si chiama congiura, Harvey” affermò impassibile, mentre c’incamminavano verso il portone di casa mia. Riuscì ugualmente a sentire, però, il tono scherzoso che si covava dietro quella finta diffidenza. “Oh, taci. Lo so che c’è l’hai anche tu John Legend sul telefono” lo rimbeccai, affondando le mani nelle tasche larghe della felpa, che mi arrivava sino alle ginocchia. “Ma questo a Jared non l’hai detto” rise, scuotendo la testa per scrollarsi di dosso l’acqua che gli stava appesantendo i capelli. Annuì distrattamente con la testa, facendo scivolare il mio sguardo sul vialetto che precedeva la casa, trovandolo – come mi aspettavo – vuoto. Della macchina scura di Elia non c’era traccia, e dalle finestre che affacciavano su quel lato di strada non fuoriusciva nessuna luce o rumore che potesse far intuire la presenza di qualcuno in casa. Era sempre così nelle ultime settimane da quando aveva cambiato posto di lavoro; e lavorare nella Downtown di San Diego, a Gaslamp, comportava quello, oltre all’ottima retribuzione: ore piccole, turni dirottati continuamente, stanchezza e assenza costante in casa. Ci avevo anche fatto l’abitudine, sapevo che fosse un qualcosa di estremamente necessaria perché potessimo continuare ad andare avanti senza consumare i beni ereditati da nostra madre, così mi accontentavo di sentire l’odore pungente del suo dopobarba Calvin Klein svegliarmi la mattina, le sue imprecazioni quando a notte fonda rientrava e nel buio sbatteva sempre contro il corrimano delle scale o ritrovare la sua canottiera scura sulla sedia della mia stanza, che prontamente dimenticava quando entrava per accertarsi che fossi effettivamente al letto. In quel preciso istante, però, - con l’enorme struttura della casa che mi s’innalzava dinanzi, con le mura candide, gli infissi di un colore scuro tendente al nero, le finestre rigate dall’acqua e l’albero sul fianco che sbatteva contro il balcone della mia camera – avrei preferito di gran lunga che quella fosse una delle serate in cui uno dei suoi colleghi o anche Cole, il fratello di Leanne che lavorava assieme a lui, gli davano il cambio. L’idea di rimanere da sola in casa per il resto della nottata, con l’immagine infuocata di Dante che sarebbe potuta tornare a martellarmi il cervello da un momento all’altro, non mi entusiasmava particolarmente. Ed ero certa che se non fosse stata la maratona di 2 Broke Girls che avevo intenzione di fare, accompagnata da una generosa scorta di caffeina e nicotina, a tenermi sveglia lo avrebbe certamente fatto quella consapevolezza ed in un modo decisamente più rude e doloroso. Mi passai una mano sulla nuca, tirandoli leggermente per tornare alla realtà, mentre mi piegavo sul bordo dello scalino sotto lo sguardo curioso di Justin. Tastai alla cieca il marmo freddo ed umidiccio alla ricerca della piccola e familiare crepa sulla sua superficie, che, non appena individua, strattonai leggermente all’indietro facendo rimbalzare rumorosamente a terra il doppione delle chiavi di casa – per la fretta di trascinarmi chissà dove, Justin non mi aveva concesso nemmeno il tempo di prendere cellulare e chiavi, e fortunatamente Leanne sapeva che ero con lui altrimenti mi sarei trovata alle calcagna un’orda di macchine della polizia che cercavano il mio possibile rapitore. Mi sollevai, appoggiandomi con forza sulle ginocchia, inserendo con qualche difficoltà la chiave nella serratura. “Lo zerbino del benvenuto non ce l’abbiamo e il vaso dei fiori era troppo scontato” spiegai, notando l’occhiata confusa e divertita allo stesso tempo che Justin mi aveva lanciato. Spalancai la porta, sentendo una folata di calore colpirmi in pieno, mentre mi voltavo di nuovo verso il ragazzo che avevo dietro trattenendo la porta aperta con la mano libera. “Stai bene?” mi domandò fievolmente, lasciando vagare lo sguardo sul corridoio buio della casa, alle mie spalle, inarcando improvvisamente le sopracciglia. “Sei sola?” Scrollai le spalle, ignorando entrambe le sue domande. “Ti serve un ombrello?” domandai a mia volta, indifferente. Ecco che la Carter acida e strafottente tornava dentro di me, a sorreggermi. “Che c’è?” ringhiai quasi, a bassa voce, notando lo sguardo infuriato che mi stava lanciando. “Che c’è? C’è che pensavo lo avessi capito che con me queste stronzate da ragazzina dalla corazza dura, menefreghista ed acida non funzionano Harvey, ecco che cosa c’è!” mi ringhiò improvvisamente contro, stringendo le braccia lungo i fianchi. “E al diavolo il tuo fottuto ombrello!” “Ma questa non è una fottuta corazza, idiota!” gli urlai contro, stringendo le mani per non rispondere ai miei impulsi violenti e scagliarmici contro. “Questa sono io, porca troia! Perché non lo volete capire?” Avevo il fiato corto, gli arti molli ed indolenziti dall’acqua fredda e continue fitte dolorose alle tempie, come se qualcuno m’avesse puntato un trapano in testa ed avesse iniziato a bucare con insistenza le ossa del mio cranio. La storiella della corazza che viene usata come difesa dal dolore era sempre stata la scusa migliore che la gente tendesse ad affidare al proprio carattere – o a quello degli altri – di merda. Ma la maggior parte delle persone non era mai riuscita a distinguere un carattere orribile ad una corazza – muro, scudo, portone, cancello o in qualsiasi modo lo si chiamava – contro il dolore, fisico e mentale che sia. Avercela significava non dare facilmente confidenza alle persone, evitare a se stessi di farsi prendere troppo dalle situazioni per non rischiare di rimanerci dentro con entrambi i piedi, non dare troppa dimostrazione di emozioni in un luogo particolarmente affollato per non far capire agli altri d’avere qualcosa a cui aggrapparsi per dare sfogo alla loro, di frustrazione. Essere una stronza patentata, acida, lunatica, strafottente e con un dizionario abbastanza amplio di parolacce era avere un carattere di merda. Dire le cose in faccia senza il minimo tatto alle persone per le quali non si stravede particolarmente, mandare a ‘fanculo tutti il Lunedì mattina nonostante tre tazze di caffè super dolcificato e un intero pacchetto di sigarette da dieci terminato in meno di mezz’ora, sfogare su qualcun altro i propri scatti rabbiosi. Quello era avere un carattere di merda, ed era esattamente così che ero io. Lo ero sempre stata, probabilmente; anche quando dai sette ai dodici anni non spiaccicavo parola con nessuno, né a scuola né in casa – dove sicuramente tra urla e volume esageratamente alto della televisione in camera mia e dei miei fratelli non mi avrebbero sentita lo stesso. Dentro di me ero sempre stata così, poi pian piano avevo lasciato che questo caratteraccio venisse tutto fuori, ma c’era sempre stato. Era la gente che lo confondeva sempre; e che poi un piccolo strato di corazza ce lo avessi anche io era tutta un’altra cosa, ma non cambiava niente. Io ero così, e mi stava anche abbastanza bene. Justin, d’altro canto, non sembrava messo meglio di me in quel momento e questo contribuiva a darmi almeno un minimo di soddisfazione momentanea; i capelli gli si erano incollati alla faccia, le guance scavate erano terribilmente rosse ed il suo petto si muoveva su e giù violentemente mentre i suoi occhi continuavano a rimanere fissi dentro i miei, svuotati e che si tenevano a malapena aperti da soli. Mi voltò le spalle con una rotazione fulminea ed improvvisa del corpo, in silenzio, mentre iniziava a correre velocemente verso la macchina parcheggiata ancora sul ciglio della strada, le quattro frecce accese che illuminavano l’aria, mentre Jared si sporgeva per aprirgli lo sportello lanciandomi un sorriso di saluto. Ricambiai tirata, richiudendomi la porta alle spalle con un leggero tonfo che si sparse per tutta la casa. Mi appoggiai contro il legno scuro e freddo della porta, il maglione bagnato che mi pesava addosso, lasciandomi scivolare lentamente verso terra fino a toccare il pavimento con il sedere. Scalciai brutalmente gli stivaletti lanciandoli in un punto indefinito del soggiorno, seguiti a ruota dal maglioncino e dalla felpa che avevo addosso, rimanendo in intimo con lo sguardo perso nel vuoto. Writer's corner:
Okay, sono di nuovo in ritardo, ma vabbè oramai è una cosa che si sa già. E dopo il flop dell'ultimo capitolo - mi spiace she sia venuto così merdoso, non credo avrei potuto fare di meglio, sorry - rieccomi con il tredicesimo. E non so com'è venuto nel complesso, sinceramente; l'ho riletto un sacco di volte ma non saprei davvero come commentarlo. E, boh, ditemi voi se va meglio o peggio dell'ultimo (lol) Quindi, non so, battete un tasto(?) se ci siete - anche per capire se la storia sta inevitabilmente crollando. E ora evaporo. Alla prossima x |
Capitolo 15
*** 14. He's just a memory ***
 14.
Carter Il buio che mi circondava stava iniziando pian piano a sparire; il vuoto che ero rimasta a fissare per un lasso di tempo indefinito stava venendo rimpiazzato da una strana sensazione di inquietudine che mi fece rabbrividire. Sbattei frastornata gli occhi, muovendo irrequieta le gambe nude, tentando di scacciare via il tremore delle mie labbra, ma quando il parziale istante di buio che era tornato ad avvolgermi svanì quello che mi si presentò dinanzi agli occhi era ciò che stavo disperatamente tentando di evitare da anni. Il corridoio di casa che si andava confondendo con il nero fuligginoso che oscurava le pareti era stato sostituito da un paesaggio ben più insopportabile e amaro: dinanzi a me si estendeva infinito un pezzo riquadrato di terreno fangoso, l’erba bruciacchiata e nera che ne delineava aspramente i contorni tetri. All’orizzonte il cielo si stava colorando di una inquietante e distorta sfumatura color ghiaccio, – nessuna traccia di nuvole, uccelli o sole – unicamente una distesa monocolore e piatta di quel colore così chiaro ed innaturale. Sbattei energicamente le palpebre, pesanti, abbassando lo sguardo sul mio corpo: ero in posizione eretta, ancora in intimo, con i capelli che mi scivolavano increspati sul petto ed una strana sostanza appiccicosa e scura che mi colava giù per le gambe – che solo in quel preciso istante notai – erano ancorate a terra da una pesante e grigia catena spessa – di quelle che venivano usate per le ancore delle navi. Sobbalzai spaventata sul posto, tentando inutilmente di liberare i miei arti che ad ogni strattone sfregavano dolorosamente contro il metallo freddo e arrugginito. Alzai, tentennante, ed in maniera dolorosamente lenta, lo sguardo e mi scoprì a trattenere il fiato per non urlare da ciò che improvvisamente si era sostituito al paesaggio ambiguo e terrificante di prima: una coltre spessa di fumo aveva circondato il perimetro bruciato, avanzando sibilante verso di me, ricordandomi il raccapricciante movimento dei serpenti che strisciano nella sabbia pronti a mordere. La terra nera aveva iniziato a bruciare, indomabile; scintille aranciate zampillavano verso l’alto in una danza tribale che mi fece accapponare la pelle. E poi, improvvisamente, ad un altro mio sbattere di ciglia, lo scenario mutò nuovamente, facendomi esplodere il cuore in petto nel dolore più straziante e insopportabile che avessi mai provato in vita mia. Le fiamme si erano aperte elegantemente, lasciando spazio alla maestosa struttura in legno di una casa che fumava aria nera da ogni finestra o fessura che lo permettesse, le tende svolazzavano verso l’esterno mentre il fuoco le consumava e le assi portanti della struttura iniziavano a crollare, una dietro l’altra come in una brutta partita a domino. E, ancora, la scena cambiò velocemente: la casa, in fiamme rosso fuoco, stava crollando a terra in un mare di fuliggine e sangue scuro che scivolava serpeggiante tra l’erba, verso di me. Terrorizzata iniziai a muovere convulsamente i piedi, scalciando e gridando con quanto più fiato avevo in corpo, mentre le mie caviglie si aprivano e il sangue che ne sgorgava fuori sembrava richiamare maggiormente quello scuro e viscido che fuoriusciva dalla casa. Sollevai, improvvisamente consapevole, lo sguardo di fronte a me, riconoscendo improvvisamente e con un forte senso di nausea la situazione. Una figura alta, tonica e slanciata troneggiava ora imponente al centro del riquadro scuro di terra, mentre anche il secondo piano della casa cedeva inesorabilmente sotto il peso del fuoco. Sentì il mio corpo iniziare a tremare convulsamente ed in modo spaventoso quando la figura, che stava iniziando a prendere fuoco, voltò la sua faccia biancastra verso i miei occhi: i capelli biondicci e mossi avevano assunto una orribile tonalità aranciata grazie alla luce del fuoco che lo spalleggiava, gli occhi dello stesso colore del cielo precedentemente visto avevano la pupilla rossa, iniettata di sangue, e le mani sembravano essere state sostituite da piccoli falò infuocati, quasi fosse diventato la torcia umana. “Carter” Spalancai tremolante gli occhi, lasciando la mia bocca spalancarsi ed un urlo strozzato e disperato uscire dalla mia gola - levandomi il respiro per qualche attimo – attirando inevitabilmente la curiosità del ragazzo che avevo di fronte. Inclinò confuso la testa, iniziando a muovere qualche passo silenzioso verso di me; i piedi nudi che calpestavano tranquillamente la scia viscida e rossa di sangue – che in quel momento mi accorsi era a qualche centimetro di distanza dalla punta delle mie dita dei piedi, dai quali fuoriusciva altro sangue, più chiaro e liquido. Lasciai che un altro verso strozzate scappasse al mio controllo, mentre mio fratello continuava imperterrito e ghignante ad avvicinarsi, infuocato, a me. Perché quello era lui, quella era la nostra casa, e quel sangue era quello di nostra madre. A quella consapevolezza il mio cuore iniziò a battere convulsamente contro la mia cassa toracica, così dolorosamente che sembrava volesse rompermi le ossa per uscire e lanciarsi contro l’autore della sua irrequietezza, mentre sentivo i miei occhi iniziare a bruciare sempre più fin quando percepì qualcosa di bagnato, viscido e doloroso scivolarmi giù per le guance – con la stessa intensità di un fiume in piena – fino ad annidarsi sul mio petto e sul reggiseno bianco. “Carter” E poi fu un attimo. Riuscì solo ad intravedere un enorme lago di sangue annidarsi sul mio petto, gocciolandomi sulle gambe, prima che qualcosa di caldo e rovente risalisse sui miei piedi ed iniziasse a scottarmi avidamente la pelle. “Carter! Carter!” Mio fratello, di fronte a me, aumentò visibilmente l’andatura dei suoi passi per raggiungermi, alzando meccanicamente un braccio verso di me con espressione confusa e scioccata negli occhi. Un altro automatico e strozzato urlo mi scivolò fuori dalle labbra – mentre serravo involontariamente le palpebre - quando sentì la sua mano, grande e scottante, poggiarsi sulla mia spalla ed iniziando a scuotermi violentemente con sguardo infuriato e … “Carter, cazzo, svegliati! Svegliati, dannazione!” Strabuzzai gli occhi frastornata, sollevando con uno scatto repentino il busto dal materasso e prendendo a guardarmi furiosamente intorno; sentivo gli occhi pesanti, la pelle del collo e della fronte appiccicosi e il mio petto che faceva su e giù in una maniera quasi preoccupante. Impiegai qualche altro istante prima di capire – tranquillizzandomi - che ero effettivamente sul comodo e caldo letto della mia camera e che il paio di occhi azzurri che mi fissavano appartenessero ad un Elia visibilmente preoccupato e in ansia. Lasciò scivolare le mani – prima serrate duramente attorno alle mie spalle – sul materasso con il palmo aperto all’insù. “Cristo, mi stava per venire un infarto!” biascicò, portandosi l’altra mano al petto, lanciandomi un’occhiataccia di rimprovero. “Per quale cazzo di motivo eri mezza nuda a terra devi ancora spiegarmelo, cavolo” Lo guardai di sottecchi, mordendomi convulsamente il labbro alla disperata ricerca di qualcosa di convincente e che stesse in piedi da rifilargli. “Lo so che stai pensando a qualche stronzata da dirmi” mi ammonì serio mentre gli angoli della bocca gli si storcevano – contro sua voglia – verso l’alto a formare un piccolo sorriso divertito. “Colpevole” Scosse la testa sconsolato, passandosi frustrato una mano tra i capelli corvini. “Prova a rifarti una cosa del genere e ti giuro che vado di già in pensione per tenerti d’occhio” “Oh, andiamo! Mi sono solo addormentata a terra, Elia. E’ stata una giornata pesante e in più sono sempre stata una tipa strana, pensavo ci fossi abituato” sbottai, incrociando le braccia al petto, – e solo in quel momento mi accorsi di indossare un pigiama a scacchi di mio fratello che mi andava decisamente largo e che in compenso era caldissimo – roteando gli occhi. “Tingerti i capelli di viola non è una cosa strana, e ci può anche stare perché ti stanno da Dio” sibilò a bassa voce, sedendosi con una gamba sul bordo del mio letto. “Ma addormentarti a terra mezza nuda non lo è, affatto. Non è né una cosa strana né anormale, nel tuo caso. Ed io e te sappiamo perfettamente cosa significa” Puntò irremovibile i suoi occhioni chiari nei miei alla ricerca di qualche segno di conferma che, ovviamente, non tardò ad arrivargli. Certo che lo sapevo a cosa si riferisse, e troppo bene perché potessi anche solo minimamente pensare di poter fare la finta tonta e terminare lì il suo – non più insensato – rimprovero. Momentaneamente, quando mi ero quasi strappata di dosso i vestiti con quella brutalità, non ci avevo nemmeno pensato - d’altronde però era sempre stato così: lasciarmi cadere a terra, in un qualunque posto della casa purché fosse estremamente oscurato e freddo, senza quasi niente addosso e rimanerci anche per delle ore a volte era una cosa che avevo iniziato a fare da quando ero piccola – o molto più precisamente quando la mia vita aveva iniziato a prendere quella improbabile discesa verso l’inferno, che non era partito quando Dante aveva dato fuoco alla nostra casa e con nostra madre all’interno, per di più. No. Il declino era iniziato molto prima, – dovevo avere sette anni o giù di lì – molto più gradualmente rabbioso, e portava un solo ed unico nome, quattro lettere e una sola fottuta faccia: Rick. – per non pensare o sentire nulla. Quando in casa esplodeva il coro acuto e spaventoso di voci che si coprivano l’un l’altra, rabbiose, alte, cattive e né Dante né Elia riuscivano a farle smettere o a distrarre me, mi accucciavo a terra e stavo semplicemente lì ferma contro il pavimento freddo ad occhi chiusi. Allora non funzionava, ovviamente, perché le urla le sentivo lo stesso e mi piombavano violentemente dentro. Ma a quei tempi i miei fratelli c’erano entrambi. Più tardi – e qui entrano in scena Dante e le sue stronzate – aveva iniziato a funzionare. Quando Elia era sempre fuori per lavoro o per qualche udienza, il padre di Ian non mi costringeva a fermarmi a casa loro ed i miei amici – Keaton, Leanne e Baja – avevano i loro impegni; era allora che funzionava. Ed era anche allora che avevo iniziato a levarmi i vestiti. Le persone avevano ognuna il proprio modo di lottare i pensieri strazianti e feroci che si impossessavano in alcuni momenti della loro testa, e non solo durante la notte – crudeltà della vita, a me succedeva maggiormente durante le ore pomeridiane; alcool, fumo, rebus, libri, disegni, musica, cibo, docce gelate, prendere a pugni un albero, e chi più ne ha più ne metta. Quello, beh, era il mio personale modo di sfuggire a quel susseguirsi di incubi, immagini frastagliate e attacchi di voglia di piangere che erano state le mie costanti compagne per l’infinito durare di un anno intero dall’incarcerazione di mio fratello e automaticamente dalla morte di … mia madre. Semplicemente mi sedevo a terra, - nel momento in cui sentivo che qualcosa dentro di me non riusciva più a reggere ed aveva bisogno di una pausa – chiudevo gli occhi ed aspettavo che il freddo si impossessasse completamente di me impedendomi di pensare a qualcosa che non fosse l’effetto che sopraccitato freddo aveva su di me. Solo la pelle che sembrava essere punzecchiata da tanti aghi e il gelo che s’insinuava nella carne. Ne avevo presi di raffreddori così ma solitamente mi limitavo ad una o due orette e mezzo passate in quel modo perché sentissi la forza tornare a sedersi comodamente dentro di me; ma che mi avesse trovato Elia al suo ritorno – e contando che ero arrivata a casa attorno alle otto e qualcosa e lui staccava verso le cinque/sei di mattina il tempo era davvero un sacco – era capitato per l’unico motivo che non mi succedeva di farlo da un bel po’ di tempo, avendo io completamente rimosso mio fratello e ciò che era antecedente a lui dai miei pensieri giornalieri, ed avere avuto un impatto così forte con il mio passato dopo tre anni mi aveva sorpresa particolarmente portandomi a perdere la cognizione del tempo. Scossi brutalmente la testa, sentendo un’improvvisa fitta di dolore colpirmi e tempie che mi costrinse a aggrapparmi al braccio di mio fratello, tornando alla realtà. “Andiamo fratellino, non è successo niente” scherzai comunque, accarezzandogli la mascella. Ma non sembrava effettivamente pensarla come me perché i suoi occhi si accesero improvvisamente di pura e autentica rabbia. “Davvero? Niente? Non è successo niente Ter?” urlò stizzito, battendo contrariato un pugno sul materasso. “Hai la febbre a trentotto e mezzo da tre fottuti giorni! E se non avessi provato a chiamarti e tu non mi avessi risposto chissà quando t’avrei trovata lì a terra!” “Cos … che? Tre giorni? Febbre? Ma io sto benissimo!” protestai basita. “Guardati, cazzo! Guardati allo specchio e dimmi se stai così fottutamente bene come dici, perché allora non saprei più come spiegarmeli gli incubi che hai ogni volta che chiudi gli occhi e la tua pelle che si surriscalda talmente tanto da costringermi a metterti dei fottuti cubetti di ghiaccio su petto e pancia!” ringhiò arrabbiato, piantandomi in mano il suo iPhone dorato, attendendo che facessi ciò che mi aveva detto di fare. Stizzita e senza più niente da controbattere per non fargli perdere ulteriormente la pazienza sbloccai lo schermo e schiacciai con poca forza l’icona della fotocamera, che un istante dopo mi apparve già posizionata sulla modalità interna, facendomi trattenere leggermente il fiato per la sorpresa – o lo spavento, dovevo ancora capirlo – di ciò che rifletteva. Una ragazza dai capelli violetti che le ricadevano appiccicosi ed arruffati sul petto attaccandosi alla pelle; pelle cadaverica con solo una spruzzata di rosso acceso su guance, naso e fronte, le labbra senza colorito e screpolate, le guance leggermente scavate, la fronte imperlata di sudore, gli occhi che a malapena si tenevano aperti ed una spaventosa chiazza violacea che li circondava, quasi fossero stati presi a pugni. Alzai lentamente la mano e me la posizionai sul mento notando che il riflesso nel telefono effettuò gli stessi movimenti confermandomi che quello zombie vivente fossi effettivamente io. Abbassai consapevole lo sguardo, lanciando lontano da me il telefono. “Io … uhm … mi dispiace Elia” Mi sembrava passata un’eternità da quando mi ero vista per la prima volta in certe condizioni e ricordare improvvisamente come si erano abbattute le conseguenze di ciò su Elia non mi piaceva particolarmente. Iniziai a srotolarmi e intrecciarmi le dita, convinta nel non voler alzare lo sguardo su mio fratello, quando sentì il materasso piegarsi leggermente sotto il peso del suo corpo e le sue mani grandi poggiarsi cautamente sulle mie, accarezzandomi. “Voglio solo capire cosa ti succede, principessa. Lo sai che preferirei mille volte stare tutto il tempo qui con te piuttosto che andare a lavorare, ma è necessario, purtroppo. Se poi tu non mi parli più quando ne hai bisogno le cose si complicano ulteriormente ed io non riesco più a capirti” sussurrò tranquillamente, alzandomi la testa con le dita così da potermi guardare attentamente negli occhi. “Che cos’hai?” “Il solito” “Cioè?” domandò ancora, accarezzandomi il mento con il pollice caldo. “L’acidità a duemila” sussurrai, scrollando le spalle, sperando che ci credesse. Ma, ovviamente, con la fortuna che mi ritrovavo non poteva essere proprio così. “Tu non sei acida, principessa” mi sorrise divertito, scuotendo la testa. Inarcai le sopracciglia, guardandolo dubbiosa. “Ah no?” “La tua è solo .. uhm … come dire … dolcezza andata a male. Basta solo saperti guardare un po’ meglio dentro per capirlo …” spiegò semplicemente, passandomi un dito sopra l’occhio destro per levare qualche residuo fastidioso del mascara. “Quindi, dimmi Ter, da cosa stai cercando di scappare adesso?” Colpita e affondata. Avevo dimenticato quanto Elia fosse bravo ad arrivare direttamente al nocciolo della questione senza girarci troppo intorno e di quanto questo mi portasse a sentirmi terribilmente scoperta. Strizzai leggermente le palpebre, allontanandomi dalla sua presa per potermi infilare tra le coperte con un magone pensate in gola. “E’ lui il problema, Elia, è sempre lui. Non se ne vuole andare questa sua parte che si è lasciato dietro e certe volte torna. Sembra non volermi lasciare in pace. Ed allora io faccio quello che ho fatto, senza nemmeno rendermene quasi conto” “Perché?” domandò quasi subito, a bassa voce. Semplice, netto, conciso. Solo … perché. Mi rigirai affannata sulle coperte, stendendomi su un fianco così da poterlo, in qualche maniera, fronteggiare. “Te ne devi andare adesso?” Lui scosse la testa, iniziando a levarsi le scarpe intuendo probabilmente dove volessi andare a parare. “Ho preso un paio di giorni liberi” “Bene” soffiai flebilmente, sollevando le coperte così che potesse entrarci sotto anche lui. “Dormi con me” Si sistemò per bene a pancia in su, aggiustando le coperte sui nostri corpi e infilando furtivamente un braccio sotto alla mia testa così da farmi come cuscino per poter poggiare la testa su una piccola parte del suo petto. Infilò delicatamente una mano tra i miei capelli attorcigliandoseli attorno alle dita, pensieroso. “Perché, Ter?” ripeté a bassa voce, sospirando affranto. “Perché se mi lascio andare sento solo dolore …” Semplice. Netta. Concisa. Solo quello. ____________________________________________________________________________ Ero arrivata alla conclusione che passare metà della giornata – con ancora la febbre che faceva su e giù dal trentasette in un momento al trentanove in un altro - tra lo stare con Elia al letto a guardare una maratona di tutti i film di Robert Pattinson – anche contro le sue continue proteste - ed il resto con Keaton tra una sigaretta, un sorso di birra e una fetta di pizza non era servito poi a molto se alla fine mi ritrovavo sola nel soggiorno, a mezzanotte meno venti con la casa che sembrava una stufa, la maglietta di Elia ancora addosso ed una scatola di biscotti e cioccolatini in grembo che stentavo a mandar giù nonostante risultassero terribilmente invitanti per il mio appetito – ed il fatto che il mio stomaco brontolasse ogni due ne era la prova concreta. Verso le sette di quel pomeriggio era passato a casa Cole, il fratello maggiore di Leanne, ed avevo praticamente costretto Elia ad andarsi a fare un giro con lui rassicurandolo dicendogli che avrei chiamato Keaton per farmi tenere compagnia – Leanne era impegnata al Sanyo per dare una mano ad Hayden e dal canto suo Baja proprio a quell’ora aveva da dare ripetizioni di Storia ad un ragazzino di prima - che poi era ciò che effettivamente avevo fatto, ma verso le dieci meno venti il mio amico era dovuto scappare a casa sua per badare alla sua sorellina più piccola che si era beccata la varicella. Così eccomi sul divano di casa, sprofondata nei cuscini, con la febbre che era risalita e la paura costante di chiudere gli occhi per non rivedere le immagini delle ore precedenti, a guardare Charlotte, Holly e Vicky di Geordie Shore che correvano impedite in un pollaio nel disperato tentativo di riuscire ad acchiappare una gallina per potersela così portare a casa. Mi rigirai sul divano, spostando il peso dalla gamba sinistra a quella destra, infilando il terzo biscotto in quelle due ore in bocca, scocciata. Detestavo decisamente non riuscire a dormire essendo una persona dall’indole terribilmente pigra; non farlo poi per una persona, o meglio, la paura di rivedere una certa persona nei miei incubi peggiori non mi era mai piaciuto e non mi piaceva certamente in quel momento – e sicuramente non piaceva alle persone che avevano a che fare con me il Lunedì mattina. Ma mi conoscevo troppo bene per dar ascolto al mio orgoglio che mi diceva chiaramente di andarmene al letto a dormire fregandomene di Dante, delle sue stronzate e dei suoi incubi che sembravano voler tornare a darmi la caccia dopo una pausa di due anni e mezzo; se lo avessi fatto avrei finito solo per autodistruggere ulteriormente me stessa finendo per ritornare allo stato iniziale di zombie senza voglia di vivere, muto, a digiuno da cibo e rapporti interpersonali, che finiva per urlare e dimenarsi continuamente ogni qual volta chiudeva gli occhi per più di quindici minuti. Ricordavo chiaramente quel periodo, come se mi guardassi allo specchio; le mie gambe quasi scheletriche, i capelli troppo lunghi senza vita, gli occhi arrossati continuamente e le braccia senza forza per riuscire a sorreggermi troppo. Il mio essere terrorizzata all’idea di chiudere gli occhi, anche solo per sbaglio, – degno di Nightmare – ed il rifiuto costante di cibo e parole di conforto da chiunque. Ma non era il fantasma della vecchia me – seppure avessi voluto fosse così nonostante la detestassi davvero tanto – a darmi la forza di andare avanti anche senza Dante e a rifiutare un ritorno alle vecchie abitudini, tralasciando ciò che era successo il giorno precedente per colpa di Justin – che non sapevo se tornare a detestare come prima cancellando quei pochi aggettivi positivi che gli avevo affibbiato e che avevano contribuito al rendermelo addirittura simpatico e dolce. Ma, piuttosto, l’immagine del ragazzo che avevo costretto mio fratello a diventare. Rammentavo come fosse ieri il pianto infinito che mi ero fatta – l’unico in vita mia – quando mi ero decisa ad aprirgli la porta della mia camera, avendo capito che era il momento di tornare a vivere. Per quanto lo avessi trovato bianco come uno straccio, spaventosamente magro, con due pozzi neri sotto agli occhi e la barba troppo folta per il suo volto, non era stato quello ad innescare qualcosa dentro di me. No. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso erano stati i suoi occhi. Occhi di solito dannatamente chiari, quasi color acquamarina – quello dei mari Brasiliani che mostrano su National Geographic – con delle striature verdastri, sempre chiare, attorno alla pupilla e con una strana lucina di vitalità e forza che me li avevano fatti sempre amare, ma che in quel momento si potevano definire in tutti i modi possibili tranne quello. Perché di vitale, gli occhi dell’Elia di due anni e mezzo fa, non avevano niente. Erano semplicemente brutti, ma brutti davvero: scuri, con l’acquamarina che era diventato quasi grigio scuro e che aveva interamente coperto quelle pagliuzze verdi all’interno; con uno strato bagnato di tristezza che li ricopriva come una coperta, un secondo di rabbia che li rendeva rossi come lo smalto che preferivo ed un terzo di dolore che gli dava quella consistenza liquida e malinconica che io proprio non ero riuscita a reggere. Vederlo in quello stato, vedere me in uno stato simile, a causa mia e di Dante mi aveva fatta davvero infuriare e solo la remota idea che tutto potesse in qualche modo tornare come ad allora mi faceva sentire la stessa rabbia dentro che automaticamente mi dava la forza di lottare contro il mio stesso orgoglio e riuscire a mantenermi intatta quando quella di lasciarmi di nuovo andare mi sembrava l’unica scelta che fossi in grado di fare. “Carter, cazzo, che ti prende?” Un urlo acuto e rabbioso mi riportò brutalmente alla realtà facendomi sobbalzare sul posto. Strabuzzando gli occhi lanciai all’aria il biscotto metà morsicato che avevo tra le mani, lasciandomi sfuggire un urlo spaventato quando una mano grande e fredda si poggiò improvvisamente sulla mia spalla iniziando a scuotermi. Saltai giù dal divano come una molla, voltandomi ancora con il cuore a mille verso l’intruso, strabuzzando gli occhi nello scoprire chi fosse in realtà. “Che diavolo ci fai tu qui? E come cavolo hai fatto ad entrare?” gridai incredula portandomi una mano al cuore, sentendolo terribilmente veloce, spostando lo sguardo da lui alla porta chiusa. “Cristo, sto per morire, me lo sento …” “Cazzo, non mi rispondevi e pensavo ti fosse successo qualcosa” sbuffò irritato, sfilandosi la felpa bianca. “Mi hai fatto venire un colpo, idiota!” “E che dovrei dire io?” ribattei piccata, incrociando le braccia al petto. “Sei entrato in casa mia chissà come e per di più mi hai fatto quasi venire un infarto dallo spavento, stronzo!” Lui roteò gli occhi, abbandonando l’indumento sullo schienale del divano. “Certo, perché starti a chiamare per dieci minuti senza ricevere risposta quando era chiaro che eri in casa è una cosa normale, eh!” “Come sei entrato qui dentro, Justin?” domandai nuovamente, passandomi una mano tra i capelli e sentendo la mia temperatura ricominciare a salire. “E cosa ci fai qua, a quest’ora?” “Cazzo, sembra di essere al rogo qui dentro” rantolò, sfilando anche il cappellino di lana e scompigliandosi con una mano i capelli nel vano tentativo di distogliere la mia attenzione dalla sua presenza nella mia casa. “Justin!” sibilai acida, ri-attirando la sua completa attenzione verso di me. “Che vuoi?” “Oh, che palle!” sbuffò irritato, allargando le braccia. “Volevo vedere come stavi. Sei stata decisamente poco rintracciabile in questi giorni …” Mi lanciò un’occhiata stranita, soffermandosi in particolar modo sulle mie gambe scoperte a causa della camicia del pigiama di Elia. “E dovresti coprirti. Sei rossa, mi sa che ti sta tornando la febbre” “Come hai fatto ad entrare?” continuai imperterrita – non mi sarei fatta abbindolare dalla sua ‘preoccupazione’ sul mio stato in quel momento - inarcando le sopracciglia. “E cosa ne sai tu della mia salute?” “L’ultima volta che ci siamo visti mi hai fatto vedere dove nascondete il doppione della chiave, rimbambita. E, per quanto riguarda la seconda domanda, ti ricordo che il mio amico e la tua amica si stanno frequentando. E’ ovvio che le venga a sapere certe cose, soprattutto se stiamo parlando di quel chiacchierone di Jared - che, tra parentesi, ti saluta – e se tu non rispondi al telefono” rispose tranquillo, inumidendosi le labbra. “Contenta?” “No, ovviamente. Perché sei qui Justin?” domandai, muovendo un passo in avanti per coprire i biscotti. “Per quale vera ragione oltre alla mia salute, sei qui, intendo” “Perché tutte queste domande Carter?” “Perché tutti questi tentativi di sviare le risposte Justin?” “Oh, Cristo, e va bene!” ringhiò spazientito, avvicinandosi a me. “Volevo vederti, okay? Ero preoccupato e volevo vederti, tutto qui!” Portò le mani lungo i fianchi, piegando leggermente la testa di lato per guardarmi attentamente negli occhi. “Per quale diavolo di motivo devi sempre pensare che dietro a tutto quello che faccio ci sia un doppio fine?” “Perché non mi hai mai detto cosa vuoi in realtà da me” sussurrai, arretrando di un passo. “Perché non volevi che uscissi con Wes, perché sei venuto a casa dopo che quel tizio mi ha colpito, perché mi hai portata … lì … l’ultima volta che ci siamo visti, perché non mi dici se lo hai fatto di proposito o, in caso, dove volevi portarmi realmente, perché una volta mi sbraiti contro che sono una stronza che non si merita la libertà del fratello e gli altri tre dopo sei così carino e dolce che quasi mi piaci. Perché sembra che tu faccia di tutto pur di farmi parlare di Dante, perché mi abbracci quando ti pare senza fregartene se io possa avere o meno un ragazzo, perché sei scappato via tre anni fa o perché non avessi capito che razza di stronzo era Dante. Perché vuoi per forza entrare nella mia vita …” Okay, probabilmente quel mio sparlare senza freni era dovuto in principal modo alla poca lucidità causata dalla febbre, ma, sostanzialmente quelle erano le domande che avrei sempre voluto porgli ma, per un motivo o per un altro – o più che altro perché quando ci vedevamo finivamo per litigare – non ero mai riuscita sfogarmi così con lui. Arretrai di un altro passo - sentivo la testa iniziare a girarmi leggermente - che Justin si preoccupò di ricoprire velocemente con gli occhi strabuzzati mentre stava visibilmente elaborando le mie parole. Aveva tirato fuori le mani dalle tasche dai pantaloni a cavallo basso di pelle che indossava, mordicchiandosi convulsamente il labbro nel tentativo di diminuire il più possibile la distanza tra di noi – che avesse capito quando ciò mi mettesse agitazione non lo sapevo ancora, ma certamente non migliorava il mio stato psicofisico. Allungai le mani all’indietro, scontrandomi improvvisamente contro la superficie liscia e calda della Tv, mandando giù il groppo che mi si era formato nella gola osservando quanto poco mancasse prima che mi fosse troppo vicino. Un passo. Due. Tre. Quattro. Ed eccolo. Le sue ginocchia leggermente piegate sfioravano delicatamente le mie gambe nude ed il suo fiato caldo mi scompigliava fastidiosamente i capelli sulla fronte. “Non voglio farti del male, Carter. Davvero …” sussurrò dolcemente, sollevando la mano aperta sulla mia guancia, spostandomi una ciocca di capelli che mi si era appiccicata alla pelle. “Allora rispondi, Justin” Lui sospirò, iniziando a far passare il pollice sulla mia guancia. “Non … posso, okay? Non è compito mio spiegarti certe cose” Sollevai improvvisamente lo sguardo, lasciando cadere furiosa i miei occhi nei suoi sperando di riuscire a mantenere un minimo di autocontrollo su me stessa ed il mio corpo. “Quindi mi stai dicendo che tutto questo … interesse … verso la mia vita è perché Dante ti ha chiesto di tenermi d’occhio?” domandai acida, cercando di aggirarlo ed allontanarmi da lui. “Non … Cristo e stai ferma …” sbottò, piantando deciso le mani sui miei fianchi, facendo sollevare di poco la camicia sulle gambe, trattenendomi tra lui e la Tv. Si passò una mano tra i capelli, sospirando. “Tuo fratello non mi ha chiesto niente … ma … cavolo, come te lo spiego? Ci sono … delle cose che hanno a che fare con lui e che solo lui ti potrà spiegare. Mentre, beh, per il resto delle tue domande ho miei motivi per averti tenuta lontana da quello stronzo o per aver fatto determinate cose” “Non mi stai aiutando Justin” “Senti, lo so, okay? Ma non posso, davvero. Devi fidarti di me, però” Strabuzzai gli occhi, scuotendo in automatico la testa. “Fidarmi di te? Stai scherzando? L’ultima volta che mi sono fidata di un uomo è finita molto male Bieber, non ci tengo a ripetere l’esperienza, grazie” “Non puoi incolpare tuo fratello per tutto, Carter. Lui non ne ha di colpe in questa storia. Lui è lo stesso uomo che credevi fosse, lo è sempre stato. E non è tantomeno un assassino o un piromane impazzito. Ogni cosa che ha fatto a una sua logica dietro … e tu potrai capirla quando sarai pronta ad ascoltare la sua versione dei fatti. ” mormorò, accarezzandomi ancora la guancia. Inchinò leggermente la testa verso di me, sfiorandomi la pelle con il naso, respirandomi sulla gola. “Ti puoi davvero fidare di me, piccola Harvey ..” sussurrò, accennando un piccolo sorriso di incoraggiamento. Non sarei stata in grado di fidarmi di lui. Ne ero certa. Sospirai, chiudendo gli occhi per riflettere sulle sue parole – troppe informazioni - ma prima ancora che potessi elaborare un qualche tipo di pensiero la mia bocca si era già aperta e si era lasciata sfuggire l’ultima cosa che avrei dovuto mai tirare fuori in quel preciso momento. “Perché mi hai baciata?” Breve. Chiara. Spaventosamente idiota. Non sapevo con quale coraggio gli avessi domandato una cosa del genere – anche perché non ero certa di volerne sapere la risposta o anche solo tirare in ballo l’argomento – ma la febbre, il caldo ed il batticuore insensato avevano contribuito abbastanza alla mia stupidaggine, nonostante quella fosse una domanda che mi ero posta decisamente molto spesso negli ultimi giorni in cui non ci eravamo visti. Fatto sta che Justin sbarrò leggermente gli occhi, fermando le carezze della sua pelle su di me, a qualche millimetro dal mio viso, a qualche pericoloso millimetro della mia bocca bruciacchiante. “Vuoi davvero saperlo, Carter?” mi domandò fievolmente, accostando nuovamente la sua pelle alla mia, soffiandomi sulla guancia mentre le sue dita ricominciavano a muoversi sul mio volto. Volevo davvero saperlo? No, ovvio che no, ma il mio corpo sembrava non essere propriamente d’accordo e mi ritrovai ad annuire lentamente, tenendo gli occhi fermi sulla sua maglietta bianca semplice. Mi sentivo bruciare, il respiro lento e un leggero accenno di battito accelerato nella cassa toracica, mentre i secondi scorrevano lenti tra la poca distanza che ci separava. “Sai, inizialmente avevo convinto perfino me stesso a credere che l’avessi fatto per non farti guardare indietro, sai … poi, però, mi sono reso conto che in realtà volevo semplicemente farlo. Quella probabilmente sarebbe stata la scusante che ti avrei rifilato per attutire leggermente la tua rabbia in caso avessi voluto pestarmi a sangue … ma la verità è che mi sono lasciato trasportare dai miei istinti e … ti ho baciata … tutto qui. Volevo solo farlo ” sussurrò semplicemente, le labbra che si increspavano leggermente all’insù in un sorriso divertito, facendo per allontanarsi da me. Ma quella volta, contro tutte le aspettative di entrambi, fui io a fermarlo. Per la rabbia, la disperazione, la confusione, le mille domande, i dubbi … Mi aggrappai semplicemente con quanta più forza potessi al suo collo, schiacciandomi contro di lui, premendo bruscamente le mie labbra contro le sue, morbide. Non sapevo perché, per quale strano impulso, per quale effetto della febbre troppo alta, ma lo avevo fatto. Lo avevo baciato, e sapevo che lui di certo non si sarebbe tirato indietro. Difatti era ovunque. Sentivo le sue mani muoversi frenetiche sui miei fianchi, la mia schiena, le guance, i capelli, mentre spostava famelico la bocca sul mio labbro inferiore, stringendolo leggermente prima di ritornare a baciarmi seriamente, le labbra che sfioravano ed assaggiavano ogni centimetro della mia pelle arrossata e calda. Intrecciai le dita ai suoi capelli, stringendoli leggermente per sorreggermi a lui mentre sentivo la sua lingua passarmi lentamente sul labbro inferiore, le sue mani sul fondo della schiena che giocherellavano intrepide con il tessuto della mia maglietta. La sua bocca tornò a premere bramosa sulla mia e non c’era uno solo dei miei pensieri che non fosse concentrato su ciò che stavamo facendo, sulla vicinanza assurda dei nostri corpi, invaso da un’ondata improvvisa di calore e desiderio – per quanto ciò potesse, da una parte, risultarmi insensato, stupido, pericoloso, assurdo e sbagliato. Insomma, quello lì era Justin. Justin Bieber. Lo stesso Justin che tratteneva mio fratello fuori casa fino alle quattro del mattino; lo stesso identico ragazzo che quando si presentava a casa nostra per prendere mio fratello non salutava nessuno e criticava sempre Elia; quello che diceva di non aver mai capito cosa avesse in mente di fare Dante, quello che al processo era rimasto in piedi in fondo alla sala con le sue scarpe scarlatte e che dopo la condanna a quattro anni per incendio doloso era andato via da San Diego silenzioso come un ladro. Ed era anche lo stesso Justin che era tornato e che continuava a mentirmi spudoratamente su mio fratello e su quanto lui avesse effettivamente a che fare con le sue azioni. Come potevo lasciarmi andare ulteriormente avendo quelle consapevolezze? E mi conoscevo abbastanza per sapere che ogni minimo tentativo di andare oltre a quello stato di sopportazione-odio che caratterizzava il nostro ‘rapporto’ sarebbe stato vano, soprattutto essendo consapevole della poca fiducia che ero capace di riporre negli uomini – Keaton, Elia, Cole e Jackson permettendo. Mi era difficile pensare che Justin – ammesso e non concesso che gli dessi una possibilità di entrare nella mia vita – non avrebbe fatto ciò che mi aveva fatto Dante: sparire da un momento all’altro senza spiegazioni. Sapevo quanto quei miei pensieri fossero apparentemente insensati e brutti – soprattutto ripensando a quanto oggettivamente Justin mi avesse in qualche modo aiutato negli ultimi due mesi – ma non potevo farne a meno. Essere così diffidente dalle persone non mi piaceva, ovvio, ma era risultato molto utile negli anni passati a sapermi scegliere gli amici e a tenermi alla larga da gente poco raccomandabile o incredibilmente falsa. E sopportare ulteriore dolore mi sarebbe impossibile – sapevo che Justin, essendosi rivelato anche un tipo di ragazzo del quale avrei potuto facilmente invaghirmi nonostante non avessi mai pensato che un tipo come lui potesse piacermi, se avesse voluto, sarebbe stato facilmente in grado di infliggermelo – quindi, ‘meglio prevenire che curare’. Liberai la mia bocca dalla sua, affannata, – la testa mi girava leggermente, segno che il mio corpo necessitava di qualche bustina di Tachipirina – poggiando tentennante le mani sul suo petto per allontanarlo da me. Trattenni leggermente il fiato, sentendo ancora il suo irregolare scompigliarmi i capelli, prima di decidermi a rialzarlo su di lui. “Carter …” provò a parlare, ma lo fermai scuotendo decisa la testa. “Justin, senti .. Dio … facciamo … uhm … finta di niente, eh?” mormorai a bassa voce, mordendomi dubbiosa il labbro. “Tu hai baciato me e io ho baciato te. E poi basta. Io non posso fidarmi di te, non ci riuscirei, quindi lascia perdere. Non mi interessa più avere delle risposte da te e tu comunque non me le daresti, quindi ognuno per la sua strada. E … basta. Le cose tra di noi non potranno continuare ad andare in questo modo per sempre quindi meglio lasciar perdere da subito …” Perché in quel momento tutte quelle parole mi sembravano le più stupide che avessi mai potuto dire? Lasciai andare l’aria che avevo trattenuto quando sentì Justin mollare la presa su di me, allontanandosi di qualche passo. Si sporse all’indietro per afferrare la sua felpa sullo schienale del divano, senza perdere contatto visivo con me. La infilò lentamente, senza il minimo accenno a qualche tipo di emozione negativa come rabbia o risentimento, semplicemente e irritabilmente apatico. “Voglio bene a Dante ma pensavo avessi capito che io non sono tuo fratello, piccola Harvey” affermò semplicemente prima di sbattersi la porta di casa alle spalle, lasciandomi di nuovo sola. Sbuffando mi chinai a terra, afferrando il biscotto che primo avevo lanciato. Mi rialzai dolorante e accaldata aggirando il divano ed iniziando a dirigermi verso la cucina, con le parole di Justin ancora in testa. Ma, un secondo prima che potessi aprire la porta, il suono squillante e fastidioso del campanello mi fece sobbalzare costringendomi a tornare in corridoio. Justin sicuramente non era; se voleva dirmi qualcos’altro avrebbe di certo usato la chiave. D’altronde, però, chi poteva suonare a casa a quell’ora di sera? Titubante mi avvicinai alla porta afferrando da uno scaffale la palla autografata dai San Diego Padres di Elia – non sapevo esattamente come avrei mai potuto usarla ma sempre meglio avere qualcosa in mano. Tirai lentamente il pomello e spalancai la porta, lasciandomi cadere ‘l’arma’ dalle mani nello stesso istante in cui riconobbi la figura magra e alta del ragazzo che mi si presentava, sorridente, dinanzi. “Jackson?” Jackson Russell Writer's corner: Okay, rieccomi. Tralasciando il mio solito non saper come commentare l'ennesimo capitolo - che non vi interessa nemmeno lol - questa volta non mi dilungherò troppo. Questo era più che altro un capitolo diciamo di passaggio per far entrare in scena un altro personaggio, Jackson, che sarà una figura abbastanza rilevante d'ora in poi. Vi anticipo solo che tra un paio di capitoli - pochi - le cose inizieranno a complicarsi e tutte le domande che vi siete poste all'inizio troveranno finalmente risposta. Poi, per il resto, le considerazioni come sempre a voi. Quindi - se ci siete - se vi va battete un click. Ora evaporo. Baci ☺♥ |
Capitolo 16
*** 15. The worst things in life comes free to us. ***
 15.
Justin Frenai bruscamente sul ciglio della strada udendo perfettamente lo stridere acuto e forzato delle ruote sulla fiancata destra che invadevano bruscamente buona parte del marciapiede, facendo sobbalzare un gatto arancione che mi ringhiò contro prima di correre - con la coda tra le gambe - dietro ad una panchina dall’altro lato della strada. Mi tastai furiosamente le tasche alla ricerca del sesto o settimo pacco di sigarette da dieci che avevo finito nelle ultime tre ore e mezza, estraendone velocemente – non appena avvistato - una sigaretta. “Se non mi muori prima dei quarant’anni mi faccio tatuare il tuo nome Bieber” bofonchiò Blake dall’altro capo del telefono. “Ho un déjà-vu” sospirai, lasciando mio malgrado che l’angolo della mia bocca si piegasse leggermente all’insù a formare una sottospecie di sorriso un po’ forzato che, in quel momento, poteva benissimo sembrare una smorfia di disgusto. Blake sospirò rumorosamente, accompagnato da qualche rumore di sottofondo – probabilmente sua madre e sua sorella maggiore che chiacchieravano nella loro cucina rustica di Campagna nello Utah. “Dopo quella volta hai iniziato a stare molto più tempo fuori casa e non hai voluto dire a nessuno di noi di cosa avevate parlato tu e Dante” rimuginò sospettoso, e potevo tranquillamente immaginarmi la pelle della sua fronte che si corrugava in piccole e rialzate pieghette d’espressione. “Non oso immaginare cosa ne verrà fuori da questa cosa” “Nulla di buono, temo …” mormorai a bassa voce, aspirando con foga la nicotina, il catrame, e tutte quelle merdate che mettevano dentro ad una sigaretta, stringendo rabbioso il filtro tra le labbra. Parlare con Blake in certe ‘situazioni’ – la mia visita in carcere a Dante ne era un esempio – mi veniva quasi automatico sin da quando eravamo diventati amici. Non mi portava alcun sollievo, non mi catapultava magicamente fuori dal mondo facendomi dimenticare dei miei problemi per qualche minuto ne riusciva tantomeno a far scemare, almeno un po’, quel miscuglio incasinato ed irritante di emozioni negative che mi attaccavano in casi come quello; semplicemente mi parlava, ricordandomi – con la sua rumorosa e numerosa famiglia, il suo lavoro da fattorino per una pizzeria e il lamentarsi di quanto fosse irritante sapere d’avere così poca fantasia da permettere a sua sorella di indovinare subito le sue password – che per un breve periodo della mia vita anch’io sapevo di aver avuto un’esistenza meno complicata e stressante di quella che poi era andata a crearsi dal mio arrivo a San Diego, dopo la morte di mio zio. E, nonostante nel profondo adorassi gli altri ragazzi, sapevo che nessuno di loro sarebbe stato in grado di darmi quegli attimi di ‘normalità’ che mi dava Blake semplicemente parlando o sfottendomi; Sal era troppo facilmente irritabile, Ian aveva già i suoi problemi con il padre e la madre e Jared, be’, Jared aveva la sua opinione sulle mie scelte – soprattutto quando il fulcro di queste fosse mia zia – quindi avrebbe finito solo per irritarmi ulteriormente, nonostante capissi che il motivo della sua disapprovazione sulla mia scelta di andarmene fosse dettata da una motivazione più che valida. “Sei sicuro di volerlo fare Justin?” mi domandò tentennante il moro, riportandomi bruscamente alla realtà. “Si, tranquillo. Ora devo chiudere” mi sbrigai a parlare, nonostante le lancette dell’orologio non segnassero ancora le quattro e dieci del pomeriggio. “Va bene” mi assecondò rassegnato lui, sospirando. “Quando hai finito, se la cosa è andata troppo male, puoi sempre guidare un paio d’ore e fare un salto qui a casa mia. Lo sai che mia madre e mia sorella stravedono per te” aggiunse ridacchiando, e riuscì anche a sentire delle risatine più acute e di protesta in sottofondo. “Salutamele” ammiccai, lasciandomi sfuggire un piccolo sorriso divertito, prima di agganciare la chiamata e buttare il telefono sui sedili posteriori, afferrando un’altra sigaretta. La accesi più in fretta che potessi fare, mentre scendevo – quasi trascinandomi – dalla macchina; la aggirai e mi lasciai cadere contro la fiancata, osservando – a metà tra il dubbioso e il rancoroso – la piccola casetta bianca malmessa che avevo di fronte. Erano quasi due mesi che non ci mettevo piede, ma potevo affermare con certezza che come mi aspettavo non era cambiato molto; solo le luci intermittenti e colorate di un possibile albero di Natale si accendevano e affievolivano dalla finestra che dava sul soggiorno. Lasciai fuoriuscire dalle mie labbra una piccola e densa nuvoletta di fumo, stringendo il pugno libero lungo i fianchi nel sentire la rabbia degli ultimi giorni tornare ad aleggiare sopra di me. Le ultime due settimane dell’ultimo mese dell’anno erano state le più merdose ed irritanti della mia vita, probabilmente. Avevo passato il Natale con uno Ian più taciturno del solito ed un Jared più voglioso di fare a botte con le persone – il sottoscritto sembrava essere più benvoluto di chiunque altro; il Capodanno in uno squallido locale nel centro popolato principalmente da ragazzine con perfino i capelli leopardati e degli alcolici da far schifo. Con mia zia che improvvisamente si era ricordata – dopo che sicuramente uno dei suoi ‘nuovi fidanzati’ l’aveva mollata – di avere un nipote, ricominciando ad asfissiarmi e tempestarmi di telefonate; Ryan e mia madre che a loro volta avevano ricominciato a farsi vivi – dopo una sicura lamentela con loro dalla sorella – e la mente in parte costantemente occupata dalla questione ‘Carter Harvey’. Avevo passato delle ore a rigirarmi il cervello nel vano tentativo di capire quale fosse effettivamente la cosa più giusta ed indolore – per tutti – che potessi decidere di fare. Sapevo quanto potesse essere frustrante e – in qualche maniera doloroso – per lei, sapere che io ero a conoscenza di fatti e risposte che a lei erano state negate e che, nonostante ciò, avessi deciso di tenerle per me; che non potessi, in verità, farlo, se non volevo peggiorare ulteriormente la situazione. Ma, in quel ambaradan di ‘posso’, ‘non posso’, ‘voglio’, ‘non voglio’, ero arrivato ad essere assolutamente certo di una cosa: se c’era un qualcosa che in quel momento avevo bisogno – una piccola parte di me, probabilmente, lo desiderava anche - la piccola Harvey non venisse a sapere era quanto io fossi effettivamente coinvolto in tutta quella faccenda dell’incendio; quanto realmente ne facessi parte – indipendentemente dalla validità delle mie motivazioni. Io avevo aiutato, di mia spontanea volontà, Dante ad organizzare tutto. Io lo avevo aiutato ad appiccare il fuoco. Io lo volevo aiutare a far fuori Rick. Io avevo continuato ad aiutarlo quando lo avevano sbattuto dentro ad una cella, andandomene in giro per gli Stati Uniti alla sua ricerca. E, sempre io, lo stavo ancora aiutando in quei mesi. E se la piccola Harvey, in qualche assurda ed improbabile maniera, – che comprendeva, ovviamente, la lontananza forzata di quello stronzo di Wes da lei – fosse magicamente venuta a sapere qualcosa di tutto ciò, ero certo che - oltre al non perdonarmi mai nella vita – con la sua probabile reazione rabbiosa avrebbe combinato più casini di quanti ne avesse fatti suo fratello e, inoltre, avrei quasi sicuramente rischiato anch’io un bel paio d’anni in galera. Era quasi come se mi fossi piazzato nel messo esatto di due fuochi che volevano entrambi farmi fare quel passo in più che m’avrebbe irrimediabilmente portato o da una parte o dall’altra: lasciare che Carter riponesse un minimo di fiducia nel sottoscritto e nelle mie menzogne o lasciarla stare una volta per tutte? Ed inizialmente entrambe le opzioni mi erano sembrate abbastanza a portata di mano e ragionevoli, ma poi – rimuginandoci troppo – ero arrivato quasi ad escluderle entrambe; scegliendo la prima avrei rischiato sicuramente ed irrimediabilmente di spezzarle il cuore, alla fin fine, ed era una cosa che sinceramente non riuscivo a mandare giù. D’altro canto, scegliendo la seconda, avrei rischiato di mettere a rischio la mia salute mentale – stranamente sapevo che non sarei riuscito a trattenermi dal intromettermi nella sua vita, a non averci a che fare solo per stuzzicarla e farla arrabbiare un po’ – e la sua fisica – per quanto Carter potesse riuscire ad essere forte ed indipendente sembrava particolarmente incline all’attirare situazioni poco piacevoli su di se, e non mi riferivo solo alla figura di Rick che incombeva minacciosa e costante su di lei. Il mio essere quasi alle strette, quindi, mi piaceva ben poco; non avevo mai amato non avere una scelta in più da usare come scappatoia per temporeggiare e rimettere in sesto le idee, e ciò mi portava ad essere più scazzato ed insopportabile del solito con me stesso, perfino, o con chiunque. E trovarmi, di nuovo dopo quella che mi era sembrata un’eternità, di fronte alla casa poco curata e triste di mia zia non contribuiva certamente a migliorare il mio stato psicofisico in quei giorni. Sollevai lentamente lo sguardo, lasciando scivolare la sigaretta sotto la suola di scarpe mentre mi incamminavo verso la porta, nel sentire una sporta venire sbattuta brutalmente. La figura leggermente ricurva e slanciata di un uomo, controsole, mi si avvicinò lentamente con un sorriso amaro sulla bocca, le mani affondate malamente nelle tasche dei pantaloni rotticchiatti. Mi si fermò di fianco, squadrandomi curioso da capo a piedi. “La nostra bella starà fuori servizio per un po’, mi sa, amico” ammiccò, quasi dispiaciuto, lanciando un’occhiata veloce alla casa dietro di lui, assestandomi delle pacche ‘amichevoli’ sulla spalla prima di sparire dietro ad un’altra casa – anche prima che avessi anche solo il tempo di scagliarmici contro e pestarlo fino allo sfinimento, che sentivo fosse una cosa che necessitavo urgentemente di fare per non rischiare di scoppiare da un momento all’altro. Strinsi i denti contro le labbra, salendo scocciato quei tre gradini malmessi che portavano sul portico, prima di bussare titubante sul legno ruvido e fastidioso della porta. Le quattro finestre che davano sul primo piano della casa erano tutte illuminate, qualche pezzo di tenda svolazzava all’esterno a causa del vetro leggermente sollevato di alcune, e sentivo il chiacchiericcio fastidioso di qualche stupido programma di cucina che dovevano star trasmettendo in quel momento. Riuscivo quasi a vedere qualche ramo di pino irrompere nella mia visuale, addobbato a dovere con palle blu e grigie, dalla finestra alla mia destra. “Oh, diamine, John, ti avevo detto di non farti più vedere!” sentì urlare improvvisamente dall’interno, dei passi che si avvicinavano veloci alla porta, prima che questa si aprisse bruscamente mostrandomi la figura minuta e scura di mia zia che mi guardava a occhi sbarrati. “Oh, sei tu tesoro. Scusami, sai …” si affrettò ad aggiungere con tono mielato, facendosi di lato per farmi entrare. Strinsi i pugni nelle tasche dei pantaloni, cercando di ignorare il vano tentativo di mettere nella parola ‘tesoro’ lo stesso mix di dolcezza e premura che era capace di usare quando ero bambino, facendo qualche passo per seguirla nel soggiorno e senza però allontanarmi troppo dalla porta – che era la più vicina via di fuga da quella casa in caso ciò che mi avesse detto non mi piacesse particolarmente. “Perché mi hai fatto venire?” domandai meccanicamente, piantando per bene i piedi a terra. Lei, che prima era intenta a sistemare per bene un cuscino bianco del divano quasi pensasse mi sarei seduto, si voltò stupita verso di me, incrociando le braccia al petto. Aveva i capelli scuri che sembravano più disordinati del solito ricadendole sulle guance scavate e pallide; gli occhi erano contornati da un leggero alone violaceo, la pelle pallida che si illuminava di rosso quando le luci dell’albero si facevano più intense, ed indossava una vestaglia marroncina legata in vita abbinata, probabilmente, alle ciabatte pelose e dello stesso colore. Batteva fastidiosamente la punta del piede a terra, mentre mi guardava attenta, ma non mi sembrava più brilla o fatta del solito quindi rilassai di poco le spalle, attendendo una sua risposta. “Torna qui, Justin” sussurrò indecisa, passandosi una mano sulla fronte. “Mi hai tempestato di messaggi e chiamate solo per questo?” sibilai irritato, scuotendo la testa furiosamente. Non che mi aspettassi chissà quali scuse o promesse di smetterla con le sue stronzate da donna immatura che affogava il dolore per il marito in alcool, droga e sesso, ma non pensavo nemmeno che avesse dimenticato il ‘no’ irremovibile che le avevo ripetuto miliardi di volte quando, per lo stesso numero di volte, mi aveva chiesto di tornare a vivere lì. Chiedermelo di persona o tramite telefono non avrebbe cambiato le mie decisioni, e lei lo doveva sapere perfettamente. “No, insomma … Dio, come te lo dico …” mormorò sconsolata, iniziando a muoversi su e giù tra il divano e la Tv attaccata al muro, pronunciando parole senza senso a se stessa. Ripeté quel susseguirsi di parole e movimenti apparentemente illogici per qualche altro minuto, il tutto sotto il mio sguardo vigile e stranito, prima di fermarsi bruscamente in mezzo al salotto. Lasciò sbattere le braccio contro i fianchi e alzò di scatto la testa verso di me; gli occhi leggermente spalancati e lucidi e le guance pallide con qualche scia bagnaticcia a rigarle. “Sono incinta, Justin” ________________________________________________________________________________________________
“Ehy, rossa! Dammene un altro!” urlai mangiandomi anche qualche lettera, alzando il bicchiere vuoto che avevo in mano per portarlo così all’altezza della sua faccia, appoggiando malamente l’altro braccio sul ripiano liscio e luccicante del bancone. “Sarà il decimo bicchiere solo nell’ultima ora, Justin” mi rimproverò lei, contrariata, soppesando lo sguardo tra me e l’oggetto trasparente tra le mie mani. “Non starai esagerando un po’ stasera?” “Non sei mia madre tu, ammesso che l’abbia mai avuta” ridacchiai senza però essere divertito, agitandole il bicchiere in faccia. “Ne voglio ancora” “Sei un idiota!” mi sibilò adirata contro, afferrando controvoglia l’oggetto e riempiendolo nuovamente con ciò che le avevo richiesto – ad essere onesto con me stesso non ricordavo nemmeno cosa stavo bevendo, lo avevo scordato all’incirca al quinti bicchiere, ma per quanto m’importasse poteva darmi tutto ciò che voleva purché dannatamente alcolico e distruttivo. “Grazie tesoro” ghignai, alzando il bicchiere a mo di saluto verso di lei, prima di ricominciare a sorseggiare quel liquido scuro sotto il suo sguardo indagatore. Faceva così da quando avevo messo piede, non ricordavo quanto tempo fa, dentro quel posto – non avevo capito se per l’espressione da pazzo con la quale ero entrato lì o perché stavo effettivamente bevendo troppo: serviva una birra, preparava un cocktail, mandava via chi aveva bevuto troppo e aiutava l’altro ragazzo biondo che lavorava assieme a lei a pulire senza mai perdermi di vista con lo sguardo. “Sei sicuro di non voler chiamare Jared?” mi domandò di nuovo, lanciando un sorriso svelto al ragazzo a cui aveva stappato una birra, prima di incitare qualcun altro a fare la sua ordinazione. Sollevai stordito lo sguardo sui suoi occhi chiari, scuotendo con foga la testa. “Se ti dico che se solo lo vedo lo pesto a sangue, mi chiederai ancora di poterlo chiamare?” ribattei acido, tracannandomi l’ultimo sorso di quello che mi sembrava Jack Daniel’s e porgendole nuovamente il bicchiere da riempire. “Ancora” “Non ne ho più di Jack Daniel’s, Hayden è appena andato a prenderne qualche altra bottiglia” dichiarò, quasi speranzosa che abbandonassi i miei propositi di bere fino a scordarmi perfino come mi chiamavo, iniziando a sciacquare agilmente il bicchiere sotto al getto dell’acqua. “Dammi una birra” biascicai, stampandole i soldi sotto al naso con un colpo secco della mano – riuscì a sentire qualche ragazzina sobbalzare di fianco a me. “Justin, stai bene?” domandò ancora la rossa, rimanendo con il cavatappi a mezz’ora sopra il collo chiuso della bottiglia, inclinando leggermente la testa verso di me. “Sono incinta, Justin” ripeté fievolmente, stringendosi le braccia magre attorno al busto, lasciandosi ricadere stancamente sui cuscini morbidi del divano. “I .. cosa?” domandai stridulo, azzardando un passo in avanti; sentivo le gambe leggermente molli e la testa iniziare a girarmi vorticosamente. Incinta. Incinta voleva dire che c’era qualcosa nella sua pancia. Incinta voleva dire nove mesi di pancione e cibi strani. Incinta voleva dire un bambino. Incinta voleva dire un’altra persona a passare ciò che avevo passato io in quegli anni. Incinta voleva semplicemente e orribilmente dire … incinta. Sentì quella consapevolezza impossessarsi dolosamente lenta di me, costringendomi ad aggrapparmi all’ultimo briciolo di forza fisica che mi era rimasta per non cadere a terra. Avevo il cuore che mi premeva imbestialito contro la gabbia toracica, quasi volesse uscire e prendere a schiaffi lui al mio posto la faccia magra e scossa della donna che avevo di fronte. Incinta. Era rimasta incinta … “Lo voglio tenere ..” mormorò titubante, senza osare alzare lo sguardo dal pavimento chiaro, sfregandosi le mani sulle braccia. Strabuzzai gli occhi terrorizzato a quella sua improbabile decisione, arretrando di qualche passo verso la porta. Sentì la mia schiena andare a sbattere contro il mobiletto che affiancava la mia via di fuga, pungendomi il fianco. Abbassai frastornato lo sguardo su di esso, prima che qualcos’altro iniziasse a farsi spazio dentro di me quando notai la fotografia incorniciata e sorridente di mio zio al di sopra, circondata da qualche fiore artificiale e qualche candela profumata. “Tu non puoi essere incinta!” tuonai adirato, buttando a terra tutto ciò che occupava quell’ammasso di legno, facendola sobbalzare leggermente sul posto. “Non puoi esserti fatta mettere incinta, cazzo! Tu, non puoi avere un bambino, non ora e, probabilmente, mai!” Avevo il respiro irregolare che mi batteva contro la gola ogni volta che lo buttavo fuori, pronto ad esplodere del tutto. Afferrai un altro quadro appeso al muro e lo scaraventai a terra, schiacciando convulsamente il vetro frantumato contro la foto che ritraeva me da bambino che soffiavo imbranato le candele sulla torta di compleanno di mio zio. “Tu non sai badare a te stessa e vuoi un figlio? Adesso?” le urlai contro, allargando rigidamente le braccia, percorrendo con lo sguardo ogni centimetro della casa alla ricerca di qualcos’altro da rompere. “Come cazzo hai potuto farti fare una cosa del genere?” “Io .. non … non volevo … ma … ma ..” “Ma un cazzo!” inveì ancora, interrompendola lanciando all’aria una bomboniera di chissà quale matrimonio al quale aveva partecipato. “Sei incinta! Dio, sei incinta! Sei una fottuta alcolizzata incinta! Lo sai che finirai con l’ammazzare tuo figlio? E anche te stessa, probabilmente? Tu non puoi avere un figlio ora! Non puoi essere incinta!” “Justin …” “Non … parlare!” ansimai annebbiato, scalciando lontano da me un pezzo di vetro più grande degli altri. Non riuscivo a ragionare, non riuscivo a pensare ad altro che a lei che mi diceva di essere … incinta. Era spossante solo pensarlo o immaginarlo, figuriamoci sentirselo dire così, da un momento all’altro, quasi fosse una bella notizia. Non capivo se si fosse dimenticata gli ultimi undici anni che avevamo trascorso insieme, ma io non li avevo di certo cancellati così dai miei ricordi, e non potevo di certo accettare che avesse tutte le intenzioni di far rivivere le stesse cose ad un altro bambino. Perché ero certo che non sarebbe riuscita a levarsi quel vizio che aveva preso così in fretta; non lo aveva fatto per nessuno – me, sua sorella, suo padre, sua madre, i suoi nipotini, suo marito – e mi era terribilmente difficile pensare che da un momento all’altro ci sarebbe riuscita solo perché era … incinta. Non ne sarebbe stata capace, e non ero nemmeno certo di essere io capace a starle vicino. In un improvvisa vampata di rabbia afferrai la prima cosa che trovai – un vaso vuoto – e lo scaraventai contro il muro della cucina, ignorando i singulti rumorosi della donna dietro di me e anche alcuni pezzetti di vetro che mi si stavano infrangendo contro la pelle delle braccia. Ero semplicemente furioso. “Chi è stato?” ringhiai a bassa voce, stringendo i pugni lungo le gambe, rimanendole girato di spalle. “Dimmi chi è!” urlai quella volta, sbattendo rabbiosamente una mano contro il muro. “Non … lo so” “Justin …” Scossi leggermente la testa, sentendola pulsare violentemente, abbandonando quelle immagini crude e irritanti che mi si presentavano dinanzi ogni volta che sbattevo gli occhi. “Sto bene” bofonchiai, sollevandomi lentamente, facendo stridere le gambe dello sgabello contro il pavimento lucido. “Anzi, facciamo due birre, eh” “No, Justin, non puoi …” si rifiutò la rossa, scuotendo decisa la testa mentre sporgeva lentamente il braccio per levarmi la birra che mi aveva già dato. “Due” ringhiai a bassa voce, sbattendo frustrato un pugno contro il tavolo e facendola leggermente sobbalzare dallo spavento. Afferrai incurante la bottiglia e me la portai alle labbra mentre la ragazza trafficava sotto al bancone, imprecando contro me e la mia testardaggine. Rispuntò qualche istante dopo, con un bottiglia più piccola che fece scivolare verso di me, lanciandomi occhiatacce truci di disappunto. “Grazie” sibilai, sbattendole altri soldi sul bancone, prima di afferrare l’altra bottiglia e iniziare a farmi largo tra la folla, a furia di spintoni e minacce di pestamenti, verso l’uscita d’emergenza che dava sul parcheggio. Probabilmente aveva ragione; stavo esagerando, e di brutto, ma sentivo che se mi fossi fermato dal bere sarei stato capace di camminare per strada picchiando chiunque mi capitasse dinanzi – il che era peggio, per loro. Io mi sarei sentito ugualmente meglio. Sentivo le mani formicolarmi continuamente, mentre qualche gocciolina di birra mi scivolava nei palmi, e la faccia che mi stava andando a fuoco, in netto contrasto con il mio corpo che stava quasi gelando dal freddo. “E levatevi di mezzo, troie!” ruggì acido contro un gruppo di ragazze che mi ostruiva il passaggio, afferrando le due centrali e spostandole bruscamente di lato, interrompendo la loro ridicola catena umana e riuscendo così ad intravedere la porta che cercavo. Ingoiai velocemente un altro sorso di birra, abbandonando sul pavimento la bottiglia ormai vuota, pronto a dedicarmi all’altra non appena messo piede fuori, ma sentì una mano appiccica e piccola stringermi con forza la spalla, trattenendomi. “Come hai chiamato mia sorella, stronzo?” mi ringhiò contro un ragazzo dai capelli scuri, nascondendo dietro la sua stazza la figura piccola e seminuda di una delle ragazze che avevo evitato precedentemente. Inarcai le sopracciglia, prendendo un altro lungo sorso dalla bottiglia di birra, ghignando nella sua direzione. “Beh, da com’è vestita direi che è stato un paragone decisamente azzeccato, non credi?” lo provocai, improvvisamente voglioso di fargli perdere il controllo – ed io ero fottutamente bravo in quello, soprattutto da ubriaco fradicio. Per di più lui sembrava un tipo tutto fumo e niente arrosto, e, nonostante non fosse ciò che mi serviva per sfogarmi, me lo sarei fatto andare bene lo stesso. “Oh, questo non avresti dovuto dirlo” sussurrò, accennando un sorriso ironico e poco deciso, prima di scagliarsi poco saggiamente contro di me con tutto il peso del suo corpo, con l’urlo terrorizzato della sorella ad accompagnarlo. Mi scansai leggermente di lato, facendolo incespicare nei suoi stessi piedi, deridendolo con una risata secca e amara, prima di spostare la bottiglia di birra nella mano sinistra e assestargli il pugno più forte che potessi sullo zigomo, facendolo ruzzolare all’indietro. Riuscì a prendere un altro sorso di birra, sotto lo sguardo truce e inorridito della sorella, prima che il moro tornasse alla carica riuscendo a colpirmi di sfuggita il naso. Mandai giù il liquido che avevo trattenuto nella bocca, prima di colpirlo con un calcio nello stinco e tirargli un altro pugno sulla faccia, facendolo cadere addosso ad un tipo grande il doppio di lui. “Hey, marmocchio, che cazzo ti prende?” tuonò questo, afferrandolo bruscamente per un braccio ed aiutandolo a rialzarsi, lasciandomi così il tempo di fare un cenno di saluto alla sorella e uscire da quella baraonda, per niente soddisfatto o leggero. La testa continuava a girarmi e le mani ancora pronte per colpire altro. “Ciao Dom” accennai al omone della sicurezza fermo in un angolo a fumare, alzando la birra in un cenno di saluto, imboccando il parcheggio pieno di macchine e dove dei fanali accesi vi si aggiravano alla ricerca di un posto libero. “Hey, Bieber, sati bene?” mi domandò dietro l’uomo, preoccupato. “Oh, si, alla grande! Tranquillo” ridacchiai ironicamente, allargando le braccia. Scivolai tra due BMW bianche e identiche, tirando fuori dalla tasca le chiavi della macchina ed iniziando a schiacciare il tasto di sblocco delle portiere per vedere quali luci si illuminavano ed individuare così la mia macchina. Continuando a schiacciare furiosamente iniziai a perlustrare sempre più nervoso l’area, cercando di ricordare dove diavolo avessi parcheggiato – non sarebbe nemmeno dovuto essere così difficile visto che il mio SUV doveva essere probabilmente l’automobile più grande e vistosa lì in mezzo. “Fratello, dall’altro lato” Mi voltai scocciato, pronto ad istigare chiunque mi avesse a modo suo dato una mano, prima di bloccarmi sul posto e incurante dei fasci intermittente di luci che emanavo i fanali aranciati della mia macchina, effettivamente dall’altro lato da dove stavo guardando io. “Justin?” Portai il collo della bottiglia alle labbra in un gesto automatico, osservando la figura piccola ed esile di Carter farsi sempre più vicina a me man mano che mi avvicinavo. Indossava una maglia larga ed in pelle che le arrivava fin quasi al ginocchio, al di sotto di una giacca stile universitario gialla e con inserti scuri su polsini e colletto, con un paio di stivaletti neri ai piedi ed i capelli colorati stretti in una coda alta che le lasciava intravedere perfettamente il collo liscio e roseo. Si mordicchiava nervosamente le labbra mentre sentivo i suoi occhi posarsi titubanti e confusi dalla bottiglia che avevo in mano alla mia faccia, esaminandomi attentamente. Ma non era stata la sua voce a parlarmi, bensì il ragazzo alto e dai capelli che gli arrivavano alle orecchie che l’affiancava sorridente prima, confuso in quel momento, mentre mi guardava. “Jackson?” biascicai a bassa voce, lasciando rotolare via la bottiglia oramai vuota ed inutile. “Quand’è che sei arrivato?” “Justin … che hai?” Quella volta ero certo che a parlarmi fosse la piccola Harvey che, in un gesto fulmineo e rapido, mi si era avvicinata circondandomi il polso con una mano piccola e calda. Abbassai lo sguardo su di lei, scontrandomi con i suoi occhioni scuri ed indagatori, che mi stavano implicitamente imponendo di risponderle se non volevo farla incazzare. Quella sera, però, non avrebbe funzionato nemmeno lei. “Per quanto tu sia dannatamente bella anche questa sera, non è un buon momento questo, bambolina” Lei inarcò le sopracciglia, avvicinando la mano alla mia faccia. Mi toccò leggermente il labbro superiore prima di portarsi le dita agli occhi e tornare a guardarmi, preoccupata. “Questo è sangue, diamine. Dove vuoi andare conciato così, Justin?” “A fare un giro” le confessai, chinando leggermente la faccia per essere al suo livello e riuscire a schioccarle un confuso e veloce bacio sulla guancia, prima di schiacciare di nuovo i tasti sul telecomando delle chiavi ed individuare di nuovo la mia macchina. “Non puoi guidare così” protestò la ragazza dietro di me, tentando di trattenermi per la maglietta. Mi si avvicinò ulteriormente, camminando al mio stesso passo. “Facciamo una cosa: torna dentro con me e Jackson e aspettate che finisco il turno con Leanne, poi ti porto io a casa, eh?” Scossi la testa, accennando un sorriso divertito dai suoi vani e falsi tentativi di farmi restare con lei per il resto della serata per impedirmi di fare qualche altra cazzata. La scostai rudemente dalla mia traiettoria e mi rifugiai in macchina, chiudendo le sicure ed ignorando che lei, testarda, si era fermata di fianco al mio sportello ad ordinarmi di scendere dalla macchina. Afferrai una sigaretta dal pacco sul sedile del passeggero e la accesi, mettendo in moto la macchina ed infischiandomene di Carter che ancora si ostinava a rimanere lì e battere contro il vetro, infuriata. Infuriata? Proprio lei? “Torna a vivere qui” “Sono incinta Justin” “Voglio tenerlo” “Non lo so di chi è” “Al diavolo” sibilai, alzando bruscamente il freno a mano ed facendo retromarcia il più velocemente possibile, imboccando l’uscita del parcheggio con il piede che non mollava l’acceleratore ed il pensiero di mia zia che, invece, sembrava non voler mollare me. Writer's corner: Okay, rieccomi a rompervi le scatole con il quindicesimo capitolo. lol Beh, insomma, non saprei come spiegarvelo(?) Insomma, era da un pò che non si parlava più di Justin e della sua di vita, così ho pensato che sarebbe stato carino mettere un capitolo dal suo POV e farvi capire un altro pò di lui e di com'è realmente. In realtà non so se l'effetto ottenuto e questo o mi sia lasciata trasportare ed abbia esagerato con il fatto della zia e della sua reazione. Però ci sono anche delle cose che riguardano Dante e ciò che ha fatto, e che dovrebbero farvi capire qualcosina in più di tutta la faccenda, ma ovviamente anche qui non so se l'idea è riuscita. Insomma, come sempre non so se sia una merda o perlomeno decente(?) c': Vabbé, tralasciamo. Vi auguro Buon Natale - in ritardo - e Buone Feste :3 E ora evaporo, sperando che vi piaccia almeno un pochino lol. Alla prossima, Baci ☺♥ |
Capitolo 17
*** 16. We try to escape but this life is like a fuckin' tapis roluant! ***
|
“Andiamo, non puoi continuare a tenermi il muso lungo” bofonchiò irritato Jackson, picchiettando le dita sull’orlo del bicchiere di vodka.
Lasciai cadere una fetta di limone nel bicchiere bordato di sale, facendolo scivolare sul bancone verso Leanne, “Il Margarita, Lay, per il tipo in fondo” urlai appena, indicandole il ragazzo con il cappellino da baseball in testa dall’altro lato del bancone, tornando poi a prestare attenzione al ragazzo di fronte a me. “Primo, non ti sto tenendo il muso, sto cercando di lavorare, Jacko. E secondo, potevi anche evitare di superare i cento orari. Non avremmo certo rischiato di morire per una stupida pigna e un inseguimento alla CSI con la polizia, così!” “Non è colpa mia se quella stupida pigna mi è sembrata un cazzo riccio e non volevo ammazzarlo, okay?” si difese il biondo, ingoiando stizzito l’ultimo sorso della sua bevanda. “Ecco perché mi sono sempre piaciute di più le autostrade tedesche” “E che cazzo c’entrano le strade tedesche adesso?” domandai confusa, rimanendo con il cavatappi a mezz’aria al di sopra del collo di una bottiglia di birra. “Le autostrade tedesche non hanno limiti di velocità” ridacchiò lui, allungando il braccio per darmi un buffetto sulla mano. “Tu dovresti saperlo meglio di me visto che sei mezza tedesca” “Oh, ma chissenefrega di quanto di tedesco c’è nel mio sangue, adesso!” sbuffai, riempiendogli di nuovo il bicchiere. “Io voglio sapere che diavolo c’entri tu con Justin!” Lui aggrottò scocciato le sopracciglia, strappandomi di mano il suo drink. Si issò agilmente su uno sgabello libero, lasciandosi sfuggire qualche piccolo grugnito di disapprovazione appena accennato – come c’era da aspettarsi, d’altronde – fingendo di non avermi sentita. Jackson – secolare amico di Dante e poco approvato da Elia per motivi a me ovviamente sconosciuti – era sempre stato un ragazzo dinoccolato, con la pelle pallida, gli occhi piccoli, verdognoli, ed i capelli che gli si arricciavano disordinatamente vicino alle orecchie. Ricordavo anche, vagamente, d’aver avuto una specie d’infatuazione abbastanza breve per lui a quattordici anni – il classico cliché della sorellina a cui piace l’amico del fratello più grande - ma quella era una cosa che non avrei osato rivelare mai a nessuno, i miei fratelli ed il tirato in causa in primis. Era partito per un semestre di studio – che poi si era prolungato - a Toronto poco prima che Dante iniziasse con le sue stronzate, e da quando era tornato si era fermato a casa nostra – sotto ovvio disappunto da parte di mio fratello - mentre cercava un appartamento da affittare. Non avevo mai capito, e probabilmente non avevo nemmeno cercato di farlo, perché quei due sembrassero sopportarsi decisamente poco, ma dopo il recente incontro con Justin nel parcheggio del Sanyo, non avevo fatto altro che tentare di capire come mai si conoscessero – perché ero certa fosse così. Jackson dal canto suo si era ben assicurato di non lasciarsi scappare niente, liquidandomi con domande o risposte evasive che si concentravano su argomenti come i miei capelli o Keaton che girava in boxer - per la maggior parte del tempo - in casa mia. E come volevasi dimostrare, anche quella sera aveva spostato per tutto il tempo l’attenzione sull’evitato incidente che stavamo per avere in sella alla sua moto, una Derbi Mulhacen 659 fiammeggiante che io adoravo, tra l’altro. Gli lanciai un’occhiata accusatoria, incrociando le braccia al petto, prima che un ragazzo tarchiato con le labbra gonfie e la testa rasata mi si parasse dinanzi, fissandomi insistentemente. “Sei tu Carter?” mi domandò ad alta voce, sporgendosi leggermente sul bancone perchè lo sentissi per bene – quella sera Trey sembrava volersi davvero sbizzarrire alla console. Annuì mesta al ragazzone, osservando con la coda dell’occhio il corpo di Jackson tendersi leggermente, in allerta. “C’è il tuo amico sul retro. Ha detto che ti aspetta lì” “Che amico?” domandò velocemente l’altro, fermandolo per una spalla. Il tipo si scrollò indifferente la sua mano di dosso, mischiandosi nella folla un istante dopo, senza dare alcuna risposta. “Sarà sicuramente Keaton. Si ferma sempre lì prima di entrare, per fumare” spiegai a Jackson, mostrandogli un sorriso appena accennato per cercare di tranquillizzare quella sua aria sospettosa e pronta a rincorrerlo per chiedergli altre informazioni. Mi sfilai velocemente l’asciugamano dalla tasca dei jeans, buttandolo sul ripiano, alzando la mano a Leanne per avvisarla che sarei uscita. Lei annuì semplicemente, continuando a shakerare il mixer pieno, chiacchierando con Jared – che era ormai diventato una piacevole costante nelle nostre serate. “Non avrai seriamente intenzione di andarci, vero?” mi rimproverò serio Jackson, bloccandomi la strada. “Sarà qualche cretino in vena di scherzi” Roteai gli occhi, cercando di trattenermi dal dirgli di smetterla di comportarsi da mamma orsa con i suoi cuccioli – e come sicuramente avrebbero fatto lo stesso Keaton ed Elia. “Tranquillo, papino, non c’è nessun pericolo. E non seguirmi, per l’amor del cielo” ridacchiai, sollevandomi sulle punte delle scarpe per potergli lasciare un veloce bacio sulla guancia, prima di imboccare velocemente – così che non potesse prendermi – la strada per la porta che dava sul retro. Porta che, dopo vari spintoni e imprecazioni contro la folla, riuscì a raggiungere e attraversare in breve tempo. La lasciai richiudersi con il vento alle mie spalle, accendendo sollevata una sigaretta. Mi strinsi nella magliettina corta che indossavo, assieme ai jeans a vita alta che mi coprivano per bene la pancia, cercando con lo sguardo la figura di Keaton vicino al muro in mattoni o accovacciato tra qualche cassettone stracolmo di bottiglie. Lo faceva spesso quando il locale sembrava essere più affollato del solito – il che stava a significare molti più attaccabrighe ubriachi vicino al bancone ad infastidire me e Leanne e più possibilità che lui perdesse la pazienza. Poteva quasi definirsi un modo per prepararsi psicologicamente a ciò che lo aspettava per riuscire così a tenere sotto controllo la sua rabbia, che nell’ultimo periodo sembrava davvero far fatica a contenere per motivi ignoti. In realtà, il loro – Justin, i miei fratelli, Jackson e Keaton - considerarmi una bambina minuscola e fragile – che li portava automaticamente a nascondermi un sacco di cose, troppe - stava iniziando ad infastidirmi particolarmente, soprattutto quando queste riguardavano la mia, di vita. Non sapevo cosa avessero paura di rivelarmi, ma, ad essere onesti, i miei ultimi diciassette anni di vita, – sin dalla mia concezione – erano stati abbastanza ‘movimentati’ da indurmi a credere d’avere almeno un minimo di forza per poter reggere qualche altra ‘brutta situazione’ – o così speravo. Non appena avvistai una figura leggermente ricurva su se stessa avvolta nell’ombra, tra i due cassettoni, iniziai ad avvicinarmici con passo svelto. “Hai dimenticato di nuovo le sigarette da Brazil?” ridacchiai, toccandogli la spalla per farlo voltare. “Oh, no.” Sentì una risata a mezza voce appena accennata fargli vibrare i muscoli delle spalle sotto le mie dita, mentre iniziava a girare molto lentamente su se stesso nell’ombra. A pensarci, i rigonfiamenti delle sue braccia sembravano leggermente più accennati di quanto ricordassi e la sua voce risultava più roca e cupa del solito – sapevo per certo che non avesse febbre o raffreddore in quel periodo. Arretrai istintivamente di un passo nello scorgere la forma ombreggiata di un cappellino da baseball sulla testa del ragazzo – e Keaton detestava profondamente quei cappellini – mentre pian piano il suo volto mi si mostrava a pieno, come un brutto scherzo del destino. I capelli biondi erano appiattiti contro la fronte, leggermente arricciati, la mascella squadrata - in tensione - con un leggero accenno di barba a ricoprire il mento, la pelle appena dorata e gli occhi blu, lucidi e fortemente segnati da aloni rossicci, fissi con insistenza su di me; l’aspetto trasandato di un possibile figlio di Johnny Depp tra una decina d’anni. La sigaretta mi scivolò dalle labbra, andando a depositarsi – ancora accesa – sulla punta delle mie Creepers nere. Il flusso dei miei precedenti pensieri s’impennò istantaneamente, concentrandosi sull’incubo che avevo dinanzi. “K … Kyle?” balbettai fievolmente, arretrando istintivamente di una passo, senza quasi accorgermene. Il cuore aveva iniziato a schizzarmi frenetico nel petto; lo sentivo incespicare su se stesso in battiti forzati e brutali che mi bloccavano l’aria in gola, facendomi girare la testa. Le gambe sembravano essermi diventate della consistenza della cera fusa e le mie mani erano talmente umide e bagnate che dovevo sfregarle più e più volte sul tessuto ruvido dei jeans per asciugarle, prima che ricominciassero a sudare. Il mio incubo si raddrizzò, assumendo una posa più rigida e forzata, mentre iniziava a far indugiare lo sguardo sul mio corpo; sui jeans blu, i bottoni che mi salivano sui fianchi, la maglietta nera che lasciava libera una striscia minuscola di pelle dal quale s’intravedeva il mio primo tatuaggio, la mia clavicola - tatuata anch’essa da poco -, il collo scoperto e i capelli viola racchiusi in una treccia disordinata poggiata sulla spalla destra. “Sapevo che saresti venuta. E’ sempre stato così facile raggirare la tua piccola testolina colorata” ammiccò piano lui, accennando un piccolo sorrisino divertito mentre dondolava una bottiglia di vetro semivuota sulla coscia - ciò stava a significare una sola cosa: era inequivocabilmente ubriaco, se non anche fatto di qualcosa. E non era certo un buon segno per me. Piantai bruscamente i denti sul mio labbro inferiore per non farlo tremolare, impedendo al mio cervello di assorbire a pieno il tono roco e basso della sua voce, prima che questo potesse riportarlo a ciò che era successo un anno prima nello stesso posto in cui eravamo - ricordare era l’ultima cosa che mi serviva in quell’istante. Strizzai gli occhi, iniziando a strisciare i piedi all’indietro, sperando stupidamente che non si accorgesse della distanza. “Che … ci fai qui?” gli domandai piano, tentando di tornare a respirare regolarmente, ispirando ed espirando lentamente come ero solita fare per tranquillizzarmi. Quella volta, però, non ero certa sarebbe servito a qualcosa; sembrava quasi che ad ogni boccata d’aria che cercassi di prendere il gomitolo d’ansia e preoccupazione che avevo sul petto si appesantisse sempre più. E mi maledì mentalmente per aver indugiato, nonostante la voce mi fosse uscita più ferma e sicura di quanto non fossi io realmente; non era una cosa che potevo permettermi, soprattutto non in quella situazione e non con uno come Kyle. Lo ricordavo perfettamente l’anno prima, e quegli interminabili minuti che ci avevo trascorso in sua ‘compagnia’ mi erano bastati per capire, più o meno, com’era fatto, perlomeno da ubriaco; era molto suscettibile e non sopportava particolarmente chi lo trattava con un po’ più ‘rudezza’ del solito - e ciò stava a significare che io ero fregata se non trovavo alla svelta qualche soluzione, perché somigliare più ad uno scaricatore di porto di cento chili piuttosto che a una ragazza era nel mio DNA da quando in quarta elementare la mia professoressa di storia si era lamentata della mia poca loquacità, indipendentemente dalla persona con cui avevo a che fare. “Sono qui per te” spiegò il biondo, allungando improvvisamente una mano sulla mia spalla e trascinandomi poco delicatamente con le spalle al muro, impedendomi così la fuga. Sentivo il suo tocco bruciarmi sulla pelle, nonostante lo strato di stoffa che separava la sua mano dalla mia epidermide; e – inorridita da quel contatto - non riuscì ad impedire a me stessa di scrollarmelo di dosso, poco gentilmente anche. “Non puoi venire qui” gli intimai, dura, tenendo costantemente sotto controllo la porta con la coda dell’occhio. “Keaton ti fa fuori se ti vede, lo sai” “Non fare la stronza, Harvey” mi ammonì lui, stringendo la bocca in una linea dura; riuscì ad afferrare un piccolo guizzo fulmineo sulla sua mascella, prima che si portasse alla bocca ciò che rimaneva della sua birra. “Lo sai com’è finita l’altra volta … sai, non avrei problemi a finire quello che avevamo interrotto …” mi canzonò ancora, asciugandosi la bocca con il dorso della mano, mentre la bottiglia vuota scivolava sotto un cassonetto. “E’ una minaccia, questa?” sbottai rigida, appiattendomi contro il muro di mattoni, freddo e sudicio, dietro di me. Sintonizzai la colonna vertebrale lungo il suo profilo,perlustrando furtivamente la zona alla ricerca di qualcosa a portata di mano da poter usare in caso la situazione degenerasse. Non tanto a causa sua, ma mia; mi conoscevo abbastanza da sapere che, nonostante la situazione, non sarei riuscita a starmene buona fin quando Jackson o Keaton non avrebbero iniziato a cercarmi. E non, certamente, se Kyle iniziava ad usare quel tono da teppistello fatto e vissuto su di me, come se fossi una ragazzina che viene sgridata dai genitori per aver fatto qualcosa di sbagliato. “Oh, non esattamente” replicò beffardo, riempiendo in men che non si dica quei pochi centimetri che ci separavano del tutto. “Ero venuto per … be’, in realtà non lo ricordo esattamente dopo aver incontrato un mio amico … ma stai bene così, sai?” ghignò, apparentemente soddisfatto da chissà quale pensiero gli aveva attraversato la testa. Allungò convinto una mano verso la mia nuca, infilando le dita tra i capelli intrecciati, sciogliendoli man mano che si abbassava verso le punte e facendo cadere a terra la molletta arancione che li teneva legati. “Non … toccarmi, Kyle” ringhiai disgustata, scostandogli stupidamente la mano con uno schiaffo. Mi morsi subito il labbro, battendomi mentalmente una mano sulla fronte; parlargli come ero solita fare, o reagire semplicemente, non mi avrebbe aiutato a tenerlo calmo, lo sapevo - anche per quello l’anno scorso era finita molto male - soprattutto se non era esattamente nel pieno delle sue facoltà mentali e fisiche. Ma il mio cuore nelle orecchie a coprire quasi del tutto la sua voce e le mani che continuavano a sudare insistentemente non facevano altro che mandarmi in confusione ed irritarmi. E il suo odore d’erba e alcolici vari che mi s’infilava prepotente nel naso non migliorava di certo la situazione nel suo complesso – non se poi mi sembrava di vedere un paio di occhi scuri e vomitevoli alle sue spalle, come se fosse fiancheggiato da una seconda persona: da lui. Come se Rick fosse tornato a tormentarmi, non solo più nei miei incubi. Detestavo sentirmi in quel modo, soprattutto a causa di Kyle, per la seconda volta nel giro di due anni – e la milionesima negli ultimi sette fino all’incendio. “Sai, non mi è piaciuto molto ciò che mi ha fatto il tuo amichetto l’ultima volta” sibilò il biondo, digrignando i denti dietro alle labbra, avvicinando la sua fronte – imperlata di sudore - alla mia. Puntò impertinente i suoi occhi chiari su di me, stringendomi il mento con una mano per tenermi ferma. “Ho delle cicatrici, ancora. E non sono belle da vedere” ringhiò a bassa voce, soffiandomi sulla bocca. “Ne da toccare …” Allora la sua mano destra scivolò furtivamente verso la mia, lungo il fianco, afferrandomela bruscamente; strinse le dita sottili e lunghe attorno al polso - conficcandomi i braccialetti appuntiti nella carne - schiacciandomi il palmo della mano sulla sua mandibola. Percepì perfettamente qualcosa di scavato, ruvido e leggermente molle al tatto e in uno scatto di rabbia, mischiata alla paura che mi faceva ancora tremolare il cuore, lo spintonai violentemente all’indietro, lasciandomi sfuggire un urlo spaventato dalle labbra. Ero altamente consapevole di ogni centimetro di me stessa e di quanto stupida fossi stata, ma mi ero sentita troppo esposta, vulnerabile e impaurita - quasi debole - davanti ai suoi occhi per riuscire a non farmi sopraffare dal mio istinto terrorizzato. Osservai affannata il suo corpo arretrare di qualche passo prima che inciampasse nei suoi stessi piedi e cadesse all’indietro, attutendo la caduta con i palmi delle mani sul terreno sporco e bagnato – e solo in quel momento, mentre non riuscivo a staccarmi da quel muro, osservandolo a terra, intravidi i cocci di vetro sui quali era atterrato che si tingevano di rosso. Mandai giù il groppo pesante e fastidioso che avevo in gola, ritrovandomi a tossicchiare leggermente, mentre mi staccavo con foga dal muro, pronta ad andarmene. Ma Kyle era un ragazzo, in primis, ed era anche decisamente alto ed agile mentre io avevo la grazia di un elefante nella cabina armadio di Paris Hilton – e lo avevo dimenticato, per quell’attimo in cui mi ero lasciata sopraffare dalla paura. Così non riuscì a trattenermi dall’urlare quando una sua mano insanguinata mi si piantò, viscida, sulla guancia, strattonandomi all’indietro. “Ti avevo detto di non … farmi … incazzare!” mi urlò contro, allungando un’altra mano insanguinata verso di me; aveva gli occhi infuocati, la faccia livida e il suo corpo era scosso, interamente, da piccoli e violenti spasmi di rabbia. “Lasciami stare!” urlai anche io, allontanandomi bruscamente dalla sua presa. Mossi qualche passo all’indietro, tremante, e poi per qualche secondo l’aria prese il posto della terra che avevo sotto i piedi, sferzandomi contro le orecchie. Lanciai un gridolino soffocato, - quasi sicura che senza farsi vedere Kyle mi avesse in qualche modo afferrata - prima che la mia schiena atterrasse grottescamente a terra; il tonfo mi mozzò il respiro nel petto per un istante che mi sembrò infinito prima che l’aria ricominciasse – seppur arrancando – a circolarmi nella gola. Strabuzzai dolorosamente gli occhi, mentre delle fitte acute e brucianti iniziavano ad attraversarmi il fianco; qualcosa di caldo e denso mi stava appiccicando la maglietta alla pelle, aumentando a dismisura la sensazione di bruciore. Come se fossi atterrata su un letto di carboni ardenti e puntaspilli affilati. Mi lasciai sfuggire qualche mugolio contrariato, cercando di rigirarmi su un fianco per alleggerire il dolore – o perlomeno spostarlo da qualche altra parte che non fosse la mia schiena. Senza fiato sollevai lentamente le palpebre, mentre cercavo di far forza sul braccio destro; riuscì solo ad intravedere il colore pallido della mia pelle che veniva sommerso dal sangue scarlatto che mi stava scivolando tra le dita, prima che le ossa mi cedessero facendomi atterrare di nuovo a terra. “Cazzo, sei ancora così intrattabile!” mi apostrofò arrabbiato Kyle, stringendo una mano attorno al mio braccio un attimo dopo, risollevandomi con vari strattoni che servivano solo ad aumentare la mia poca sopportazione del dolore. Mi piantò di nuovo contro il muro, battendo le mani ai lati della mia faccia e lasciando cadere la fronte sulla mia testa. “Oh mio Dio, lasciami Kyle ..” mormorai appena, sentendo le orecchie iniziare a ronzare fastidiosamente. Percepivo il sangue – era sangue, riuscivo a vedere i pezzi di vetro sui quali ero atterrata anch’io macchiati – che mi impregnava la stoffa doppia dei pantaloni, scivolandomi viscido sulla pelle mentre il braccio si intorpidiva pian piano. “Lasciami, e vattene via, cazzo!” “Te lo avevo detto che non volevo finisse come l’altra volta, cavolo!” mi disse contro la bocca, soffiandomi il suo alito caldo e nauseante nel naso, facendomi girare la testa in una familiare sensazione di confusione. “Sei ubriaco di nuovo, Rick, vattene! Va’ via … mio Dio … ‘ai via” biascicai mangiandomi le parole – isterica e poco lucida - appoggiando le mani contro il muro, come se potesse sorreggermi ulteriormente mentre le gambe iniziavano a dare segni di cedimento. Un istante dopo, sbalordita, aprì gli occhi, rendendomi conto improvvisamente di ciò che avevo inconsciamente detto. “Rick? Mi spiace tesoro, io non sono Rick. Ma credo che tra un po’ imparerai a ricordarti perfettamente anche il mio nome!” ammiccò lascivo, prima di schiacciare arrabbiato la sua bocca contro la mia, tenendomi per le spalle e imbrattandomi la maglietta di altro sangue. Mugolai contrariata a quel contatto inaspettato, irrigidendo velocemente i muscoli del corpo e tentando di arrotolare il più possibile le labbra all’interno della bocca per sfuggirgli. Mi aggrappai con tutte le forze alle mattonelle, conficcandovi le unghie negli spazi vuoti, per impedire a me stessa e all’agitazione di schiacciarmi ulteriormente contro il muro. Ero piombata nel panico più totale, e la sensazione che dietro Kyle ci fossero un paio d’occhi scuri, rabbiosi e terrorizzanti non sembrava volermi abbandonare, costringendo il mio cuore a correre ancora più velocemente di quanto non fosse già costretto a fare. Sembrava quasi m’avessero attaccato al petto tanti piccoli piranha che mi scavavano a fondo nella carne, trafiggendomi da una parte all’altra come spade, mentre le mani erano talmente tanto sudate e appiccicose da sembrarmi immerse nella gelatina. Sapevo perfettamente cosa ciò avrebbe comportato, se non fossi riuscita ad imporre a me stessa di tranquillizzarmi all’istante. Non avevo più avuto un attacco di panico dalla prima superiore, ma quei quattro in tre mesi che avevo avuto mi erano sicuramente bastati a farmi capire di non voler ripetere l’esperienza per nulla al mondo. Ma – in modo dolorosamente lento, quasi fosse il tutorial su YouTube di un disegno -, come se non bastasse ancora, quegli occhi iniziarono ad essere circondati da altro; sopracciglia folte, pelle abbronzata, ruvida e un po’ rugosa sulla fronte, occhiali rotondi, dalla montatura sottile, capelli scuri e pieni di gel, mascella tonda, barba ispida e … Istintivamente, con una nuova paura che mi comprimeva lo stomaco, alzai un ginocchio contro l’inguine di Kyle con quanta più forza riuscissi a trovare dentro di me - e che fosse sopravvissuta a quella sensazione di debolezza che si stava impossessando di me. Mi lasciai sfuggire un altro urlo, rauco, mentre il ragazzo si accasciava dolorante a terra. All’improvviso mi sembrava di avere di nuovo dodici anni, rannicchiata sul pavimento contro Elia e Dante, durante l’ennesimo raptus di Rick contro mia madre o me. Inerme. Spaventata. Confusa. E se io avevo capito abbastanza Rick, e se Kyle gli somigliava almeno un po’ – quel poco che bastava – la ‘cosa’ non sarebbe finita lì; non con un calcio, non con me che me la cavavo così, non con lui che non otteneva ciò che desiderava – o che droga e alcool non gli facessero desiderare. Lasciai scivolare circospetta lo sguardo a terra, notando il corpo inerme del biondo che ancora si contorceva dal dolore – triplicato dal suo ‘stato’. Con un balzo mi allontanai il più possibile da lui e dalla prigionia di cassettoni e spazzatura a cui mi aveva costretta; nel silenzio mi sembrava quasi di sentire le goccioline di sangue che cadevano a terra, e che mi facevano salire la sensazione di nausea, prossima a sfociare nel vomito. Ricacciai tutto indietro, sputando a terra per liberarmi almeno un po’ la bocca. Dovevo analizzare la situazione. Il cellulare lo avevo lasciato in carica sotto al bancone, dove anche se avessi potuto chiamare in qualche modo nessuno lo avrebbe notato; ad occhio dovevano essere passati solo cinque minuti da quando ero uscita, e Jackson non sarebbe venuto a cercarmi prima di una decina di minuti abbondanti, Keaton non doveva essere arrivato ancora, e se non volevo far piombare il locale nel panico generale non potevo permettermi di entrare dentro, insanguinata e mezza in piedi. L’unica entrata alternativa era quella principale, che però doveva essere ancora più affollata del locale stesso, Kyle iniziava a dare segni di ripresa e la rete d’acciai in fondo alla strada sembr … la rete, certo! Sembrando aver elaborato prima di me la cosa, sentì le mie gambe lanciarsi a capofitto verso il fondo del piccolo spazio ancora di proprietà di Tyreek; la rete metallica delimitava una stradina secondaria e piena d’erba che portava non so dove. “Dove … pensi di andare, cretina?” La voce di Kyle mi arrivò alle orecchie più cattiva e netta di quanto sperassi, e il mio corpo – la mente accecata da paura improvvisa – riuscì a fare una sola e stancante cosa: correre. Il braccio destro mi doleva terribilmente, e ogni volta che mi sbatteva sul fianco mi sembrava quasi sul punto di voler cadere a terra, come se qualcuno l’avesse tolto da un manichino. Strinsi i denti contro la bocca, incespicando più volte nei miei stessi piedi, prima di arrivare di fronte vari cassettoni e sedie rotte che si dovevano buttare. Piegando velocemente i piedi riuscì a salire su una di esse, quella che a vista mi sembrava la più resistente; mi aggrappai con entrambe le braccia – tutti i muscoli protestarono per lo sforzo – al bordo del cassonetto, alzando un ginocchio per riuscire a spingerci il mio corpo sopra. Mi sollevai con le ginocchia tremolanti e jeans strappati in più punti, avvicinandomi alle punte taglienti del metallo che spuntavano nel buio come paletti di legno. Infilai le dita in più buchi rettangolari e con quanta più forza riuscì ad accumulare spinsi il mio corpo dall’altro lato, cercando di affondare la punta delle scarpe nei fili per sorreggermi meglio. Ricordavo vagamente un documentario su uno scalatore di montagna che Keaton aveva voluto vedere un giorno; cercando di imitare i suoi movimenti iniziai a scendere, stringendo gli occhi per non guardare di fronte a me. Qualcosa stava strisciando a terra pesantemente, e se non volevo che altro panico inutile mi attaccasse, per il mio bene non dovevo guardare. Fuga. Non c’era nient’altro che riuscisse a tenere occupata la mia testa; dolore, paura, lacrime, terrore, voglia di gridare … tutto improvvisamente sparito. Volevo, desideravo ardentemente, solo riuscire a levarmi dalla vista la disgustosa immagine di Rick che prendeva posto nei tratti contratti di Kyle. Perchè in quel momento, più che in altre volte, mi sembrava davvero che per quanto desiderassi o provassi a scacciarlo via, il mio passato sembrava seguirmi. E la vita tornava ad apparirmi come un fottuto tapis roulant rotto che voleva prendersi gioco di me. Atterrai nell’erba alta, piegando malamente la caviglia destra, nello stesso istante in cui Kyle era riuscito a mettersi in piedi e sembrava avere tutta l’intenzione di seguirmi, se la porta blindata che si spalancava brutalmente non lo avesse costretto a fermarsi. Le mura di mattoni si colorarono di blu, mentre all’esterno si riversavano le ombre di quattro o cinque figure avvolte nel buio che chiamavano a gran voce il mio nome. Sapevo che erano Jackson e Keaton, lo sapevo per davvero, ma l’unica cosa che riuscì a vedere erano gli occhi chiari di Kyle che mi fissavano impassibili, prima che le mie gambe decidessero da sole di ricominciare a correre. Writer’s corner: Okay, un altro bel po’ di ritardo eh? Come sempre, però, eccomi ancora qui con un altro dei miei ‘capitoli’ lol Ma a chi interessa, no? :’) Okay, tralasciando, non ho molto tempo perché devo tornare a completare un lavoro per domani, quindi lasciando a voi le ‘considerazioni’ di tutto quello che è successo mi dileguo subito, sperando che vi piaccia almeno un po’ c: Mi scuso in anticipo per alcuni probabili errori grammaticali, ma nonostante abbia riletto probabilmente - nella fretta - mi sarà scappato qualcosa, che provvederò ad aggiustare non appena possibile. Alla prossima, Baci ☺♥ |
Capitolo 18
*** 17. Breathe. It's just an another bad day. ***
 17. Carter “Sei sicuro? Ormai sono più di dieci ore … forse dovremmo …”
“Devi darle tempo, Kayden. Con tutta la morfina che le ho dato ci vorrà del tempo per smaltirla completamente. Comunque, non molto ancora” “Be’, lo spero. Sto iniziando a p … papà! Si sta muovendo, per Dio!” Avevo la strana e rivoltante sensazione che la pelle degli occhi si strappasse – come se qualcuno mi avesse cucito le estremità l’un l’altra – man mano che li aprivo. Strizzai gli occhi un’altra volta, adocchiando sopra di me il soffitto immacolato che grazie alla luce di diverse lampade al neon assumeva una tonalità ancora più biancastra, da clinica chirurgica privata. Non ricordavo d’aver visto le pareti del Sanyo così bianche nemmeno dopo l’ultima sessione di riverniciatura l’estate scorsa, dopo la quale avevano assunto quella tipica colorazione nera e fluorescente. Percepì delle dita ruvide e calde poggiarsi sulla mia guancia per trattenermi la testa sul cuscino, mentre un lampo di luce ancora troppo bianca – inondandomi la vista – seguiva lo schizzare a destra e a sinistra delle mie pupille, accecandomi; intravidi il vago accenno d’un paio di occhi azzurri che mi fissavano amorevolmente prima che i tratti tesi e pallidi di Kyle gli si sostituissero, facendomi sobbalzare appena. Un’improvvisa consapevolezza di ciò che era successo mi piombò brutalmente addosso, colpendomi ogni singolo muscolo indolenzito del corpo. Scattai dolorosamente a sedere, scoprendo di avere la gola troppo asciutta e debole anche solo per urlare; il corpo mi doleva completamente - spalle, braccio destro, fianco e polpacci più del resto. Il tessuto liscio e morbido di un lenzuolo, altrettanto immacolato, mi copriva le gambe, assieme ad una coperta marrone più pesante; alle finestre erano appese delle tende monocolore che schermavano la luce - che però non impedivano al rumore degli pneumatici sull’asfalto di arrivarmi chiari e striduli alle orecchie. “Finalmente ti sei svegliata, dormigliona” mi apostrofò una voce secca e profonda, nell’attimo in cui l’orlo di un bicchiere trasparente e pieno d’acqua occupò completamente la mia vista. Percorsi titubante le dita lunghe, squadrate e pallide strette attorno al vetro; lungo il braccio coperto da un maglione blu navy, sul collo scoperto e al cappello nero attorno alla fronte che tratteneva a stento dei ciuffi lunghi e biondi. Gli occhi acquamarina del ragazzo mi sorrisero, coinvolgendo anche le labbra chiare e doppie a fare lo stesso, - in un insieme che nel complesso potevo quasi giudicare come rassicurante – mentre la sua mano si faceva un po’ più avanti verso la mia faccia. A me, però, le persone apparentemente ‘rassicuranti’ – soprattutto bellissimi ragazzi dai capelli biondi – non ‘rassicuravano’ poi così tanto; che fosse per un mio essere prevenuta o esperienze personali terminate in tragedie, poco m’importava. L’ultima immagine che rammentavo con certezza era la mia vista che si oscurava sempre con maggiore intensità, più mi addentravo dentro quel pezzo di terra privato che affiancava il Sanyo, mentre scappavo da tutto e tutti. Non c’erano nessuna parete immacolata, nessun lenzuolo pulito e nessun ragazzo con l’orecchino sottile al naso; pertanto non avrei bevuto quell’acqua, malgrado sentissi ogni parte del mio corpo reclamarla avidamente. “Erano le due e mezza, circa, quando ti ho trovata. Ero uscito per portare a passeggiare il mio cagnolino rompi balle, - questo pezzo di terra appartiene a mio padre – e potremmo quasi dire che è stato lui a trovarti, svenuta e sanguinante tra l’erba. Non potevo lasciarti lì, così ti ho portata via” mi spiegò gentilmente, cogliendo probabilmente la mia riluttanza nell’accettare qualunque tipo di contatto con lui. Mi infilò cautamente il bicchiere tra le mani, accertandosi che riuscissi a reggerlo prima di staccarsi e posizionarsi al centro della stanza con le braccia lunghe aperte all’aria. “Questa è casa mia” mi sorrise, con un non so che di malinconico e forzato negli occhi; un lampo divertito glieli attraversò, facendogli inarcare le sopracciglia scuotendo la testa. “Be’, tecnicamente questo è lo studio medico di mio padre, - che ti ha curata - ma il resto è anche casa mia.” Solo in quel momento, quando dubbiosa lasciai vagare lo sguardo per la stanza, mi accorsi della presenza di una terza persona vicino al mio letto; un uomo dalla pelle pallida, con capelli biondi perfettamente pettinati, occhi chiari e un maglione scozzese verde dal quale spuntava il colletto ben piegato di una camicia celeste. Stringeva al fianco un paio di fogli bianchi, mentre mi sorrideva cordiale. “Dottor Charlie Walker. Questo giovanotto è mio figlio Kayden” presentò l’uomo, sistemando degli occhiali quadrati sul naso lungo. “E’ stato difficile scoprire la tua identità, signorina Harvey” Il cuore ricominciò a galopparmi nel petto, agitato, mentre mi affrettavo ad ingurgitare il più velocemente possibile tutta l’acqua di cui sentivo il bisogno. Quello era un altro segno del passaggio di Rick nella mia vita: avevo visto ogni tipologia di persona che lui riteneva ‘amici’ passare per casa nostra, – la maggior parte dei quali probabilmente spacciatori, ladri, drogati, ubriaconi o chissà cos’altro. Mia madre – prima del ‘fattaccio’ - aveva sempre tenuto in considerazione la possibilità che, dopo l’inizio del divorzio e l’uscita dal carcere finiti i suoi sei mesi per furto, Rick potesse assoldare qualcuno per farci fare un ‘visitina’ a casa. Così ogni qual volta un uomo che superava i venticinque anni diceva di sapere il mio nome, l’ansia e la paura mi attanagliavano lo stomaco. Nonostante il Dottore non somigliasse nemmeno vagamente a nessuno di loro, le mie reazioni iniziali erano automaticamente di dubbio e paura. Era ‘un’abitudine’ che non ero ancora riuscita a levarmi, purtroppo. “Come diavolo ha fatto a scoprire come mi chiamo?” “Colpa mia, temo” s’intromise il figlio con un passo avanti, - rassicurandomi all’istante - grattandosi distrattamente il pezzo di pelle tra l’orlo della maglietta e la cintura dei jeans, mostrando un pezzo di pancia pallido e tonico. “Mi sembrava di conoscerti già, sai … magari ti avevo vista per i corridoi a scuola qualche volta. Poi, un paio d’ore fa mi ha chiamato il coach della squadra, così mi sono ricordato d’averti vista sugli spalti agli ultimi allenamenti, mentre chiacchieravi con Keaton Haig. Allora ho fatto due più due e mi sono ricordato il tuo nome” Strabuzzai gli occhi, lasciandomi scivolare in bocca anche le ultime gocce d’acqua. La gola mi bruciò appena, mandandomi l’impatto freddo al cervello; quasi meccanicamente il dolore iniziò a premere contro le ossa fragili del cranio, infastidendomi. “Ah, giusto. Sei il Ricevitore tu” mormorai, ricordando indistintamente il suo viso tra quelli degli altri giocatori. “Non dirmi che lo hai chiamato, però! ‘Dio, ma che ore sono? Da quanto sono qui? E perché sono qui, poi?” Il Dottore si fece avanti, afferrandomi il polso per poggiarvi due dita e rimanere in silenzio con lo sguardo fisso sulle sue unghie squadrate e lucide. “E’ mezzogiorno, e sei qui da più o meno undici ore” In quel preciso istante mi accorsi, con mio orrore, d’avere addosso dei vestiti decisamente non miei e il braccio destro completamente fasciato da più strati di garza. Cautamente, sperando con tutta me stessa che nessuno dei due uomini facesse caso a me, infilai furtivamente una mano sotto l’orlo del lenzuolo, sollevandone un pezzo abbastanza ridotto verso l’alto; le mie gambe erano coperte da una paio di calzoni larghi e felpati, ma sentivo comunque qualcosa – al di sotto - che ne stringeva la pelle. Lasciando ricadere la mano, improvvisamente esausta, mi limitai ad abbassare lo sguardo sul mio petto senza riuscire a fermare il mio cuore dal ricominciare a picchiarmi violentemente la cassa toracica; sentivo la pelle scoperta del seno sfiorare appena la felpa senza cerniera, e una familiare sensazione di forzatura che avvolgeva completamente il busto, dove sicuramente dovevano esserci altre fasciature a coprire i tagli sul fianco. Intuendo le mie perplessità e la mia espressione da ragazza pronta a sotterrarsi per l’imbarazzo, il dottore allontanò le dita dal mio polso e tornò a guardarmi attentamente. “Quando Kayden ti ha portata qui c’era solo mia moglie, quindi si è occupata lei di te. Ma non ci sarebbe stato bisogno di preoccuparsi in ogni caso. Faccio questo lavoro da dieci anni, oramai.” Mi limitai ad annuire mestamente, osservando l’uomo fare dei passi all’indietro per dare qualche indicazione al figlio in merito a qualche pasticca da farmi prendere, prima di scomparire dietro una porta in legno. “Lo sai che andrà in galera quel pezzo di merda, vero?” mi domandò schiettamente il biondo, iniziando a frugare superficialmente nei cassetti del comodino che affiancava il letto; riuscivo a scorgere i muscoli sottili della schiena tendersi attorno alla spina dorsale ad ogni movimento, sotto la maglietta leggera. Srotolai sorpresa le dita dal groviglio ‘cui le avevo costrette, sollevando allarmata lo sguardo, con il cuore nelle orecchie. “Si è già sparsa la notizia? Cosa ne sanno?” “E’ una cosa inevitabile, Carter. Ma comunque ne so ancora poco o niente …” “Voglio tornare a casa. Adesso” rantolai, strizzando gli occhi per ricacciare indietro l’alone umidiccio che stava iniziando ad impedirmi la vista. Non volevo entrare di nuovo nell’occhio del ciclone dei Servizi Sociali - soprattutto senza avere sotto controllo la situazione. Anche se non mi ero mai preoccupata più di tanto di capire come funzionassero quelle cose, una sola orribile cosa mi era stata chiara sin dall’inizio: ogni minima problematica che arrivava alle orecchie degli assistenti sociali equivaleva ad una sempre maggiore possibilità che a Elia non venisse più riconosciuta l’idoneità per prendersi cura di me e tenermi così insieme a lui – sarei così finita nel Wisconsin, da mia zia Rose e la sua mentalità preistorica riguardo l’allevare una ragazza. Il pensiero di non sentire la mattina il suo corpo che sbatteva contro ogni tipo di superficie mobile, alla ricerca dei suoi calzini che puntualmente finivano tra la mia biancheria – che lui si rifiutava categoricamente di toccare - mi stringeva il cuore, talmente tanto da lasciarmi senza fiato. Il solo rischio di perdere anche lui mi spezzava in tanti minuscoli pezzettini. Una prospettiva di vita senza Elia non potevo nemmeno immaginarla, non poteva definirsi tale; sarei definitivamente e realmente crollata sotto le macerie della mia vita ancor prima che qualcuno avesse potuto separarmi fisicamente da lui. Era stato quasi naturale e dolorosamente facile abituarsi all’assenza di Dante nella mia vita; lui era lentamente riuscito a spezzare quel piccolo filo invisibile che ci teneva uniti, riuscendo a farsi finalmente detestare dalla sottoscritta, e nonostante tutto avevo avuto costantemente la sicurezza che uno dei miei fratelli era dall’altro lato della mia camera, pronto a prendermi ad ogni mia caduta. Non avevo più foto che lo ritraevano – o se anche c’erano, io non sapevo dove fossero – o qualcuna delle magliette che gli fregavo per dormire d’estate. Nessuna sua traccia; viveva a malapena nei miei ricordi. Con Elia non sarebbe mai potuto essere lo stesso; non avrei mai accettato di vivere anche lui solo di ricordi vaghi e che con il tempo sarebbero andati sbiadendo pian piano, rimpiazzati da altri meno importanti e inutili. Elia non era Dante, e io lo amavo; più di quelle poche persone a cui ero realmente riuscita ad affezionarmi, senza alcuna barriera o limite. Più di quanto avessi mai osato ammettere a lui o a me stessa - perché volere bene ai propri fratelli non era stata una cosa così scontata e semplice per noi, per niente. Essere figlia di un uomo diverso da quello cui erano figli loro, e che puntualmente m’aveva abbandonata ancor prima che potessi nascere, non poteva che portare resistenza tra loro e me, la piccola ‘cosina’ appena venuta al mondo. Crescendo mi ci era voluto del tempo per capire che il loro essere dei maschi – che li portava automaticamente a somigliare all’uomo che avrebbe dovuto accompagnarmi ogni mattina all’asilo, come succedeva alle mie compagne, ma che effettivamente non c’era mai stato - non era obbligatoriamente un pericolo per me, così come a loro era servito altrettanto tempo per capire che non avevo rovinato effettivamente la loro piccola famigliola con il mio arrivo – e che la mamma li amava in egual modo. Poi lei aveva fatto la scelta – tra le tante sbagliate – che non le avrei mai potuto perdonare in vita mia, neanche sotto tortura: sposare Rick. Da quell’istante, mentre iniziavo ad amare incondizionatamente Dante ed Elia, al contrario la nostra vita stava crollando senza controllo sotto i nostri piedi, verso l’Inferno più profondo, rude e buio. Senza alcuna via d’uscita. Dopo Elia non ci sarebbe stato più niente e nessuno; nessun motivo abbastanza valido che potesse portarmi a vivere la mia vita come avevo ricominciato a fare – perché vivere a cento ore e qualcosa di distanza avrebbe potuto portare esclusivamente a ciò. Non ci sarei stata più io. Ed era così surreale rendermi conto di dipendere così tanto da una persona; da un uomo, soprattutto, che forse avrei dovuto iniziare a domandarmi se ciò era un bene o un male. Senza quasi neanche accorgermene mi ritrovai con le gambe penzoloni sul bordo del letto, e le braccia di Kayden strette sulle mie spalle per tenermi ferma; la faccia irremovibile a pochi centimetri dalla mia. “Che stai cercando di fare, razza di cretina? Non puoi scendere adesso, Carter” mi ammonì duramente, appiattendomi le gambe contro il bordo del materasso con le sue ginocchia spigolose e sottili. “E non dimenarti così, altrimenti ti saltano i punti” “Ma quanto pensi me ne possa fregare dei punti adesso? Lasciami solo andare, Kayden” replicai allarmata, schiaffeggiandogli il petto con colpetti deboli e forzati. Più che altro si potevano definire piccoli sfioramenti appena accennati sulla sua maglietta blu per quanto i muscoli mi risultassero deboli e stanchi. “Fammi scendere da questo letto, Kayden. Voglio tornare a casa mia e risolvere in fretta la cosa” “Ma risolvere cosa, porca misera?” urlò lui, quasi più arrabbiato e contrariato di me, tirandomi i capelli all’indietro. Sentì la pelle delle guance tirare, lasciandomi sfuggire un mugolio di protesta. “Quel bastardo ti avrebbe ammazzata se non fossi riuscita a scappare. Vuoi davvero dire alla polizia che è stato tutto un incidente?” Per salvare la mia vita con Elia? Da grandissima egoista quale ero, si, dannazione. Si. Per un qualche motivo a me ignoto, però, non riuscì a liberare dalla mia bocca quelle parole così sbagliate. C’era qualcosa nel modo cauto e sovrappensiero con cui i suoi occhi mi scrutavano che mi convinse a tenere a bada la mia lingua lunga. Kayden conosceva Kyle, ne ero certa. Una cosa che invece non ero sicura di voler conoscere, era il perché. “Lo sai quante denunce ha per aggressione e violenza a danno di ragazze come te, o più piccole, Carter?” Quello non era esattamente un argomento che avrei voluto affrontare in quel preciso momento – o molto più sicuramente, per me, mai. Scossi lentamente la testa, faticando a mandare giù la bile. Le mani mi scivolarono sulle sue braccia, stringendo i bicipiti in attesa della risposta – che in cuor mio conoscevo già: molte, troppe probabilmente. “Quante?” “Quasi dieci solo quelle ufficializzate negli ultimi tre anni e mezzo.” Un suono a metà tra un singhiozzo ed un’imprecazione mi scivolò fuori dalla gola, mentre quel numero si incideva a forza nella mia testa. Con il cuore ancorato in gola, talmente gonfio e ingrossato che avevo paura m’avrebbe schiacciata sotto il suo peso da un momento all’altro, sollevai lo sguardo su Kayden, insicura su cosa provassi realmente. L’unica cosa di cui avrei desiderato avere la certezza, in quel momento, era che Elia fosse in attesa dietro quella porta, come sempre. “Ma suo padre è un fottuto riccone del cazzo, così si è limitato a pagare le cauzioni e continuare a giocare a golf con i suoi amici imprenditori, come se niente fosse successo” continuò teso il biondo, fissando distrattamente il mio collo scoperto. Kyle non sarebbe più stato un problema, avrei voluto dirglielo, - il padre di Ian era un ottimo avvocato con alle spalle nessuna causa persa ed ero fermamente certa che avesse già preso in mano la situazione. Come aveva sempre fatto da quando mia madre aveva capito d’avere bisogno d’un bravo avvocato di fiducia, e anche dopo la sua morte – ma avevo la strana sensazione che non gli sarebbe bastato sapere che avrebbe marcito in prigione per un bel po’ di tempo. Forse non sarebbe bastato a nessuno di noi, in fondo. “Mi dispiace.” Buttai fuori l’aria che avevo trattenuto, lasciando scivolare la presa delle mani dalle sue braccia. Lui inclinò la testa, con uno strano luccichio negli occhi mentre l’angolo della bocca si stendeva all’insù, in un sorriso malinconico. “Tu me la ricordi molto, sai?” “Tua … tua … sorella?” “Anche lei, dopo quello che è successo, ha costantemente negli occhi questa voglia continua di piangere che copre con quintali e quintali d’arroganza e menefreghismo” spiegò dolcemente, stringendo ed allentando ritmicamente la presa sulle spalle, come in un massaggio rilassante. “E nessuna delle due ha ancora capito quanto questo, in realtà, vi renda dannatamente forti e bellissime” “Lei … è …” “E’ felice, adesso.” Mi sorrise calorosamente, puntando i suoi occhi chiari nei miei, scuri, quasi neri. “Tuo fratello è qui, comunque, assieme ad altri due ragazzi e una rossa sull’orlo di una crisi isterica. Vuoi vedere qualcuno?” domandò, allontanandosi di qualche centimetro da me. “Ah, ti consiglierei di scegliere tuo fratello. Mi ha distrutto mezza casa in queste ore. E pensare che credevo fosse lui quello meno innocuo” Mi mossi agitata sul letto, riportando le mani sulle sue braccia. “Elia, decisamente” mormorai appena, accennando un piccolo sorriso nel rendermi effettivamente conto che Elia era davvero dietro la porta, pronto a prendermi. “Dopo torni?” Kayden ridacchiò divertito, levando il cappello per scompigliarsi i capelli biondi. “Se lo vuoi tu, certo.” _____________________________________________________________________________ [Due settimane dopo] Strofinai, per l’ennesima volta, la mano sul vetro appannato dello specchio, cercando di spazzare via il vapore. Le impronte delle mie dita formavano un piccolo e confuso insieme di linee doppie, nelle quali vedevo riflesso il mio viso; più smunto, giallognolo e magro del solito. Le occhiaie appena accennate che avevano sempre caratterizzato la pelle sotto agli occhi, – causa la mia costante anemia – negli ultimi quattordici giorni erano diventate più marcate e violacee; le guance erano più scavate e senza vitalità e gli occhi più scuri del normale. L’unico accenno di colore sul mio corpo erano le labbra, costantemente rosse a furia di mordicchiarle, i capelli che a breve avrei dovuto tingere nuovamente e la pelle accesa per colpa dell’acqua bollente e il mio continuo sfregarci contro la spugna durante la doccia. Piegandomi sulle ginocchia tirai su il paio di boxer che Keaton mi aveva lasciato sulla maniglia della porta, aggiustandoli sui fianchi – anche loro meno tondi e morbidi. Spettinai i capelli con l’asciugamano, quel tanto che bastava per levare le goccioline d’acqua di troppo e lasciarli bagnati, tornando a osservare il mio riflesso nello specchio. Ripresi a mordicchiarmi la bocca, lottando contro l’urgenza che mi spingeva a spaccare quel pezzo di vetro quadrato con un pugno. Le ultime due settimane erano state stremanti e stressanti, sia da un punto di vista strettamente fisico che mentale. Elia era costantemente agitato, facilmente irritabile, arrabbiato, preoccupato e sottopressione, - causa il lavoro che doveva alternare con gli incontri in tribunale – il che aveva portato a triplicare il numero giornaliero dei nostri litigi; essere costretta a casa per un’intera settimana a causa del dolore mi aveva lasciata indietro con il programma scolastico, che dovevo sbrigarmi a recuperare prima della fine del semestre; e Jackson - sotto ordini del mio sopraccitato fratello - era stato invitato a rimanere da noi per tenermi d’occhio il più possibile. Giornali e canali TV locali non si erano certamente lasciati sfuggire l’occasione di poter infangare un po’ il nome dell’omonimo imprenditore padre di Kyle e della poco funzionante giustizia, facendo si che la notizia arrivasse in poco tempo alle orecchie di mezza città – fortunatamente il mio nome non era stato fatto da nessuna parte, concedendo un po’ di riserbo a me e alle poche persone a conoscenza della faccenda. D’altro canto, non appena scattata la denuncia a mio nome contro il ragazzo, i Servizi Sociali non avevano tardato nel richiamare Elia per un incontro in tribunale, mentre le indagini della polizia continuavano ininterrotte. La versione ‘modificata’ ufficiale dello svolgimento dei fatti, messa a punto da Oliver – padre di Ian – era stata distribuita ai pochi presenti sulla scena del ‘crimine’: io ero ad una festa di compleanno con alcuni amici, quando questo ragazzo mi aveva portata di peso sul retro con intenzioni ‘decisamente discutibili’. La mia fuga e l’aiuto di Kayden erano rimasti tali, testimoniati con grande piacere dall’intera famiglia Walker. Eravamo tutti consapevoli che cambiare qualche cosa sulle dinamiche della situazione era altamente rischioso per tutti, ma se ciò sarebbe servito a fare giustizia, togliere dalla circolazione Kyle, sistemare le cose con i Servizi Sociali e tirare fuori dai guai Tyreek ed il Sanyo, avremmo ‘mentito’ volentieri tutti quanti. Nessuno, di certo, avrebbe avuto da protestare sulla probabile incarcerazione di Kyle – suo padre permettendo, ovvio. La causa, comunque, continuava ad andare inevitabilmente avanti mentre aspettavamo che il giudice decidesse il giorno della sentenza finale – Elia e Oliver tendevano a tenermi all’scuro della maggior parte delle cose, non che io premessi poi più del dovuto per esserne messa a conoscenza. Ero sempre stata piuttosto brava a cancellare dalla mia testa i ‘brutti ricordi’, – tralasciando Dante e Rick – quindi meno ne sapevo più facile sarebbe stato per me farlo anche con Kyle. Non che quella consapevolezza mi fosse tornata di gran utilità nelle ultime settimane; per assurdo, i miei incubi sembravano non volermi dare tregua soprattutto in quel momento. Mi svegliavo due o tre volte durante la notte, trovandomi un Elia sempre più spaventato di fronte e Jackson con costantemente un bicchiere d’acqua in mano – che alla fine ingurgitava solo lui. Erano probabilmente loro, il fumo e la birra – che, assieme a Keaton, poi, sembravano anche essere l’unico accenno di normalità ancora rimasta nella mia vita – la causa dei miei quasi sei chili persi in sole due settimane. E la situazione stava iniziando a piacermi sempre di meno. Afferrai il tubicino di crema sul mobiletto che affiancava lo specchio spruzzandone un po’ sulle dita; scostai un po’ il bordo largo della maglietta, passandola delicatamente sull’inchiostro scuro del tatuaggio sulla clavicola. Keaton era poggiato mollemente con la spalla allo stipite della porta – riuscivo a scorgere la sua figura illuminata con la coda dell’occhio; caviglie accavallate, braccia incrociate al petto e nocche fasciate con la garza affondate sotto le ascelle, mentre i suoi occhi guizzavano veloci da una parte all’altra del mio corpo. “E’ tua, per caso?” gli domandai, tirando l’orlo della maglietta all’ingiù. Era visibilmente troppo larga e lunga per la mia taglia; l’avevo ripescata dal fondo dell’armadio, dove alloggiavano anche parecchi indumenti che Keaton si era dimenticato nel corso degli anni. Lui sembrò osservarla attentamente per un po’, mordicchiandosi il labbro. “No” rimuginò, allungando un braccio per pizzicarmi il pezzo di pelle appena sotto l’orlo dei boxer. “Ma devo portarti al più presto a pranzo da McDonald, questo è sicuro.” “Lo sai che non aspetto altro” ridacchiai, lanciando distrattamente l’asciugamano bagnato sulla cesta dei vestiti da lavare prima di seguirlo giù per le scale. “Sei sicura di non voler venire a dormire da me?” domandò, infilandosi la felpa da sopra la testa. “No” bisbigliai, piegandomi con la pancia sullo schienale del divano, gambe all’aria, per raccogliere il telecomando incastrato tra due cuscini. “Tranquillo, me la caverò” “Be’, in effetti, adesso che ci penso, mia madre sarebbe stata capace di farmi dormire sullo zerbino per cederti la mia camera. Quindi direi che è un ottima idea che tu rimanga qui” “Ma sparisci idiota” risi, spintonandolo per una spalla fuori dalla porta. “Oh, ma anch’io ti voglio bene, Ter” ammiccò con un ghigno, posandomi un veloce e rumoroso bacio sul naso prima di saltare in sella al suo motorino e sparire dalla mia visuale, inghiottito completamente dall’oscurità della notte. Richiudendomi la porta alle spalle allungai il braccio verso la televisione schiacciando al contempo il tastino rosso d’accensione, mentre mi dirigevo a passo trascinato in cucina. Jackson era uscito già un paio d’ore fa per un appuntamento con un vecchio amico di Los Angeles di passaggio in città e probabilmente non sarebbe tornato prima dell’una; lanciando un’occhiata veloce all’orologio constatai che fossero a malapena le dieci e mezza. La voce profonda e roca di Robert Downey Jr nel ruolo di Sherlock Holmes si diffuse per tutta la cucina, mentre infilavo la testa nel frigorifero, alla ricerca di qualcosa che potesse soddisfare il mio appena accennato appetito. Durante il pomeriggio Keaton m’aveva costretta ad ingurgitare patatine, insalata e Würstel a non finire, così mi limitai a tirare fuori una birra, una confezione di salame ancora sigillata e il pane. Sullo schermo, Sherlock stava combattendo abilmente contro qualche omone vestito di nero, lanciando qualche volta battutine e occhiate di scerno nei loro confronti. Sollevai un pezzo di salame e, avvolgendolo nel pane, lo infilai in bocca; ero pronta a rilassarmi completamente tra le coperte e donare tutta la mia attenzione al film, e a nient’altro per quella sera – tra le continue visite di Leanne e Baja, le uscite di nascosto con Keaton, il recupero delle materie a scuola e i litigi con Elia, solo in quel momento riuscivo a rendermi conto di quanto effettivamente poco tempo avessi avuto per me. Ovviamente, però, non potevo davvero credere che la tregua arrivasse così in fretta e così facilmente; come se me lo fossi cercato, il campanello di casa iniziò a suonare impertinente, coprendo il volume della Tv. Sbuffando rumorosamente scivolai lentamente giù dal divano, trascinandomi verso la porta con attorno ai fianchi ancora il plaid grigio – imposi a me stessa di impedire al mio sguardo di vagare, anche per sbaglio, sullo specchio che decorava le mura d’ingresso. Doveva essere sicuramente Keaton che aveva dimenticato qualcosa, come suo solito, ipotizzai rapidamente. “Un secondo, porca miseria! Che cazzo succe …” Non riuscii a terminare la frase che avevo già aperto la porta; la figura di Justin - avvolta nell’ombra - era in attesa e con il dito ancora premuto sul tastino del campanello. Ogni singolo muscolo che pensavo di possedere si irrigidì istantaneamente al contatto visivo inaspettato con il suo volto tumefatto e rigido, prima di lasciarmi travolgere dalla rabbia e l’odio che avevo sempre provato ne suoi confronti – che con le sue ultime tre settimane di assenza non erano di certo andate scemando – e che avevo represso a forza di sigarette e maledizioni dentro di me, negli ultimi giorni. Tutti gli insulti che stavo rivolgendo mentalmente al possibile ‘disturbatore’ fino a pochi secondi prima si erano magicamente volatilizzati dalla mia testa; l’unica cosa a cui riuscivo a pensare in quel momento erano le mani che mi prudevano dal nervoso. Mi resi conto che quel momento lo stavo probabilmente aspettando da ben quattordici giorni o più. Forse da quando aveva rimesso piede a San Diego o proprio nella vita di Dante. Non tentai nemmeno di sbattergli la porta in faccia e rompergli il naso. L’unica cosa che riuscii a sentire, nei secondi a seguire, furono le mie nocche che si scontravano brutalmente contro la sua guancia già viola. Dante mi aveva insegnato a tirare un pugno per bene a tredici anni, dopo che Dan Michaels mi aveva tirato volontariamente una pallonata in piena faccia durante l’ora di educazione fisica, l’anno prima dell’inizio delle superiori. Dita ben strette contro il palmo, racchiuse sotto la stretta del pollice. Polso rigido, braccio mobile e pugno sempre all’insù. Justin si lasciò sfuggire qualche lamento appena accennato, più per la sorpresa che per il colpo, – probabilmente – massaggiandosi la mascella con le dita. “Che cazzo fai? Ti sei fottuta il cervello, per caso? Porca troia!” Quasi come se fosse stata dotata di vita propria, la mia mano stretta a pugno partì di nuovo alla carica per inveire ulteriormente contro di lui. Il colpo atterrò per bene sul suo zigomo, costringendolo ad arretrare di qualche passo, – questa volta davvero per il dolore – mentre il labbro inferiore cominciava a sanguinare. Strabuzzando gli occhi - consapevole che se non mi fossi sbrigata sicuramente m’avrebbe ammazzata - mi catapultai sulla porta; afferrai tra le mani il legno e iniziai a spingerlo con quanta più forza e rapidità mi riuscisse possibile, tenendo conto che fianco e braccio mi facevano ancora male per i punti appena tolti e i lividi in via di guarigione. Mi lasciai sfuggire un piccolo sospiro, nell’esatto momento in cui la serratura della porta sembrò scattare, allentando la presa – abbassando automaticamente la guardia. Cosa assolutamente da non fare. Ecco a cosa serviva guardare Karate Kid, dannazione! Qualcosa di pesante e forte si lanciò dall’esterno contro la porta, spalancandola con forza bruta e buttando automaticamente me contro la parete adiacente. Solo il tempo di percepire il cemento freddo delle mura a contatto con la mia guancia, che un paio di mani grandi si piantassero violentemente contro i miei fianchi, facendomi girare su me stessa. La schiena sbatté dolorosamente contro la parete, allineandosi al suo profilo dritto e scomodo; sentii un dolore secco partire dal centro esatto della colonna vertebrale – mi sembrò quasi che le ossa scricchiolassero l’una contro l’altra – ed espandersi per tutto il mio corpo, schiacciato completamente dal suo. Justin schiacciò infuriato una mano contro il muro, a due centimetri dal mio viso, con il petto che seguiva un ritmo irregolare tutto suo. La guancia aveva assunto un colore viola acceso, le labbra sanguinavano appena e un taglio abbastanza lungo dava mostra di se di fianco al suo sopracciglio sinistro. “Che cazzo ti è preso, eh?” ringhiò – lo fece per davvero – a bassa voce, tentando visibilmente di riprendere il possesso di se stesso. Il suo fiato caldo si scontrò come una raffica di vento contro la mia bocca, facendomi balzare immediatamente il cuore in gola, mentre lasciava piroettare il suo sguardo nel mio. Oro liquido contro il nero più assoluto, come due cacciatori nati a cui non è stato insegnato nient’altro nella vita. Due leoni dalla criniera folta e possente a contendersi la preda più grande e appetibile fra tutte; a scavarsi dentro con prepotenza, in una gara all’ultimo respiro a chi trova per primo il punto debole a suo favore nell’altro. Determinati e orgogliosi fino alla morte. “Sei un bastardo” lo affrontai, arrogante, raddrizzandomi per quanto il suo corpo contro il mio mi concedesse di fare. Lui scoppiò semplicemente a ridere, buttando all’indietro la testa, come se gli avessi appena raccontato una delle barzellette più divertenti al mondo. Una presa in giro bella e buona, in poche parole. Furente, sollevai il braccio, mirando quella volta direttamente al naso. Ma Justin sembrava aver preso per bene le sue precauzioni, perché la sua mano fu ben pronta ad incastrare la mia al muro, con una mossa talmente fulminea che riuscì a rendermene effettivamente conto quando sentì le sue unghie affondarmi nella pelle dei polsi. E poi la sua bocca si scaraventò famelica e aggressiva contro la mia, facendomi schizzare il cuore al cervello. Inchiodò i suoi occhi luccicanti ai miei, tirando l’angolo del labbro inferiore trai denti per farmi reagire; l’impatto del percepire il sapore metallico e salato del suo sangue contro la mia bocca mi mozzò per un istante il respiro nello stomaco. Sentii le sue mani scivolare furtive sul collo, le spalle, il petto, i fianchi, per arrivare alle gambe; affondò le dita dietro alle ginocchia, costringendomi a stringerle attorno ai suoi fianchi per non far cadere entrambi a terra. E, per la terza volta nel giro di un solo mese, lasciai che Justin si prendesse un po’ della mia rabbia addosso, schivando la parte del mio cervello che mi gridava allarmata fermarmi. Di, nuovo, però, sentire la sua bocca avvolgere delicatamente la mia sembrò mandarmi completamente in tilt il cervello. L’unico pensiero su cui riuscivo automaticamente a concentrarmi e a cui davo istintivamente senso, era la sua lingua che rincorreva la mia. “Maledizione, Carter. Non dovresti farmi fare certe cose” farfugliò affannato, ripiombando nuovamente sulla mia bocca, aumentando la stretta del braccio sinistro attorno alla mia schiena. La mano destra si sollevò leggera sulla mia guancia, iniziando a lasciare piccoli disegnini immaginari con le dita sulla mia pelle arrossata e calda. “Io non raccolgo i pezzi delle persone, non lo faccio. Io riesco le spezzo solo di più, Carter” mormorò a bassa voce; la bocca ancora attaccata alla mia, il suo corpo ancorato al mio, i suoi occhi persi nei miei. Tradotto in parole povere? Un avvertimento. Justin mi avrebbe fatto del male; mi avrebbe spezzata. Volontariamente o no, lo avrebbe fatto. E non sarebbe riuscito a ricompormi, forse non ci avrebbe nemmeno provato. La scelta sarebbe stata solo mia. Ed era proprio quello il nocciolo della questione: arrivata a quel punto, dopo tutto ciò ch'era successo, m'interessava ancora che qualcuno mi facesse del male - fisicamente o emotivamente? Quanto avrebbe potuto farmene, poi? Comunque non più di quanto solo due persone nella mia vita erano riuscite a fare: Dante e 'mio padre' biologico, l'uomo che aveva contirbuito a mettermi al mondo e che poi era scappato a gambe levate ancora prima che nascessi. Come, quando o perché non importava, in quel momento. Lo avrebbe fatto, e quella consapevolezza sembrò essere quella gocciolina mancante che riuscì finalmente a farmi esplodere il cuore, dopo tre settimane di battiti accelerati in cui non facevo altro che domandarmi quando sarebbe successo veramente. Non avevo messo in conto, però, che sarebbe stato il ragazzo che stavo baciando a innescare la bomba; non mentre mi baciava come se non desiderasse faro altro da anni. Non fu quella sensazione di oppressione al petto, però, a ricordarmi che avevo smesso di respirare; Cole era in piedi, sull’uscio della porta, con al seguito Jackson e una ragazza dai capelli rossicci. “Che cazzo stai facendo?” Writer's corner: Okay, non vi rubo ulteriore tempo dicendovi perchè sono in ritardo. La situazioen ultimamente è così: magari non scrivo per una settimana o più perchè non ho niente in mente, e poi magari un giorno mi viene l'ispirazione e scrivo di getto tutto il capitolo. Se poi ci mettiamo interrogazioni, verifiche e raffreddori vari il tempo mi si dimezza ulteriormente, abbiate pazienza. E boh, il capitolo è questo. C'è l'arrivo di Kayden, che si farà vedere più spesso dai prossimi capitoli. Ci sono ulteriori problemic he si uniscono a quellic he già c'erano, e ci sono Carter e Justin che come sempre non hanno - o si danno - pace. E lo so che magari vi starete annioando a non sapere esattamente la trama della storia, ma ripeto: pazientate. Non dico che nel prossimo si scoprirà di già tutto, ma ci saranno degli episodi che pian piano porteranno al capitolo della 'verità'. Io non spiego il capitolo perchè mi piace che oguno arrivi alle proprie conclusioni o ipotesi, ma se comunque ci sono delle cose in cui non sono riuscita a spiegarmi per bene sono pronta a chiarirle con piacere. Nel frattempo, grazie a chi segue questa mia costante 'incognita' - se voliamo definirla così. Davvero, sono contenta che a qualcuno piaccia o interessi almeno un pò ciò che sto scrivendo. E adesso, siccome devo finire un lavoro per domani, mi sa che è il momento di evaporare. Baci ☺♥ |
Capitolo 19
*** 18. Yesterday will last forever. Tomorrow never comes. ***
 18. Carter A bassa voce mi lanciai in una sfilza infinita di imprecazioni, destinate a nessuno in particolare, mentre sentivo il mio corpo andare letteralmente a fuoco per l’imbarazzo; aggrappandomi alla maglietta di Justin per non cadere tornai con i piedi per terra, cercando di sistemarmi – nella maniera più silenziosa e discreta possibile ai loro occhi – la maglietta sulle gambe.
Inutile rettificare quanto poco – o praticamente niente – gradissi di quell’assurda situazione; a partire dalla gelida consapevolezza che stava sgomitando dentro di me per risalire in superficie, probabilmente per ricordarmi quanto stupida fossi; passando per la contrastante sensazione di bruciore che provavo nello stare di fianco a Justin, mentre le sue parole si affacciavano beffarde ogni tanto nelle mie orecchie, come fastidiose zanzare; per arrivare all’inquietudine dei miei pensieri sulle possibili conseguenze di tutto ciò. In primis di Cole, e poi di Elia, in caso l’amico avesse – disgraziatamente – deciso di riferirgli quanto aveva appena visto. Ed io, man mano che i minuti ci scorrevano addosso silenziosamente lenti, avevo sempre più voglia di scavarmi un buco nel pavimento e nasconderci dentro la testa come uno stupido struzzo spaventato. Una risata sinceramente divertita – che poteva appartenere solamente ad una persona in quella stanza – spezzò l’alone di tensione formatosi sulle nostre teste, facendoci sobbalzare un po’ tutti per la sorpresa. Jackson, giubbotto di pelle mollemente appoggiato su una spalla e chiavi penzoloni da un passante dei jeans, continuò a ridacchiare per conto suo, come se stesse guardando una puntata del The Ellen DeGeneres Show o Ridiculousness. Ignorando deliberatamente l’occhiataccia di fastidio che gli lanciò Cole, si abbassò sulle ginocchia per raccogliere da terra il plaid che avevo fatto cadere io, invitandomi a raggiungerlo con un segno delle dita. E non so se fu per la piccola stretta di protesta che Justin lasciò al mio polso o lo sguardo diffidente con il quale Cole seguì quel gesto, ma fuggì – letteralmente – verso Jackson. “Ehilà, piccoletta” mi salutò lui, con lo sguardo fisso sulle sue mani mentre mi avvolgeva la coperta attorno alle spalle; infilò le due estremità tra le mie mani e senza nemmeno lasciarmi il tempo di rispondergli affondò un braccio attorno al mio collo, attirandomi bruscamente contro il suo fianco. “Giornataccia eh?” “Carter” mi richiamò Cole nello stesso istante, voltando accigliato la testa verso di noi. “Che sta succedendo?” insisté, fulminando nuovamente Jackson con un’occhiataccia agghiacciante prima che questo potesse intervenire e prendere le mie difese. Gelido e distaccato come mai lo avevo visto, irrigidì le spalle mentre con la mano indicava Justin. “Che diavolo stai combinando ragazzina?” Cole non conosceva Justin, perlomeno non di vista a quanto ne sapevo io – quando usciva con lui, Dante tendeva a stare il più lontano possibile da casa, il contrario di Elia e Cole, la maggior parte delle volte per tenere d’occhio Rick e i suoi sbalzi d’umore; l’unico motivo che poteva averlo portato ad avere quella reazione esagerata – anche perché era già capitato che il biondino facesse la sua entrata in scena nei momenti meno adatti ed imbarazzanti. Era successo quando a tredici anni il ragazzino che mi piaceva si era finalmente deciso a baciarmi; era capitato quando io e Leanne avevamo provato, per la prima volta, a farci la ceretta a strappo da sole a casa; e poi quando a sedici anni era piombato in camera mia senza bussare, nel esatto momento in cui stavo per infilarmi il pezzo di sopra del costume da bagno. L’ultima volta, ai ventidue anni di Elia, aveva addirittura beccato me e Jackson che – sotto l’effetto dei troppi alcolici bevuti – limonavamo sulla porta del bagno del locale. Niente di così eccessivamente imbarazzante da non riuscire più a guardarci negli occhi, ma la faccia – un mix tra orrore e imbarazzo – che aveva assunto ogni volta non si poteva dimenticare neanche con una sbronza colossale come quella. – era che Elia doveva avergli parlato di lui. E se la poca simpatia che aveva sempre mostrato nei confronti di Justin non era stata tutta una messinscena, allora le parole che aveva usato non dovevano essere state sicuramente delle più lusinghiere. In quel momento – il meno opportuno probabilmente – mi trovai a chiedermi se in realtà Cole non sapesse più di quello che aveva mai mostrato di sapere con me. E una parte di me, chissà quanto grande e importante, iniziò a suggerirmi che forse avrei dovuto iniziare a domandarmi quante fossero in realtà le persone intorno a me a sapere più di quanto non fosse stato concesso a me di conoscere. Irrequieta, a causa di quelle assurde possibilità che avevo preso seriamente in considerazione per qualche breve istante, strinsi tra le mani i lembi della coperta ritornando di malavoglia alla realtà. Realtà dove, tra l’altro, mi ero sicuramente persa più della metà del discorso che Cole doveva avermi rifilato, ancora con quell’aria scazzata e inquieta che mai gli avevo visto negli occhi. “Almeno mi stai ascoltando?” mi ringhiò contro improvvisamente, allargando esasperato le braccia all’aria. “O sto parlando con i muri?” “Cole …” tentò di ammonirlo Jackson, accarezzandomi distrattamente una guancia con il pollice. “In realtà no” mi affrettai nella risposta alla sua domanda prima che potessero sviare il discorso, incrociando le braccia al petto. “Non vedo dove sia questo gran problema che vedi tu, sinceramente.” Cole strabuzzò sorpreso gli occhi, avanzando minaccioso di qualche passo in mia direzione; come se non stesse infierendo già abbastanza, puntò di nuovo il dito contro il petto di Justin, quasi fino a sfiorarlo. “Il problema è lui! Maledizione, ragazzina, questo è Justin Bieber, okay? Non è il tizio dai capelli viola con cui sei uscita l’anno scorso, non è il ragazzino di un paio di settimane fa e non è tantomeno Jackson! E’ Justin!” mi ruggì contro; gli occhi allargati puntati nei miei, con la pupilla dilatata, e il respiro corto, come se avesse corso per tutto il tempo. “E tu devi stargli lontana!” “Cole, smettila!” lo rimproverò in fretta Jackson, allungandosi in avanti per guardarlo negli occhi. “Me ne occupo io di questo.” Tralasciando il fatto che stare il più lontana possibile da Justin fosse stato il mio intento sin dall’inizio – indipendentemente dal fatto che più ci provavo, più lui sembrava spuntare un po’ ovunque -, sarei stata capace di lasciar credere a Cole di avere una relazione amorosa con lui pur di fargli capire che mai e poi mai mi sarei fatta impartire delle regole senza senso o valida motivazione. Né da lui né da chiunque altro – Justin ci aveva provato con Wes, e la cosa non era finita nel migliore dei modi, tra l’altro. Strabuzzando gli occhi mi scostai dall’abbraccio di Jackson, arretrando istintivamente verso il fondo del salotto, dove iniziavano le scale che portavano al piano di sopra. La mia via di fuga. “E questo cosa vorrebbe dire?” domandai confusa, spostando lo sguardo dall’uno all’altro, sperando capissero che la domanda era rivolta ad entrambi. “Che non devi più vederlo!” mi urlò contro il biondo, nello stesso istante in cui dalla bocca di Jackson uscì un ‘assolutamente niente!’ urlato con la stessa intensità e rabbia dell’altro, che mi fecero sobbalzare sul posto. Cole non sembrò più infastidito da quella risposta simultanea di quanto non lo fossero Jackson e, a sorpresa, Justin. Strisciando sulle scarpe da ginnastica consumate, mi si avvicinò di nuovo, allineando il suo volto all’altezza del mio così da potermi inchiodare gli occhi ai suoi. “Niente più Justin, okay? Ciao, ciao. Au revoir. Aloha. Adieu. A mai più. Sayonara. Chiaro il concetto adesso?” “Cole, dannazione, smettila!” intervenne ancora Jackson, stringendogli con forza una spalla, imponendosi nel suo abbondante metro e novanta. “E mollami!” se lo scrollò di dosso l’altro, spintonandolo poco gentilmente all’indietro. E come se la situazione non fosse già sul filo del rasoio, proprio in quel momento Justin decise che era il momento migliore per entrare nel mezzo della conversazione; abbandonando il muro sul quale si era poggiato, affiancò Jackson, incrociando le braccia al petto con aria di sfida. “Io credo che sia abbastanza grande da poter prendere le sue decisioni da sola.” L’intervento non richiesto di Justin sembrò irritare ulteriormente Cole; riuscì a scorgere ogni muscolo visibile del suo corpo irrigidirsi istantaneamente, trasformandolo in una statua di marmo. Con la coda dell’occhio osservava Justin come un rapace con la sua preda, in attesa che facesse uscire qualche altra stronzata dalla sua boccaccia per potergli finalmente saltare addosso. E per quanto l’idea che qualcun altro lo sottoponesse ad un nuovo round di pugni, mi sembrava che la sua faccia ne avesse risentito abbastanza per quel momento. In più, la testa e il fianco avevano ricominciato a pulsarmi fastidiosamente, tirandomi la pelle; segno che era arrivato il momento di bermi una bella tazza di camomilla, sprofondare tra le lenzuola del mio letto e chiudere fuori dalla porta tutti i problemi - per quanto mi fosse consentito anche di notte. “Una” parlai ad alta voce, sventolando davanti alla faccia di Cole un dito – anticipando così anche Justin, che mi sembrava più che ben disposto a continuare a parlare -, attirando l’attenzione di tutti e tre su me e nient’altro. “Dammi una sola valida ragione per fare ciò che mi stai ordinando. Una sola. E ti starò a sentire.” Cole non se lo fece ripetere due volte, accettando la sfida con una preoccupante lucina di vittoria a lampeggiargli negli occhi; mi schiaffò la mano in basso, incollando il suo naso al mio. “Elia” scandì lentamente, - mentre sentivo il cuore strapparsi dalla sua postazione per affondarmi nelle gambe -, come se volesse spaventarmi; come se stesse raccontando la storia dell’uomo nero chiuso nell'armadio ad una bambina capricciosa, per convincerla a lavare i denti prima di andare al letto. “Se non stai lontana da questo ragazzo, lo dirò ad Elia.” _____________________________________________________________________________ Mi svegliai di soprassalto, forse più spaventata nel percepire un peso che gravava su buona parte del mio corpo piuttosto che per uno dei soliti incubi che mi tenevano ‘compagnia’ durante la notte. Mi guardai alcuni secondi intorno, abituandomi all’oscurità della camera, prima di tentare di rimettere insieme i pensieri. Ero decisamente scombussolata; delle immagini frammentate di alcune ore prima si susseguivano nella mia mente in un cumulo confuso, e non riuscivo ancora a capire se tutto quello che era successo fosse stato un sogno troppo ben architettato o la crudele realtà. L’occhio mi cadde su una terza gamba, tatuata e tonica, che spuntava in mezzo alle mie da sotto alle lenzuola. Riluttante feci scivolare lo sguardo sulla mia pancia, trovandola circondata - con mio enorme terrore - da un braccio dalla pelle leggermente dorata, completamente tatuato anch’esso, che non poteva certamente appartenere né a mio fratello né a Jackson. Impiegai qualche secondo di troppo per collegare la spina del cervello e capire che non avevo la minima idea a chi potessero appartenere quegli arti in più – e che ovviamente non potevo rimanere ferma nel mio letto con uno sconosciuto talmente schiacciato contro di me da riuscire a farmi quasi da seconda pelle. “Oh Cristo Santo!” gracchiai stizzita, con gli occhi che mi sarebbero potuti benissimo uscire fuori dalle orbite da un momento all’altro. Sopraffatta da una scarica di adrenalina mista alla paura - senza perdere inutilmente altro tempo per riflettere su chissà cosa - , aiutandomi con gambe e braccia riuscì a far arrivare sull’orlo del materasso il corpo estraneo; abbastanza perché dopo qualche istante di precario equilibrio cadesse sul linoleum freddo del pavimento con un tonfo rumoroso – speravo bastasse a far svegliare Jackson nella stanza affianco. Come una molla balzai giù dal letto, rischiando oltretutto d’inciampare nei pantaloni del pigiama che dovevo aver levato durante la notte. Tastai alla cieca la superficie della scrivania, con lo sguardo ancora fisso oltre la sponda del letto come se da un momento all’altro potesse spuntarne fuori Godzilla; afferrai al volo la palla da football, con la quale l’anno scorso la squadra della scuola aveva vinto il campionato studentesco, e che Keaton – e automaticamente tutti i ragazzi della squadra – avevano insistito che tenessi io. Non che servisse poi a molto, ma siccome io ero probabilmente l’unica cittadina d’America a non avere in casa una mazza baseball o da golf avrei dovuto arrangiarmi come meglio potevo. Con la palla stretta saldamente tra le dita, cercando di credermi più minacciosa di quanto non fossi realmente, feci un piccolo passo verso il letto da dove provenivano dei piccoli grugniti. “Sono cintura nera di arti marziali!” sbottai, sollevando il braccio, pronta all’attacco. Tutte stronzate, ovviamente. Io neanche sapevo cosa rappresentasse una cintura nelle arti marziali, figuriamoci stendere un probabile stalker seriale con una palla nel bel mezzo della notte. In quel momento mi pentivo davvero di non aver dato retta a Dante tanto tempo fa e aver preso lezioni Karate o Judo, MMA, Ju Jitsu, Kung Fu, Taek-won-do; oppure stare a sentire Keaton e farmi dare lezioni di Boxe da lui nella palestra che frequentava. O, maledizione, perlomeno fare attenzione alla Tv quando guardavamo I Mercenari o Fight Club. Giusto per sapere qualche nozione di autodifesa - da autodidatta - in più , oltre al solito e prevedibile calcio dove non batte il sole. Sicuramente un po’ più di sicurezza nelle mie inesistenti doti sportive non mi avrebbe certamente fatto male. Dovevo seriamente iniziare a prendere in considerazione un corso di autodifesa. “Gesù Cristo Harvey, non ti stanchi mai di sparare certe stronzate?” Iniziavo davvero a detestare che riuscisse, in un modo o nell’altro, ad entrare in casa senza troppi problemi. Perché, quando succedeva, lui aveva il coltello dalla parte della lama ed in qualche assurda maniera riusciva sempre a calmarmi e passarla liscia. E perché di solito venivo sempre assalita dal ricordo della pelle delle sue dita sulla mia; permaneva come un retrogusto zuccheroso, del quale sembrava non riuscissi a sbarazzarmi nemmeno con ancora in corpo l’assurdo desiderio di ritrovarmi tra le mani il suo collo. Infilando la mano tra i capelli per tirarli all’indietro, gli lanciai un’occhiataccia di fuoco prima di lasciare il via libera alla mia mano; la palla volteggiò sinuosamente al di sopra del letto, andando a scontrarsi rumorosamente contro il centro esatto della faccia di Justin. “Che diamine ci fai qui? In camera mia? Nel mio letto? Di notte?” gli ringhiai contro, ispezionando circospetta la mia camera alla ricerca di qualcos’altro di abbastanza pesante e appuntito da lanciargli. Per sua fortuna – e mio dispiacere – i vasi e i quadri con la cornice in ferro battuto erano sparsi un po’ ovunque per il soggiorno; allora mi rimaneva solo la sedia della scrivania, ma l’avevo spostata vicino all’anta aperta dell’armadio e lo schienale era pieno di vestiti, quindi la cosa avrebbe richiesto troppo tempo. E la mia pazienza non ne aveva. Scrollando le spalle afferrai uno dei cuscini sul letto e, prendendo per bene la mira, glielo scaraventai in faccia. “Che ti salta in mente, razza di imbecille?” Con uno scatto fulmineo afferrai anche il secondo cuscino e glielo gettai di nuovo addosso, ancora accigliata e fremente di rabbia per lo spavento. “Per la misera, la vuoi smettere di fare la pazza?” grugnì lui, visibilmente infastidito, cercando di recuperare l’equilibrio sorreggendosi al letto con le mani. Inarcai minacciosa le sopracciglia, sporgendo l’orecchio verso di lui e tenendo sollevato un altro cuscino sopra la testa. “Come scusa? Non credo di aver capito bene cos’hai detto …” Justin indietreggiò di un passo, con le mani sollevate all’aria in segno di resa. Titubante, aprì la bocca per dire qualcosa - per difendersi probabilmente -, ma l’unica cosa che uscì dalla sua gola fu un grugnito roco e talmente flebile che avrei giurato di non averlo sentito se non avessi visto le sue labbra spalancarsi. Strizzò stordito gli occhi, avanzando di qualche passo; lo sguardo, improvvisamente liquido, fisso su di me. Ed io lo sapevo perfettamente che cosa stava guardando; ma quale essere umano di sesso femminile, ritrovandosi uno sconosciuto nel letto, si sarebbe preoccupata d’infilarsi uno stupido reggiseno addosso? Io, di certo, no. “Che c’è? Non l’hai mai vista una ragazza prima d’ora?” brontolai acida, incrociando comunque le braccia al petto e cercando d’ignorare al meglio la vampata di caldo che mi era salita dai piedi alla fronte, facendomi arrossire pesantemente – riuscivo quasi ad immaginare la tonalità della mia pelle allo specchio, o ai suoi occhi. “Che diavolo ci fai nella mia camera, Justin?” “Maledizione … Carter …” “Parla!” I suoi occhi iniziarono a spostarsi su ogni punto della stanza dove non ci fosse la mia faccia, improvvisamente vigili e pensierosi, mentre con la mano si sfregava la nuca. “Dopo che sei scappata di sopra ho dovuto riaccompagnare a casa Jodi, la ragazza coi capelli rossi. Poi sono tornato qui per parlare con Jackson di alcune cose. Stavo per andarmene quando ti ho … sentita. Lui ha detto che era normale, ma non è riuscito a fermarmi. Sono salito. E non sono più riuscito ad andarmene … non credo riuscirò più a farlo … ma …” Con lo sguardo ispezionò pensieroso i palmi delle sue mani, come alla ricerca di qualcosa che potesse aiutarlo con le parole, nonostante inconsciamente fossi riuscita a finire la frase al posto suo. Dopo qualche attimo di esitazione i suoi occhi scattarono su di me, scintillanti di qualcosa che avrei quasi definito … tenerezza - se solo, così, la cosa non rischiasse di diventare davvero troppo strana per le tre di notte. “Dici il suo nome.” Ovviamente non erano quelle le parole che avevo immaginato di sentirgli uscire dalla bocca. E di certo non avevo preso in considerazione l’idea che avesse potuto assistere all’osceno spettacolo che ero durante la notte; soprattutto quando doveva essermi sfuggito dalla bocca il nome di … Gesù, il suo nome! Lasciando ricadere il cuscino ai miei piedi mi precipitai verso l’armadio, afferrando la prima felpa a portata di mano , infilandola da sopra la canottiera; raccattando i pantaloni a quadrettoni da terra li tirai sulle gambe, infilando anche i calzini antiscivolo con la faccia di un orsetto sulle dita, stringendomi il più possibile su me stessa. Mi sentivo scoperta. Nuda, nonostante fossi più vestita di prima. A rischio, in qualche modo. Vulnerabile. Troppo, vulnerabile, sotto i suoi occhi ardenti ed indagatori. Sull’orlo di una crisi di pianto incredibile. Casualmente, Justin aveva appena rotto il muro dietro al quale lottavo disperatamente eclissare la parte più fragile, debole, schiacciata dagli eventi e senza forze di me stessa; quella che se liberata dalle catene alle quali l’avevo costretta mi avrebbe investita e buttata giù come un F-35 americano in caduta libera sulla Route 101 – c’era pure un motivo se le uniche persone a conoscenza di quella parte della mia vita si contassero sulle dita di una mano. E sarei stata capace di scoppiargli davanti senza alcun ritegno, in una delle peggior crisi di pianto mai viste, purché scegliesse di dimenticare quello che doveva aver visto. Gli sarebbe bastata una parola, un gesto, un’espressione sbagliata per mandare definitivamente in frantumi quella parte di me e far uscire fuori tutto quanto, come una valanga implacabile, come un incubo: il passato. La mamma. Kyle. Rick. Dante. Dante lo era da se, un incubo. Uno dei peggiori, anche. Era una di quelle cose che non se ne vanno, quando vengono concretizzate dopo così tanto tempo passato nel tentativo d’ignorarle il più possibile. Quelle cose che tagliano la pelle, che la marchiano, come un tatuaggio mai desiderato. Sbagliato. Indelebile. Dante era una di quelle cose che più ci provi a cancellarle e più ti si marchiano a fuoco addosso, per ricordarti che loro ci sono. Che ci saranno sempre, nonostante tutto. Nonostante tutti. Ed in quel momento Justin mi era arrivato abbastanza vicino, era entrato abbastanza a fondo - più di quanto probabilmente immaginassi avrei mai permesso di fare a nessuno – da riuscire a prendersi il potere di ferirmi. Di farmi davvero, davvero molto male. E lo avrebbe fatto, in qualche modo. Lo sapeva lui e lo sapevo io. Il problema, realizzato ciò, sarebbe diventato un altro: trovare un modo efficace per allontanarlo. Mandarlo via. Escluderlo dalla mia vita definitivamente. Prima che quella spezzata – ancora una volta – nella storia, fossi io. “Sogni solo lui?” Mandai giù la bile, sentendo il sangue pomparmi rumoroso nelle orecchie, tentando di reggere al meglio il suo sguardo; riuscivo a leggerci dentro tutto l’orrendo stupore che provava nello scoprire che una parte ‘umana’ esistesse ancora dentro di me. ‘Pensi che io sia forte perché riesco a scacciare tutto nell’oscurità. Ma mi lascia vuota. E l’oscurità finisce sempre per tornare nel sonno.’ “Si” esordì invece, mentendogli spudoratamente. Non credevo davvero ci fosse bisogno che sapesse tutto il resto. In fondo una brutta storia, dettaglio più dettaglio meno, resta pur sempre una brutta storia da raccontare. E la mia, di storia, era una di quelle così brutte e ruvide che ti rimangono impresse nella testa contro la tua volontà, per quanto tu cerchi disperatamente di dimenticarle perché fanno troppo male. Riuscì a contare all’incirca una quarantina di secondi immersi nel silenzio più totale scorrerci attorno, prima che Justin muovesse titubante dei passi verso di me, aggirando con grazia la testata del letto. Automaticamente arretrai, infilzandomi il fianco destro nello spigolo della scrivania, mentre lui continuava – ostinato – a riempire quei pochi metri che avevo rimesso tra di noi. “Tuo fratello ti ama, Carter. Più di quanto non riesca a immaginare nemmeno lui, probabilmente” mormorò, gelido. E se la sua voce era ghiaccio impenetrabile, i suoi occhi erano un fuoco ardente. Un’antitesi pericolosamente allarmante. Quasi più del fatto che non avesse ancora arrestato la sua camminata, limitando la distanza tra i nostri corpi a due o tre spaventosi passi di distanza. Un muscolo guizzò sul suo volto, mentre potevo vedere i muscoli delle braccia tendersi. “Maledizione!” continuò furente, passandosi una mano tra i capelli chiari. “Non doveva essere questa la tua vita, Carter. Per quanto sbagliato possa essere ciò che ha fatto, dannazione, lui voleva solo il meglio per te! A costo di sacrificare se stesso.” Scossi testarda la testa, con il cuore che mi stava scivolando pian piano giù nello stomaco, staccandomi dalla scrivania per impedirgli di avvicinarsi ulteriormente a me. In quel momento, con quel tipo di discorso – che io mi rifiutavo categoricamente di affrontare – in corso, avevo bisogno di porre una certa distanza tra me e lui. Distanza che lui stava bellamente oltrepassando, seguendomi nella mia fuga in quello spazio ormai troppo stretto che era diventata la mia stanza. Io non lo avevo mai voluto quel ‘meglio’ di cui parlava lui. ‘Lo restituirei. Tutto quanto. Pur di riavere indietro loro. Pur di riavere indietro mia madre. Pur di riavere mio fratello’ avrei voluto urlargli; perché era quella la verità – nuda e cruda -, e Dante per primo avrebbe dovuto saperla, indipendentemente da quante volte gli dicessi ad alta voce quanto lo amavo. Di nuovo, però, dalla mia bocca non fui capace di far uscire nient’altro se non un sospiro strozzato – che Justin sembrò udire perfettamente. Con uno scatto felino balzò in avanti, stringendomi le dita attorno al gomito, riuscendo a strattonarmi per qualche secondo più vicina a lui. “Non piangi mai” sussurrò, affondando le mani sul mio collo, reclinandomi con i pollici la testa all’indietro, così da impedirmi di sfuggire al suo sguardo. “Non ti ho mai vista piangere.” Presa alla sprovvista lasciai le sue mani ancorarsi ancora più saldamente attorno alle mie guance. Per un istante mi parve d’essere a corto di parole; un istante però brevissimo. Giusto il tempo di analizzare a fondo il suo improvviso cambio d’argomento – il necessario per capire dove non volevo andasse a parare -, prima di levarmi brutalmente di dosso le sue mani. “Vattene!” gli ringhiai contro, rimbalzando sul letto per arrivare dal lato opposto della camera. Scappando come se fossi un animale indifeso e spaventato, rinchiuso in una gabbia troppo piccola e asfissiante, con il suo cacciatore all’interno ad attendere l’attimo perfetto per mettere a segno la mossa finale. Quella vincente, che gli avrebbe levato anche l’ultimo respiro di vita. Lui si limitò a girare su se stesso e ricominciare ad avvicinarsi, mettendomi spalle al muro. “Pensavo fosse perché sei coraggiosa. Maledizione, riesci a sembrarlo così tanto in qualunque situazione ti ritrovi.” Mentre incollavo la mia schiena al muro riuscì ad avvertire il tonfo sordo con il quale il cuore sembrò cadermi nello stomaco, attorcigliandomelo così tanto da farmi male. E Justin che continuava a venirmi incontro non migliorava certamente la sensazione di essere presa a pugni in pancia da un wrestler professionista, di quelli che si vedono in Tv nelle gare della WWE - che Keaton e i suoi amici seguivano il Mercoledì sera sullo schermo piatto. “Vattene! ‘Dio, lasciami stare. Vattene!” quella volta quasi urlai, cercando di appiattirmi il più possibile contro la parete fredda. La canottiera sottile mi si era appiccicata alla pelle sudata della schiena, ed il contatto con il muro – che avvertì nonostante la felpa – mandò una schiera di brividi lungo tutte le ossa del mio corpo. “Adesso invece no.” Improvvisamente scattò in avanti, facendomi sbattere contro il bordo di un quadro che avevo sopra la testa, deciso a non demordere come ma lo avevo visto. “Adesso penso che sia perché sei emotivamente bloccata.” E mi abbracciò. Senza darmi nemmeno il tempo di respirare, m’imprigionò in quella stretta mortale che erano le sue braccia strette attorno alla mia schiena. Le sue ginocchia cozzarono contro le mie, il suo mento inchiodò sulla mia testa; la mia faccia affondò nelle curve gentili del suo petto, ed il suo respiro si mischiò al mio, mentre mi trascinava di peso tra le lenzuola nere del mio letto, con il battito irregolare del suo cuore ad inondarmi tutti i sensi, chiudendo fuori tutto il resto. I'M BACK. AND I'M ALIVE. Quasi due mesi. Sono quasi due mesi che non entravo qui su efp o aggiornavo la storia. Mi sembra assurdo che sia passato tutto questo tempo così in fretta, e mi scuso davvero per il ritardo con le personcine che hanno continuato a seguire la storia. Purtroppo, tra la fine del pentamestre e il nuovo giro di verifiche di queste ultime due settimane non ho avuto praticamente un attimo libero, il che ha anche influito con la mia voglia e la possiblità di scrivere. Non sapete quante idee ho cambiato e quante volte ho riscritto questo capitolo, che probabilmente non sarà venuto nemmeno bene. Purtroppo, nonostante lasci a desiderare, diciamo che 'serve' anche per i prossimi capitoli, dove vi assicuro che le cose inizieranno a farsi davvero interessanti. Anzi, già dal prossimo capitolo ci sarà già un pò più di azione. Ci sto lavorando da un pò, sperando che ne esca meglio di questo qui. E, insomma, non saprei cosa dirvi oltre a questo. Mi piacerebbe che mi diceste davvero cosa ne pensate. Cosa vi piace, cosa non vi piace, o se non vi piace per niente. Mi farebbe piacere avere qualche opinione ogni tanto, anche per capire se quello che sto combinando è perlomeno accettabile o se devo proprio smettere per non farvi sanguinare gli occhi. lol Non so, fatemi sapere qualcosina magari(?) E c'è anche un nuovo banner (olè)! Che ne dite? Alla prossima, Baci ☺♥ |
Capitolo 20
*** 19. Sorrow is a part of package. ***
 19. Carter. Osservai distrattamente le gambe lunghe e snelle del professor Hall – fasciate da un paio di Levi’s scoloriti – mentre continuava a fare su e giù dinanzi alla cattedra; la bocca, piena e rosea, non si era chiusa nemmeno per un nanosecondo di pausa da quando aveva iniziato la speciale lezione su Ernest Hemingway di quel giorno. Il tutto accompagnato immancabilmente da ampi gesti di mani e braccia che volevano mettere maggior enfasi nelle sue considerazioni sull’operato dello scrittore. Il professor Trenton Hall era trentanove anni – portati anche meglio dei cinquanta di Will Smith – per un metro e novanta di abbagliante fascino; con un paio d’occhi azzurri tendenti al verde, torniti da una schiera di folte ciglia scure, la voce calda con un vago accento texano, i capelli scuri e un sorriso dannatamente sensuale, si era aggiudicato a pieni voti lo status di uomo più bello che avesse messo piede alla San Diego High School – anche per sbaglio – negli ultimi vent’anni. Inoltre – per assurdo – le sezioni che seguiva da un anno a quella parte risultavano essere anche quelle con la media di voti più alta nella sua materia; pur di sentirsi rivolgere qualche complimento – seppur in ambito strettamente professionale da insegnante-alunno -, magari accompagnato da uno dei suo sorrisini storti, la maggior parte delle ragazze aveva iniziato ad applicarsi a pieno nello studio in prospettiva di quelle quattro ore settimanali che spettavano alla sua materia. Io fortunatamente non potevo includermi in quella ‘maggior parte’; i miei voti non scendevano mai oltre una misera C- in Chimica, Biologia, e le varie materie scientifico-matematiche obbligatorie. Ciò non mi rendeva ovviamente meno immune al suo fascino da modello ventenne uscito da una delle copertine di ‹‹GQ››. E l’essere probabilmente l’unica studentessa che - nonostante lui fosse una piacevolissima fonte di distrazione - riusciva ad avere sempre il massimo dei voti e che poteva perfettamente trattenersi dal guardarlo ogni due con occhi sognanti, contribuiva notevolmente al farmi catalogare come la sua alunna preferita, o ‘cocca del bel Trenton Hall’, dalle altre ragazze. Che la cosa potesse avere un fondo di verità, e mi facesse sentire così dannatamente fiera e soddisfatta, era tutta un’altra storia. Quella mattina, però – nonostante i suoi occhi chiari continuassero a spostarsi su di me nella speranza di ricevere quel reale interesse alle sue parole che dimostravo sempre -, non riuscivo davvero a concentrarmi su Hemingway e le sue opere. O meglio: a concentrarmi davvero su qualcos’altro che non riguardasse gli eventi della scorsa notte. O, più precisamente: su qualcosa che non fosse quel mistero che era Justin Bieber. Ed avere anche la consapevolezza d’essermi già persa metà dell’argomento a causa di un maledetto ragazzo non faceva altro che indignarmi ancora di più; soprattutto se poi il protagonista di tale lezione era uno dei miei scrittori preferiti. Dai quindici anni avevo passato mesi a mettere da parte i soldi per potermi regalare un’edizione originale de ‘Il vecchio e il mare’, avvistata da Baja nella vetrina di una vecchia libreria in centro città. Quando, pochi giorni prima di Natale, mi ero presentata lì con l’intenzione di farmi un bel regalo e il proprietario mi aveva detto di aver venduto il libro quello stesso giorno ci ero rimasta davvero malissimo; come se mi avessero appena detto di avermi preso a calci il cagnolino. Da immaginarsi quindi la mia faccia nel ritrovarmelo sotto l’albero di Natale il venticinque Dicembre mattina, impacchettato con tanto di enorme fiocco rosso. Da quel giorno avevo decretato Oliver Harding – il padre di Ian - il miglior Babbo Natale che avessi mai avuto sin da bambina; ancora meglio di quando Elia e Dante mi avevano regalato la loro macchina a cinque anni. O del mio pesciolino rosso a dieci, chiamato dalla sottoscritta Shrek, e che quel moccioso orribile che era Keaton all’epoca mi aveva ammazzato due mesi dopo senza alcuno scrupolo. Pensare a lui, quindi, era l’ultima cosa che quella mattina – oppure se proprio vogliamo ogni giorno in generale – volevo davvero fare. Tener fede a quel obiettivo, però, sembrava riuscirmi al quanto difficile e male – soprattutto dopo la scorsa notte. Justin era ovunque, diamine: nei capelli color grano del ragazzo seduto di fronte a me, nella voce di Keaton che mi sussurrava chissà cosa nell’orecchio e negli occhi color whisky di Baja fissi sulla lavagna; nel chiodo di pelle che avevo sulle spalle, o addirittura nell’orecchino nero di Brazil, il migliore amico di Keaton, seduto alla mia sinistra. Justin che dopo l’ennesima lite s’era infilato nel mio letto, tenendomi stretta a sé in attesa che la stanchezza prendesse il sopravvento sull’orgoglio e sulla paura. Justin che dopo l’attacco di un altro incubo, con una scia di baci roventi sulla faccia e una ninnananna canticchiata sottovoce, aveva atteso pazientemente che riuscissi a ri-addormentarmi, vegliando sul mio sonno come era solito fare Elia. Justin che poche ore prima avevo trovato appoggiato al piano del lavello, vestito solo di un paio di boxer neri, corti e aderentissimi che lasciavano decisamente poco all’immaginazione, che chiacchierava allegramente con Jackson mentre preparavano la colazione. Justin che sapeva. Che sapeva di me, di Elia e Dante; della mamma, di Rick e degli scorsi otto anni; della paura matta che mi faceva l’idea di chiudere gli occhi ogni notte e non sapere cosa mi aspettava, e del perché volessi tenerlo ad una distanza di sicurezza da me. Justin che semplicemente – nonostante tutto, nonostante mi fossi impegnata con tutta me stessa nel tentativo di fargli perdere la pazienza – restava. Ed era proprio per questo che diventavo ancora più restia a lui. Il reale motivo per il quale continuasse a mostrarsi così interessato a me, perché si ostinava a voler restare, mi rimaneva ancora oscuro – quando un normale ragazzo di vent’anni mi avrebbe denunciata per aggressione se lo avessi preso a pugni come avevo fatto con lui. E non sapevo se era per colpa dell’abbandono di mio padre, dell’inferno che Rick aveva portato dentro di me o della sfilza di persone orribili che avevano percorso la strada che portava alla mia vita; delle bugie e del tradimento di Dante, della consapevolezza che se mi fossi lasciata andare Justin mi sarebbe potuto piacere sul serio, o semplicemente dell’amicizia che legava quei due. Non lo sapevo, davvero. Ma non riuscivo a spiegarmi perché continuassi a dubitare del suo volermi essere una sorta di amico, standomi vicina in tutti i modi possibili; fatto sta che rimanevo fermamente convinta della mia tesi iniziale: dietro alla sua intromissione nella mia vita c’era un unico, sconosciuto, spaventoso ed allarmante motivo. Qualcosa che andava ben oltre al legame di sangue che univa Dante e me – e che comunque non spiegava un bel niente sulla sua riapparizione dopo due anni e mezzo di assenza. In effetti, pensandoci meglio, c’erano molteplici cose di cui Justin doveva ancora darmi delle spiegazioni; non che nei nostri incontri ci fosse stato mai abbastanza tempo o atmosfera adatta per fare qualcos’altro che non fosse litigare o prenderci a spintoni e pugni. Ma se Justin ci teneva così tanto a giocare, allora avremmo giocato. Ma sicuramente non più a modo suo, per quanto mi riguardava. Non ero più disposta a sopportare tutti i suoi capricci, i suoi sbalzi d’umore e le sfuriate gratuite senza contrattaccare; non era da me. “Carter, maledizione!” La voce scocciata di Keaton nell’orecchio mi fece sobbalzare sulla sedia, strappandomi brutalmente dai miei pensieri per riportarmi alla realtà. Realtà dove trenta paia d’occhi mi fissavano insistentemente; riuscivo a sentire gli sguardi dei ragazzi che sedevano dietro di me bruciarmi sulla nuca. Perfino Mandy Clarkson - che durante le lezioni non avrebbe osato distogliere la sua attenzione dal libro nemmeno con la minaccia imminente di un terremoto o un uragano -, aveva puntato stranita i suoi occhioni grigi su di me. Era chiaro che qualcuno voleva qualcosa da me. Il problema era che io non avevo la benché minima idea di chi fosse quel ‘qualcuno’ e cosa fosse il ‘qualcosa’. Stralunata, voltai la testa verso il mio amico in una tacita e disperata richiesta d’aiuto. Lui sollevò esasperato gli occhi al soffitto, pizzicandomi la pelle dell’avambraccio. “Sulla porta. La bidella. Ti sono venuti a prendere, devi andartene adesso.” Con un altro movimento istantaneo spostai l’attenzione sulla porta in fondo all’aula, scoprendoci il professor Hall e la bidella Angela anche loro con gli occhi che puntavano in mia direzione, in attesa di un mio cenno. Avvampando - prendendo una lunga e rumorosa boccata d’aria che fece ridacchiare sotto i baffi Keaton e Brazil -, mi alzai dal banco e mi avvicinai all’uscio della porta con la borsa in mano. “Uhm … si?” Il professor Hall mi appoggiò una mano sulla spalla e mi spintonò delicatamente fuori dalla classe, chiudendosi un po’ la porta alle spalle per impedire a mezza classe di farsi gli affaracci miei. “C’è tuo zio di sotto. Ha firmato per farti uscire prima, quindi puoi andare via adesso.” Mi spiegò gentile il professore, sfilando dalle mani della bidella un foglio formato A4 scritto per metà e infilandoselo sotto il braccio, mentre iniziava a parlare con la donna al suo fianco. Di cosa, non avrei saputo davvero dirlo, perché la mia mente sembrava essersi cementata da sola attorno ad un’unica, breve e assolutamente spaventosa parola: zio. Come un automa accennai un breve saluto alle due persone di fianco a me e m’incamminai velocemente verso le scale in fondo al corridoio. Essere al terzo piano quella mattina - per una perdita nella nostra classe abituale - era stato un vero e proprio colpo di fortuna. Mi ci sarebbero voluti due o tre minuti per riuscire a raggiungere il portone d’uscita, e nel frattempo avrei avuto modo di prendere in considerazione ogni più florida possibilità che il cervello sarebbero stato in grado di sottopormi. Sentendomi al sicuro da sguardi curiosi rallentai il passo, prendendomela con quanta più calma il corpo mi permettesse. La domanda era: chi diavolo mi aspettava di sotto? Elia era escluso a prescindere; era mio fratello, mio tutore legale, e non avrebbe certo avuto bisogno di una scusa poco credibile come quella per venirmi a prendere a scuola. Per Cole, la stessa cosa; a scuola lo conoscevano un po’ tutti, e comunque con la litigata della scorsa notte non ci saremmo parlati per un bel po’ di tempo. Jackson mi aveva accompagnata a scuola quella mattina, e sapevo per certo che sarebbe stato fuori città per buona parte della giornata. Inoltre, conoscendo la sua indole pigra, se avesse avuto qualcosa da dirmi mi avrebbe chiamata direttamente al cellulare. E di certo non avrei mai creduto che la persona in attesa a due piani di distanza fosse veramente un mio zio. Di parenti ne avevo pochi o nessuno, e quelli che sapevo d’avere vivevano sparsi tra Germania, Ungheria e Romania; dopo la disastrosa decisione di sposare Rick, i rapporti tra mia madre e i suoi parenti avevano iniziato a diradarsi in modo lento e straziante – così come invece Rick accumulava un debito dopo l’altro, come se stesse collezionando francobolli, e che poi portavano alle innumerevoli liti giornaliere e al sempre maggiore stress della mamma. Le conseguenze erano state a dir poco disastrose: i viaggi in Europa erano diminuiti con l’avanzare degli anni, così come le chiamate, i messaggi, gli auguri di buon compleanno, le cartoline, le videochiamate su Skype e i regali per le varie festività in cui non riuscivamo a vederli. Da parte loro, ad un certo punto, non c’era più stata nemmeno tutta quella comprensione e vicinanza che avevano dimostrato all’inizio, così il filo si era spezzato una volta per tutte. Eravamo rimasti la mamma, Dante, Elia ed io, contro Rick e tutte le sue stronzate. E l’ultima volta che avevo sentito uno di loro era stata dopo la … la morte della mamma; un sacco di ‘mi dispiace’, ‘condoglianze’ e ‘ti siamo vicini tesoro’ erano voltai da un cellulare all’altro, prima che tutti loro scomparissero nuovamente, eclissati nelle loro bolle europee di felicità, armonia e serenità. Mentre io ed Elia rientravamo nella nostra, nera ed asfissiante. In realtà, non ero nemmeno certa che sapessero che eravamo ancora vivi; a pezzi, ma vivi. Non che la cosa potesse importarmi più di tanto a quel punto; dopo l’amarezza iniziale, il caldo torpore dell’indifferenza aveva ricoperto il loro ricordo quasi completamente. Quindi, escludendo tutti loro, rimaneva un’unica persona che avrebbe avuto interesse a parlare con me – nonostante faticassi davvero a capire a cosa diavolo servisse la scusa dello zio: Justin. Solo che non mi sembrava così sciocco da accampare una sceneggiata del genere. Non era nel suo … stile. A meno che … pensandoci, una persona che avrebbe dovuto servirsi di un tale escamotage per riuscire a vedermi di nascosto da Elia – o da chiunque altro – e contro la mia volontà c’era: Rick. Al solo pensiero una sensazione stomachevole e acida s’impossessò della mia pancia, costringendomi ad arrestare i miei passi in mezzo al corridoio. Inorridita, scacciai a suon di imprecazioni contro me stessa quell’assurda e spaventosa ipotesi; Rick era lontano, via da me, Elia e San Diego. E non sarebbe ritornato mai più. No. Sicuramente era Justin. Doveva, a quel punto, essere lui. Inviperita, afferrai il cellulare dalla tasca del jeans e digitai sulla tastiera il più velocemente. “Qual è il problema, Harvey?” mi domandò ironico Mr. Simpatia, rispondendo al secondo squillo. “Che ne sai che ho qualche problema?” grugnì indispettita, presa in contropiede da quell’affermazione cinica. Lui rise amaro, sbuffando. “Primo, mi hai dato dello stronzo. E secondo, per quale altro motivo avresti dovuto chiam …” “Lo stesso per il quale ti fai passare per un mio zio per farmi uscire da scuola adesso!” sbottai isterica, interrompendolo nel bel mezzo della frase, allargando un braccio all’aria. Dall’altro capo, non ci fu più nulla per dei lunghi ed interminabili secondi. Quaranta per a precisione. Poi il silenzio venne spezzato da alcuni strani rumori, mentre Justin mugugnava parole incomprensibili a bassissima voce; e poi il tonfo di quello che doveva essere lo sportello di una macchina sbattere, accompagnato da altre voci maschili che brontolavano il loro disappunto. E Justin non aveva nemmeno più bisogno di rispondermi; in quei mesi avevo imparato a conoscerlo almeno un po’, ed il suo silenzio parlava da sé: non c’era lui ad aspettarmi. Ma qualunque persona ci fosse ad aspettarmi, stava cercando proprio me. E per quanto preoccupata da tutta quella segretezza, avevo tutte le intenzioni di scoprire cosa diavolo stava succedendo attorno a me; ero stanca dei segreti. Impiegai qualche altro istante perso nel nulla, prima di partire a razzo lungo il corridoio del piano terra. “Maledizione!” sbraitò ad un certo punto Justin, con voce grave, come se avesse letto i miei pensieri. “Due secondi e sono da te. Ma tu devi stare ferma lì, Carter, okay? E’ un ordine. Giuro su Dio che ti prendo a pugni se fai qualche stronzata, Harvey. Ti ammazzo. Rimani dentro!” E riattaccò. Ma io ero già arrivata, e con l’affanno fissavo confusa chi mi si presentava, impertinente, dinanzi; dentro di me tirai un sospiro di sollievo nel osservare le linee gentili del suo viso piuttosto che quelle spigolose e rigide di qualcun altro. “Wes?” “Mi spiace averti spaventata, non era mia intenzione” si limitò a dirmi, invitandomi a seguirlo giù per gli scaloni d’ingresso. Titubante lo seguì, attendendo ulteriori spiegazioni – vista anche la metodologia poco ortodossa usata per vedermi. “Che succede?” Stavamo per mettere piede nel parcheggio degli studenti, quando lui decise di fermarsi proprio di fronte all’entrata, fissando divertito qualcosa sulla strada; oltre le sbarre in ferro che delimitavano l’area dell’edificio. “Sai, il tuo amico Bieber è un tipo difficile da rintracciare. Soprattutto se passa tre settimane in Ohio abbandonando lavoro, parenti e amici senza lasciare traccia del suo passaggio” mormorò scrutandomi, inclinando la testa verso di me. “E qui entri in gioco tu. E’ proprio una fortuna che sia talmente cotto di te da venire in tuo soccorso così repentinamente, piccola Harvey. Non trovi?” E probabilmente il mio cuore ebbe un gran sobbalzo a quell’ultima scioccante confessione; lo stridere degli pneumatici di un SUV nero che tagliò la strada a Wes separandolo da me, però, ricoprì completamente quel suono alle mie orecchie, facendomi sobbalzare. Tutti e quattro gli sportelli del veicolo si spalancarono contemporaneamente con dei colpi secchi, mostrando le figure definite e snelle di Jared, Blake, un ragazzo bruno che non avevo mai visto, e Justin; livido di rabbia, vestito completamente di nero e con le braccia tese lungo i fianchi, il biondo si avventò ringhiando contro Wes. Il pugno che gli scagliò in piena faccia lo fece ruzzolare a terra, contro la ruota di un Pick-Up rosso parcheggiato lì di fianco. “Portatela dentro!” urlò Justin, lanciandomi da sopra la sua spalla un’occhiata assolutamente gelida che mi mandò una scia di brividi dritti lungo tutta la schiena. Strabuzzai gli occhi, alzando un piede per avanzare verso di lui. “Cosa … no. Che cosa?” “Stai ferma, principessa …” La voce bassa e dura di qualcuno mi rimbombò nelle orecchie mentre due lunghe braccia dorate mi accerchiavano dalla vita. L’amico di Justin mi sollevò da terra e mi fece girare - davanti Blake e Jared che sorridevano divertiti -, per poi piantarmi sul sedile in pelle del veicolo. Ancora prima che riuscissi a rendermene effettivamente conto e poter balzare giù, Blake – da sinistra – e Jared – da destra – scivolarono sui posti restanti intrappolandomi lì dentro. “Questo è un fottuto sequestro di persona!” sbottai, calando arrabbiata la mano contro il poggiatesta del guidatore; sobbalzai nel notare la testa chiara di Justin appoggiarsi improvvisamente sopra il cuscinetto, sbucando dal nulla. Era bianco come un cencio e l’unico accenno di colore erano le guance terribilmente rosse; strinse convulsamente una mano – le nocche scorticate – attorno al volante, immettendosi in strada, mentre con l’altra libera frugava disperato nelle tasche dei calzoni. “Cercava te, non è vero? E ha usato lei per riuscirci …” affermò sicuro il brunetto, lanciandomi velocemente un’occhiata obliqua. “Dannazione, te l’avevo detto di lasciarla perdere, Justin!” L’amico continuava a guardarsi attorno con aria persa, perquisendo con la coda dell’occhio ogni centimetro della macchina; io forse avevo già capito cosa stava cercando con tanta determinazione. “Vorresti per caso dare a me la colpa di qualcosa?” grugnì contro l’altro, sporgendomi in avanti. Lui mi lanciò quella che doveva essere la sua miglior occhiata intimidatoria, stringendo i pugni sulle gambe. “Non esattamente. Cioè, posso capire perché gli sei sempre piaciuta così tanto ma … se mi avesse dato retta avrebbe avuto meno casini e … sinceramente, c’è anche di meglio in giro … per cui …” mi spiegò tranquillo, interrompendo volutamente la frase, congedandosi con un’occhiata decisamente lasciva in mia direzione. Spalancai gli occhi, scattando indietro con la schiena come se avessi appena messo la mano nel fuoco. E non so per quale scherzo della mia mente, ma voltai la testa verso Justin; come avessi pensato per davvero che sarebbe intervenuto in mia difesa. Come se per un momento avessi davvero creduto che ci tenesse realmente a me - come si ostinava a dire -, da impedire al suo amico di offendermi in modo così acido e gratuito. “Sal. Smettila di fare lo stronzo!” lo rimproverò invece Jared, dandogli uno scappellotto non tanto gentile sulla testa. Indignato, mi riservò uno dei sorrisi più dolci che mi fosse capitato di vedere negli ultimi tempi – come volesse quasi scusarsi per l’amico. Mandai giù la saliva - lo ringraziai con una delle espressioni meno tese di cui disponessi -, tornando a drizzare orgogliosa la schiena. “Justin …” Nel tachimetro la freccia continuava la sua ascesa dopo aver superato gli ottanta orari. “Dove cazzo sono finite …” Ero praticamente invisibile. “Justin!” “Jared, dove cazzo hai messo le sigarette?” Indignata, arrabbiata, e forse anche abbastanza delusa, allungai la mano – anticipando lo stronzo al suo fianco, Sal – afferrando il pacco di sigarette che giaceva proprio di fianco al freno a mano. Glielo sventolai in faccia, vincente, conficcandogli le unghie nella spalla. “Adesso mi vedi, eh stronzo?” Come se fossi fatta della stessa consistenza di un fantasma, - cioè come se non riuscissero né a vedermi né a sentirmi –, Sal cacciò fuori un pacco di Lucky Strike, che porse indifferente all’amico. Fulminea, però, riuscì ad appropriarmi anche di quello; ed intercettando l’occhiata che Justin rivolse a uno dei ragazzi di fianco a me, mi voltai e afferrai anche il pacco di Marlboro di Blake e le Merit di Jared, stringendomeli tutti al petto. E allora, solo allora, Justin sembrò davvero vedermi e ricordarsi che c’ero anch’io lì dentro; mantenendo rabbioso il contatto visivo con me, inchiodò il piede sul freno, fermandosi bruscamente in mezzo alla strada. Presa in contropiede, non riuscì ad evitarmi di sbattere il fianco contro il sedile – per mia fortuna il gemito di dolore che mi lasciai sfuggire non parve sentirlo nessuno. Con inesorabile lentezza, Justin girò la faccia di tre quarti, fulminandomi con lo sguardo. “Ridai quelle fottute sigarette, piccola stronzetta!” mi minacciò, allungando un braccio all’indietro; il palmo in alto rivolto a me, in attesa. La sua voce cattiva m’invase l’udito; quella cadenza nel tono, la sillabazione delle singole parole e la calma inquietante dei suoi occhi erano qualcosa che avevo già visto. Qualcosa che non avrei mai più voluto vedere. Non nei suoi, di occhi. Strizzai le palpebre un paio di volte per scacciare via l’immagine di … Kyle, sentendo uno strano sapore acido alla bocca dello stomaco nel rendermi conto di aver paragonato – per un brevissimo istante – Justin a Kyle. E quello era davvero troppo, allora. Stringendo le sigarette al petto, scavalcai agilmente le gambe di Blake e balzai giù dall’auto. “Vaffanculo, Justin!” ruggì infuriata, sbattendo la portiera con quanta più forza riuscissi. “E non osare più farti rivedere, bastardo!” “Troia!” mi apostrofò lui di rimando, prima di premere l’acceleratore e ricominciare a sfrecciare dritto lungo la strada. E davvero, con tutta me stessa, con tutta la malvagità di cui ero capace, sperai che andasse a schiantarsi contro un fottuto albero. Aveva preso a pugni Wes, lui ed il suo compare mi avevano aggredita ed abbandonata su una strada a scorrimento veloce in nemmeno dieci miseri minuti; non riuscivo davvero a capacitarmi di quanto appena accaduto. ‘Dio, avevo voglia di prenderlo di nuovo a pugni!’ mi trovai a pensare, conficcandomi con forza le unghie nel palmo della mano, mentre una sensazione che era un misto tra delusione, frustrazione e rimpianto mi attaccava le viscere, contorcendomi dolorosamente lo stomaco. “Serve uno strappo?” mi sentì domandare – dopo qualche minuto passato a fissare il vuoto -, mentre il finestrino oscurato di una Ford color petrolio – della cui presenza mi ero accorta solo in quel momento - si abbassava per rivelarmi chi fosse il mio interlocutore. “Travis?” __________________________
Buttai fuori un’altra boccata di fumo, facendo cadere via la cenere fuori dal finestrino prima di riportarmi la sigaretta tra le labbra. A minimo volume, dallo stereo acceso risuonavano le note di In Da Club di 50 Cent. Con lo sguardo fisso sulla strada di fronte a sé, in attesa che il semaforo tornasse ad essere verde, Travis picchiettava il dito sul volante seguendo un ritmo tutto suo - cosa che d’altronde stavo facendo anch’io con il piede, sul tappetino nero. Quando della sigaretta non rimase che il filtro bollente, il semaforo cambiò colore, e What I’ve Done dei Linkin Park riempì l’interno del veicolo, ne afferrai un’altra dal pacco di Lucky Strike che mi ero tenuta. “Te ne possa scroccare una?” Travis parlò lentamente, con calma, e a bassa voce, senza mai spostare la sua attenzione dalla strada. Scrollando le spalle, aspettai che la richiudesse tra le labbra per potergliela accendere; comunque le sigarette non le avevo pagate io, poco m’importava di terminarle, anzi. Il ragazzo abbassò il finestrino, sporgendo il gomito di fuori per stare più comodo. “Grazie” accennò un mezzo sorriso, abbandonando momentaneamente la presa sul volante per cambiare marcia. Appoggiandomi con le spalle alla portiera, sentendo un venticello caldo far svolazzare oltre il finestrino i capelli, mi concessi di osservarlo meglio: Travis aveva spalle larghe, braccia toniche, fianchi stretti e gambe chilometriche anche da seduto; i capelli biondo cenere erano legati sulla nuca, un accenno di barba adornava la mascella poco squadrata, labbra piene e occhi di un bel color cielo in primavera. Indossava semplicemente una maglietta a maniche corte blu opaco, un paio jeans larghi e logori, e delle scarpe nere. Era bello, davvero bello; quel tipo di bellezza quasi rude che aveva sempre fatto capitolare decine di ragazze ai piedi di Dante. Ed il piccolo e significante particolare che era stato lui a ridurmi mezza faccia viola per quasi due settimane – per sbaglio, certo, lo sapevo – non me lo faceva assolutamente risultare meno attraente. Inconsapevolmente, al ricordare quella notte, mi accarezzai la guancia sinistra. E a Travis quel gesto sembrò non sfuggire, perché riuscì a scorgere la presa della mano attorno al volante aumentare mentre svoltavamo nel quartiere dove risiedevo io. Riuscivo a scorgere a qualche metro di distanza casa mia. “Mi dispiace, Carter” mormorò a bassa voce, grattandosi pensieroso il mento. “Per tutto …” Senza nemmeno farci troppo caso lasciai cadere sull’asfalto la sigaretta, alzando del tutto il finestrino mentre Travis accostava sul ciglio della strada; un’espressione pensierosa gli increspava la fronte. Sentivo delle voci provenire da fuori, e sul giardino di casa Harding notai tre o quattro macchine mi bloccava la visuale sull’abitazione; avevo il vago presentimento che lì in mezzo ci potesse essere anche lo stronzo, ma comunque nessuno avrebbe potuto riconoscermi dentro quella macchina e da quella distanza. “Cosa intendi?” domandai invece, guardando confusa Travis. Aveva spento la macchina, ma lo stereo continuava a suonare: quella volta riconobbi - piacevolmente – i Blink 182. “Per il pugno …” rispose, un po’ meno incerto, risalendo con gli occhi fino ad averli nei miei. “ Per tua mamma e … Dante … non pensavo lo avrebbe fatto davvero …” “Cosa … tu … tu conoscevi mio fratello?” domandai stupita, allargando a dismisura gli occhi; riguardai attentamente in volto Travis, cercando di ricollegarlo a qualche volto amico di Dante, ma davvero non riuscivo a ricordarlo. Anche se, in effetti, l’unico amico di mio fratello che avevo conosciuto – più o meno – era Justin; Dante tendeva a stare più alla larga possibile da casa nostra, quelle poche volte che usciva con i suoi amici, perciò nessuno di noi li conosceva per davvero. “E … e sapevi … sapevi quello che voleva fare …?” mormorai ancora, incredula, infilzandomi la coscia con le unghie. “Perché non lo hai fermato?” Lui si grattò il collo, abbassando la testa. “Credimi, ci ho provato davvero. Ma quando Dante ha capito che avrei tentato di fermarlo, mi ha letteralmente tagliato fuori … e non ho potuto fare più niente.” Sbattei forte la mano sul cruscotto, guardandolo adirata. “Come niente? Potevi denunciarlo! Dirlo ad Elia. O alla mamma. O a me. A qualcuno, però!” protestai, sentendo montare dentro di me la voglia di prendere a pugni anche lui. “E poi … è mai possibile che tu fossi l’unico che … che sapeva qualcosa?” “In quel periodo anch’io avevo dei problemi, Carter. E farmi coinvolgere dalla polizia non avrebbe … giovato, ecco, alla mia situazione. So che ti sembrerà orribile, ma davvero, ti giuro, se avessi potuto lo avrei legato da qualche parte pur di fermarlo ed evitare quella pazzia!” Per quanto mi sembrasse dannatamente sincero, però, la rabbia era troppa. E solo in un secondo momento riuscì a realizzare che Travis Roden, il ragazzo che avevo di fronte, era la mia unica possibilità di conoscere finalmente la verità sulla vicenda senza dovermi scontrare con le bugie di Elia e Justin. “E tu eri l’unico con cui si era confidato?” insistetti, legandomi insofferente i capelli in una lunga coda. “Che cosa sai, esattamente? Voglio che tu mi racconti tutto quello di cui sei a conoscenza!” “No, macché, l’aveva detto a me e … oh cazzo!” Sgranò improvvisamente gli occhi, fissando un punto indefinito sopra la mia testa. “Attenta, Carter!” Lo sportello dietro la mia schiena si aprì di scatto, e dovetti aggrapparmi alla mano che Travis aveva allungato per non cadere di testa a terra. Prima ancora di poter ristabilire il mio equilibrio sul sedile, qualcosa – o meglio qualcuno – mi scaraventò con una brutalità inaudita fuori dalla macchina; rischiando nuovamente di inciampare nei miei stessi piedi, poggiai male quello destro per tenermi dritta sentendo una fitta acuta colpirmi la caviglia. Mordendomi la bocca per trattenere un gemito di dolore sollevai lo sguardo, incendiandomi d’ira nel notare chi mi stava effettivamente di spalle. Justin, piegato sul finestrino della macchina, rifilò qualche minaccia di ripercussioni a Travis se non mi fosse stato lontano, intimandogli di sparire da lì il più velocemente possibile. “Travis, no, ho bisogno di parlarti!” urlai stizzita, guardandolo disperata negli occhi – sperando leggesse tutta l’urgenza che provavo nel terminare quel discorso appena agli inizi. Il ragazzo mi lanciò uno sguardo rassicurante, sorridendomi gentile. “Tranquilla, Carter” tentò di rincuorarmi, prima di sgommare lontano da lì; lontano da me, portandosi dietro tutta la verità e con sé la mia speranza di sapere. Con il fuoco bruciante della rabbia riscaldarmi lo stomaco, fronteggiai impertinente uno Justin – se possibile – più incavolato, teso, aggressivo e rosso di rabbia di prima; gli occhi, di una tonalità più scura e inquietante del solito, sprigionavano tutta la voglia di prendermi a schiaffi che aveva. Sotto quello strato nero, però, riuscì ad individuare qualcos’altro, come paura e tormento … ma fu solo un brevissimo attimo, prima che tornasse la maschera di pietra che era. “Come diavolo di sei permesso, razza di imbecille?” gli urlai in faccia, spintonandolo indietro con tutta la mia forza, riuscendo a farlo indietreggiare di qualche passo. “Ma ti rendi conto di che razza di bastardo sei? Non hai nessun diritto di comportarti in questa maniera assurda, te l’ho sempre detto, ma tu non vuoi capire. Ma ti rendi conto di cosa hai fatto? Chi diavolo ti credi di essere, eh Justin? Devi smetterla, una buona volta. Perché, notizia dell’ultima ora, non sei mio fratello. Né tantomeno mio padre!” “Tu non ce l’hai nemmeno mai avuto un padre!” Mi ero sempre chiesta, guardando CSI Miami con Keaton, cosa si provasse nello sentire il proiettile di una pistola conficcarsi nel corpo di qualcuno, lacerargli la pelle, strapparla, farla a pezzi. Fortunatamente non m’era mai successo, ma immaginavo la sensazione fosse quella provai nel sentire Justin pronunciare quelle maledette parole. E, sul serio, nemmeno l’attrice più brava sarebbe stata in grado di mascherare quel tipo di dolore. A quel grido sussultai fisicamente. Arretrai di scatto, con le ginocchia sul punto di cedere sotto il mio peso, con gli occhi sbarrati e la bocca spalancata tanto ero stata colpita a fondo. E poi successe il peggio del peggio: sentì un pizzicore fastidioso salirmi dalla bocca dello stomaco lungo, lungo per la gola, attraversarmi le guance e arrivare dritto agli occhi, rendendoli umidi, delicati, e ricoperti da una patina trasparente che mi bloccava la vista. E un singhiozzo, roco e acuto, mi sfuggì dalle labbra; lo sentì rimbombarmi nelle orecchie, rumoroso, doloroso, tagliente. Attraverso l’alone umidiccio che mi copriva gli occhi vidi Justin stringere le braccia e fare un passo verso di me; sprizzava ira da tutti i pori. “Carter … cazzo, Carter …” “Non toccarmi!” gridai, non riuscendo a sopportare il pensiero di averlo vicino in quel momento. “Lasciami stare! Non mi toccare!” Testardo, Justin osò fare un altro passo in mia direzione. Poi fu un attimo. Jared lanciò un grido degno di un gladiatore, prima di scagliarsi contro Justin e atterrarlo con un gancio destro dritto in piena faccia, lasciandomi così via libera. E mentre gli altri ragazzi si destreggiavano per dividere i due, io raccolsi tutte le mie forze e mi lanciai in una corsa disperata verso casa, sentendo i pezzi del mio cuore cadermi a terra ad ogni falcata. Writer’s corner: Okay, questa volta sono davvero, davvero molto di fredda. Mi scuso in anticipo per eventuali errori, che mi occuperò di correggere al più presto, giuro. Scusate per il nuovo ritardo c: Spero vi piaccia. Baci ♥ |
Capitolo 21
*** 20. The evil that I've got inside I mask it well. ***
 20. Justin Sazio, buttai una crosta bruciacchiata nel cartone, lasciandomi cadere sul materasso; gettando un’altra occhiata al mio volto riflesso negli occhiali di Sal, mi lasciai sfuggire un rumoroso sospiro.
Avevo passato l’ultima ora e mezza destreggiandomi tra l’evitare i messaggi assillanti di mi zia, ignorare deliberatamente le chiamate provenienti dal Canada e tentare di non farmi prendere di nuovo a pugni da Jared. Nelle ultime settantadue ore nessuno aveva dimostrato un minimo di pietà nei confronti della mia ormai dolorante e tumefatta faccia – dai motociclisti dell’Ohio con i quali avevo fatto a pugni, passando per Carter e Ian, per arrivare a Jared; la bocca mi bruciava anche solo a tenerla chiusa, l’occhio destro era circondato da un terrificante cerchio quasi nero, lo zigomo era abbastanza gonfio e arrossato , e il naso mi dava parecchio fastidio ad ogni respiro. Le nocche delle mani erano scorticate e pulsanti, zoppicavo appena dal piede destro per aver rifilato un calcio alla ruota della macchina, e anche il fianco sinistro sembrava essere un po’ ammaccato – non riuscivo nemmeno più a ricordarmi il possibile motivo, con tutte le ‘violenze’ subite nel giro di così poco tempo. Tutto sommato però - tenendo conto di tutte le stronzate che avevo combinato - potevo dire che nel complesso mi era andata anche piuttosto bene. I lividi sarebbero spariti nel giro di una o due settimane; cosa che non si poteva certo dire della rabbia e del dolore che avevo causato in poco meno di un minuto a Carter e Jared. Maledizione, a ripensarci mi veniva voglia di prendermi a calci da solo. Catturai nella mano un pezzo del piumone che ricopriva il letto, stringendolo con foga mentre cercavo le sigarette; sapevo quanto a Ian desse fastidio che lo facessi dentro casa sua, ma m’importava decisamente poco. E sicuramente al suo ritorno sarebbe stato troppo ubriaco per sentire la puzza di fumo impregnata nei cuscini. In quel preciso momento, magari al Sanyo o in un bel locale a Gaslamp, si stavano festeggiando i ventiquattro anni di Elia Harvey. E tutta la famiglia Harding era stata ovviamente invitata; i due coniugi, però, erano dovuti partire in tutta fretta quel pomeriggio per l’Arizona a causa di un problema familiare – non prima d’aver portato i due fratelli a pranzo in uno dei ristoranti più costosi della zona. Così, mentre Ian, accompagnato da Blake, si stava sicuramente godendo la festa, noi abusavamo di casa sua: io e Sal nella camera degli ospiti al piano di sopra e Jared sul divano, di sotto. Non mi rivolgeva sguardo o saluto da quando avevo spezzato un po’ di più il cuore di Carter – quindi, anche il suo – con quell’uscita infelice da vero mostro insensibile che diventavo quando m’arrabbiavo ; e la cosa mi mandava in bestia. Jared era forse l’uomo che stimavo maggiormente sulla faccia della Terra. Suo padre era morto in un incidente d’auto poco prima che lui nascesse, sua madre se n’era andata quando lui aveva solo cinque anni a causa di un tumore, e i suoi parenti più prossimi – degli sconosciuti nel Kentucky – non avevano voluto avere niente a che fare con lui. Da allora, fino ai tredici anni, la sua vita era stata un continuo scappare da una casa famiglia all’altra. Poi era spuntata una vecchia amica universitaria di sua mamma che, appena tornata dalla Francia, si era immediatamente preoccupata di rintracciare il suo ‘nipote acquisito’ e portarlo con lei. Prima a San Francisco, fino ai diciassette anni, e in seguito a San Diego. Rachel – così si chiamava -, era stata essenziale perché Jared raggiungesse l’età adulta con la fedina penale immacolata e senza una mandria di figli illegittimi alle spalle. Erano arrivati a San Diego a Luglio, esattamente il mese in cui la famiglia di Fay tornava lì per le vacanze; Rachel e Jessica, la madre di Blake, si conoscevano un po’, quindi ad entrambe era sembrata una buona idea farci incontrare. Fu per mano loro, che ci conoscemmo. Precisamente non so cosa mi aspettassi da un ragazzo con una tale storia alle spalle; forse qualche notte in cella per rissa – com’era successo a me -, o magari anche droga, spaccio, brutti giri o rapine. Ero pronto a tutto, ma non al uomo diciottenne, intergo e giusto, che mi si era presentato dinanzi quella mattina in piscina. Nonostante i suoi momenti di grande cedimento ai ricordi, alla brutalità con la quale il destino s’era portato via la sua famiglia, Jared Grant si era dimostrato sin da subito essere una gran bella persona; sorridente, lavoratore, giudizioso ed ottimo amico. Con il cuore più grande, forte e pieno d’amore che avessi mai potuto vedere in una persona. Esattamente ciò avrei voluto essere io, quindi l’opposto di com’ero venuto fuori dalla mia altrettanto tragica situazione familiare: stronzo, attaccabrighe, indisponente, manesco e soprattutto arrabbiato. Un barile che strabordava di rabbia e voglia di prendere tutti a pugni perché la vita era bastarda. Per assurdo, però, Jared non mi aveva mai rimproverato niente, nessuna scelta sbagliata o azione avventata. Anzi. Era stato un po’ come l’angioletto buono sulla mia spalla: quello che combatteva contro il diavoletto cattivo che m’istigava alla violenza; quello sempre pronto a consigliarmi – mai insistentemente - nonostante alla fine facessi sempre di testa mia; quello che nei momenti più bui mi ricordava di volermi bene, di quanto ai suoi occhi io apparissi – nonostante tutto – come una bravissima persona, degna d’amore, amicizia, fedeltà e felicità. Jared era stato un po’ come la mia Rachel. E proprio per questo, vedere come il nostro rapporto s’era incrinato da quando avevo scelto di andarmene da mia zia – scelta che lui, dal suo punto di vista, riteneva molto stupida – fino agli episodi dell’altro giorno, m’irritava a morte. Anche perchè, con i suoi lunghi silenzi e gli sguardi risentiti, Jared riusciva sempre a farmi sentire il pezzo di merda più grande dell’intera galassia – non che avessi mai osato affermare il contrario, certo. Ma tutto ciò, assieme alla difficile situazione che si stava creando con Wes, all’imminente scarcerazione di Dante, e i continui litigi con Carter, mi stavano facendo uscire fuori di testa. Forse anche letteralmente parlando. ‘Dio, cos’avevo combinato? Si poteva essere più stupidi di così? “Justin!” La voce bassa di Sal mi arrivò ovattata alle orecchie, ma il tono di rimprovero e irritazione che l’avevano colorata mi convinse a spostare lo sguardo su di lui. Alzai un sopracciglio, togliendomi la sigaretta dalla bocca. “Cosa?” domandai con un punta d’astio, sollevando di poco la testa. A essere sinceri, ce l’avevo anche con lui. Sapevo quanto fosse scorretto scaricargli addosso un po’ della mia rabbia, ma anche lui aveva avuto la sua parte in tutta quella merda. “Smettila” mi ammonì, serio, torcendo le labbra in una smorfia. “Di fare cosa?” “Smettila di pensare alla ragazza” mi disse con tono autoritario, sollevandosi a sedere. “Devi lasciarla in pace. Non merita quello che tu e il fratello le state facendo. E le farete.” Cosa? Scattai a sedere, tirandomi dietro la coperta, che si sollevò sul lato destro del letto. “Che diavolo stai blaterando, Sal?” Lanciai una veloce occhiata a terra, notando come immaginavo che la sua Tennent’s era ancora mezza piena. Ubriaco, quindi, non poteva esserlo – ed era una delle persone che reggeva meglio l’alcool, tra noi. E non credevo ci fosse bisogno di ricordargli chi, in un modo decisamente poco sottile, aveva insultato Carter in macchina. Sal portò le mani all’indietro, spostando tutto il peso del busto su di esse, allungando le gambe sul letto e incrociandole all’altezza delle caviglie; quello era un gran brutto segnale. Quando durante una conversazione Sal cercava di mettersi comodo, significava solo che avremo finito per litigare. Nonostante fosse l’ultima cosa che volevo fare in quel preciso momento, non mi sarei certo tirato indietro di fronte allo scontro. Magari sarei anche riuscito a scaricare un po’ di tensione così. “Lo so a cosa stai pensando, Bieber, e ti sbagli. Voglio solo capire … tentare di far capire a te … di farti ragionare un po’” mi anticipò lui, piegando per un secondo l’angolo della bocca in un sorrisetto divertito. Inarcai le sopracciglia, fissandolo. Se la sua idea di farmi ragionare equivaleva all’impormi di stare lontano da quella ragazza, be’ non ci sarebbe riuscito. Non era un’opzione fattibile né di mio gradimento. Anzi, non era proprio un’opzione da poter prendere in considerazione. Avevo capito da me, nelle ultime tre settimane passate nell’Ohio con la famiglia di Blake, che stare lontano da quella ragazzina non mi riusciva per niente bene; sembrava quasi impossibile. Nemmeno la consapevolezza che con il ritorno di Dante sarebbe venuta a conoscenza della verità su tutto quanto – su di me -, e quanto automaticamente questo l’avrebbe ferita, sembrava funzionare più; per quanto poco mi piacesse quell’idea. “Che intendi, Sal?” “Dante uscirà fra poco, Justin. Certo, Carter non lo saprà fino ad allora, ma davvero pensi sia tanto stupida? Per quanto l’argomento Dante sia tabù in quella casa, la sua voglia di scoprire tutte le carte in tavola andrà oltre il risentimento che prova per il fratello. E allora quanto credi ci metterà ad andare da lui e scoprire tutto quanto? A capire quanto crudele tu sia stato nel tenerle nascoste tutte quelle cose?” Sal non era mai stato il tipo di persona che si soffermava troppo a lungo sulle problematiche altrui, nemmeno quelle che riguardavano me o i ragazzi; il suo voler improvvisamente esprimere la sua opinione sulla faccenda Harvey mi colse di sorpresa. Anche perché voleva significare che, molto probabilmente, le cose mi stavano davvero sfuggendo di mano. E l’idea non mi allettava particolarmente. “Non capisco, Sal.” “Si che capisci, amico. Hai solo bisogno che sia qualcun altro a dirti come stanno veramente le cose, perché ti renda conto che è il momento di prendere una decisione, una volta per tutte” convenne a bassa voce, fissando il soffitto. “Parliamoci chiaro, Justin. Tu sei pazzo di quella ragazzina; forse sei cotto di lei dalla prima volta che hai messo piede in quella casa. E lo capisco, davvero, perché è uno schianto e sembra una ragazza fantastica …” “Woah, woah. Frena amico. Voglio ricordarti che sei stato tu ad insultarla, ieri” lo fermai, confuso. “Perché diavolo hai fatto una cosa del genere allora?” “Perché sapevo che avrebbe sperato tu la difendessi, e sapevo che tu eri troppo immerso nella tua bolla di rabbia per accorgerti del suo bisogno di te, e quindi si sarebbe arrabbiata ancora di più con te per averla illusa d’essere meno stronzo di così” ammise, scrollando indifferente le spalle. A quell’ammissione sentì il sangue salirmi dritto al cervello. “Tu … cosa?” ruggì, alzandomi dal materasso facendolo scricchiolare. Sal rotolò di schiena sul letto, balzando velocemente in piedi; inghiottì un lungo sorso di birra, asciugandosi la bocca con il dorso della mano, e mi appoggiò quella libera al centro del petto per arrestare la mia camminata verso di lui. Prese un altro sorso dalla bottiglia, prima di sbattermela delicatamente addosso e piantare i suoi occhi nei miei, mortalmente serio. “Hai aiutato suo fratello a dare fuoco a casa sua, Justin. Volevi ammazzare quel pezzo di merda di Rick tanto quanto lo voleva lui, e come se la cosa non fosse abbastanza terribile da sé, nell’incendio è invece morta sua madre. Non le avete nemmeno detto che ad ucciderla in realtà è stato Rick, e non suo fratello, dannazione! Per tutto questo tempo le avete fatto credere che il fratello fosse un fottuto assassino! Hai passato gli ultimi due anni in giro per l’America dando la caccia a quell’uomo come un vendicatore assetato di sangue, e sei tornato solo quando era ormai troppo lontano da qui. E non è nemmeno finita qui, cazzo. Per colpa di quel moccioso di Wes stavi per finire dietro alle sbarre anche tu, se non fosse stato per la confessione di Dante che ti ha salvato il culo dalla galera. Non le hai nemmeno confessato – e avresti potuto farlo – che volevi tenerla lontana da Wes perché è un cazzo di ragazzetto scocciato che ficcanasa in cose che non deve. E avresti potuto tranquillamente omettere la parte dove sospetti che quello sciocco l’ha avvicinata solo per mettere il naso nella vita degli Harvey. Per non parlare del fatto che tu e Dante siete, segretamente, in contatto con alcuni vecchi colleghi di tuo zio che tengono d’occhio gli spostamenti di Rick; o che ultimamente il bastardo sembra anche intenzionato a fare una capatina qui a San Diego il giorno in cui Dante verrà liberato. E come se non bastasse, ci si aggiunge il fatto che sia per colpa di Rick che hanno sparato a tuo zio, o anche il perché tu abbia deciso di aiutare Dante nelle sue imprese folli nonostante lui ti abbia chiesto spesso di lasciarlo fare da solo.” Sal prese un gran respiro, continuando ad osservarmi apertamente, prima di ricominciare con il suo fastidioso discorso. “Ci sono così tanti segreti, Justin. Forse sei tu stesso un grande segreto. Il problema, però, è che per quanto tu tenga a quella ragazza, non riesci a scoprire nemmeno un lembo della tua vita per lei. Tu conosci la sua vita, quasi meglio di lei … mentre tu sei un libro vuoto ai suoi occhi. Per questo non riesce a donarti la sua fiducia, adesso, nonostante probabilmente lo voglia davvero. Ed è anche per questo che, appena scoperta la verità, non riuscirà a capirti. Non riuscirà lo stesso a perdonarti, per quanto le tue motivazioni siano valide. E lo so che è difficile, cazzo. Lo capisco. Come puoi dire a una ragazza che le hai distrutto casa? Come glielo dici che tu c’entri tutto, con la piega storta che ha preso la sua vita? Come glielo fai a spiegare che odi tua zia perché ha lasciato entrare nella tua vita tutti quei mostri d’uomini? Come potresti dirle, poi, che vai matto per quel suo visino? Dove troveresti la forza di spezzare il battito del suo cuore, e non curartene? E’ impossibile, maledizione, lo so!” Allargò le braccia all’aria, sembrando comprendere sul serio la mia frustrazione. “Con questo, amico, ti sto dicendo che devi lasciarla stare una volta per tutte. Per il suo bene e anche per il tuo. E questi sono buona parte delle motivazioni che avrebbero dovuto farti capire che questa è la scelta migliore. Per tutti.” “Ci ho provato … ma non ci riesco, Sal …” proruppi, sollevando improvvisamente esausto gli occhi al soffitto. “C’è … c’è sempre, ogni volta che mi convinco ad andarmene, qualcosa che me lo impedisce. Che mi convince a non farlo. E alla fine non lo faccio. Mai. Non ci riesco, Sal. Cazzo, non ce la faccio!” “L’ho capito, Justin. Non ne hai più né la forza né la voglia. Voler bene alle persone, amarle così intensamente sin da subito è sempre stato una tua caratteristica. Sin da quando eri bambino, quando continuavi ad amare incondizionatamente tua zia nonostante tutto quello che ha permesso di facessero. E sei andato avanti così fino a pochi mesi fa, cazzo. E adesso hai ventuno anni.” Si passò una mano tra i capelli, scuotendo la testa. “Ma lei Justin … Carter, fin quando avrà la certezza che le nascondi qualcosa, non vedrà mai quello che prova per te. O non nella sua completezza, almeno. Non ammetterà mai a se stessa, forse anche per orgoglio, che in un qualche momento impreciso hai iniziato a piacerle davvero; che si fida abbastanza di te da non averti ancora tagliato fuori ...” “Arriva al punto, Sal.” lo interruppi ancora. “Avresti già dovuto esserci arrivato da solo” mi riprese, increspando la fronte. “Quando litigate, tirate fuori il meglio e il peggio l’uno dell’altra. Ve ne dite dietro di tutti i colori, con l’unica differenza che tu sai che punti colpire per farle male, mentre lei … va alla cieca. Ma … quanto pensi reggerà questi tuoi sbalzi d’umore improvvisi, che per lei non hanno spiegazione?” Strabuzzai gli occhi, rischiando di strozzarmi con la birra. Fu un attimo, come se la lampadina mi si fosse improvvisamente accesa sopra la testa, e capì: Sal puntava sulle continue liti che vedevano protagonisti me e Carter, e nelle quali – in un modo o nell’altro – io finivo sempre o per farla arrabbiare ancora di più, o per farle del male. E lei non ne avrebbe mai saputo abbastanza su di me per ferirmi come io facevo con lei. Come avevo fatto l’altro giorno. “Ti prego, amico, dimmi che la tua idea di scelta ‘giusta per tutti’ non mi vede come lo stronzo che lentamente, lite dopo lite, le spezzerà il cuore in così tanti pezzettini che le confessioni di Dante le sembreranno una barzelletta …” Speravo, davvero, con tutto me stesso, che Sal non stesse davvero pensando a quello. Non sapevo nemmeno se sentirmi più offeso, incazzato o divertito per quell’assurda idea. Perché era ovvio che non avrei mai fatto una cosa del genere; perlomeno avrei fatto di tutto per impedirmi di continuare a litigare, o dare a lei motivi per farlo. Mi sarei staccato volentieri la lingua a morsi da solo per la cazzata che m’era venuta fuori l’altro giorno; figurarsi anche solo pensare di poterle sputare addosso altre bestialità del genere … volontariamente, per giunta. Sal aprì bocca per parlare - sicuramente per sparare un’altra delle sue perle di saggezza -, ma alcuni tonfi rumorosi dal piano di sotto gli impedirono di far uscire le parole. Probabilmente Jared era ubriaco; e siccome io avrei rischiato un pestaggio a stargli a meno di dieci metri di distanza, toccava a lui scendere e vedere cosa succedeva. “Sai, Justin, un uomo ferito non va da nessuna parte” mormorò a bassa voce Sal, con la mano ferma sulla maniglia della porta. “Una donna ferita, invece, non la trovi più. Neanche se resta.” E uscì, chiudendosi la porta alle spalle senza nemmeno sbatterla. Al che, mi sembrò davvero d’essere rimasto improvvisamente a corto di parole. O fiato, per pronunciarle. Mi limitai a ringhiare, letteralmente, contro la porta chiusa, mollando la presa sul collo della bottiglia – ormai vuota, e, anche se non lo fosse stata, non mi sarebbe importato molto. Sporgendomi sul letto afferrai il telecomando dello stereo, accendendolo; guardando tra la pila di CD che avevo lasciato a Ian, ne afferrai uno contenente una selezione delle mie canzoni preferite dei Linkin Park, a partire dal primo Hybrid Thoery all’ultimo album uscito. Alzai il volume al massimo – o almeno abbastanza da non riuscire a lasciar entrare altro nella testa -, e sulle note di Faint mi chiusi in bagno. Avevo urgente bisogno di una doccia per scacciare via la sensazione d’oppressione che quelle parole avevano poggiato sul mio petto. Lanciando pantaloni e maglietta a terra, m’infilai nel box trasparente, sotto il getto bollente dell’acqua. Non ricordavo in quale punto preciso del discorso di Sal, ma ogni muscolo che sapevo d’avere in corpo si era irrigidito; il cuore batteva in modo talmente lento, con dei colpi forti e profondi, che mi sembrava quasi di non sentirlo più. Sui palmi delle mani avevo ancora la forma a mezzaluna delle unghie, che avevo tenuto conficcate nella carne per tutta la durata di quella conversazione. A dimostrazione di tutto ciò, sentì immediatamente i benefici dell’acqua calda che scorreva velocemente sul mio corpo. La mia mente era però ancora annebbiata dai troppi ricordi che quelle parole avevano riportato a galla in pochi minuti. Erano tutte cose – a malincuore vere – che sapevo già; mi ripetevo un discorso simile in testa quasi ogni giorno,nella speranza di trovare una possibile soluzione tra quelle parole. Ma niente. Sembrava non esserci via d’uscita, se non quella che implicava il dolore della sorellina degli Harvey. Ed era quello il punto, il nocciolo della questione. Per quanto potessi sperare che, fornendole le motivazioni che m’avevano spinto a pianificare l’assassinio di quel pezzo merda – perché era così che avremmo dovuto chiamarlo - avrebbe potuto in qualche modo capire, sapevamo tutti che in realtà non sarebbe mai potuto succedere. Il cuore di quella ragazza si sarebbe definitivamente sbriciolato, a causa mia, dei suoi fratelli, dei suoi amici e delle persone che le stavano intorno – nessuno escluso, nemmeno Keaton. E non tanto per la brutalità e l’immoralità di ciò che io e il fratello volevamo e avevamo fatto, piuttosto per tutte le bugie su cui aveva piantato la sua fiducia nei suoi amici; da quanto avevo capito lei faticava davvero tanto a fidarsi delle persone. E quando poi ci riusciva lo faceva per davvero. Senza limitazioni. Così la verità l’avrebbe investita come uno Tsunami, e non ci sarebbe stato modo alcuno per prevederlo, o evitarlo. Il suo cuore sarebbe scoppiato tutto d’un colpo, assieme a lei. “Oh, maledizione!” bofonchiai frustrato, tirando un pugno contro le mattonelle color biscotto del muro; sentì istantaneamente il dolore espandersi lungo tutto l’avambraccio, distraendo così il mio cervello – per dei brevissimi secondi – da tutta quella merda. Lasciai uscire un altro verso lamentoso, colpendo di nuovo le mattonelle. Frustrato, mi tirai i capelli verso l’alto, chiudendo l’acqua con un colpo di gomito alla manopola. Avevo bisogno di un’altra birra, in quel momento. Alcool e sigarette. O magari una scazzottata con Sal o Jared. Qualcosa in grado di farmi scaricare completamente la tensione almeno per quelle ultime ore della notte. Mi passai un asciugamano su gambe e braccia, asciugandomi alla bell’e meglio, per poter uscire da lì senza rischiare di bagnare il pavimento. Frizionai i capelli con un asciugamano pulito, lasciandomi la porta del bagno aperta alle spalle per non far concentrare il vapore creato dall’acqua calda solo in quella stanza. “O mio Dio! O mio Dio! O. Mio. Dio! Porca miseria!” Sobbalzai sul posto a quelle urla inconfondibilmente femminili – anche perché nessuno dei ragazzi avrebbe avuto da urlare così nel trovarmi nudo in camera. Scostai l’asciugamano dalla faccia, solo per scorgere la schiena completamente nuda e sensuale di Carter di fronte a me, intenta ad affondare goffamente la faccia nelle mani, continuando quella cantilena di ‘o mio Dio’ e imprecazioni a bassa voce. Ebbi l’impressione che il cuore avesse fatto un balzo, come a voler uscire dal petto, nel vedermela per davvero lì davanti – anche perché avevo già previsto di non riuscire a rivederla per un bel po’ di tempo. Scivolato via lo stupore iniziale di trovarmela dinanzi agli occhi, ridacchiai divertito mentre tiravo sulle gambe un paio di pantaloni grigi; la pelle non del tutto asciutta ne bagnò la stoffa in alcuni punti, ma ignorai quella fastidiosa sensazione. Carter veniva evidentemente dalla festa di suo fratello, anche abbastanza alticcia visto il suo continuo traballare sui tacchi gialli che portava ai piedi: indossava solo dei jeans strappati arrotolati sulle caviglie e un top leggero, nero, che le sarebbe scivolato via mostrando le sue grazie a chiunque se non fosse stato legato sul dietro, alla base del collo, da un laccetto minuscolo e quasi invisibile. La lunga coda rosa le scivolava su un lato della spalla, lasciando in bella mostra le curve gentili e femminili di collo e spalle. Era … maledizione, era maledettamente bella, ed improvvisamente il sangue che prima mi era salito al cervello virò molto, molto più a Sud. “Carter, sono coperto adesso” la avvisai, schiarendomi la voce con un colpo di tosse, avvicinandomi silenziosamente alla sua schiena. La vidi chiaramente sobbalzare nel sentirmi così vicino, ma dubitavo potesse anche essere un riflesso involontario causato dall’alcool. Completamente rossa in volto abbandonò comunque le mani sui fianchi, guardandomi finalmente in faccia con l’espressione imbarazzata più carina e divertente che avessi mai avuto occasione di vedere su una persona. “Io … ehm … dovevo tornare a casa per lasciare Elia con i suoi amici ma ho dimenticato le chiavi. E siccome Oliver m’aveva dato una copia di quella di casa loro, mi è sembrato meglio fermarmi qui che tornare al Sanyo. Non … non sapevo ci fosse già qualcuno … che ci fossi tu qui in questa camera … sc … scusa … insomma, non volevo sorprenderti … così …” Era decisamente più che alticcia, constatai, abbozzando un sorriso al suo straparlare balbettando. “Ehi, ehi, tranquilla. Non è successo niente” tentai di rassicurarla senza scoppiare a ridere, chinandomi verso il bordo del letto per afferrare la bottiglia d’acqua e progergliela. “Bevi.” Lei strabuzzò gli occhi, guardandomi accigliata. “Ho visto il tuo pacco, dannazione. Si che è successo qualcosa!” sbottò impacciata, allargando le braccia piccole. “Credo che non mi riprenderò mai più!” Vista la sua instabilità e avendo la bottiglia piena in mano che la sbilanciava, incespicò nelle scarpe rischiando di cadere di sedere a terra; la risata mi morì sul nascere. D’istinto, mentre le sue braccia si allacciavano al mio collo, mi chinai per far passare un braccio attorno alla sua schiena, tenendola stretta a me. La bottiglia cadde a terra con un tonfo sordo, che a malapena riuscì ad udire. “Sai, dovrei abbandonarti in mezzo alla strada come hai fatto tu con me quella volta al locale” la schernì, raddrizzando la schiena, assicurandomi che non si fosse fatta male alle caviglie visti i tacchi omicidi che indossava. Carter, involontariamente, si strinse ancora di più a me; aveva le mani infilate tra i miei capelli bagnati, e pian piano aveva affondato completamente la faccia nell’incavo del mio collo, respirandomi profondamente sulla pelle appena lavata della schiena. “No, non dovresti” protestò lei flebilmente, con le labbra terribilmente vicine al mio orecchio. Mandai giù il groppo che mi si era formato in gola, affondando di riflesso le dita nel suo fianco. “Ah no? E perché?” domandai, con la voce più bassa e roca di quanto mi aspettassi. Mandai di nuovo giù la bile, ispirando il suo profumo: un misto pungente di alcool, sigarette, profumo da uomo e ragazza che io adoravo su di lei. Forse ero anch’io un po’ alticcio, perché sentivo che la mia testa stava iniziando a vagare verso un punto di non ritorno; non sapevo quanto ancora sarei riuscito a controllare i miei istinti se non si decideva a scostarsi – non che il suo calore contro la mia pelle bagnata mi dispiacesse. Carter esalò un lungo respiro, iniziando a scostare la testa dal mio collo; con un movimento maledettamente lento scivolò all’indietro, strofinando la sua guancia contro la mia mentre giocherellava con le punte corte sulla mia nuca. Allineò la sua bocca alla mia, alla pericolosissima ed eccitante distanza di qualche millimetro, buttando l’aria sul mio collo; mi lanciò uno sguardo stralunato, mordicchiandosi il labbro. “Perché io ti piaccio” sussurrò impercettibilmente, lasciando vagare il suo sguardo per la mia faccia – quasi come fosse stupita di se stessa nell’avermi detto una cosa del genere. Spalancai gli occhi, stringendo ancora di più la sua carne morbida, respirando a fatica. Carter ubriaca era decisamente … intraprendente. “Quindi io non ti piaccio?” Instabile, si mosse insofferente ed inconsciamente contro di me. “Maledizione!” grugnì, pizzicandole la schiena per tenerla ferma. Non sarei riuscito a resistere ancora per molto, me lo sentivo. Lei s’inumidì la bocca con la lingua, puntando i suoi occhioni scuri e lucidi nei miei. “Non … lo so, Justin. Non ci capisco più niente da un bel pò” ammise tentennante e totalmente sincera. Cristo, quanto si sarebbe pentita di quelle parole il giorno dopo – se le avesse ricordate. E forse per la sincerità che le riempì lo sguardo per un brevissimo attimo, o forse per l’ammissione in sé - mentre continuava ad accarezzarmi la guancia con la sua -, o forse perché era riuscita a spostare involontariamente l’attenzione della mia mente su qualcos’altro, ma percepì chiaramente il cervello andarmi in cortocircuito. E non fu solo il mio a mandare scintille. Non so se il primo a cedere fossi stato io, o lei, o se avessimo letto il desiderio negli occhi dell’altro contemporaneamente, fatto sta che potevo riassaporare di nuovo la morbidezza e la dolcezza delle sue labbra attaccate alle mie. Quella ragazzina riusciva a trascinarmi in un mondo a parte, fatto di passione, sorrisi, liti e rabbia, dal quale sentivo però di non voler uscire per il resto della mia vita, se lei sarebbe rimasta con me. Sentì Carter sorridere dolcemente contro di me, mentre le mordicchiavo il labbro per farle aprire la bocca per me; circondandole la schiena con entrambe le braccia feci scivolare piano le mani nelle tasche dei jeans, stringendomela talmente tanto al petto che per un attimo mi sembrò di sentirla smettere di respirare. Avevo il cervello ed i pensieri, finalmente e meravigliosamente, spenti. E non m’importava più di nulla: della musica in sottofondo, dei ragazzi al piano di sotto o del nostro stato d’ebbrezza; della lite il giorno prima, del fatto che avremmo dovuto parlare prima d’avere un approccio come quello, da lucidi, o che molto probabilmente se ne sarebbe pentita non appena tornata lucida. Sapevo e contava solo che, per Dio, la stavo baciando. E mi sembrò che il cuore le fosse restato sulle labbra. ___________________
Mi svegliai di soprassalto, spaventato, quando dei rumori assordanti – qualcosa di simile alla musica – mi arrivarono dritti alle orecchie. Mi guardai intorno per alcuni secondi, confuso, passandomi ripetutamente la mano sulla faccia. L’occhio mi cadde sulla radiosveglia sul comodino: segnava a malapena le otto del mattino. Sbuffando, mi misi a sedere sul bordo del letto, infilandomi le mani nei capelli; con disappunto notai che il resto del materasso era vuoto, senza nessuna figura femminile distesa sopra, come ricordavo fosse la notte precedente prima che chiudessi gli occhi. Speravo solo che non se ne fosse andata o che, tornando, Ian l’avesse vista - così sì che avrei rischiato un’altra bella dose di percosse. Alzandomi mi trascinai fuori dalla camera, continuando a strofinarmi gli occhi per riuscire a tenerli aperti; ultimamente non ero più abituato a svegliarmi così presto, ed ero certo che mi sarei portato dietro quella stanchezza. Se non per tutta la giornata, almeno per buona parte. Affacciandomi sul corridoio, riuscì a riconoscere il mio CD dei Linkin Park suonare ad un volume decisamente troppo alto per quell’ora e un invitante odore di dolce e cioccolato aleggiare per casa. Con l’avvicinarmi alla cucina, tra le molteplici voci che mi arrivavano alle orecchie, fui in grado di riconoscerne una in particolare: Carter. E mi lasciai sfuggire un sospiro di sollievo nel constatare che non era scappata a gambe levate, come avevo immaginato nelle mie peggiori ipotesi – quella che più temevo era lo svegliarmi con lei che mi prendeva di nuovo a pugni, probabilmente. Anche perché da quanto avevo visto ero certo ne sarebbe stata perfettamente capace. Scendendo l’ultimo scalino, mi affacciai alla cucina, poggiandomi con la spalla allo stipite della porta: Sal, Blake e Ian sedevano attorno al tavolo, con dei piatti pieni di frittelle e fragole sotto al naso che fumavano ancora; Carter mi dava le spalle, vestita di una felpa grigia e un paio di pantaloni da basket di Ian arrotolati sulle cosce. Muoveva i fianchi al ritmo della musica, mentre sfornava una frittella dopo l’altra in un altro piatto al suo fianco, apparentemente di buon umore. Jared era poggiato, in boxer, al piano della cucina. Braccia incrociate al petto e un’espressione rilassata, chiacchierava allegramente con lei, ridacchiando ogni tanto per chissà cosa diceva. Mi sembrò quasi di sentire un fitta di gelosia scuotermi il petto, alla vista di quella scena così serena e felice che avevano creato da soli, e che un tempo colorava molto più spesso le mattinate mie e dei ragazzi, mentre cercavamo di cucinarci qualcosa. E mi venne improvvisamente voglia di girare i tacchi e andarmene da lì, per non rischiare di rovinare tutta quell’allegria con la mia sola presenza. Come d’altronde facevo da un po’ di tempo a quella parte. Prima che potessi farlo davvero, come se avessi espresso quei pensieri con un altoparlante, Jared spostò lo sguardo da Carter – continuando a parlarle – per scontrarsi con il mio. Fece per aprire bocca e venirmi incontro, ma lo fermai, mimando un ‘no’ con la bocca in sua direzione cercando di passare inosservato. Ma, di nuovo, mi sembrò d’avere urlato, perché i ragazzi alzarono gli occhi e s’accorsero della mia presenza. L’unica che sembrava non averlo ancora fatto era Carter, fortunatamente. Avevo bisogno di un altro po’ di tempo per svegliarmi del tutto e riuscire così ad affrontare la sua furia- Mi mordicchiai l’interno della guancia, inchiodato lì sulla soglia della cucina dai loro occhi così familiari, in attesa del verdetto finale di tutti loro; se m’avessero rifiutato – ‘Dio, non riuscivo nemmeno a pensarlo – non sapevo esattamente cos’avrei potuto fare. Come mi sarei potuto sentire dentro. E non era una cosa che, sinceramente, avrei mai voluto scoprire. “Ehi, Principessa” fu sorprendentemente Jared a parlare per primo, rivolgendosi a Carter con un sorriso, mentre Ian abbassava la musica dello stereo perché potessimo sentire tutti. “Ti va di farne un altro giro?” La ragazza piantò un’altra frittella sul piatto, afferrandolo in mano e voltandosi verso il tavolo con aria confusa, permettendomi di guardarla per la prima volta quella mattina. Aveva i capelli legati in modo disordinato sulla testa, le guance rosse e sotto gli occhi un po’ di residuo del trucco, ma era comunque dannatamente bella. Non appena i suoi occhi si posarono su di me, la vidi sobbalzare impercettibilmente, mentre una sfilza di emozioni indefinite le sfumavano negli occhi grandi; nonostante la probabile furia che covava nei miei confronti, non riuscì però ad impedire alle sue guance di farsi ancora più adorabilmente rosse e gonfie. E con quello capì che si ricordava dei baci di ieri sera. E delle parole. I ragazzi afferrarono il proprio piatto in mano e, lasciando un bacio di ringraziamento sulla testa della ragazza, sparirono in soggiorno. “Jared .. ” mormorai a bassa voce, con l’intenzione di scusarmi con lui, quando si fermò di fianco a me battendomi la mano sulla spalla. “Lo so, ragazzino, lo so” mi anticipò flebilmente lui, dandomi una pacca amichevole e pacifica sul collo. “Solo … non rovinare tutto.” Mi spintonò dentro la cucina, chiudendosi la porta alle spalle con uno strano sorriso sulla bocca, lasciando me e Carter soli nel silenzio più imbarazzante e teso possibile. Mi passai una mano tra i capelli, dando dei colpetti al muro dietro di me con le nocche della mano per scaricare le emozioni. Ero io quello che doveva scusarsi, lo sapevo, ma non sapevo nemmeno da quale parte iniziare a parlare. Fosse stato per me avrei tenuto la bocca chiusa, o l’avrei usata per baciarla di nuovo e farle sentire così quanto mi dispiaceva per tutto, per non rischiare di rovinare di nuovo tutto con la mia boccaccia larga. Carter sembrò la prima a non riuscire più a reggere quell’atmosfera, però. Sedendosi sul piano del tavolo, divise le frittelle appena fatte su due piatti, ricoprendole di cioccolato e fragole; voltandosi ne fece scivolare uno verso di me con un sorriso appena abbozzato sulle labbra morbide. “Io non ce la faccio più, Justin” sussurrò incerta, infilzando la sua colazione con le punte della forchetta. “Non ci capisco più niente. Tutti questi segreti, tuoi e di Dante … tu, io e te che un giorno litighiamo e l’altro pure, ma poi finiamo sempre … uhm … con il baciarci o il dormire insieme come se niente fosse successo …” “Carter … io … mi dispiace, lo sai … ” “No, aspetta” alzò una mano, bloccandomi; le dita le tremarono leggermente in aria. “Mia madre è morta. Mio fratello è … è … non so nemmeno come definirlo. Mio padre non so nemmeno se sia vivo. I miei parenti sono spariti nel nulla. Rick … Rick non smette di darmi il tormento, nonostante sia lontano da un pò. E tu … maledizione, Justin, tu complichi sempre tutto. Certe volte mi … mi fai sentire anche bene, con tutte le scemenze che dici o fai … ma le altre volte mi sembra quasi che tu ci trovi gusto nel rovinare sempre tutto. Facciamo un passo avanti e venti indietro. Io non l’ho nemmeno voluto tutto questo. Sei entrato nella mia vita per chissà quale motivo e non ne sei voluto più uscire, nonostante tutto. E ci può anche stare, in un certo senso, okay? Ma … non così. Non in questo modo dove alla fine quella che ci rimane sempre di merda sono io.” Teneva lo sguardo fisso su di me e nient’altro, e sembrò non accorgersi che pian piano mi stavo avvicinando a lei. “Io non ce la faccio più con questo ritmo, Justin. Vorrei … vorrei solo un po’ di tranquillità per godermi questo periodo dove tutto sembra andare per il verso sbagliato. Gli ultimi nove anni sono stati infernali, e vorrei che la serenità che avevo riacquistato negli ultimi due potesse tornare. Non voglio più sentire urla uscire dalla bocca di nessuno; non voglio più arrivare a pensare che le cose potrebbero arrivare a degenerare a tal punto; semplicemente non voglio più sentirmi come mi sentivo in quel periodo. Cerco solo un po’ di … tranquillità. Almeno fin quando non … lui non uscirà di prigione, ecco. E con questo non sto dicendo che devi lasciarmi in pace, perché ormai l’ho capito anch’io che è impossibile che tu lo faccia. Ma … non sono tanto cretina da non aver capito che … che … che, si, insomma, c’è qualcosa … tra … tra me e te. Cioè, no, magari sono abbastanza idiota in questo campo, ma le persone attorno a me no quindi … capisco in fretta le cose, una volta che mi vengono poste da una diversa prospettiva. Dai, ho quasi diciotto anni e non riesco a godermi la mia adolescenza, adesso che finalmente quel mostro di Rick non me la può più rovinare, senza stare costantemente sull’attenti. E’ una cosa .. così ridicola, Gesù. Mi sento così stupida, certe volte, nel dubitare così tanto delle persone. Nemmeno fossi a conoscenza che qualcuno vuole ammazzarmi, cazzo. Ma … è così difficile. Non fidarsi di nessuno, intendo. E’ così maledettamente doloroso, certe volte. E’ una cosa che mi porto dietro da sempre, e se poi una delle figure maschili più importanti nella mia vita mi distrugge così … be’, le cose si complicano ulteriormente.” Si lasciò sfuggire un sorriso amaro al ricordo del fratello, spostando una ciocca di capelli dietro l’orecchio. “Sono quelle cose che ti segnano dentro, alcune volte per sempre. E non so se questa mia mancanza di fiducia è una di quelle che non guariscono mai …. ma …” S’interruppe, e non so se per trovare le parole o perché s’era accorta che le ero ormai davanti. Avevo fatto di tutto per non fare troppo rumore, così da permetterle di esprimersi senza interruzioni, in piena libertà. E avevo capito che, in realtà, mi piaceva un sacco ascoltarla parlare; così, senza urla e maledizioni per me. Le allargai le gambe, abbastanza da potermici infilare in mezzo, abbandonando le mani sulle sue cosce calde. Ne mossi una per prenderle il mento tra le dita, sollevando la sua testa verso di me: si mordicchiava insistentemente il labbro inferiore, e aveva gli occhi troppo allargati per la vergogna. Non riuscì a non sorridere a quella visione. “Cosa vuoi dirmi, piccola Harvey? A parole tue, Carter. Dillo a parole tue, non c’è problema” tentai di rassicurarla. Volevo davvero che finisse di parlare, per sapere la sua … decisione. Era così strano che si stesse aprendo di sua spontanea volontà con me, rivelandomi i suoi veri pensieri e permettendomi di capirla un po’ meglio; non potevo negare quanto piacere mi facesse la cosa, ma allo stesso tempo mi sentivo dannatamente stronzo e in colpa perché ero certo che io non sarei riuscito a fare lo stesso con lei. Non in quel momento, almeno. Più del porgerle le mie scuse ed accettare le sue scelte, non avrei potuto fare. Non ero ancora pronto per parlare di me, del mio passato, della mia infanzia, della mia vita; nemmeno con lei. Dovevo prima riuscire io a farci i conti, se mai ne fossi stato davvero in grado; smettere di lasciarmi influenzare dalla mia famiglia era stato un primo, piccolo passo, e andarmene da casa di mia zia il secondo. Ma … me ce ne sarebbero voluti molti altri prima che mi sentissi davvero in grado di confessare a qualcuno quello che era successo in realtà tra quelle mura mentre mia zia giaceva ubriaca o fatta nel suo letto. Era un qualcosa di ancora troppo fresco e ardente, per permettere a qualcuno di provare a lenirla senza che rischiasse d’esplodere al primo impatto. Tornai alla realtà quando Carter mi pizzicò il mento, contrariata della mia poca attenzione. Merda. Ecco che rischiavo di nuovo di fare qualche cazzata. “Cazzo, mi dispiace Carter” Lei inclinò la testa di lato, guardandomi seria. “Va tutto … bene, Justin?” “Eh?” “Sei … per un momento mi è sembrato …” Scosse la testa, ridendo di se stessa. “Niente.” Fallo, dannazione, avrei voluto urlarle. Guardami. Ma qualcosa, sempre la stessa indefinita sensazione, m’impedì di parlare ad alta voce. Mi limitai a sorriderle, nel modo più vero che riuscì a trovare, accarezzandole il collo; e poi sempre più giù, lungo tutta la spina dorsale. “Continua, per favore.” “Io …” biascicò, titubante, arricciandosi le dita in grembo. “Io … insomma … credo di … di poterci provare … a … a dimenticare quella parte della tua vita che ha a che fare con Dante. Almeno per un po’. Penso … si, insomma, sto dicendo che … potremmo ricominciare da .. uhm … capo?” Avevo capito. Perfettamente. Non riuscì a trattenermi e mi chinai, baciandole di nuovo le labbra; lucido, consapevole, e fottutamente egoista, come mio solito. Perché in quel momento, se avessi avuto un minimo di buon senso, l’avrei fermata; le avrei detto di star zitta e avrei impedito che prendesse quella scelta disastrosa – ma allo stesso tempo magnifica. Avrei dovuto dirle la verità, dirle che non m’importava niente o andarmene. Istigarla al litigio, come aveva consigliato Sal, o far finta di niente mangiandomi la colazione. Addirittura spezzarle il cuore in quello stesso istante. Tutto pur di non farle fare quel madornale sbaglio, che alla fine l’avrebbe uccisa davvero; se prima avevo qualche dubbio, in quel momento erano tutti svaniti nel nulla: io le avrei spezzato il cuore, e non solo per quello che avevo fatto con suo fratello. Ma, da grande stronzo egoista e codardo che non ero altro, non lo feci. Scacciai via quei pensieri e mi concentrai su di lei; su quanto bene mi facesse sentire sempre, quando mi portava fuori dal mio mondo di demoni succhia sangue che non mi davano tregua. “Dovremmo farlo, sai ?” le dissi, passandole una mano tra i capelli per scioglierli sulle spalle in una cascata rosata. “Cosa? Mangiare la nostra colazione? Si, sono d’accordo” parlò in fretta, cercando di sfuggire al suo imbarazzo di quel momento, chinandosi in fretta verso il piatto per infilarsi un enorme boccone in bocca. “No, uscire insieme.” Cazzo, ero davvero un gran bastardo. Writer's corner: Okay, per l'ennesima volta in ritardo, lo so. E probabilmente il capitolo fa anche tanto schifo. L'ho finito da poco e ho avuto anche poco tempo epr rileggerlo, quindi mi scuso anche in anticipo per eventuali errori - che provvederò a correggere al più presto. Purtroppo però mi sono trovata costretta a pubblicarlo così in fretta perchè ultmimamente il computer mi sta dando un pò di problemi ,quindi domani dovrei portare a farlo vedere e non so per quanto non l'avrò. Potrebbero essere un paio di giorni come delle settimane, per cui ho aggiornato adesso con la speranza che non sia niente di grave. Anyway, il capitolo è ... non so, intenso? E' dal punto di vista di Justin, dopo un bel pò che non lo facevo. E ci sonoa nche molti più dettagli sui suoi segreti. E anche degli indizi per capire la sua vita privata, il suo passato con sua zia. Che non è così scontato come sembrava all'inizio, con la solita zia ubriacona. E' qualcosa di un pò più complesso, che spiegherà anche il suo caratteraccio in certe situazioni. Poi c'è anche la storia di Jared, dalla quale si capisce perchè abbia dato un pugno a Justin alla fine dellos corso capitolo; insomma, anche lui è cresciuto senza padre quindi si è sentito toccato e deluso quando Justin ha detto quella frase a Carter. Quindi ha reagito così. E infine c'è l'arrivo di Carter. Be', la parte sui loro due insieme preferisco la commentiate da voi. Nel prossimo capitolos i capirà anche perchè la ragazza ha questo apparente e improvviso cambio d'idea nei confronti di Justin, nonostante le sue perplessità rimangano, eh. Ma, comunque, prima o poi ci doveva essere una svolta, no? E volevo anche rendere le cose un pò più semplici, almeno per un capitolo; senza liti e urla. E, bo, non so cosa ne pensiate. Non ho la minima idea di cosa ne sia venuto fuori, quindi sta a voi giudicare, come sempre. Ma spero comunque che sia piaciuto, almeno un pochino lol. Adesso però mi sa che è anche il momento che mi dilegui. Quindi, alla prossima, spero. Baci☺♥ |
Capitolo 22
*** 21. Issues and fury. ***
 21. Carter Justin, al mio fianco, grugnì rumorosamente, tirandomi il braccio per non farmi finire contro qualche passante. “Ma fai sul serio, Harvey?” protestò contrariato, cercando di mantenere in equilibrio la vaschetta di patatine e la birra nella mano sinistra. “Diamine, non avrei mai pensato che Raffaello sarebbe piaciuto ad una ragazza più di me.”
Accennai un sorrisetto divertito in sua direzione, continuando a scorrere la galleria delle immagini sul suo cellulare. “Cavolo, gli hai fatto un intero book fotografico, Bieber” lo punzecchiai, strattonando giocosamente la sua mano intrecciata alla mia. “Non hai niente di meglio da fare, il pomeriggio?” “Dici che devo iniziare a preoccuparmi di qualcosa?” continuò lui imperterrito, alzando teatralmente gli occhi al cielo. “Cazzo, Ian mi prenderà in giro a vita se dovesse venirlo a sapere.” “Cosa? Che preferisco passare la serata a guardare le foto della tua tartaruga piuttosto che prestare attenzione a te?” “Si, cavolo!” sbottò frustrato, conficcandomi le dita nel palmo della mano. “E ti ho anche portata da Hodad’s(*). Come minimo saresti dovuta saltarmi addosso già venti minuti fa …” Scoppiai a ridere, distogliendo lo sguardo dallo schermo del telefono per spostarlo sulla sua espressione imbronciata ed infantile. “Oh si, Ian ti prenderà in giro per il resto dei tuoi giorni per questo” infierì ancora, lanciando il suo iPhone nella borsa. Mi allungai oltre il suo petto e afferrai la bottiglia di birra, liberandogli la mano da quel impedimento; ne presi un lungo sorso, osservando le luci colorate che illuminavano ogni tratto delle strade affollate di Gaslamp. Era passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta che Elia mi ci aveva portata, e in quel momento mi sembrava di vedere per la prima volta quella parte bellissima di San Diego. Justin s’infilò due patatine ricoperte di maionese in bocca, gettando la vaschetta ormai vuota; mi sorrise sicuro, prendendomi di nuovo la mano. “Ma Ian non lo saprà mai” ghignò, sporgendosi con il collo verso di me; gli avvicinai la bottiglia alla bocca, permettendogli di bere. “Cosa ti fa pensare che io non glielo racconterò?” Il suo sorriso sembrò allargarsi ancora di più, mentre si chinava per stamparmi un bacio veloce sul collo. “Se lo farai, io gli dirò che sei stata tu a rompere la sua maglia autografata da Kobe Bryant(*)” mi guardò, sbattendo innocentemente le ciglia. Strabuzzai gli occhi, schiaffeggiandogli il braccio. “Non oseresti!” “Mettimi alla prova, tesoro.” Lo colpì di nuovo, non riuscendo a contenere una risatina divertita. “E’ stato un incidente! Nessuno mi aveva detto che era così importante!” borbottai sconsolata, scuotendo la testa. “E’ colpa mia se non sai un bel niente di basket?” ribatté vittorioso, sollevando le sopracciglia per prendermi ancora in giro. “Che razza di amico ti sei scelta che non ti ha già portata a vedere una partita?” “Keaton gioca a football e va pazzo per i Giants(*). Elia è tifoso dei San Diego Chargers(*) da una vita. E il padre di Ian stravede per i Pittsburgh Steelers(*)” risposi stizzita, inarcando le sopracciglia in sua direzione. “Ti basta, come risposta?” Justin sollevò le braccia all’aria in segno di resa, avvicinandomisi furtivamente con passo strisciante; allungò le mani in avanti, verso di me, costringendomi ad indietreggiare fin quando la superficie fredda di un palo della luce contro la mia schiena non me lo impedì. Bevvi l’ultimo sorso di birra rimasto, lasciando cadere la bottiglia nel cesto a qualche passo da noi, mentre lui mi circondava agilmente la vita. “Che c’è?” gli domandai confusa, seguendo la traiettoria del suo sguardo, fisso sui miei piedi scoperti dai sandali bassi. Scrollò le spalle, ammiccando. “Niente … hai piedi sexy Harvey.” “Hey!” sbottai stralunando gli occhi, picchiandogli il braccio. “Smettila di sbavare sui miei piedi!” “Bene! Fammi sbavare su qualcos’altro, allora!” ribatté ancora lui, sfoggiando un sorrisetto maligno. Avvicinò il volto al mio e mi leccò giocosamente la guancia, scendendo a mordicchiarmi il mento; sentivo il suo petto vibrare, scosso dalle risate, mentre tentavo in vano di spingerlo via. “Andiamo, Bieber, sei disgustoso!” gracchiai stizzita, pizzicandogli violentemente il collo – come del resto era solito fare lui con me. “Siamo in vena di complimenti stasera, eh?” Justin aumentò la stretta delle braccia attorno a me, continuando a mordicchiarmi il mento per tutto il suo breve profilo; lentamente, risalì verso l’altro, intrappolando il mio labbro inferiore tra i suoi denti. La mia mano era ancora ferma nel punto in cui l’avevo lasciata, sul suo petto; potevo sentire il battito irregolare del suo cuore battere contro il mio palmo come se non ci fosse impedimento di alcun tipo tra loro. “Justin …” lo richiamai flebilmente, roteando gli occhi al cielo. Immediatamente mollò la presa sul mio labbro, iniziando a baciarmi molto lentamente la bocca; schiacciò un bacetto all’angolo, scivolando man mano sempre più a sinistra verso l’altro. “Lo so che non ti piacciono queste effusioni davanti a tutti … “mormorò, carezzandomi la schiena con le dita. Si sollevò sul labbro superiore e ripeté il passaggio: lentamente e dolcemente da sinistra a destra, bacio dopo bacio. “Ma, davvero, per favore, non chiedermi di non baciarti. Adesso. In questo preciso istante ..” I suoi occhi, luccicanti sotto il bagliore delle luci colorate, inchiodarono senza alcuna via di fuga i miei; aprì bocca per dare forma e voce a una risposta, non sapevo nemmeno per dire cosa, ma venni bloccata da un paio di labbra morbide che abbracciarono bramose le mie. Sentii il mio respiro accelerare per poter prendere il ritmo del suo, e prima che potessi anche solo provare a controllarlo, il mio corpo reagì – come se dotato di vita propria, in grado di fare al momento quello che io avrei fatto dopo minuti di riflessioni e paure da sconfiggere – ricambiando quel bacio. Sopra il rumore del sangue che mi scorreva a velocità moltiplicata nelle vene, riuscivo a sentire il mio cuore ed il mio cervello urlarsi contro pensieri contrastanti – come sempre quando Justin mi baciava. Erano sempre un susseguirsi di ‘smettila’, ‘non fare la stupida’, ‘non farti abbindolare dal suo bel faccino’, ‘ti rovinerà la vita’, che poi si ricongiungevano in un breve e convincente ‘lasciati semplicemente andare’. Dovevo ancora abituarmi del tutto all’idea del … si, insomma, del ‘frequentarci per vedere cosa ne viene fuori’ – soprattutto sulla sua parte più fisica. Ma l’ultimo mese era stato davvero, davvero fantastico sotto ogni punto di vista; dopo un lasso di tempo che m’era sembrato un’eternità potevo finalmente concedermi il lusso di credere che la ruota avesse iniziato a girare per il verso giusto. E se in quel pacchetto di tranquillità e semplicità era inclusa la presenza di Justin, in quel modo … be’, non avrei avuto nulla in contrario. Non più – visti i precedenti. E non al momento, almeno. Perché, per quanto stessi cercando con tutta me stessa di mettere da parte il passato e tutti i suoi bagagli a mano, in alcuni momenti davvero non riuscivo a far finta di niente; i dubbi, le paure, la rabbia … tornavano sempre all’attacco. Arrivavano tutti insieme, in gruppo; piano e in silenzio. Mi entravano dentro fino in fondo, tra gli spazi delle ossa, devastanti. Potevo sentirli che ispezionavano ogni singola cellula del mio corpo per farmeli ricordare; non mi lasciavano mai completamente indifferente, come se non volessero farsi dimenticare del tutto. Li sentivo sempre presenti, sull’attenti, in agguato nelle parti più remote e inesplorate di me stessa, come un plotone addestrato dell’esercito nel bel mezzo di un’operazione militare. E quando arrivavano quei momenti, quando riuscivo a sentirli: vivi, muoversi dentro di me … era allora che smettevano di nascondersi e iniziavano a torturarmi. Iniziavano a correre da un parte all’altra del mio corpo, sempre più su, fino a raggiungere la testa; mi entravano nel cervello e sembravano avere tutte le intenzioni di non voler più uscire. Quando poi riuscivo a scacciarli, non ero in grado di metterli a tacere del tutto; non dormivano mai, sempre con un occhio semiaperto, pronti a ritornare all’attacco. Come fastidiose zanzare assetate di sangue. Quelli erano decisamente i momenti peggiori; mi facevano solo venir voglia di urlare contro Justin tutto quello che sentivo, insultarlo e farla finita con tutta quella merdata dei segreti tra lui e mio fratello. E la consapevolezza che qualunque cosa avessi fatto, lui comunque non avrebbe aperto bocca, non faceva altro che peggiorare la situazione. Avevo rischiato più volte, nelle ultime settimane, di scoppiare; mi sentivo quasi come un marchingegno ad orologeria pronto a saltare in aria da un momento all’altro. Ma poi c’era Jared. Jared Tobias Grant che arrivava sempre in mio soccorso, come il mio supereroe della Marvel personale; bastava solo che gli permettessi di guardarmi dritto in faccia per qualche secondo, rivelandogli almeno un quarto delle mie reali emozioni, perché capisse quale fosse il problema. E riusciva a fermarmi prima che mandassi all’aria tutti i passi in avanti che avevo fatto negli ultimi sei mesi. Poche parole dette al momento giusto e tutto batteva in ritirata, lasciandomi libera di respirare un po’ meglio. Dall’ultima lite con Justin, in mezzo alla strada, Jared s’era rivelato essere il mio salvagente, la mia boa in mezzo al mare. Non aveva bussato alla porta o suonato il campanello, quel giorno; aveva solo forzato la finestra della cucina - chissà in quale modo -, ed era entrato. Si era seduto sul pavimento di fianco a me, infondendomi forza con la sua semplice presenza, mentre io cercavo di tenere insieme i pezzi rotticchiatti di me stessa. Mi aveva aiutato ad incollarli insieme un po’ meglio e rimetterli al loro posto. E continuava a farlo; salvaguardava ciò che era rimasto del mio cuore, quello che Dante aveva perso per strada, impedendo agli altri di toccarli ancora – soprattutto Justin. Si stava semplicemente … prendendo cura di me. Come nessuno aveva fatto da un bel po’; come Dante non aveva più fatto – o voluto fare. Ed io glielo stavo permettendo – non so se per il suo modo fraterno di fare, il suo capirmi al volo come se mi conoscesse da una vita, oppure a causa di ciò che gli era accaduto e che un po’ c’accomunava, ma mi fidavo di lui. Non completamente, ma lo facevo. Era un altro modo per mettermi alla prova, per non lasciarmi più influenzare così tanto dal mio passato, mentre cercavo di riprendere in mano le redini della mia vita. Solo quando il bisogno umano d’ossigeno ci fece tornare alla realtà, trovammo la forza e la voglia di staccarci; mi allontanai da lui quei pochi centimetri che il suo braccio ancorato alla mia vita mi permetteva. Sentì la mano di Justin risalire i miei capelli, aprendo le dita sulla base della nuca; me li tirò leggermente, facendomi sollevare la testa verso di lui. “Va tutto bene?” mi domandò preoccupato, schioccandomi un altro bacio sulle labbra. “Cosa?” “Ad un certo punto non c’eri più” mormorò, picchiettandomi il dito alla tempia per farmi capire cosa volesse dire esattamente. “Dove sei andata, piccola Harvey?” “No, da nessuna parte … solo …” bisbigliai, non sapendo bene che risposta dargli. Sapevo che voleva sentirsi dire davvero cos’avessi pensato, ma io non ero certa di volergli rivelare tutte quelle cose. Anche perché c’era una buona percentuale di probabilità che finissimo per litigare, di nuovo. Ed era l’ultima cosa che volevo succedesse in quella serata. “Okay, va bene” si riscosse improvvisamente, sbattendo le mani. “Io ho fame, torniamo da Hodad’s a prendere altre patatine?” “Eh?” Boccheggiai sconcertata, lasciando che le sue dita trovassero le mie. “Ma se ha mangiato già due hamburger e una vaschetta intera di patatine con maionese?” Lui alzò semplicemente le spalle, sorridendomi sghembo. “Sei un buco senza fondo, Justin!” “Hey, non è colpa mia se non mi hai fatto mangiare un po’ del tuo cibo!” “Grazie, era mio!” protestai, non riuscendo a trattenermi dal ridere per l’assurda piega che aveva preso una conversazione che sarebbe potuta finire con urla e parolacce. “Scusa, di solito le ragazze non mangiano solo metà di quello che ordinano e il resto lo danno al loro ragazzo?” ghignò, mordicchiandomi di nuovo la guancia. Avevo vissuto abbastanza quel ragazzo, nell’ultimo mese e mezzo, per essere assolutamente certa di una cosa – oltre al suo essere così dannatamente ermetico e impassibile sulla sua vita: a Justin piaceva il contatto fisico. Gli piaceva molto, in realtà; non perdeva occasione per un abbraccio o un bacetto. Anche solo un pizzicotto – di quelli fastidiosi che mi lasciavano segni rossi sulla pelle per almeno mezz’ora – sembrava bastargli, alle volte. E inutile dire quanto la cosa mi avesse inizialmente … sorpresa. Ma mi ero abituata in fretta a quel lato di Justin, e le sue attenzioni – per quanto difficile fosse stato ammetterlo a me stessa, in primis, e poi a lui – avevano iniziato a piacermi sul serio. Anche più di quanto avrebbero dovuto. Forse. Increspai la fronte, fermandomi in mezzo alla strada per fronteggiarlo. “E cosa ti fa pensare che sei il mio ragazzo?” Le sue sopracciglia scattarono come razzi verso l’alto, mentre la sua bocca si piegava in un sorrisetto storto e ammiccante. Portò la mano sul fondo della mia schiena, al limite della decenza per un luogo pubblico e così affollato, aprendo le dita sulla stoffa leggera del mio vestito; mi tirò contro di lui, incurvando la faccia all’altezza della mia. “A me basta comunque sapere che ti piaccio più di Raffaello” gongolò ironico, sfiorandomi la guancia con il naso. “Ma se proprio ci tie …” S’interruppe bruscamente, lasciando cadere su di noi un lungo momento di silenzio; l’unica cosa che riuscivo a sentire chiaramente era il suo respirare ed espirare lento e profondo. E qualcosa in lui cambiò; c’era evidentemente qualche cosa che non andava. Lo si capiva da come le sue braccia si erano contratte attorno a me, da come il suo collo era teso e la mascella rigida. Lentamente e con disinvoltura ruotai la testa verso la strada, scrutando attentamente in mezzo alla folla per trovare il motivo di quell’improvviso cambio d’umore. C’era una via-vai infinito di persone che entravano e uscivano dai vari locali che occupavano i lati della strada, e gli occhi mi dolevano un po’ a causa di tutta quella luce ad accompagnare i loro movimenti, ma riuscì comunque a vederlo. La sua figura si stagliava alta contro lo sfondo di un muro in mattoni, distinguendosi tra tutta quella massa concentrata all’entrata del ristorante. E lui aveva chiaramente visto me. Oh, merda. “Elia?” gracchiai spaventata, ritrovandomi improvvisamente di fronte gli occhioni chiari e fiammeggianti di mio fratello. Dietro di lui riuscivo a scorgere anche l’occhiataccia di rimprovero che Cole mi riservò. Il cuore mi cadde nello stomaco quando mi resi conto che Justin era proprio di fianco a me, e le nostre dita erano ancora intrecciate; tentai di mandar giù il groppo che mi si era formato in gola, osservando lo sguardo di Elia diventare gradualmente più scuro, mentre i suoi occhi si soffermavano su quel punto preciso in cui i nostri corpi si univano dolcemente. Spalancai la bocca per … per fare non sapevo esattamente cosa nemmeno io, ma prima che potessi anche solo riprendere a respirare mi trovai scaraventata contro il petto di mio fratello. La faccia schiacciata contro la sua maglietta bianca e il suo braccio a trattenermi. Ma mi bastò sentire il mugolio di dolore che si liberò dalla bocca di Justin per realizzare che Elia lo aveva davvero preso a pugni, lì in mezzo alla strada, davanti a tutti quegli sconosciuti. “Elia!” tentai di richiamarlo, graffiandogli le braccia nude con le unghie perché capisse che doveva lasciarmi andare; iniziava a mancarmi l’aria. “Non ho capito ancora perché la tua fottuta faccia non è dietro a delle sbarre assieme a quella di mio fratello” ringhiò ad alta voce, affondando le dita nel mio fianco. “Ma … lo giuro, lo giuro su Dio Bieber, ti ammazzo se osi avvicinarti di nuovo a lei. Fosse l’ultima cosa che faccio, ma ti ridurrò a pezzetti se provi a sfiorarla un’altra cazzo di volta!” Inorridita, conficcai brutalmente un unghia nel suo collo, facendolo sobbalzare. “Elia! Smettila, non …” “Tu stai zitta, idiota di una ragazzina!” mi urlò in faccia, digrignando i denti con fare rabbioso. Con un movimento fulmineo, mi strappò letteralmente la borsa dalle spalle, rovistandoci all’interno fin quando non ne tirò fuori il mio cellulare. Lo sventolò all’aria e se lo infilò nella tasca dei jeans, soddisfatto. “Elia … per favore, smettila …” lo pregai, afferrando al volo la borsa che mi aveva rilanciato tra le braccia. “T’ho detto di chiudere la bocca, dannazione!” “No! Devi smetterla! Non …” Mugolai di dolore, sentendo le sue dita stringersi violentemente attorno al mio braccio; mi sembrava di non riuscire più a trovare aria da buttare fuori tanto era il dolore, ma mi morsi con forza il labbro e strizzai gli occhi per non piangere. Elia non mia aveva mai fatto del male. Era Dante quello che, da bambini, mi mordeva le mani per prendersi le mie caramelle; Elia era quello che mi dava le sue, per non farmi piangere. Elia non era le urla asfissianti di Rick che mi impedivano di dormire. Elia non era gli occhi spiritati di Kyle fissi nei miei. Non lo era, non lo sarebbe stato e mai sarebbe potuto esserlo. Lo sapevo, dal profondo del cuore; non c’era cosa di cui fossi più convinta in vita mia, su cui avrei scommesso tutta me stessa, della bontà di Elia. Ma stava succedendo tutto troppo in fretta, c’era troppo rumore e nessuno ci sentiva, a Justin sanguinava il naso e le unghie di mio fratello mi pungevano la carne come punte affilate. “Mi fai male!” gracchiai agitata, sentendomi tremare da capo a piedi. Un rantolo sofferente mi sfuggì dalla gola, e riuscì a sentire perfettamente una scia d’acqua salata cadermi dagli occhi; giù lungo la guancia, sotto il mento fino a gocciolarmi sul petto. Mi scrollai di dosso le mani di Elia, sbattendo più volte gli occhi nel tentativo di liberarmi da quella patina lucida che mi offuscava la vista. Riuscì a distinguere approssimativamente i contorni irregolari del corpo di Justin che si avvicinava di corsa da me, scansando a spallate mio fratello e Cole per raggiungermi. Non appena sentì un suo braccio afferrarmi mi ci abbandonai completamente contro, stringendomi la borsa al petto per impedirmi di continuare a tremolare come una foglia mossa dal vento. “Non … toccarla, porca miseria!” ringhiò ancora Elia, facendo un passo in avanti. “No” ribatté a denti stretti Justin, parandomisi di fronte. “Tu. Osa toccarla tu e sono io che ti faccio a pezzi, brutto bastardo!” “E’ mia sorella!” protestò ferito mio fratello, lanciandomi uno sguardo implorante da sopra la spalla di Justin. “E’ mia!” Un lampo di puro terrore gli schiarì lo sguardo, mentre Justin mi faceva indietreggiare; sempre più lontana dalle sue braccia familiari e calde, fino a quando l’unica cosa che vidi fu la sua sagoma venire inghiottita dalla folla, mentre cercava di raggiungermi. Ma troppo tardi. (*)Hodad's è un ristorante specializzato in hamburger, realmente esistente e realmente situato a San Diego, nel Gaslamp Quarter. (*)Kobe Bryant è un cestista Statunitense appartenente ai Los Angeles Lakers (squadra di pallacanestro). (*)I Giants, i San Diego Chargers e i Pittsburgh Steelers sono delle squadre professioniste di football americano. Wrtier's corner: Di nuovo in un riatrdo bestiale. Perdonatemi. Purtroppo però, come vi avevo già anticipato, il computer aveva dei problemi quindi ho dovuto portarlo in assistenza, e le cose si sono prolungate più del previsto. E solo ieri ho potuto ritirarlo, purtroppo. Ma, eccomi qui, come sempre. Con un capitolo che è esattamente il contrario di quello che mi ero aspettata inizialmente, ma che comunque prelude già un pò di guai. E, notizia delle notizie, manca poco al gran capitolo. Non so precisamente quanti capitoli, ma sono sicuramente pochissimi. Poi, finalmente, ci capirete qualcosa. Per il dopo, non so ancora dirvi niente, ma ci sto lavorando. Purtroppo sono di fretta, perchè tra Sabato e la settimana prossima ho ben quattro verifiche da fare e altrettante interrogazioni per la fine dell'anno - perchè ovviamente qualcuno dei professori adesso se n'è ricordato. Giuro, però, che sarò puntuale con il prossimo aggiornamento. E, massimo per Venerdì prossimo, pubblicherò. Scusate, inolte, per eventuali erroracci nel testo. Ho ricontrolalto, ma come sempr epotrebbe essermi sfuggito qualcosa, e non appena riuscirò a respirare per cinque minuti, provvederò a correggere. E boh, spero sia venuto bene questo, di capitolo. E che, ovviamente, vi sia piaciuto. Alla prossima ☺♥ |
Capitolo 23
*** 22. No way out. ***
 22. Carter. Raffaello cacciò fuori la testolina scura, muovendo il collo a destra e poi nella direzione opposta – verso di me; i suoi occhietti scuri scrutarono attentamente il divano, andandosi a posare sul piede di Justin che ballonzolava oltre il bordo dei cuscini. Elettrizzata allungai il collo, fissandolo insistente; feci passare un braccio sopra il petto del biondo, afferrando un altro bastoncino di liquirizia dal pacco di Twizzlers sul tavolino che mi aveva portato Blake. Jared alzò di scatto gli occhi, voltando la testa verso di me il più lentamente possibile per non far spaventare la tartaruga adagiata sulla sua pancia. “Lanciamene uno, principessa” mi pregò, sporgendo il labbro all’infuori. Roteando gli occhi m’infilai in bocca il bastoncino rosso, tastando la superficie piena del tavolo alla ricerca del suo pacco di Jelly Belly; tra Marshmallow, M&M’s, Hot Tamales, Life Savers, Skittles, Laffy Taffy e Red Vines c’era l’imbarazzo della scelta. C’erano addirittura due vaschette di gelato affogato al cioccolato che ci attendevano, nel congelatore. Diamine, a furia di mangiare liquirizia dovevo aver rimesso su buona parte dei chili persi negli ultimi due mesi. Infilai la mano nel pacchetto interessato, afferrando due caramelle gommose rosse. “Pronto?” domandai a Jared, steso ancora sul tappeto con Raffaello che nel frattempo gli era risalito sullo stomaco. Lui mi strizzò l’occhiolino, spalancando la bocca in attesa; titubante e con mano ferma gli lanciai le caramelle tanto agogniate, cercando di centrare la sua lingua. La prima volta che m’aveva chiesto di fare quella stupidata la caramella gli era finita dritta in gola, rischiando di strozzarlo; essendo così ben piazzato mi era stato impossibile effettuargli la manovra di Heimlich(*), anche per colpa di quello stronzo di Justin che era rimasto fermo a ridersela, quindi mi ero dovuta arrangiare con delle forti pacche sulla schiena nella speranza che non mi crepasse davanti per una stupida caramella alla gelatina. Dopo una buona mezz’oretta passata nel tentativo di convincermi che, in caso di morte, la colpa sarebbe stata solo sua – e che con la testa poggiata su un cuscino non ci sarebbero stati più rischi di alcun tipo -, era riuscito ad ammaliarmi completamente. Stranamente, aveva anche avuto ragione, perchè da allora non si erano più verificati simili incidenti. Il biondino sollevò contento il pollice, tornando a chiudere rilassato gli occhioni blu. Raffaello mosse qualche altro passo in avanti, scrutando con gli occhietti scuri e sospettosi la foglia verde brillante di lattuga – presumevo – che gli si presentava dinanzi. “Ah, come vorrei che una di quelle stupide caramelle ti finisse di nuovo in gola!” Sobbalzai alla voce dispettosa di Justin, rischiando di strozzarmi io con l’ultimo pezzo di liquirizia che avevo appena mandato giù. Mi sollevai con il busto, schiaffeggiandogli il collo con una mano. “Che stronzo!” lo rimbeccai, battendomi qualche pugno sul petto per riprendere a respirare regolarmente. “Occhio, Bieber. Potresti ritrovarti con un cuscino sulla faccia nel bel mezzo della notte” ribatté immediatamente l’altro a tono, spingendo con le dita la foglia di lattuga in avanti. La piccola tartaruga mosse un altro passetto verso il cibo, sbattendo ripetutamente gli occhi; aprì la bocca e ne strappò un gran bel pezzo, masticandolo lentamente, ignorando il sorriso soddisfatto di Jared. “Smettetela, siete dei bambinoni” li rimproverai, spostando lo sguardo su Justin sotto di me. Nell’ultimo periodo il suo rapporto con i ragazzi sembrava essere stato messo un po’ sottosopra, soprattutto quello con Jared; che Sal fosse quello più scorbutico e diffidente tra tutti loro non era stata una scoperta, quindi non mi stupiva più di tanto vederlo poco o niente nell’appartamento. Era sempre in giro da qualche altra parte – così diceva Blake -, soprattutto quando c’era la possibilità d’incontrarmi – d’altronde io facevo di tutto per mettere piede lì il meno possibile, nonostante le proteste continue di Justin. Io non stavo simpatica a lui, e lui non lo era certo a me; era stato tutto una specie di reazione a catena. Ma almeno la nostra ‘tattica’ per evitarci sembrava star funzionando alla grande, permettendo una convivenza pacifica a tutti. Non per questo, però, riuscivo a comprendere il motivo di tanta improvvisa tensione tra i ragazzi; non che potesse essere affar mio, ma nel tempo avevo litigato con così tante persone che pensavo di poter considerare amiche, che mi sembrava davvero un peccato pensare ad un possibile spezzarsi del legame che quei cinque avevano. La mano di Justin s’infilò furtivamente sotto la maglietta per accarezzarmi gentilmente la schiena nuda, attirando la mia attenzione; voltai lo sguardo verso di lui, trovando i suoi occhi color whiskey già fissi sulla mia faccia, pensierosi. Inarcai le sopracciglia, sistemandomi meglio per non pesargli; il divano non era granché largo, quindi per poterci entrare tutti e due mi ero ritrovata con buona parte del corpo sopra di lui. La sua gamba era intrecciata alla mia, ed ero in una posizione in cui il mio cuore ed il suo erano praticamente sovrapposti; se mi concentravo e facevo attenzione potevo sentirne i battiti lenti e regolari che si mischiavano strategicamente ai miei, come se fossero un unico cuore che bastava per entrambi. “Stai bene?” mi domandò il biondo, anticipandomi dal porgli la stessa domanda; sentivo le sue dita disegnare cerchi concentrici sulla mia pelle, in un rilassante e piacevolissimo sali-e-scendi che mi fece rabbrividire. Sapevo si stesse riferendo ad Elia e a quello che era successo la sera precedente, ma non ero certa di volerne parlare; come mio solito, probabilmente avrei preferito archiviare la cosa e non tirarla in ballo mai più. Jared probabilmente intuì la futura piega del discorso, perché si alzò lentamente in piedi con Raffaello in una mano. “E’ meglio che lo rimetta al suo posto prima che mi faccia la pipì addosso” ridacchiò, lanciandomi un’occhiata comprensiva prima di girarci le spalle e dirigersi verso il terrario della tartaruga. L’appartamento che lui, Justin, Blake e Ian condividevano era davvero molto carino; decisamente più pulito, profumato e in ordine di quanto mi fossi aspettata, sapendolo abitato unicamente da ragazzi. Era molto in stile Los Angeles, con pareti scure che si alternavano ad altre composte interamente da mattoni bordeaux di diverse dimensioni. Al centro del soggiorno erano stati piazzati due enormi divani ad ‘L’, che insieme formavano un enorme quadrato di pelle nera che dava sul balcone in fondo; la Tv era stata appesa all’angolo, sopra il tavolo da calcetto – motivo principale per il quale acconsentivo ad andare lì da loro qualche volta. Nonostante le mie doti non fossero delle migliori, io e Blake riuscivamo sempre a battere il resto dei ragazzi con un vantaggio costante di cinque o sei punti. L’ampia cucina in stile cambusa, piena di legno scuro e acciaio inossidabile, era separata dal soggiorno da un lungo muro in mattoni, aperto al centro da un arco a tutto sesto al posto della porta. Il pezzo forte, però, era decisamente l’impianto stereo ultra moderno attaccato al muro del soggiorno, degno dei migliori festival di musica elettronica di Miami. Ed essendo quel tratto di quartiere abitato da persone che non salivano mai oltre i quarant’anni d’età, non avevano mai avuto problemi con vicini infastiditi o polizia quando lo accendevano, i fine settimana. Inizialmente ero rimasta un po’ interdetta nel vedere quel genere d’ambiente, che sembrava anche costare molto, e mi era venuto il dubbio che il padre di Ian avesse pagato tutto quanto. Poi avevo scoperto che in realtà Blake faceva il modello e lavorava in un ristorante messicano in centro; Ian, nonostante non avesse bisogno di soldi, lavorava assieme a Jared in una discoteca lì vicino; Sal faceva il Flair Bartender(*) in un nightclub a Gaslamp, e Justin lavorava in un negozio di tatuaggi. Quel negozio di tatuaggi. Quello dove aveva iniziato a lavorare Dante quando aveva sedici anni. Allora tutto quel ‘lusso’ non mi era parso più così … inspiegabile. Il terrario di Raffaello era adagiato su un tavolo lungo e stretto, dalle gambe altissime, poco lontano dall’entrata ma ancora ben visibile dalla nostra postazione. Affondai la testa nell’incavo del collo di Justin, sospirando rumorosamente. “Va tutto bene, Justin” lo rassicurai, accarezzandogli un fianco con la mano – dove sapevo si trovasse uno dei miei tatuaggi preferiti, tra tutti quelli che gli ricoprivano il corpo. Si trattava di una morte, con la falce intricatissima e coloratissima. Aveva un volto bello e tragico, metà oscurato dal cappuccio del mantello che gli copriva del tutto il corpo, se non per il punto in cui spuntava un cuore brillante e sanguinante, circondato da fiamme delle più varie tonalità di rosso, arancione e giallo. Gli copriva tutto il fianco destro, dalla base dell’ascella alla curva della coscia, scendendo ad arrivare quasi fino all’attaccatura del ginocchio; era enorme ed elaborato, e si estendeva per buona parte anche sulla sua pancia – imbarazzante ma vero, era una delle prime cose che m’ero ricordata dopo la sbronza colossale presa al compleanno di Elia, con la quale ero finita ad osservare un suo nudo frontale. Non volevo saperne il vero significato, perché la possibile spiegazione mi spaventava un po’, ma sapevo riconoscere un lavoro davvero ben fatto – anche grazie a Dante che disperdeva sempre i suoi disegni in giro per casa -, e quello lo era assolutamente. Era fantastico, e mi piaceva da morire. “Lo sai che puoi rimanere a dormire qui anche questa notte, Carter. E per i ragazzi non ci saranno sicuramente problemi” mi sussurrò Justin, ridacchiando. “Perlomeno, se quando sei qui si svegliano con l’odore di quei fantastici pancake non ci saranno sicuramente obiezioni!” “Dovrò tornare a casa prima o poi, Justin” mormorai, chiudendo gli occhi. Sebbene l’idea di ciò che sicuramente m’aspettava non era particolarmente allettante, non potevo rimandare ulteriormente l’incontro con mio fratello. E, sinceramente, non lo volevo fare. Per quanto Elia m’avesse colta alla sprovvista con quell’assurda reazione, non mi piaceva saperlo senza controllo, arrabbiato e lontano da me. Né tantomeno se pensava che avessi paura di lui. Negli ultimi anni la sua capacità di controllare la rabbia era andata scemando pian piano, e volevo assicurarmi che stesse bene e che la nostra casa non fosse a pezzi – non completamente, almeno. Justin sospirò, baciandomi la mandibola. “Lo so, è solo che …” “Elia non sarebbe capace di farmi del male, Justin. Su questo non avere mai dubbi.” Lui grugnì, irrigidendosi. “Davvero?” chiese a bassa voce, scostando la mano dalla mia schiena. La sollevò, e con il dito andò a tracciare il largo segno violaceo che mi circondava il braccio all’altezza del seno – ricordo della presa ferrea di Elia. “Questo cos’è, allora?” I suoi occhi scintillarono di rabbia, e per dare manforte alle sue parole con un po’ di pressione affondò il dito nella pelle, facendomi sfuggire un lamento di dolore. Ero abituata ad avere lividi lungo il corpo, visto che sbattevo ogni due ovunque, ma quello era decisamente il più grande e doloroso che avessi mai avuto, e dovevo ancora abituarmi alla sua presenza. “Justin …” “Voglio solo essere certo che starai bene, una volta lì” si scusò il biondo, dedicandomi uno sguardo addolorato. Delicatamente e con più gentilezza mi alzò il braccio, abbandonando dei morbidi e caldi baci lungo il punto ferito. “Se Elia ha anche un quarto del temperamento di Dante, voglio avere la certezza che casa tua è sicura.” “Justin, Elia e Dante non mi hanno mai fatto male fisicamente” ringhiai scandalizzata, sollevando di scatto la testa per guardarlo negli occhi. “Lo so, Carter. Ma so anche quanto quel tipo di rabbia furiosa che aveva tuo fratello ieri sera possa spingere ai limiti un uomo.” “Ripeto: Elia non mi farebbe mai del male!” “E io ti ripeto che voglio esserne certo, prima di lasciarti andare” ribatté scocciato, alzando gli occhi al soffitto. “Cosa vorresti fare, quindi? Accompagnarmi tu alla porta?” “Be’ …” Strabuzzai gli occhi, guardandolo stralunata. “Non pensavo avessi manie suicide, Bieber. Elia ti ammazzerebbe, letteralmente. Era serio quando te lo diceva, ieri …” “Notizia dell’ultima ora, tesoro: il tuo fratellino non è l’unico che sa tirare pugni, qui. E posso affermare con certezza di avere qualche asso nella manica in più di lui …” “Voi uomini siete così … sbruffoni!” mi lamentai, pizzicandogli il braccio. “Certo, anche io ti trovo fantastica piccola Harvey” mi scimmiottò Justin, schioccandomi un rumoroso bacio sulla bocca, abbracciandomi. “Certo …” ridacchiai, allungando volutamente le ‘e’, mentre mi sporgevo per afferrare un’altra liquirizia. Me la infilai in bocca e, sorreggendomi sul suo petto, guardai Justin che mi fissava divertito; le labbra piegate in un sorrisino storto. Senza che nemmeno me ne accorgessi, la sua testa scattò in avanti, prendendo tra i denti l’altra estremità del dolce; sobbalzai spaventata, e lui mi strinse al volo i fianchi per non farmi muovere più. Mi inchiodò con lo sguardo, mangiucchiando piano la liquirizia, avvicinandomisi sempre di più. Lasciò scivolare di nuovo la mano sotto la maglietta, spostando momentaneamente l’attenzione del mio cervello su quelle dita che mi riscaldavano la pelle; un attimo dopo sentì le sue labbra atterrare bruscamente sulle mie, facendomi cadere il cuore nello stomaco. Sorrise compiaciuto dell’effetto sorpresa, incastrando il mio labbro inferiore tra i denti; mordicchiandolo me lo strattonò, facendomi sfuggire un verso strozzato, di sorpresa, dalla gola. Avrei quasi giurato di aver sentito suonare alla porta, ma la lingua di Justin s’intrufolò furtivamente tra le mie labbra, cancellando ogni altro suono attorno a noi se non quello del suo respiro mischiato al mio. Lo sentì ridacchiare per il mio momentaneo smarrimento, così – in un impeto di coraggio – gli morsi con forza la lingua, facendolo sobbalzare. “Cazzo, che male!” grugnì con voce roca, mordendosi il labbro per non lasciarsi sfuggire qualche colorita imprecazione. “Così impari a prenderti gioco di me” lo presi in giro, sporgendomi verso di lui per lasciargli un piccolo bacio all’angolo della bocca. “Ti ho fatto male?” “Oh, che carina, adesso si preoccupa” rise ironico, pizzicandomi un fianco. Portò una mano tra i miei capelli, avvicinandomi la testa al suo volto; mi baciò la guancia, strofinando il naso contro il mio collo. “Carter …” I suoi occhi affondarono nei miei, osservandomi attenti e … persi; la luce del pomeriggio che filtrava dal balcone gli scivolava dolcemente sulla pelle, donando alle sue pupille un effetto quasi dorato disarmante. Inclinai di poco la testa, sorridendogli. “Uhm?” “Carter!” Una voce più profonda e roca, rispetto a quella di Justin, e dannatamente familiare alle mie orecchie, chiamò impaziente il mio nome. “Dove diavolo sei?” Io e Justin saltammo contemporaneamente a sedere, osservando sorpresi la figura snella e affannata di Keaton fare il suo ingresso in soggiorno, seguito a ruota da Jared. Aveva i capelli scompigliati, le guance rosse e il fiatone, tanto che si dovette appoggiare alle ginocchia per poter riprendere a respirare più lentamente. “Keaton …” Drizzò con uno scatto la schiena, allungando le mani verso di me; mi afferrò dalla vita e, come se fossi la sua sorellina di cinque anni, mi tirò al suo petto. Passata la sorpresa di quel gesto, lo circondai con braccia e gambe, stringendolo forte e affondando la testa nel suo collo. Sapere che stavo uscendo con Justin non aveva certo giovato al nostro rapporto, e nelle ultime settimane ci eravamo ritrovati a litigare più di quanto non avessimo mai fatto in tutti quegli anni di amicizia. Essendo poi abituata ad averlo vicino ogni singolo giorno della mia vita, anche solo per cinque minuti, ed essere stata privata della sua presenza per così tante volte da un momento all’altro, mi aveva fatto sentire ancora di più la sua mancanza. “Come hai fatto a sapere che ero qui?” gli domandai, infilando una mano tra i suoi capelli per cercare di aggiustarglieli un po’. “Leanne mi ha dato l’indirizzo. Non mi ci è voluto molto per capire che eri con lui” mi rispose con voce grave, facendomi posare i piedi a terra. Lanciò uno sguardo rancoroso a Justin, ormai in piedi dietro di me. “E’ sempre colpa sua, dopotutto. Non è vero, stronzo?” “Keaton!” lo ammonì, piazzandomi con la schiena d fronte a Justin per evitare che reagisse a quelle parole. “Che … dici? Che cos’è successo?” “Sono andato a casa tua e l’ho trovata completamente distrutta. Ecco cos’è successo, maledizione. Non c’era traccia né di Elia né di te. Stavo per chiamare la polizia, visto che non ti sentivo da due giorni, se non fosse stato per papà.” La sua voce si abbassò sempre di più ad un ringhio, mentre spostava ripetutamente gli occhi chiari da me a Justin. “Mi hai fatto venire un colpo, ecco cosa c’è. E tutto solo per questo gran pezzo di merda che prenderà il tuo cuore, se lo metterà sotto i piedi e ci camminerà sopra!” Sentì Justin, dietro di me, tendersi come un pezzo di pietra pronto a scoppiare da un secondo all’altro. “Senti, ragazzino, per la tua incolumità è meglio che chiudi la bocca!” lo minacciò, allungandosi da sopra la mia spalla per guardarlo dritto in faccia. Keaton lo ignorò, accarezzandomi la guancia. “Avete trovato Elia?” “Si. Ma … devi tornare a casa, Ter. Per favore …” Abbassai la testa, in segno d’assenso, perché era quella la cosa giusta da fare. Il mio amico mi strinse la mano, trascinandomi verso la porta; con i capelli scompigliati, le guance rosse, delle pantofole numero quarantatre di Ian, dei pantaloncini da basket e una maglietta grigia di Justin addosso. Accennai solo un sorriso rassicurante in direzione di quest’ultimo, mandandogli un bacio volante mentre sorpassavo Jared. Lui sembrò dubbioso, ma annuì lo stesso mimandomi un ‘chiamami’ con le labbra, guardandomi mentre mi allontanavo sempre di più. E mi sembrò di vedergli negli occhi una scintilla di puro ed autentico dolore. _____________________________
Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Aprii e richiusi i pugni, più e più volte, conficcandomi le unghie nei palmi; la porta di casa era socchiusa, e il fuoristrada scuro di Elia era parcheggiato malamente sul ciglio della strada. Non sapevo esattamente come avessi potuto sperare che fosse andato al lavoro nonostante tutto; la presenza della Mercedes di Cole a pochi passi da me, però, non faceva che agitarmi ancora di più. Volevo parlare solo con mio fratello, quindi la presenza del suo amico – soprattutto dopo la lite di qualche settimana fa – non era ben gradita dalla sottoscritta. Avrebbe solo reso le cose più complicate da spiegare – ed era tutto già dannatamente complicato, visto che non avevo la minima idea di cosa dirgli. Ma era già da una buona decina di minuti che ero ferma di fronte all’entrata di casa, e non potevo rimandare ancora per molto il mio rientro. E tutte le sue disastrose conseguenze. Avevo iniziato a pentirmi di non essere rimasta da Justin non appena avevo visto in lontananza il profilo della casa, e di aver mandato via Keaton cinque secondi dopo che era sparito dietro la curva a due case di distanza. ‘Dio, da quanto ero così spaventata all’idea di affrontare qualcuno per dirgli cosa mi andava bene e cosa no? Avevo sopportato per quasi dieci anni la presenza costante di Rick aleggiare sulla mia testa, come un grosso nuvolone nero che t’impediva di capire quando sarebbe scoppiata l’acquazzone. Parlare con mio fratello sarebbe stato dieci volte meglio. Ed io non ero una codarda, soprattutto. Non lo ero mai stata e non avevo intenzione di iniziare proprio in quel momento, quando avevo più bisogno di me stessa per le successive ore. Potevo farcela, come avevo sempre fatto. Buttai fuori una lunga boccata d’aria, svuotandomi completamente delle mie riserve. Delle mie paure insensate. Incrociai le dita dentro la tasca dei pantaloni e, fiera come una leonessa, percorsi quei pochi passi che mi separavano da mio fratello. Appoggiai la mano sul pomello della porta e la spinsi verso l’interno, molto lentamente, cercando di fare il meno rumore possibile – se potevo comunque ritardare l’incontro di qualche secondo, l’avrei fatto eccome. Mi bloccai all’entrata del soggiorno, sobbalzando leggermente sul posto. Tutto era a soqquadro, letteralmente. Le nostre foto da bambini sparse a terra, sotto cumuli e cumuli di vetri rotti e schegge di legno; i cuscini del divano erano a terra, rotti i qualche punto, e il telecomando aperto in due sulle scale. La TV era intatta, ma giaceva a terra, sepolta da libri ed enciclopedie buttati giù dagli scaffali; la tenda era caduta a terra, vicino al termosifone. Da quella posizione riuscivo a vedere la porta del bagno al piano di sopra aperta, e una grande crepa sullo specchio che sovrastava il lavandino. E, ‘Dio, era sangue quello che vedevo vicino alla cornice del mio ottavo compleanno? Mi portai una mano alla bocca, e con il cuore nel petto che sembrava stesse per smettere di muoversi, corsi in cucina. Frenai solo sulla soglia della porta, rimanendo in parte nascosta dal muro. In un angolo degli sportelli bassi, sotto alla finestra, vi era un cumulo abbastanza consistente di piatti rotti, bicchieri, barattoli e fogli strappati; addirittura una sedia dalle gambe spezzate in due, che non sarebbe potuta servire più a niente. Scopa e paletta erano distesi a terra, vicino ai piedi di mio fratello. Era chino sul tavolo, con una bottiglia vuota d’acqua di fronte e le mani a stringersi convulsamente i capelli scuri; riuscì a notare quasi subito le sue mani fasciate da delle bende candide. Cole era di fianco la lui, con una mano stretta sulla sua spalla. “ … niente così …” stava dicendo il biondo, battendo nervosamente con il piede a terra. “Non m’interessa. Voglio solo prendere quel bastardo, ridurlo in brandelli e fargli capire una volta per tutte che deve lasciar stare mia sorella!” sbraitò infuriato Elia, sbattendo i pugni contro la superficie vuota del tavolo. “Fratello, smettila di urlare e spiegami bene cos’è successo” intervenne una terza voce, dal suono più metallico e lontano, come se non fosse in quella stanza. Aguzzai la vista, sporgendo di più la testa per avere una visione completa della cucina, scoprendo come immaginavo che non c’era nessun’altro oltre a loro due. E solo in quel momento notai il cellulare nero poggiato sul tavolo, sotto il suo naso, con lo schermo illuminato dalla chiamata messa in vivavoce. “Succede che il tuo amichetto Bieber sembra avere una relazione con Carter, e la prossima volta che me lo ritrovo davanti ai piedi lo faccio fuori” sputò rabbioso, passandosi una mano tra i capelli. “Non sapevo nemmeno che fosse in città! Quando cazzo è tornato?” “Smettila di urlare, porca miseria! E’ tornato da … un po’ di tempo. Gli ho chiesto di farmi un favore” replicò in tono pacato il terzo uomo, dall’altro capo del telefono. La voce arrivava disturbata a tratti, come se fosse in un luogo chiuso dove la linea non prendeva bene; era molto simile a quella di Elia, solo di qualche tono più bassa … quasi familiare. “Dante, smettila con questi giochetti. Non abbiamo ancora molto tempo, quindi parla chiaro una volta per tutte!” sbottò allora Cole, digrignando i denti. “Cosa deve fare?” Il cuore sembrò smettere di battere, e automaticamente mi ritrovai a trattenere il fiato in attesa di una risposta. Non poteva, assolutamente, essere … lui. Non doveva essere lui. “Deve ... no, non posso …” Ci fu qualche attimo silenzio dall’altra parte, prima che quella voce mi tornasse chiara e forte alle orecchie, per distruggermi una volta per tutte. “La settimana prossima esco, Elia … torno a casa.” (*) La manovra di Heimlich è una tecnica di primo pronto soccorso per rimuovere un'ostruzione dalle vie aeree. (*) Il Flair Bartending è l'insieme delle tecniche acrobatiche nella preparazione di cocktail inventate ed in uso dalla figura del barman. Writer's corner: Okay, questa volta sono stata quasi perfettamente puntuale. Purtroppo la mia sorellina rompiscatole deve usare il computer per preparare la tesina d'esame di terza media, quindi ho dovuto scrivere tutto il capitolo un pò alla volta e mi ci è voluto un pò più di quanto mi aspettassi. Però adesso sono qui, e, cavolo, mi sono resa conto che il capitolo della verità è più vicino di quanto mi aspettassi. Tre, al massimo quattro, e BUM. The end. Questo capitolo è stato un pò ... come dire ... è stato strano. Né troppo tranquillo né frenetico, nel complesso, ma il finale è probabilmente la parte più importante. Perchè Dante è entrato in scena, e tra poco tornerà. Quindi tutto ... finirà. Bugie, segreti, misteri ... Justin e Carter ... tutto quanto. E ... bo, cos'è che vi aspettate voi? Di sicuro ci saranno dei gran colpi di scena, ma secondo voi? Come potrebbe andare a finire? Strage di curi spezzati? O solo quello della nostra Carter andrà in frantumi? E Justin? Dante ed Elia? Ah,sono curiosa di sapere se riuscirò a stupirvi in qualche modo, o se sono stata troppo scontata. Nel frattempo, però, spero che il capitolo vi sia piaciuto. E .. fatemi sapere(?) lol Alla prossima, Baci ☺♥ |
Capitolo 24
*** 23. No one ever really goes away and nobody stays forever. ***
 23. Carter. Affondai con il piede in una pozzanghera dallo sgradevole colore marroncino, ignorando prepotentemente il brivido gelato che mi percorse dalla punta delle dita fino ai capelli quando l’acqua m’inzuppò completamente la Converse bianca; la percepì attraversare il tessuto leggero della scarpa, seguito da quello nero dei calzini, fino a raggiungere la pelle calda dei miei piedi.
La gocce di pioggia picchiettavano forte sulla mia testa scoperta; mi scivolavano lungo i capelli, lentamente, per nascondersi oltre il bordo della felpona nera che avevo addosso. Le sentivo che mi accarezzavano delicatamente la pelle nuda del petto e della pancia, come se volessero rendermi partecipe dell’affievolirsi graduale del mio calore corporeo; proseguivano indisturbate il loro percorso, fino a dissolversi nel bordo spesso dei leggins - rigorosamente neri anche quelli. Ad ogni passo che facevo li sentivo appiccicarsi e sfregare contro le cosce, ma riuscivo comunque a sopportare quel fastidioso pizzicore creato da quell’attrito tra pioggia, tessuto e pelle. La cosa divertente in tutto ciò? Io detestavo la pioggia, maledizione. La detestavo davvero. E ne avevo sentita, di gente, affermare con certezza di amare la pioggia più di una bella giornata di trentacinque gradi, in spiaggia, a prendere il sole. Parlavano di come l’odore dell’asfalto bagnato risultasse rigenerante; di come il ticchettio ritmato della pioggia li cullasse, sotto nuvole striate e lucenti, portandosi via tutto: malinconia, tristezza, rabbia, dolore, odio. Qualcuno diceva anche che, in certi casi, riusciva addirittura a portare qualche frammento di felicità con sé. Parlavano di come accarezzava, schiaffeggiava, loro il volto, bagnando le labbra fino a farle diventare scarlatte, e nascondendo le lacrime; di come riusciva a confondere il volto tra la folla di ombrelli colorati, a nasconderlo al luccichio dei lampioni e al paesaggio lucido della città. Di come riportava alla mente gli odori della loro infanzia, in quell’età in cui da bambini si ostinavano a non lasciarsi protegge dall’ombrello e amavano invece saltellare nelle pozzanghere e ripecchiarcisi dentro mentre l’acqua tremolava; di come consigliava di rallentare un po’, abbandonare il ritmo frenetico dei grandi centri urbani, e fermarsi ad ascoltare. Tutte stronzate, dalla prima all’ultima; solo parole lette di sfuggita su romanzi rosa, o in una qualche citazione avvistata su Internet di Federico Garcia Lorca o Gabriele d’Annunzio, ripetute poi come delle filastrocche da quattro soldi. A me la pioggia non piaceva nemmeno da bambina; quando i litigi tra la mamma e Rick degeneravano, e fuori infuriava un acquazzone – la maggior parte delle volte succedeva, come se qualcuno lassù si divertisse a prendersi gioco di noi -, non avevamo dove andare. Io, Elia e Dante dovevamo rimanere chiusi a chiave nella mia cameretta, con il rumore assordante della pioggia che picchiava sul vetro e quello dei cardini delle porte che cigolavano rumorosamente sotto la furia animale di Rick. In quei momenti il tempo sembrava non scorrere mai: la mia mente non riusciva a percepire altro che le loro urla, accompagnate dal gocciolare dell’acqua sul vetro che diventava quasi assordante, e avevo solo voglia di piangere fino a perdere il respiro. Crescendo, la mia repulsione per la pioggia è rimasta immutata. Se non aumentata gradualmente. La pioggia equivaleva a marciapiedi sgombri, locali privi di vita, strade impercorribili, luci spente e, soprattutto, silenzio. Il che portava ad un’unica cosa che io non sopportavo più della pioggia: pensare. E in quel momento non riuscivo a non farlo. Da quando quella mattina ero uscita di casa non riuscivo a mettere un freno agli ingranaggi della mia testa: li sentivo che lavoravano, che si scontravano l’uno contro l’altro in fastidiosi stridii che mi riempivano l’udito. Non riuscivo a smettere, e ciò mi urtava ulteriormente il sistema nervoso. Perché c’era solo un sentiero che i miei pensieri seguivano, in fondo al quale si ammucchiavano tutti quanti come formiche in un giorno di pioggia nel formicaio: Dante. Dante sarebbe tornato a casa, dannazione. Ed io non ero, mentalmente e fisicamente parlando, pronta a quella realtà – e a ciò che questa avrebbe comportato. Non lo sarei mai stata, e forse non volevo esserlo. Probabilmente non ero nemmeno tenuta ad esserlo. Dante che tornava a … casa – ‘Dio, non riuscivo nemmeno più a considerarla casa, se m’immaginavo lui dentro -, significava riportare tutto a galla. Dopo anni passati a soffocare tutte quelle urla, quel dolore, quel fuoco ardente che m’aveva carbonizzato il cuore quando mio fratello aveva deciso di diventare un fottuto piromane assassino, il suo ritorno significava liberare quei bauli strabordanti dalle catene ‘cui li avevo costretti e permettergli così d’investirmi; lasciare il via libera a tutti quei ‘ricordi’ di riprendere il possesso completo su me stessa. E per quanto smaniassi all’idea di venire - una volta per tutte - a conoscenza di tutta la verità, in tutte le sue più piccole e oscure sfaccettature, non ero pronta a quel tête-à-tête con Dante, Elia, la morte e il passato. Avevo impiegato un anno intero a trovare una valida ragione che mi portasse ad uscire dalle quattro mura della mia camera, nelle quali mi ero rifugiata per … per il troppo dolore, lo shock, la rabbia e l’odio. Un anno, dannazione: un anno passato con me rinchiusa in me stessa, arrabbiata con l’intera popolazione mondiale, ed Elia e Keaton costantemente fuori dalla mia porta, a farmi vedere che per loro due valeva la pena vivere ancora. Avevo lavorato così tanto su me stessa negli ultimi quattro anni, avevo fatto così tanti passi avanti, nonostante tutte le riserve e il mio caratteraccio – che alcune volte mi si ritorceva contro. E in quel momento morivo all’idea di ritornare di nuovo al punto di partenza per colpa di Dante; perché per quanto consapevole del dolore che avrei provocato in Elia e Keaton, non sarei riuscita a non lasciarmi andare di nuovo. Per quanto avessi potuto lottare, difendermi con unghie e denti, non sarei mai stata più forte di Dante. Quella era una cosa che avevo sempre odiato, e amato allo stesso tempo, di lui: Dante riusciva sconvolgermi. Riusciva a raggiungermi e toccarmi nel profondo, e poi era in grado con la stessa velocità e dolcezza di strapparmi il cuore dal petto e tenerselo gelosamente tutto per se. Mi lasciavo influenzare così tanto da lui che, dopo un po’ di tempo, certi dolori, certi sprazzi di tristezza buia, erano anche colpa mia, probabilmente. Ero io che li permettevo. Sin da quando eravamo bambini era così: una parola, una frase, una constatazione detta da lui, e il mio umore, le mi convinzioni, riuscivano a cambiare sul momento. Pensava che il nuovo taglio di capelli mi facesse sembrare un maschio? Maledizione, avevo pianto a dirotto fin quando Elia non aveva urlato a tutto il quartiere che ero la più bella bambina della città, anche con i capelli cortissimi da maschietto. Mi diceva, fiero, che ero uno schianto per il ballo di fine anno al secondo anno delle superiori? Maledizione, nemmeno il mio accompagnatore Brad che si era messo a sbavare dietro ad una cheerleader più svestita che altro era riuscito a levarmi il sorriso dal volto. Dava fuoco a casa nostra, ammazzava nostra madre, e in tribunale non spiaccicava parola? Maledizione, mi aveva fatto crollare il mondo addosso e nessuno era più riuscito a ricostruirlo. Con Elia non c’è n’erano di quei problemi, perché per lui ero la luce dei suoi occhi; ma Dante … Dante era così brutalmente schietto, senza peli sulla lingua, che non ero mai riuscita a farci l’abitudine – nonostante avessi preso gran parte del mio carattere da lui. Dante avrebbe sempre vinto, contro di me; il fatto che, dopo tutto quello che aveva fatto, aveva deciso comunque di tornare, ne era un esempio lampante. Per quanto sconfinato e resistente considerasse il suo amore per me, sarebbe tornato lo stesso a darmi il colpo di grazia. E sapere che così si sarebbe preso l’ultimo pezzetto di cuore che s’era dimenticato, mi terrorizzava ancora di più dell’idea stessa di lui che tornava a casa. Alla fine il mio umore, le mie convinzioni, la mia vita, dipendevano di nuovo solo ed esclusivamente da lui: una parola, e il mio cuore sanguinante sarebbe appartenuto sempre e solo a lui, o sarei riuscita a tenermi ciò che era avanzato, e sarei tornata respirare. Non c‘era via d’uscita per me, e avevo solo sette giorni di tempo per prepararmi a … qualunque cosa gli sarebbe uscita dalla bocca. ‘Gesù, volevo mettermi a urlare. O scappare da tutti loro il più lontano possibile, senza lasciare traccia del mio passaggio nelle loro vite, e delle loro nella mia. Affondai con forza le mani nelle tasche della felpona extra large che avevo fregato a Keaton non molto tempo fa, leccandomi l’acqua dalle labbra. “Carter?” Mi sentì strattonare all’indietro dai capelli, e un secondo dopo mi ritrovai faccia a faccia con gli occhioni color whiskey di Justin. La visiera del cappellino che portava impediva alla pioggia di bagnargli il volto: aveva le guance deliziosamente arrossate, le labbra serrate in una linea dura e gli occhi sbarrati, talmente scuri da sembrare neri sotto la poca luce concessa dai nuvoloni grigi che avevano assediato la città. Mollò la presa sui miei capelli e mi sollevò il cappuccio sulla testa, stringendomi poi le mani attorno alle guance; mi passò i pollici sotto gli occhi, rimuovendo le macchie nere create dal trucco sciolto. “Che diavolo hai, Carter?” mi domandò insicuro, osservandomi di sottecchi da sotto il cappellino verde. Sulle spalle, il giubbino iniziava a presentare delle chiazze bagnate che lo appesantivano sulle spalle; i jeans chiari erano completamente fradici, e, appesantiti dalla pioggia, gli erano scivolati sui fianchi ai limiti della decenza in un luogo pubblico. “Ho provato a chiamarti, ma il telefono risultava non disponibile” continuò imperterrito, girando la visiera sulla nuca per potersi avvicinare ulteriormente a me. “Che sta succedendo, Harvey? Che problema c’è?” Appariva sinceramente preoccupato per me, e ciò non fece che farmi salire ulteriormente la nausea. Avevo, di nuovo, rotto il telefono la notte prima; se comunque non lo avessi fatto, non ero certa gli avrei risposto. Il problema … il problema era anche lui: Justin. Lui era amico di mio fratello, da un sacco di tempo; e da un sacco di tempo avevo capito che, qualunque cosa gli avessi pregato di dirmi, di rivelarmi almeno in parte, lui avrebbe scelto sempre il suo migliore amico. Ero anche riuscita a scendere a patti con tutto quello, negli ultimi due mesi, per quanto quella consapevolezza non mi piacesse particolarmente, ma comunque prima di sapere che Dante sarebbe uscito così presto dal carcere. In quel momento, sotto la pioggia che m’impediva una visuale perfetta sul suo volto, riuscivo a tratti a scorgere i lineamenti di Dante nei suoi; nel tatuaggio sul collo, nell’orecchino e nella linea tesa della mascella. Immagini reali del volto di Justin si alternavano a quelle ripescate chissà dove di mio fratello; quello era un chiaro segnale che stavo perdendo il controllo. “Io … questa cosa del … me e te … io non ce la posso fare, Justin … non voglio” mormorai, con la gola improvvisamente secca e bloccata. “Tu mi … mi …” “Carter, non c’è bisogno che …” “Non riesco nemmeno più a dirtelo, maledizione!” strillai arrabbiata, abbassandomi il cappuccio sulla schiena. Lui espirò di scatto, sgranando gli occhi. “A me non importa che tu mi dica che ti piaccio. Mi basta saperlo …” “A me no, però!” ribattei a voce più alta, allargando esasperata le braccia al cielo. La pioggia iniziò a cadere con più frequenza e ferocia sui nostri corpi, arrossando la pelle scoperta ad entrambi; mi sembrava quasi di sentire delle scie roventi sulle guance. “Ehi, tesoro, tranquilla” mi sussurrò, cercando di apparire rassicurante. “Non piange ...” “Non sto piangendo, Cristo!” lo interruppi adirata, scattando all’indietro. E per dare manforte alla mia affermazione riuscì a trattenere un singhiozzo di disperazione in gola, stringendo i denti. “Non piangerò per te!” Justin sobbalzò, fissandomi interdetto. Mi studiò attentamente per qualche secondo, mentre tentavo di riprendere fiato; fece un passo verso di me e mi afferrò per le spalle, stampandomi un bacio sulla bocca. Contrassi ogni muscolo che sapevo di avere per lo shock, sentendo il mio respiro accelerare di nuovo; sentii la sua lingua infilarsi tra le mie labbra e le sue mani scendere delicate lungo le mie braccia, fino al bacino; affondò le dita nella mia felpa, le sentì nella pelle. Premette i fianchi contro i miei e quando si scostò mi mordicchiò il labbro, sfiorandomi la guancia con il naso. “Non so che diavolo hai, ma siamo bagnati fradici. Quindi adesso entriamo in un bar, ci riscaldiamo con un bel caffè e tu ti dai una bella calmata” ordinò autoritario, pizzicandomi il collo – se la situazione non fosse stata quella, probabilmente mi sarei messa sull’attenti con una mano alla fronte e lo avrei baciato di nuovo io. Ma non potevo farlo. Non potevo, non volevo e non dovevo, farlo. Perciò strattonai via la sua mano dalla mia e arretrai di qualche passo, passandomi il dorso della mano sulla bocca. “Non … non capisci, Justin. Io non ce la faccio più, non reggo più questa situazione. Ci ho provato, credimi. E quest’ultimo mese è stato il più bello degli ultimi anni, ma … non ce la faccio. Non riesco più a ignorare le tue bugie, i tuoi segreti e … e la tua amicizia con Dante. E’ troppo da sopportare adesso, e almeno contro di te non voglio perdere. Voglio tentare di salvarmi prima che tu mi faccia troppo male, e l’unic …” “Ehi, ehi, ehi! Che cazzo stai dicendo, Carter? Che significa tutto questo?” mi parlò sopra, ripercorrendo quei pochi passi di distanza che avevo messo tra di noi. “Rispondimi! Che cos’è successo?” Mandai giù il groppo che avevo in gola, strizzando gli occhi. Quando lì riaprì, per un istante, un intenso e terribile istante, mi sembrò di avere Dante di fronte: mi fissava neutro, senza emozioni, con il fuoco che gli bruciava gli occhi. Esattamente come lo incontravo ogni notte, nei miei incubi. E avrei voluto mettermi ad urlare; se ce l’avessi avuto davvero dinanzi gli avrei urlato contro tutto quello che avevo passato a causa sua. Per lui. E, maledizione, avrebbe voluto piangere anche lui sotto la pioggia. Speravo che soffrisse, che stesse male almeno un po’; che sentisse almeno metà del dolore che avevo sentito io per lui. E non per me, anche per una persona qualsiasi sarebbe andato bene, ma solo per stare male come io lo ero stata per lui. Per versare tante lacrime quante ne avevo versate io per lui; volevo solo che provasse la stessa apatia e lo stesso senso di smarrimento che ero stata costretta a provare io. Della stessa indifferenza e della stessa voglia di lasciar marcire tutto quanto. Da non sapere dove sbattere la testa; da stare con lo stomaco in subbuglio fino alla nausea, da fargli venire la febbre e tremare anche d’Estate. E poi sarei dovuta mancargli, sarebbe dovuto mancargli tutto quello eravamo da star male; al punto da rendergli difficile parlare, piangere, o perfino respirare. Sarei dovuta mancargli quando la vita diventava troppo pesante da solo, chiuso fra tre mura e una fila di sbarre arrugginite che impedivano la vista del sole. Avrebbe dovuto sentire la mia mancanza da star male, di nuovo. Quando strizzai di nuovo gli occhi per tornare alla realtà, Justin mi era di nuovo pericolosamente vicino, spazientito. “Carter!” “E’ finita. Tutta questa cosa di noi … me e te … è finita. Non c’è più” parlai velocemente, fissando un punto indistinto al di sopra della sua spalla. “Ti voglio fuori dalla mia vita, una volta per tutte.” Una ciocca di capelli, fradicia, mi ricadde pesantemente sul naso; Justin allungò una mano e me la sistemò dietro l’orecchio, prima di afferrare il suo cappello e infilarmelo sulla testa. I capelli gli si appiattirono immediatamente sulla fronte, gocciolandogli sul naso. “Non so che razza di … che cosa ti passa per la testa, ecco, ma questa cosa del ‘ti voglio fuori della mia vita’ non ha funzionato già una volta. Cosa ti fa pensare che, proprio adesso che ti ho tutta per me, mi decida a fare ciò che mi chiedi?” mi domandò con aria vagamente irritata, strisciandosi una mano sulla faccia. “Vuoi fare un’altra partita a questo stupido giochetto? Okay, va bene. Facciamola. Passiamo altri cinque mesi a farci la guerra, e uno solo a stare bene. Ma perché, dannazione, se potremmo passarne dodici come l’ultimo, insieme? Può sembrarti strana tutta questa relazione, e ci sta. Ma ci vuole tempo per queste cose, Carter, ed eravamo d’accordo che non c’è fretta di fare nulla. Non sei l’unica che deve ancora farci del tutto l’abitudine …” Per un attimo, rimasi senza parole di fronte a quell’aria persa, quasi spaventava, che aveva Justin; sapevo quanto la sofferenza potesse rendere pesante l’aria e con quanta violenza potesse irrompere dentro il petto, e scatenare fitte di dolore in ogni angolo del corpo. Negli occhi, nella testa, nelle braccia, nelle gambe, persino nelle gengive. Ma non ero pronta a vederne gli effetti devastanti su di lui. Non potevo permettermi di fare un passo indietro proprio in quel momento – per quanto segretamente mi sarebbe piaciuto. “Che favore devi fare a Dante, Justin?” Parlai lentamente, scandendo con attenzione ogni parola, trovando il coraggio di fissarlo dritto negli occhi. Le sue pupille si allargarono a dismisura: un misto di preoccupazione, stupore, e rabbia. “Non sono cose che ti riguardano, Carter. Sono affari di tuo fratello, e quindi lui è l’unico che ha diritto e il dovere di dirtelo” mi rispose in fretta, stringendo i pugni lungo i fianchi. Un lampo illuminò il cielo alle sue spalle, donando ai suoi occhi una colorazione quasi argentea per un breve istante. “Lo sapevo” mormorai amaramente, incurante che lui mi sentisse o meno. “Dici sempre così, da quando sei tornato.” “E’ la verità, Carter.” Scossi la testa, iniziando ad arretrare con dei piccoli passetti all’indietro, che non sfuggirono all’attenzione del biondo. Allungò una mano in avanti, come per afferrarmi, ma gliela schiaffeggiai via. “Da quanto tempo sai che Dante uscirà la settimana prossima, Justin?” Un altro lampo gli illuminò gli occhi, e fu come se la lampadina si fosse accesa improvvisamente. Si limitò a chiudere la bocca, osservandomi mentre mi allontanavo per sempre da lui, senza dare alcun segnale di volermi seguire. Non mi sarei aspettata che sarebbe stato così difficile dirgli addio, e tantomeno di sentire una sensazione così simile al dolore attanagliarmi lo stomaco; ma il dolore arrivò, e fu proprio la sorpresa del suo arrivo a fregarmi. Perché, quella volta, non riuscì a trattenere un piccolo brontolio addolorato in gola. Justin sembrò sentirlo, e, quasi si fosse appena risvegliato, iniziò a camminare verso di me. Dal canto mio, scuotendo la testa mi girai e iniziai a camminare veloce nella direzione opposta, a testa bassa. Sentivo i suoi passi dietro di me, sicuri e fermi, affondare nell’acqua; poi qualcun altro urlò a gran voce il suo nome, e lo sentì fermarsi di botto. Confusa e curiosa mi voltai di poco, aguzzando la vista per vedere chi fosse l’uomo dietro di lui ad averlo chiamato: doveva essere appena uscito da un bar lì di fianco, perché la sua divisa era ancora asciutta. Strabuzzai gli occhi, rendendomi conto che quella era una divisa da poliziotto. L’uomo lanciò un’occhiata significativa al biondo, girando i tacchi e tornando al caldo del locale; Justin si limitò a scuotere frustrato la testa, immobile nello stesso punto di prima. Mentre mi giravo, e i miei piedi iniziavano a correre come se fosse questione di vita o di morte, lo sentì gridarmi qualcosa, ma un tuono coprì del tutto la sua voce, azzerandola. E lui non mi seguì più. Writer's corner: E rieccomi. Ta-dan! Un pò in ritardo, mi spiace, ma sto migliorando, no? lol E, che dire, la presenza di Dante si sente già, no? Income su di loro come un nuvolone minaccioso pronto a portare scompiglio. Ed è proprio quello che st facendo Dante, anche se non è ancora presente fisicamente. Carter, perlomeno con Justin, è tornata al punto di partenza. Non c'è più niente di quello che sono stati negli ultimi capitoli, e purtroppo il biondo non fa che complicare la situazione. Lei sta per crollare, psicologicamente e fisicamente; scoprire così del ritorno del fratello è stato un piccolo shock, e non riesce ad accettarlo. Non riesce ad accettare ciò che è lui, ciò che ha fatto e ciò che probabilmente le farà raccontandole la verità. Ma, siamo sicuri che gliela racconterà? Carter ne è convinta, ma potrebbe anche non essere così, in fondo. Inoltre, ho lasciato qualche piccolo indizio nasosto nel capitolo che potrebbe farvi capire l'andamento che prenderanno i prossimi capitoli finali. Non sono facili da trovare, ma ci sono. Comunque, spero vi piaccia - e, come sempre, per eventuali errori provvederò a correggerli. Grazie per continuare a seguire la storia, non sapete quanto mi faccia piacere. Vi adoro. Alla prossima, Baci ☺♥ |
Capitolo 25
*** 24. Switch back. ***
 24. Carter. Mi svegliai di soprassalto, spaventata, quando un rumore stridulo mi s’insinuò nelle orecchie.
Disorientata, mi passai una mano sulla faccia, cercando di levare via dagli occhi i residui del sonno. Dalla finestra che dava sul balcone filtrava ancora la luce argentea della luna, regalmente alta in cielo; la radiosveglia sul comodino segnava ancora le tre e dieci del mattino - ero quasi certa fosse Domenica. Strizzando gli occhi mi schiaffeggiai le guance, scalciando le lenzuola verso il bordo del letto; con la fine della scuola alle porte, alzarsi dal letto era diventata un’impresa quasi ogni mattina, soprattutto viste le poche ore di sonno che mi erano concesse durante l’arco della notte. Come se non bastasse Leanne era anche riuscita – come, ancora non l’avevo capito – ad infilarmi nel gruppo del comitato organizzativo del ballo di fine anno; così, ai turni intensificati al Sanyo, si aggiungevano anche i pomeriggi bloccata a scuola. E, come ciliegina sulla torta, c’era Justin. Dopo la nostra ‘rottura’ – se così la si poteva davvero chiamare – non avevamo smesso un secondo di litigare: puntuale come un orologio Svizzero alle dieci e mezza si presentava al locale, s’appostava su uno sgabello a bere birra e aspettava che terminassi il turno. Al momento di andare a casa si alzava, pagava e mi scortava fino alla macchina come uno stupido bodyguard; dal canto mio facevo di tutto per ignorarlo, o perlomeno scacciarlo, ma lui non demordeva. E alla fine ci ritrovavamo a litigare come una coppia di sposini già stufi del matrimonio. Ce ne urlavamo dietro di tutti i colori, ma il problema era solo uno, in effetti: Justin, il giorno dopo, era di nuovo al locale, come se niente fosse successo. Così per tutta la maledetta settimana. Afferrai la maglietta scolorita dei San Diego Chargers che usavo come pigiama, infilandola sulla testa mentre mi sollevavo dal materasso; rabbrividì, a contatto con il linoleum freddo del pavimento. Dal piano di sotto, il rumore di qualcosa che sbatteva a terra, mi fece sobbalzare sul posto; solitamente Elia non era così imbranato, quando tornava dal lavoro. In effetti era anche troppo presto, per i suoi standard; solitamente staccava verso le quattro, e alle quattro e mezza arrivava a casa. Mi sistemai l’orlo dei boxer sulla coscia, correndo silenziosamente alla finestra; il vialetto di casa era deserto, e di macchine non c’era traccia. Controllai anche tutto il perimetro del marciapiede – fin quando mi fu possibile – ma non riconobbi tra le auto né la Nissan 4x4 scura di Elia né la Lexus Hybrid bianca di Jackson. Il pavimento, di sotto, cigolò sinistramente sotto i passi pesanti di qualcuno – che ovviamente non era di casa; il frigorifero si spalancò, ronzando. “Fantastico, un ladro e per giunta affamato …” bofonchiai a bassa voce, allontanandomi dalla finestra. Qualcosa si frantumò sul pavimento, e mi sembrò quasi di sentire l’intruso smettere di respirare per accertarsi che non ci fosse nessuno in casa. Automaticamente trattenni il respiro, immobilizzandomi al centro della stanza con il cuore che mi galoppava impazzito nella cassa toracica; inconsapevolmente mi portai una mano al petto, spaventata che magari, in quel silenzio spettrale, potesse sentire il rumore dei miei battiti velocizzati. Con la coda dell’occhio tenni sotto controllo la radiosveglia, contando due minuti di assoluto silenzio prima che l’intruso ricominciasse a muoversi per la cucina; appoggiò qualcosa sul tavolo, e stappò rumorosamente una bottiglia. Maledizione, lo sapevo che quella sera sarei dovuta rimanere a dormire da Keaton. Scrollai la testa e respirai profondamente, aprendo e chiudendo i pugni lungo i fianchi; sangue freddo e controllo su me stessa – magari lasciarmi convincere da Leanne a guardare i Mercenari non era stata poi una così cattiva idea. In punta di piedi mi avvicinai alla porta aperta; tenendomi allo stipite in legno allungai il collo sul corridoio, per assicurarmi che fosse privo di altre presenze indesiderate. Appurato di non avere compagnia, sgattaiolai furtivamente verso la camera di Elia, in fondo al corridoio; fortunatamente non aveva problemi a lasciarla aperta, anche quando in casa c’ero solo io, perché alcune porte della casa scricchiolavano in una maniera assurda quando le si voleva aprire piano. A tentoni, nel buio, trovai il comodino vicino al letto; il più delicatamente e lentamente possibile aprii il secondo cassetto, abbastanza da poterci infilare la mano. Con una smorfia contrariata e ad occhi chiusi infilai la mano tra i boxer di mio fratello, cercando di sfiorarli il meno possibile con le dita; tastando la superficie fredda del legno, arrivata sul fondo, riuscì facilmente ad individuare la Calibro 9 di Elia. Non c’era mai stato bisogno d’utilizzarla, o anche solo tirarla fuori da quel cassetto, ma Elia – e anche io, in realtà – si sentiva più sicuro nel sapermi sola in casa, di notte, con un’arma a mia disposizione che avrei potuto liberamente usare per difendermi. Rick era un gran bastardo, e i suoi amici erano – se possibile – ancora più viscidi, vendicativi e pericolosi di lui; dopo essere uscito dal carcere se l’era data a gambe levate chissà dove, lasciandosi alle spalle un sacco di debiti con persone decisamente poco raccomandabili. Non avevamo la minima idea di chi fossero, a quanto ammontassero i soldi che gli doveva e non ci avevamo mai avuto a che fare, ma Elia aveva preferito prendere delle precauzioni in caso di … problemi. E, in quel caso, c’era un gran problema affamato che mia spettava al piano terra. Ero perfettamente in grado di utilizzare un’arma. Bene anche – Elia mi aveva fatto prendere due o tre lezioni da un amico poliziotto del padre di Ian, due anni prima. La prima era stata un completo disastro, ma alla terza sapevo prendere il centro esatto di un bersaglio da una trentina di metri di distanza. E ciò mi permetteva di mantenere intatto quel briciolo di lucidità necessario per muovermi alla svelta e silenziosamente, e pensare con razionalità. Agguantai fermamente la pistola e la tenni stretta al fianco, affacciandomi di nuovo sul corridoio; dal piano inferiore i passi non avevano cessato di muoversi. Qualcos’altro cadde a terra con un tonfo sordo, ed ero abbastanza certa che il punto fosse molto vicino alle scale. Il che non era esattamente un buon segno: l’intruso sarebbe potuto salire da un momento all’altro e beccarmi. Certo, con la pistola carica e funzionante e l’effetto sorpresa avevo delle sicurezze in più, ma dello stronzo che s’era infilato dentro casa mia non sapevo niente: se era solo, armato, e cosa aveva intenzione di fare dopo avermi svaligiato il frigorifero. Quando sentì i passi ritornare verso la cucina, scattai silenziosamente verso la mia camera; superai le scale e mi ci fiondai dentro, appiattendomi contro il muro. Con l’orecchio ben aperto aspettai qualche altro passo che mi dicesse che l’intruso era ancora in cucina; quando lo sentì continuare a girovagare vicino al frigorifero aggirai il letto e, dopo aver afferrato il cellulare dal comodino, mi affrettai sul balcone, acquattandomi dietro la tenda scura che copriva buona parte della visuale. Riuscii ad impostare il telefono sulla modalità Silenziosa pochi attimi prima che questo s’illuminasse; sullo schermo spiccava a caratteri cubitali bianchi il nome di Justin. Girai la testa di tre quarti, tenendo d’occhio la porta della camera ancora aperta; da lì fuori non potevo più avere il controllo sui movimento dell’intruso, quindi necessitavo in qualche maniera di avere comunque sott’occhio la situazione, in un modo o nell’altro Portai il cellulare all’orecchio, coprendomi la bocca con la mano per attutire il suono della mia voce. “ Stai zitto e lasciami parlare. C’è un probabile ladro in casa, al piano di sotto, e sono sola in casa. So che in quest’ultimo periodo di sto detestando più di quanto abbia mai fatto ma puoi per fav …” “Sono nei dintorni. Dieci minuti e sono da te” m’interruppe prontamente, apparentemente non toccato dalla situazione in cui mi trovavo, riattaccando un secondo dopo. Non un ‘stai attenta’ o ‘non fare niente di stupido’; maledizione, quel ragazzo era un continuo punto interrogativo. Un movimento sospetto nel corridoio mi gelò il sangue nelle vene; bloccai lo schermo del telefono, mettendolo a faccia in giù sul pavimento per evitare d’attirare l’attenzione con tutta quella luce. Una figura massiccia, incappucciata e avvolta nel buio della casa, passò davanti alla porta della mia camera; senza nemmeno darvi un’occhiata tirò dritto lungo verso il fondo del corridoio, come se sapesse già che lì c’era la camera da letto di mio fratello. Subito pensieri più o meno allarmanti mi annebbiarono il cervello; non volevo saltare a conclusioni troppo fervide da telefilm poliziesco, ma vedere l’intruso orientarsi così bene in casa nostra non era certo un buon segno. Poteva significare solo che, chiunque lui fosse, ci aveva spiati; aveva osservato bene le nostre abitudini e aveva anche avuto modo di studiare gli interni della casa. Il che portava ad un’unica e spaventosa conclusione: il ladro sapeva bene cosa voleva e dove trovarlo. La pistola di Elia? La piccola cassaforte che teneva nascosta in un doppiofondo creato sul fondo dell’armadio? O, addirittura, Elia stesso? ‘Dio, che Rick fosse tornato per una piccola vendetta? Alla sola idea mi trovai a tremolare come mai in vita mia; levai la sicura alla pistola, aumentando la forza con cui la stringevo tra le dita. Udendo una porta sbattere schizzai fuori dal mio nascondiglio; in punta di piedi, il meno rumorosamente che mi riusciva, imboccai il corridoio, puntando le scale con la pistola tenuta ben salda lungo il fianco. Scesi le scale due a due, cercando di orientarmi attraverso la poca luce lunare che filtrava dalle finestre che davano su soggiorno e cucina. La poca argenteria sparsa sulle mensole era ancora al proprio posto; niente di danneggiato o sparito. Apparentemente tutto sembrava essere rimasto dove doveva essere. L’unica nota storta era un enorme borsone nero, smunto e con qualche buco, ai miei piedi. Non avvertendo alcun rumore sospetto dal piano di sopra mi accovaccia sul pavimento e, con la mano libera, iniziai a frugarci all’interno: jeans sgualciti, due magliette nere, una felpa enorme con un altrettanto grande buco sul gomito; cellulare vecchio modello, penna, e un paio di banconote da dieci stropicciate e tenute insieme da dello scotch trasparente. Per niente rassicurante, in effetti; tutti i presupposti per un ladro disperato c’erano. “Non ti hanno insegnato a non frugare tra la roba degli altri?” Mollai la presa sul borsone, schizzando su; con un movimento fulmineo girai su me stessa, sollevando il braccio con cui impugnavo la pistola, puntandola direttamente sulla fronte dell’intruso. “Non osare fare un altro passo, o dire un'altra parola, se non vuoi ritrovarti con il cervello in pappa!” lo minaccia, riuscendo a tirar fuori una voce ferma, decisa e sicura. In realtà, sentivo di star per svenire; avevo le dita leggermente intorpidite, le ginocchia molli e il cuore che mi si era fermato tutto d’un colpo nello stomaco. Sentivo qualcosa sulla bocca dello stomaco, come un grosso masso ingombrante, che impediva all’aria di circolarmi regolarmente nei polmoni. “Diamine, Elia non scherzava quando diceva di averti mandata da quel poliziotto” continuò lo sconosciuto, sollevando sarcastico le mani all’aria. Mi superava di una buona e piena ventina di centimetri, e le sue spalle erano probabilmente il doppio delle mie; con tutta quella poca luminosità a mia disposizione riuscivo a malapena a distinguere i contorni sfocati di una canottiera bianca e dei corti capelli scuri che gli si arricciavano sulla testa. Ma quella voce. Alle mie spalle la porta scattò con un sonoro click, avvisando entrambi dell’arrivo di Justin; la sua voce mi arrivava attutita alle orecchie, come se ostacolata da dei batuffoli di cotone. Perché non mi serviva la luce accecante della lampadina in soggiorno per riconoscere il paio di occhioni azzurri che mi scrutavano intensamente dall’alto - in attesa di chissà cosa, poi. Le dita, ormai completamente insensibili, persero il controllo sulla pistola, lasciandola cadere a terra; riuscì ad udire solo il colpo secco e acuto del colpo partito, prima che la mia vista venisse occupata interamente da un velo nero di pura paura. Dante era a casa. My corner: Olè, aggiornamento record! Sono super puntualissima questa volta. Con un capitolo che non è troppo lungo, ma che ... basta, probabilmente. Più che altro è ... di passaggio, dai. Non credo ci sia nemmeno bisogno di chiarire qualcosa, parla da solo. Carter è stressata, Justin non molla, e si ritrova a casa con un probabile ladro affamato. E SBAM! Dante è tornato. Cavoli, mi sembra così strano che Dante sia finalmente entrato in scena. Non pensavo nemmeno io di farlo tornare a casa così presto, ma mentre scrivevo è uscito tutto da solo, e adesso ho anche perfettamente bene in mente cosa succederà. Inoltre mi sembrava inutile dilungare oltre la sua attesa, perchè non sarebbe servito a niente. Ma, comunque, sono i prossimi capitoli quelli davvero bomba. Quindi, dan-dan, tenetivi pronte a scoprire tutta la verità sulla famiglia Harvey e Justin. Ma, vi chiedo, non vi è sembrato strano che Justin fosse nei dintorni? ouo 'Dio, è così strano essere arrivata a questo punto con la storia. E non so come ringraziare tutte quelle care personicine che seguono questa storia, senza mai annoiarsi o lamentarsi di questa lunga attesa. Davvero, grazie, grazie mille a tutte voi. Spero vi sia piaciuto, anche se non è un granché; come ho detto, il meglio sarà nel prossimo capitolo - che spero di pubblicare entro Domenica/Lunedì. E, come sempre, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate. Alla prossima. Baci ♥ |
Capitolo 26
*** 25. Sometimes light sheets cut off your fingers, and you see the blood but not the wound. ***
 25. Carter. Risvegliarmi nel buio totale mi disorientò per qualche secondo. Ma sapevo con certezza dove mi trovavo - più o meno; il mio stomaco rumoreggiava di rabbia e sentivo un mal di testa tremendo - impossibile capire quanto dipendesse dalla stanchezza e quanto dal colpo che dovevo aver preso. Sulle prime pensai che fosse ancora notte; c’era buio, e me ne accorsi senza neanche aprire gli occhi. Ma quando avvertii una fitta alla testa e un dolore sconosciuto alla schiena notai il piccolo raggio di luce che filtrava dalle tapparelle abbassate – forse era stato proprio il dolore a svegliarmi. Ero sdraiata sulla superficie morbida di un materasso, ma rannicchiata su me stessa com’ero non riuscivo a stare comoda: sentivo pulsare fastidiosamente la schiena e i fianchi. L’aria era diventata calda e afosa, e l’umidità non faceva altro che renderla ancora più fastidiosa; ero sudata, e la maglietta mi si era completamente appiccicata alla pancia come una seconda pelle. Avevo il respiro pesante, e l’orrenda sensazione che il mio cuore non avesse smesso di battere così furiosamente nemmeno per un momento, durante il mio stato d’incoscienza; sentivo il petto dolorante, e lo stomaco in subbuglio. Schiaffeggiando l’aria, al buio, riuscì a toccare il collo di una bottiglietta d’acqua sul comodino; ne strappai via il tappo e mi ci avventai con foga, mandando giù più della metà del suo contenuto in un sol sorso. La gola era secca, e probabilmente tutta quell’impazienza mi avrebbe causato qualche problema, ma in quel momento non m’importava particolarmente. La stanza – che solo allora, guardandomi attorno, mi accorsi fosse quella di Elia - era piena dall’eco dei miei respiri affannati; sforzandomi di domarli, tesi le orecchie per sentire se ci fosse dell’altro. Pericolosamente vicino a me, sicuramente alla mia destra, sentii un respiro silenzioso e regolare; nonostante mi fosse molto familiare, non riuscì a fare a meno di spaventarmi nel notare la figura ingombrante di Keaton accasciata su una sedia lì affianco. Era stretto su se stesso in una posizione visibilmente scomoda: con le braccia incrociate al torace, la testa penzoloni su una spalla, e le gambe sollevate al petto. Forse fu il cambiamento del mio respiro a svegliarlo; o forse fu soltanto perché i nostri ritmi si erano ormai sincronizzati. Ma pochi istanti dopo vidi la sua sagoma avvolta nel buio sussultare. “Carter …?” bisbigliò, facendo scattare su la testa. Spalancò d’improvviso gli occhi, drizzandosi con un scatto talmente secco e rumoroso che fece strusciare le gambe della sedia sul pavimento; al buio, con soltanto la debole luce che filtrava dalle tapparelle a schiarirgli il volto, i suoi occhi azzurri solitamente rassicuranti mi fecero sobbalzare. Scossi invisibilmente la testa, strizzando con forza gli occhi mentre mi lasciavo scivolare verso il bordo del materasso, leggermente frastornata. “Carter … Ter … stai bene?” mi domandò cauto, sporgendosi in avanti; appoggiò i gomiti sulle ginocchia, cercando gentilmente di entrare in contatto con il mio sguardo ostinatamente fisso sul pavimento. Mi passai le mani sulla faccia, come se quel gesto bastasse da solo per poter cancellare dalla mia memoria gli avvenimenti delle ultime ventiquattrore: Dante era uscito di prigione. Dante era davvero tornato. E, maledizione, avevo anche rischiato di piantargli una pallottola in testa. Ma, per quanto potessi essere irritata, disgustata, adirata, rancorosa e incazzata, in quel preciso momento l’unica cosa che riuscivo realmente a sentire era del puro, ardente e semplice … dolore. Quel tipo di dolore molto simile a quello di milioni di tagli con la carta, di quelli che mi procuravo sempre con le pagine sottili dei libri di scuola. Di quelli che capitano in un brevissimo attimo e fanno male per giorni e giorni. Solo che quel dolore durava da cinque anni, e ogni volta che mi svegliavo la mattina ed erroneamente i miei pensieri si dirottavano su mio fratello, era come se qualcuno versasse più e più alcool sulle ferite. Con il suo indesiderato e inspiegato ritorno, Dante, però, sembrava essere riuscito a aprire altri innumerevoli squarci sulla mia pelle già dilaniata. E quella consapevolezza, - sentire quel dolore ritornare a bruciarmi il sangue di nuovo a causa sua – ironicamente, mi faceva ribollire di rabbia; ed era proprio ciò che cercavo disperatamente. Preferivo di gran lunga essere livida dalla rabbia, piuttosto che da qualche altro sentimento scomodo e frustrante. La rabbia era un po’ come una muraglia fortificata che nessuno, in alcun modo o in alcun caso, sarebbe mai riuscito ad abbattere, o anche solo aggirare. Mentre il dolore … il dolore era un po’ come lo zerbino d’ingresso con l’inutile scritta ‘benvenuti’ sopra: permetteva a chiunque di calpestarti, come se quello fosse il tuo unico destino. In quel momento desideravo, come non mai, con tutta me stessa, di non riuscire più a sentire nient’altro. Perché, dannazione, avevo scelto di riprendere a provare delle emozioni così distanti dalla rabbia proprio in quel periodo? Me l’ero cavata egregiamente in quegli ultimi anni nei panni dell’insensibile; ero riuscita a sopravvivere benissimo per tutto quel tempo nella mia bolla ristretta di emozioni limitate, senza alcun danno, prima che Justin riuscisse a rompere l’equilibrio che avevo creato. Gli ultimi mesi passati assieme a lui - litigi, urla e spintoni compresi - erano stati così freschi e … pieni di vita che m’avevano fatto dimenticare per quali motivi non avrei voluto avere nella mia vita quel ragazzo; e uno di questi era proprio lo spaventoso e inspiegabile legame che lo univa a mio fratello. Keaton mi rivolse uno sguardo implorante, in attesa di una mia risposta. “Ter … parlami …” Tirai l’orlo della maglietta giù per le cosce, asciugandomi i palmi sudaticci delle mani sul copriletto celeste. “Senti … lo so che tutta la situazione ci è un po’ sfuggita di mano, ed è normale che ti senta strana all…” “Strana, dici?” sbottai, interrompendolo, sollevando glaciale lo sguardo su di lui. “Io mi sento strana quando un libro non finisce come voglio, o quando non fumo una sigaretta dopo alcuni giorni. No, io non mi sento strana. In questo momento mi sento fottutamente arrabbiata, incazzata nera con il mondo intero.” Mi sbattei il palmo della mano sulla coscia, sibilando un’imprecazione tra i denti. “Lui non doveva tornare, okay? Doveva restarsene nel suo piccolo mondo fatto di bugie dietro alle sbarre, o dovunque cazzo volesse lui, purché talmente lontano da me che non correrei il rischio d’incontrarlo nemmeno se volessi!” “La domanda successiva sarebbe stata chiederti come l’avessi presa, ma sei stata piuttosto esauriente quindi …” mormorò nervosamente in risposta, sfregandosi la mano contro il mento. “Perfetto!” ringhiai a bassa voce. “E lascia che ti risponda anche alla domanda successiva: no. Non sono disposta a ragionare con calma sulla cosa. E no, maledizione, non ho intenzione di rivedere la sua fottuta faccia, grazie mille per l’interesse!” Il mio migliore amico si ritrasse contro lo schienale della sedia, scuotendo molto lentamente il capo; in effetti mi sentivo un po’ in colpa per aver usato quel tono così aggressivo contro di lui, ma non riuscivo proprio ad evitarlo - la nube fuligginosa di rabbia che avevo dentro stava cancellando ogni più piccola traccia del dolore provato inizialmente, lasciandosi dietro una landa desolata, dominata dall’ira e dalle sue più varie e colorate sfaccettature. La mia vita verteva, da cinque anni a quella parte, attorno ad un’unica esigenza: tenere Dante Ethan Harvey fuori da essa ad ogni costo. E non avevo certo intenzione di smettere di farlo proprio con il suo ritorno. Ma lo scrigno di Pandora della famiglia Harvey si stava comunque aprendo, portando a galla con se tutti i suoi segreti, e questo ci avrebbe inevitabilmente sommersi tutti quanti. L’unica cosa che potevo fare era tentare di sopravvivere al naufragio il più illesa possibile. “Non riuscirai ad evitarlo in eterno, Carter” mi ammonì Keaton, seguendomi a ruota fuori dalla camera. Dal piano inferiore non avvertivo nessun rumore, il che mi portò a presumere che se ne fossero – fortunatamente – andati tutti quanti via. “Oh, si che ce la farò. Sai che sono maledettamente brava in questo” bofonchiai in risposta, tastandomi i polsi alla ricerca di una molletta per i capelli. “Non se vuoi che ti dica tutta la verità una volta per tutte.” “Non devo per forza avere a che fare con lui di prima persona per sapere, Keaton!” “Gli hai ficcato una pallottola nella spalla, Carter!” mi ringhiò dietro il biondo. “Quando hai perso i sensi la pistola è caduta, ed è partito un colpo. Per poco non gli ha preso il cuore! Il minimo che tu possa fare è vederlo! So che non puoi essere così stronza, Ter.” “Lui ha dato fuoco a casa nostra. Ha … ha ammazzato la mamma! Porca puttana, se non fossi stata a casa tua quella sera avrebbe ammazzato anche me!” Arrestai la mia camminata a metà scale, allargando le braccia all’aria. “E’ vivo, okay? Non è morto, e di certo il colpo non l’ho fatto partire io di mia spontanea volontà. La mamma invece … non c’è più. Ed è stato lui con le sue stesse mani ad appiccare il fuoco! Sapeva perfettamente quello che stava facendo, a cosa andava incontro, ne era consapevole. Ma lo ha fatto lo stesso; ha scelto comunque di rovinare non solo la sua vita, ma anche la nostra. Ci ha trascinati con se nel suo oblio, senza lasciarci altra scelta! E sai qual è la cosa … la cosa che più mi fa rabbia? Non ha mai chiesto scusa per questo, mai! Non ha mai chiesto scusa a lei per averla uccisa. Perché dovrei … dovrei essere dispiaciuta? Non servirebbe a niente esserlo, comunque. Non a me. Quindi, di grazia, per quale diamine di motivo tu continui a volerlo difendere, eh?” Keaton arretrò di un passo, passandosi il dorso della mano sulla fronte; un lampo di un’emozione indefinita gli attraversò gli occhi, ammorbidendogli lo sguardo mentre tornava a fissarmi. “Non mi aspetto che dimentichi, Carter.” “Bravo, ottima intuizione!” sibilai, riportando le braccia lungo i fianchi. “Lui se n’è andato, ed è colpa sua. La mamma se n’è andata, ed è colpa sua. Io me ne sono andata, ed è colpa sua. Adesso è arrivato il momento che si prenda le sue responsabilità e sconti la sua pena. Qui, fuori, nella vita vera. Dove ci sono le cose che contano. In carcere è stato facile, perché non c’era nessuno che gli ricordasse costantemente ciò che ha fatto. Io ho avuto la sua faccia davanti agli occhi ogni singola e maledetta notte negli ultimi cinque anni, a ricordarmi che lui ci ha distrutti tutti. Io ed Elia abbiamo retto e scontato quelle che sarebbero dovute essere le sue, di sofferenze. Elia ha smesso di disegnare, ha dato fuoco a qualunque cosa gli ricordasse l’arte, nella speranza di non rivedere più il volto della mamma dovunque. Gli incubi mi tormentano ogni notte, come se non volessero farmi dimenticare lui e quello che ha fatto, quello che le fiamme mi hanno portato via per sempre. Una pallottola in una spalla non è niente in confronto. Adesso è il suo turno, invece. Mi dispiace dirtelo ma io so essere molto più stronza di così, e non gli faciliterò di certo le cose adesso che è fuori.” Strinsi di scatto le labbra in una linea dura, respirando profondamente dal naso; mi conficcai le unghie delle dita nelle cosce, cercando di spostare l’attenzione del mio cervello sul dolore fisico in quel punto preciso del corpo, dove le unghie mi graffiavano la carne. Avevo parlato senza prendere aria, e sentivo che la gola era tornata di nuovo ad essere secca ed irritante. Odiavo Dante. Lo odiavo davvero, e odiavo anche me stessa perché lo odiavo così tanto. Odiavo quell’odio che aveva trovato dimora dentro di me, e che mi faceva sentire come se non avessi più il controllo su niente. Keaton sbatté le palpebre un paio di volte, senza perdere nemmeno per un istante il contatto visivo con me; scese i due scalini che ci distanziavano, incurvandosi sul mio volto. Piantò con decisione gli occhi nei miei, impedendomi con la sola forza di volontà di opporre resistenza; gli occhi di Keaton erano sempre stati bellissimi. Dal taglio tipicamente maschile, con un’infinita serie di lunghe ciglia scure – da far invidia a Kim Kardashian - che li incorniciavano; mi avevano sempre ricordato un po’ le acque dei laghi d’estate: di un blu scuro sui bordi, che sfumava pian piano in un celeste talmente pallido e chiaro da sembrare quasi bianco. Vicino alla pupilla si estendevano infinite varietà di pagliuzze vedognole, che alla luce accecante del sole sembravano quasi dorate. Gli donavano quel tipo d’aspetto rassicurante che a scuola faceva capitolare qualunque ragazza. In quel momento, però, c’era qualcosa di diverso in quelle due pozze azzurre che amavo così tanto: una luce più scura, minacciosa, quasi simile al … al rimorso, alla colpevolezza, rendeva i suoi occhi estranei alla mia memoria, più vuoti. Tristi. Lontani. Un campanellino d’allarme si accese nella mia testa, colorandomi per un attimo la vista di un orrendo colore scuro; percepii il mio sangue congelarsi all’istante nelle vene, letteralmente. Keaton mi passò un dito sulla guancia, delicatamente, come se al posto delle dita avesse i petali di un fiore, scendendo piano fino alla curva del collo; mi accarezzò l’interno del gomito, scalando il suo tocco verso le mie dita. Intrecciò la mano alla mia, poggiandomi un lungo e tenerissimo bacio sulla tempia. Il suo tocco mi risultò improvvisamente estraneo, distante e freddo. Sentivo il mio cervello lavorare freneticamente: mi sembrava quasi di poter ascoltare il rumore degli ingranaggi che lavoravano, scontrandosi l’uno contro l’altro, riempiendomi l’udito. “Carter, devi parlare con …” “Io mi fido di te, Keaton” lo interruppi flebilmente. Non farmi del male anche tu. Una richiesta. Un’esigenza. Una preghiera. Una … supplica. Lui era, sul serio, l’unica persona che conoscevo a non avermi mai, mai, nascosto niente, neppure se troppo doloroso o insopportabile da sapere. Era un patto che avevamo fatto da bambini, una settimana dopo esserci conosciuti: la sua totale sincerità per la mia totale e cieca fiducia in lui. In noi, e in quella che sarebbe stata da quel momento in poi la nostra amicizia. Keaton sobbalzò sul posto, sgranando impercettibilmente gli occhi; si morsicò con forza le labbra, fin quando un piccolo fiotto di sangue non sgorgò da esse, imbrattandogli la canottiera grigia. Si lasciò sfuggire un ringhio animalesco dalla gola, che riecheggiò come in un film dell’orrore per tutta la casa, e l’attimo successivo piantò il pugno contro il muro alla nostra sinistra. E a me sembrò di rivedere tutto al rallentatore: un attimo prima davanti ai miei occhi c’erano due bimbetti di cinque anni, uno con gli occhi azzurri e l’altra con i capelli corvini crespi e ribelli. Si stavano scambiando delle promesse, e mentre si parlavano i loro occhi non riuscivano ad abbandonarsi, come fosse un gioco a chi resiste di più. Lui si era chinato, sulle gambe cicciottelle, ed aveva raccolto da terra un piccolo Tirannosauro verde, con i denti in bella mostra. Lo aveva offerto alla bambina, con un enorme sorrisone a mostrare un dentino mancante, ed in cambio le aveva strappato di mano un orsetto giallo, malmesso, con un fiocchetto a pois al collo. Lo aveva stretto nella manina per un orecchio, trascinandoselo malamente dietro, verso la classe. L’attimo dopo avevo dinanzi agli occhi un ragazzo, un uomo, con solo degli occhioni azzurri a ricordare il bambino che era stato e che m’aveva strappato di mano quell’orso senza permesso, prendendosi la mia fiducia. Del sorriso, della luce negli occhi e della sua lealtà non c’era più alcuna traccia; tutto svanito, in soli due secondi. E una cosa era ormai lampante: Keaton mi aveva mentito. Era diventato come tutti gli altri. Appoggiò la testa contro il suo braccio, mormorando una sfilza d’imprecazione che avrebbero fatto impallidire il Papa. Continuò così per degli interminabili ed insopportabili minuti, permettendo a ciò che rimaneva del mio cuore di frantumarsi in milioni di pezzettini, proprio di fronte a lui. Immobile, fissò ostinatamente lo sguardo a terra, come se riuscisse davvero a vedere i pezzi sanguinanti del mio cuore che esalavano il loro ultimo battito sotto i suoi piedi; strinse la mano sinistra lungo il fianco, maledicendo a bassa voce qualcuno, come se avesse davvero potuto sentire le mie urla silenziose. Come se fosse stato davvero capace di vedere nei miei occhi me, che lo pregavo, lo imploravo, di non farmi tutto quello. Ma, purtroppo, era già tardi. La catena salda e indistruttibile che ci aveva sempre uniti si stava disintegrando, proprio tra le nostre mani; sentivo i suoi anelli che mollavano la presa l’uno sull’altro, cadendo a terra in un mucchio di polvere che il tempo avrebbe spazzato via con un soffio di vento, portandosi via tutto ciò che eravamo stati. Ed era così doloroso, così straziante … come se mi stessero staccando le dita a morsi, una ad una. E senza che riuscissi davvero a rendermene conto, un singhiozzo – molto più simile al rantolo lamentoso d’un orso – mi risalì, con studiata lentezza, su per la gola; strappò il silenzio sulle nostre teste con un colpo secco, riversando anche su Keaton tutto il mio panico ed il mio dolore. “Merda, Ter …” Keaton sembrò riscuotersi all’improvviso da un brutto incubo ad occhi aperti, scattando in avanti; io sobbalzai all’indietro per lo spavento, e le sue dita riuscirono a malapena a sfiorarmi una coscia, ma mi sentivo come se quel punto preciso che aveva toccato si fosse carbonizzato irrimediabilmente. “Ter … Carter … non è come sembra. Io … Cristo, volevo solo proteggerti. Ho scoperto tutto solo un paio di mesi fa, quel giorno che hai beccato me e Justin a casa tua. E avrei voluto dirtelo, davvero, lo giuro, ma … non potevo farlo. Non era compito mio dirtelo e … non volevo si arrivasse a questo punto, lo giuro.” “Ma era compito tuo impedire a tutti loro di farmi questo!” gli gridai contro, sentendo il mio labbro inferiore iniziare a tremare. Allora mi conficcai brutalmente i denti nell’interno della guancia, sperando che il dolore fisico m’avrebbe aiutata a non perdere il controllo su me stessa; il labbro però continuava a tremare, e la vista stava iniziando ad essere meno nitida, offuscata da un velo lucido che m’irritava le pupille. “Ho sempre cercato di proteggerti, Carter, ma …” “Che cosa sai?” lo interruppi, cercando di mandar giù il groppo che avevo in gola. Arretrai sulle scale, cercando di distanziarmi il più possibile da lui. “Che inten …” “Che cosa sai!” Keaton esitò, fissandomi a bocca aperta; come se non riuscisse a riconoscermi. Come se fossi stata io quella ad avergli spezzato definitivamente il cuore, senza più possibilità di rimetterlo apposto. E poi la pronunciò. Quella parola. Quelle due sillabe. Quelle cinque lettere. “Tutto.” Mormorò in un soffio, voltando la testa di lato. “So … tutto.” Fu allora che successe; che la bomba ad orologeria che ero diventata esplose. La vista mi si annebbiò completamente, rendendo i contorni del suo volto poco nitidi e sfocati; il respirò mi si spezzò dolorosamente nel petto, come se mi avessero appena presa a pugni, e le lacrime iniziarono a rigarmi come fuoco le guance. Scendevano in fretta, furtive come la pioggia, marchiandomi la pelle a furia di percorrere sempre lo stesso tragitto: giù dagli occhi, per le guance, a solcarmi il labbro superiore, fino ad arrivare sul mento, da dove gocciolavano sul petto. E più strizzavo le palpebre nel tentativo disperato di farle smettere, più loro continuavano a scorrere copiose giù dagli angoli dei miei occhi, moltiplicandosi e dividendosi, prendendosi gioco del mio dolore. “Carter … ti prego, non piangere. Possiamo risolvere tutto, basta che ti calmi.” “No!” ringhiai tra i singhiozzi, portandomi una mano alla gola; volevo strapparmi la pelle, bucarmela con le unghie, purché l’aria ritornasse a circolarmi normalmente dentro, liberandomi la gola da quella sensazione di pesantezza che mi rendeva impossibile parlare. “No! Oh mio Dio tu sapevi. Hai sempre saputo e .. mi hai mentito! Hai giocato allo stupido gioco di Dante per tutto questo tempo!E non hai preso nemmeno in considerazione le conseguenze sulla nostra amicizia … su di me, cazzo! Come hai potuto farmi una cosa del genere? Eh? Come, cazzo!” Keaton si tirò i capelli, mugugnando altre imprecazioni oscene a bassa voce. “Carter, senti, non so come … è complicato, okay?” mormorò, gonfiando il petto per apparire più minaccioso e sicuro di se. “Ma, ti scongiuro, smettila di piangere e …” “Ci sto provando, pezzo di merda! Ci sto provando, ma non ci riesco! Ed è tutta colpa tua!” gli urlai contro, portandomi le mani al collo; mi graffiai le spalle, strizzando furiosa gli occhi, cercando di strappare via dal mio corpo quella sensazione. Ma non ottenevo altro che graffi profondi e bruciore. L’aria stava iniziando a diventare soffocante; le pareti della casa sembravano restringersi sempre di più attorno a me, come a volermi intrappolare in quella gabbia di dolore e panico. E d’un tratto quelle quattro mura mi sembravano troppo piccole perché ci potessimo stare in due, per quanto piccola potessi essere io. “Carter … Cristo, smettila. Ti prego, stammi a sentire. Non è così ..” “Smettila!” gli ruggì sopra, tra un singhiozzo e l’altro, impedendo alla sua voce di continuare a sembrarmi così rassicurante e familiare. “Smettila! Non parlare, non voglio … più sentirti. Lasciami stare. Solo … lasciami in pace! Una volta per tutte! Non ti basta quello che hai fatto? Cos’altro … che cazzo vuoi ancora da me?” Keaton molleggiò le braccia lungo i fianchi, la maglietta ormai imbrattata di sangue. “Non odiarmi, Ter” sussurrò, fissandomi. “Non lo sopporterei.” “Io …” Scossi la testa, combattendo contro la me aggressiva e rancorosa che mi urlava di dirgli di si, di fargli provare lo stesso dolore che lui stava costringendo me a sentire. Istintivamente ricominciai ad arretrare sulle scale, fino a toccare con il tallone il pavimento del soggiorno; percepivo a pieno la presenza della porta a pochi metri dalle mie spalle, come unica via di salvezza da quel luogo. Dal passato e dal presente che si erano mischiati in un mix devastante. Mi passai il dorso della mano sugli occhi, strofinandomi la pelle per riuscire a smettere finalmente di piangere; io non ero così debole. Ero capace d’essere più forte di così. “E’ troppo tardi …” mormorai. E segretamente spero che questo ti spezzi il cuore. Gli voltai le spalle e iniziai a correre verso la porta, a piedi nudi, senza preoccuparmi di indossare qualcos’altro oltre alla maglietta che a malapena mi copriva il fondoschiena. Allungai la mano verso la maniglia, strofinandomi di nuovo gli occhi con quella libera; un passo, e tutto il peso del dolore che portava con se quella casa sarebbe scemato almeno un po’. Ma prima che potessi abbassare quell’inutile pezzo di metallo, la porta si spalancò di scatto; rimasi ferma e immobile, decisa a non ritornare indietro nemmeno di un passo, nonostante quel pezzo di legno conficcato nel fianco. Justin sollevò spaventato la testa, bloccandosi sull’uscio. “Porca puttana! Ti ho fatto male?” mi domandò allarmato, abbandonando la presa sul pomello per allungare una mano verso di me. Impietrita, non sentii nemmeno il tocco leggero delle sue dita sulla pelle. Guardarlo, così simile a Dante, riportava in vita un altro tipo di dolore che pensavo ormai seppellito nei meandri più profondi di me stessa. Come se avessi anche delle ferite sconosciute sotto la pelle che non avevano intenzione di guarire, anzi aspettavano solo l’occasione di riaprirsi. Ma, per qualche assurda ragione, non riuscivo a fare a meno di guardarlo. Una parte di me, per quanto debole, aveva un disperato bisogno di guardarlo, di ascoltarlo, nella speranza che riuscisse a ridarmi quel pizzico di serenità che mi aveva regalato in quegli ultimi due mesi. Il mio cuore e la mia testa erano dilaniati. Neanche lui sembrava in gran forma: aveva l’aria stanca e le occhiaie, e perfino sotto quella luce schifosa sembrava un po’ pallido. I suoi occhi si spostarono dietro le mie spalle, e il suo sguardo si rabbuiò ancora di più, se possibile. Trasalì, ritraendo la mano. “Cosa … che cazzo le hai detto, razza di idiota?” ringhiò contro Keaton, digrignando i denti. Quello fu ciò che mi bastò per tornare alla realtà. Le lacrime, a quel punto, iniziarono a scorrere come un fiume in piena giù dai miei occhi; Justin, ricordai bruscamente, era come tutti loro. Justin mi aveva mentito come tutti loro. Con uno scattò felino gli passai sotto il braccio che teneva stretta la porta, sfuggendo finalmente a quella casa. Attraversai come un fulmine il breve tratto di giardino che separava la casa dalla strada; sentivo le urla di Keaton in lontananza e alcuni passi più pesanti dietro le mie spalle, ma non mi fermai. Svoltai l’angolo della casa dei vicini e m’infilai tra i cespugli di un parchetto per bambini lì vicino, graffiandomi a sangue le cosce; il bruciore per quelle ferite annientò per qualche attimo il dolore, permettendomi di ragionare lucidamente su dove andare. C’era solo una persona da cui potevo rifugiarmi. Aggirai uno scivolo giallo e una giostra girevole a forma di fiore, prima di concedermi un’occhiata alle mie spalle: Justin era ancora dietro di me, ma comunque troppo lontano perché potesse anche solo sperare di fermarmi. Saltai, con un po’ di fatica, un piccolo steccato dalla vernice bianca rovinata, attraversando di corsa la strada deserta. Guardai prima a destra e poi a sinistra, cercando di orientarmi; in lontananza intravidi un familiare cartello celeste piegato per metà, quindi ricominciai a correre in quella direzione. Quella volta era il mio turno di scappare. Writer's corner:
Okay, giù le armi. Lo so, sono in un ritardone che di più non si può. Ma, è di nuovo colpa del mio computer. Purtroppo la visita precedente in assistenza non sembrava aessergli bastata, e così ha deciso di non funzionare di nuovo. Solo oggi è potuto passare il ragazzo che doveva portarmi quello nuovo - anche lui è in vacanza, comunque, ecco perchè così tardi - quindi automaticamente solo oggi sono potuta rientrare qui su EFP dopo così tanto tempo. Non sapete quanto mi dispiace, davvero. Ma, DANDAN, eccomi qui. E c'è pure il nuovo capitolo. Che è anche un pò più lungo degli ultimi. So che speravate già in un incontro ravvicinato Carter-Dante, ma purtroppo, non è ancora il momento. Anche perchè la sorella gli ha piantato una pallottola in una spalla, quindi direic he sarebbe statod avvero poco adeguato farli incontrare. In compenso, però, ci sono Carte e Keaton. O meglio, c'è Carter con il cuore a pezzi, e Keatonc he peggiora le cose rivelandole che le ha mentito. So che a qualcuno potrebbe sembrare strana la reazione di Carter, ma se ci riflettete non lo è poi così tanto: Keaton è stato l'unico uomo nella sua vita che non le ha MAI mentito. Mai. E lei si fidava ciecamente di lui, gli avrebbe affidato la vita. Quindi scoprire che per tutti questi mesi le ha mentito, nascondendole di sapere tutta la verità - che poi chissà quale delle verità - l'ha giustamente distrutta. Qindi ecco spiegata la reazione. Inoltre mi sarebbe sembrato un pò scontato raccontare lo scoppio emotivo di Carter a causato da Justin, non trovate? Anche perchè non è ancora finita, eh. Carter deve ancora farsi raccontare la verità da suo fratello - e quindi anche Justin, che è stato molto partecipe nella tragedia come già sappiamo. Bene, non so come sia venuto il capitolo, ma spero comunque vi piaccia - nonostante il ritardone. E mi scuso già per eventuali errori, che provvederò a correggere non appena li individuerò. Quindi, sperando che vi ricordiate ancora di me lol, chiudo e ci vediamo alla prossima. Sperando che il capitolo sia di vostro gusto. Bacioni ☺♥ |
Capitolo 27
*** 26. Epilogue. ***
 26.
Carter Non ricordavo con nitidezza cosa fosse successo dopo. Non sapevo nemmeno con esattezza cosa intendesse il mio cervello con quel ‘dopo’; se dopo la rottura del legame che mi univa a Keaton. Se dopo aver finalmente aperto gli occhi su ciò che mi circondava. O se dopo essere riuscita a sfuggire a Justin – per l’ennesima volta. Non ricordavo se mi fossi sbucciata il ginocchio a sangue mentre correvo, guardandomi alle spalle nel terrore di veder spuntare Justin da qualche cespuglio, o se semplicemente avevo sbattuto contro gli steccati rovinati dei vari parchetti attraversati. Non ricordavo come avessi fatto ad arrivare di fronte alla porta della casa di Tyreek, né se lo avessi fatto immediatamente o se avessi continuato ad aggirarmi senza meta per le strade del quartiere poco popolato in cui viveva - barcollando tra un luogo abbandonato e una casa in rovina. Non ricordavo d’essermi presentata proprio dinanzi a casa sua, né se lo avevo fatto per sbaglio, per disperazione, o perché ero alla ricerca dell’unica persona al mondo abbastanza distante dalla mia vita al di fuori del Sanyo da non ricordarmi costantemente quello che era appena successo. Appena. Non sapevo nemmeno quanto tempo fosse già passato; secondi. Minuti. Ore. Comunque, non m’importava. Non sentivo più niente. Non avevo la minima idea di come dovevo essere apparsa, dopo quel vagabondaggio silenzioso, agli occhi degli altri; cosa avessero visto in me le pochissime persone contro cui mi ero imbattuta durante la mia fuga. Ad un certo punto, l’unica cosa che la mia memoria rammentava, erano un paio d’occhi chiari che mi fissavano, allarmati; poi un paio di braccia forti mi avevano afferrata sotto le ascelle, accompagnate da sussurri concitati, mentre una folata d’aria calda e profumata mi avvolgeva. Racchiusa tra quelle braccia conosciute, lontana, avevo lasciato che un ultimo singhiozzo mi risalisse lungo la gola: un singhiozzo unico, secco – sì, doloroso - ma senza più nessuna lacrima versata. Non avevo più pianto. Non lo avrei fatto mai più in vita mia. Per nessuno. Tyreek, come mi aspettavo e speravo, non aveva fatto troppe domande; si era tenuto sul vago, cose banali le cui riposte non interessavano a nessuno dei due. Ma tanto era bastato per farmi calmare. Perlomeno il necessario per permettermi di pensare con un po’ di lucidità sul da farsi. E lì avevo capito tutto, o quel che c’era da capire. L’unica cosa che mi restava, e volevo disperatamente fare, era una sola; semplice, veloce e indolore: mettere finalmente un punto alla fine della frase. Una frase che restava senza conclusione da troppo tempo, continuamente allungata da virgole e punti sospensivi. E io ero certa d’avere quel coraggio necessario per farlo, chiuso da qualche parte dentro di me. Con quella nuova sicurezza ero balzata giù dal letto e mi ero letteralmente fiondata fuori casa sua, incurante d’indossare solo dei calzini ai piedi. E se avevo fatto bene i miei calcoli, Tyreek quella volta doveva aver chiamato Elia o quel traditore di Keaton; in quel preciso momento dovevano essere tutti sicuramente per strada verso casa sua, sicuri di trovarmi ancora nei dintorni, mentre io in realtà stavo per raggiungere la mia, di casa. Casa. Non ero poi tanto convinta di voler considerare ancora così quelle quattro mura intrise di segreti e bugie. Segreti e bugie che credevo fossero fuggiti via assieme alla scomparsa di Rick dalla nostra vita; non avrei mai pensato che una buona metà di loro avevano come custodi le persone di cui mi ero fidata ciecamente. Elia. Keaton. Dante. Jackson. Cole. ‘Dio, chissà chi altro. Ma, mi ricordai mentalmente, schiaffeggiandomi le guance, a me non importava più niente. Di nessuno di loro. Non doveva più essere così. Scavalcai lo steccato marrone di un parchetto malandato a duecento metri da casa mia, graffiandomi polpacci e palmi delle mani. L’erba aveva assunto uno strano color senape, e la sentivo dura e ruvida al tatto nonostante avessi i calzini; c’erano due panche appartenenti a delle passate altalene appoggiate contro un palo della luce, immerse in un mix di foglie e fanghiglia. Alla mia destra era piantato nel terreno un cavalluccio giallo dagli occhi verdi, con la molla talmente danneggiata che bastava solo quel filo di vento presente per farlo muovere avanti e indietro. Poco distante c’era uno scivolo dalla coda rossa, mezza incrostata dal fango e dalla polvere, con la casetta marrone che era l’unica cosa ancora apparentemente intatta. Dall’apertura usata prima dai bambini per salire, alla quale mancava la scaletta, penzolavano fuori un paio di gambe lunghe, fasciate da jeans neri e sporchi. Dall’altra fessura, che dava sullo scivolo, affacciava una folta coda di cavallo bionda, che si muoveva al ritmo di una musichetta che chissà chi stava intonando a bocca chiusa. All’improvviso, il proprietario di quelle gambe si sollevò di scatto, con la testa già voltata verso di me; un paio d’occhi color del ghiaccio si piantarono nei miei, accessi da una luce di maliziosa curiosità. I capelli gli scivolarono attorno ai lati del volto, in morbide ciocche bionde che gli arrivavano sopra le spalle; uno spesso strato di barba scura, che mi portò a notare la ricrescita scura dei suoi capelli sulla testa, gli adornava la mascella, sin sotto alle orecchie. Il naso era un po’ arrossato sulle punta, notai, mentre se lo grattava con le dita. Le sue labbra piene di spiegarono in un sorrisetto divertito, che però non raggiunse gli occhi; mi squadrò per bene da capo a piedi, scuotendo la testa. “Scappi anche tu, eh bambolina?” mi schernì, senza però alcuna nota di vera ilarità nella voce. E solo allora, quando con un balzo saltò giù, notai l’enorme borsone nero che sostava a uno dei piedi della casetta. “Cosa … no! Scappare? Che dici?” esclamai sulla difensiva, arretrando di un passo, senza saperne nemmeno il perché. Lui mi degnò di una fugace occhiata, prima di posare il suo sguardo sul cielo che si stava oscurando di già. “Lo sto facendo anch’io. Di solito lo fanno i miei fratelli, o mia madre e mio padre. Questa volta invece lo faccio. Ma sai qual è la differenza tra di noi?” Il ghiaccio tornò a piantarsi nei miei occhi, questa volta più deciso e ardente. “Tu non tornerai” mi lasciai sfuggire lentamente, abbassando lo sguardo. “Il tuo piccolo segreto è al sicuro con me, tranquilla” affermò dopo qualche istante, e potei vederlo con la coda dell’occhio afferrare la sua borsa da terra. Se la issò sulle spalle con uno strattone, sporcandosi la maglietta bianca di terra, e si incamminò verso la direzione dalla quale ero arrivata io - verso la fermata dei taxi quindi. “Dove vai?” Non so per quale motivo glielo chiesi, ma non mi vergognai, quella volta, ad incontrare i suoi occhi indagatori. “Intendo … uhm …” “Un mio amico e la sua band sono in concerto a Seattle domani. Se decidessi di farci un salto, ti consiglio di volare con la Delta Air Lines. Si risparmia di più.” E, voltandomi le spalle, si avviò verso il marciapiede, dove aveva appena accostato un taxi. Buttò dentro l’abitacolo il suo borsone e si voltò verso di me, strizzandomi poco felice l’occhiolino. “Aspetta! Com’è che ti chiami?” “Sono sicuro che ci rivedremo presto bambolina” si limitò a rispondermi, sparendo dentro la macchina gialla. Riuscì ad intravedere attraverso il finestrino la testa cicciottella del tassista che si voltava verso di lui, annuendo alle sue indicazioni; spiaccicò qualche parola e si voltò, mettendo in moto. In pochi secondi la macchina sparì dalla mia visuale, anche troppo velocemente per quanto fosse concesso dalla legge ad un taxi. Ma non era quello l’importante. Quel ragazzo aveva appena messo il punto alla fine della sua frase. Ed io ero assolutamente certa di voler, e poter, fare la stessa cosa. Mi ridestai dai miei pensieri e ricominciai la mia avanzata verso casa, decisa più che mai, animata da un nuovo fuoco, a non farmi fermare da nient’altro. Sorpassai il parco, saltai lo steccato e attraversai velocemente la strada, impedendo ad una BMW di investire il cagnolino bianco della vicina. Il fatto che quando entrambi i coniugi fossero fuori casa lo lasciassero slegato aveva portato il povero animaletto a trovarsi in certe situazioni ‘sgradevoli’ ben più di una volta. Fortunatamente quel tratto di strada era percorso dalla maggior parte delle persone ad una velocità moderata, quindi alla fin fine l’unica cosa che il cucciolo ci ‘guadagnava’ era solo un bello spavento che lo faceva rimanere chiuso nella cuccia per un paio d’ore. Gli diedi una pacca sulla schiena, spingendolo verso il giardino di casa sua. “Dai piccoletto, vai a casa.” Quasi come se mi volesse ringraziare, o consolare magari, il cagnolino mi accarezzò un polpaccio con la testa pelosa, prima di scodinzolare allegramente via. Quando rialzai la testa, notai con disapprovazione che il giardinetto di casa mia era ancora occupato da due macchine; mi bloccai in mezzo al marciapiede per un secondo, quasi spaventata, ma ricominciai a camminare qualche secondo dopo. Jackson e Kayden potevo affrontarli tranquillamente anche da sola. Ma, di nuovo, mi ammonii da sola. Non dovevo fare niente se non ignorarli. Far finta che non esistessero. E mi bastò immaginare quante cose mi avessero tenuto nascoste in quegli anni, per ritornare ferma e irremovibile sulla decisione presa. Mi graffiai per l’ennesima volta le cosce con le unghie, concentrando la totale attenzione del mio cervello su quel punto preciso, mentre spalancavo indifferente la porta di casa. Quello che però mi trovai dinanzi non l’avevo previsto. E non mi riferivo al salotto completamente e letteralmente distrutto; ma a Kayden che sedeva con il naso sanguinante sulla poltrona, sovrastato dalla figura di Jackson che gli stava tamponando il punto ferito con un asciugamano bagnato. Sul fondo delle scale, era seduto Elia con la testa tra le mani; al suo fianco il padre di Ian gli sussurrava all’orecchio chissà quale altra sporca bugia da rifilarmi. Per un breve istante, nel rendermi conto che anche quell’uomo mi aveva sicuramente mentito, sentì qualcosa nel petto incrinarsi – come se non avessi già perso tutti pezzi del mio cuore. Ma fu solo un attimo, perché il secondo dopo tornai fredda e impassibile ad osservare lo scenario che mi si presentava agli occhi – nessuno si era ancora accorto della mia presenza, tra la confusione generale. Cole era appoggiato contro lo sportello del frigorifero, a braccia conserte, e teneva lo sguardo fisso sulle due persone che mancavano all’appello. Justin aveva, per l’ennesima volta, il volto tumefatto; le sue sopracciglia si stringevano ogni volta che inveiva contro Dante, che aveva di fronte. Su di lui non mi ci soffermai nemmeno; non sentivo il bisogno di guardarlo per capire che l’ondata di disgusto e rabbia che mi stava investendo era tutta una conseguenza della sua presenza lì. Dentro la mia casa; mia e di Elia. Una casa che apparteneva unicamente a noi due, e dove la sua presenza – oltre a non essere gradita - ‘stonava’ decisamente. Così mi limitai ad appiattirmi contro il muro, aguzzando le orecchie per cercare di captare più pezzi possibili del loro discorso. “… niente” stava dicendo in quel momento Justin, sollevando le braccia completamente tatuate all’aria. Mandai giù il groppo che mi risalì in gola al ricordo della serenità che negli ultimi due mesi quelle stesse braccia mi avevano donato – e che in quel momento lottava per sopraffare la mia rabbia. “Ne sei davvero sicuro Bieber?” ribatté secco Dante, passandosi una mano tra i riccioli ormai tornati del loro naturale color cioccolato. I suoi occhi passarono velocemente in rassegna l’amico, prima di spostarsi sul soffitto della cucina. “E’ sempre stata più furba ed intelligente di noi tutti messi insieme. Non mi stupirei se ci fosse arrivata da sola…” “Oh, andiamo! Sii realista Dante” s’intromise Cole, staccandosi dal frigorifero. “Nemmeno la persona con la più fervida immaginazione sulla faccia della Terra arriverebbe mai a pensare che il ragazzo di cui è innamorata abbia aiutato il fratello a bruciarle casa! Né che il motivo per il quale lo ha fatto è la vendetta …” Solo che dopo quelle parole, il mio udito sembrò scomparire improvvisamente. Osservavo il volto di Justin da lontano, come se il tempo si muovesse a rallentatore; lo osservavo, ed era quasi fisicamente doloroso farlo. E avrei voluto con tutto il cuore entrare a passi d’elefante in cucina, prenderlo a pugni in faccia, e urlare a tutti loro che non mi ero innamorata di lui; che non era vero, che non lo avevo mai amato, nemmeno un po’. Che l’unico sentimento che avevo provato nei suoi confronti era l’odio. Ma non ero certa il mio corpo avrebbe retto anche un solo passo in avanti - non se quello m’avrebbe portata proprio di fronte a lui. Mi accasciai così contro il muro, scivolando lentamente verso il pavimento; mi raggomitolai su me stessa, circondandomi la pancia con le braccia. Sentivo uno strano dolore attanagliarmi lo stomaco, come se quei due fossero riusciti a spezzarmi il cuore per l’ennesima volta. Era come se fossero riusciti a raccattarne i pezzi da terra, li avessero incollati insieme e m’avessero spinto il cuore nel petto, per poi romperlo nuovamente. Ancora. E ancora. E ancora. Come se tutto ciò fosse un circolo vizioso impossibile da fermare: ogni volta che sembravo riuscire a ricostruirmi, i pezzi si scollavano per ricadermi nello stomaco; taglienti. Brucianti. Dolorosi. Solo che quella volta non sentivo niente di bagnato e fastidioso scivolarmi giù dagli occhi; forse quell’emozione non era nemmeno dolore vero. Forse era l’apatia – che tanto avevo agognato in quegli anni – che si stava facendo largo dentro di me, pronta ad avvolgermi nelle sue spire, per proteggermi e non lasciarmi andare mai più. Qualunque cosa fosse quel senso di torpore, gli avrei permesso di avvolgermi completamente. Purché si portasse via tutto quanto: dolore, rabbia, panico, delusione, e ancora rabbia. Volevo solo che cacciasse tutto via, lasciando solo l’involucro vuoto del mio corpo. “Carter!” mi richiamò qualcuno, dal nulla, irrompendo nel mio campo visivo. “Carter, maledizione!” Meccanicamente sollevai la testa, osservando senza alcuna emozione il volto straziato dal dolore di Elia, ormai a pochi centimetri da me; adesso si erano tutti resi conto della mia presenza lì. Il padre di Ian si era avvicinato a Keaton e Jackson, appoggiati ormai sul dossale del divano; dalla cucina, invece, sentivo gli sguardi di Justin, Dante e Cole bruciarmi addosso – avevano anche il coraggio di guardarmi. Ma, ormai, nemmeno di quello m’importava. Di loro, del dolore di Elia, della casa distrutta. Per la rima volta in vita mia, l’unica cosa di cui m’importava davvero era di trovare l’interruttore delle mie emozioni e strapparlo via, così che non si sarebbero più potute riattivare. “Ti prego” continuò testardo Elia, afferrandomi per le spalle. “Ti supplico, non lasciarmi. Piangi, urla, prendici a pugni tutti quanti fino allo sfinimento, ma ti prego, ti prego, non abbandonarmi di nuovo. Lo so che abbiamo, che ho sbagliato a tenerti nascosta tutta questa storia. E adesso come non mai, se me lo chiedessi, butterei Dante fuori casa a calci. Lo rispedirei in prigione seduta stante. Ma per favore, non lasciarti andare di nuovo. Non … non ce la posso fare questa volta. Non lasciarmi, ti scongiuro!” Appoggiò la fronte sulla mia, fissando i suoi occhi nei miei, senza vergognarsi di mostrarmi le lacrime che minacciavano di sfuggirgli da un momento all’altro. Riuscivo a leggere in quel mare azzurro tutto quello che sentiva: la rabbia, la frustrazione e la paura cieca di perdermi. Riuscivo quasi a rivedere la me di un paio di anni fa, quando dopo l’incarcerazione di Dante mi ero rinchiusa in camera e non ne ero uscita per quasi sei mesi. Rivedevo nei suoi occhioni azzurri lo stesso terrore che aveva sentito allora, quando da quella camera non ne era uscita sua sorella ma solo il suo fantasma. Ma io non ero quella di allora, e non riuscivo davvero a sentirmi in qualche modo in colpa per il modo in cui lo stavo facendo sentire; avrei voluto, con tutto il cuore. Perché Elia era Elia, dopotutto, ed io lo amavo. Lo amavo davvero con tutto il cuore. Ma non in quel momento; non ci riuscivo. Voltai quindi la testa di lato, mettendo più distanza possibile tra noi mentre mi rialzavo da terra; sentivo le gambe molli, e le ossa indolenzite sembravano pronte ad abbandonarmi da un momento all’altro. Dovevo sbrigarmi a trovare una via di fuga per poter scappare da tutti loro. Il tempo necessario per salire in camera mia, prendere i miei soldi e un paio di scarpe, per poi saltare giù dalla finestra. Facendo un veloce calcolo, mi sarebbero bastati anche tre minuti. “Carter…” Quella volta non era stato Elia – in quel momento preso da parte dal signor Oliver - a richiamarmi. La figura snella di Justin mi si catapultò davanti; mi schiacciò contro il muro e piantò le mani sulle mie guance, costringendomi a guardarlo. I suoi occhi si spalancarono, passando in rassegna ogni centimetro del mio corpo alla ricerca di chissà cosa; salì dai calzini che avevo ai piedi, passando per la maglia di Tyreek, per arrivare al mio volto. E poi fece qualcosa che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Mi baciò, aggressivo, lì di fronte agli occhi di tutti – come se avesse letto dentro di me il modo deciso in cui avevo rinnegato i miei sentimenti per lui. Sembrava avesse visto come me li ero strappati di dosso e li avevo gettati via, senza la minima intenzione di riprenderli eventualmente indietro. E con quel bacio voleva riportarli a galla, mostrarli a tutti per fargli capire che avevo mentito. Ma non avrebbe funzionato; non lo avrei fatto vincere, non quella volta. Furiosa e ferita nell’orgoglio, appoggiai le mani sul suo petto e con tutta la forza di cui ero capace lo spintonai via; il necessario per alzare la mano e colpirlo con un pugno in pieno naso. “Non azzardarti a toccarmi mai più!” Ma lui sembrò quasi non sentirmi; si toccò il naso con la manica, e poi tornò su di me. Mi bloccò tra le sue braccia, di nuovo spalle al muro e inchiodata dal suo corpo. “Non osare aprire bocca!” lo avvisai in anticipo, lottando per liberarmi dalla sua morsa. “Non osare, perché davvero questa volta ti spacco il naso!” “Da quanto tempo sei qui? Cosa hai sentito?” domandò frettoloso, mantenendosi però distante. “Dove cazzo sei stata per sette ore?” Aveva le mani strette a pugno lungo i fianchi, e i suoi occhi ardevano di irritazione; si mordeva nervosamente l’interno della guancia, il petto si alzava ed abbassava ad un ritmo più veloce del normale, e non sembrava minimamente intenzionato a spostarsi da dove stava. Era spaventato. Justin Bieber era spaventato all’idea che avessi scoperto ciò che aveva fatto – e che m’aveva nascosto per tutto quel tempo, giocando con i miei sentimenti. Ma, sinceramente, non m’importava più di come si sentisse lui. Però c’era una cosa che volevo fare prima di sparire definitivamente dalla vita di tutti loro: ferirlo. Ferirlo tanto quanto lui aveva fatto con me. “Rispondimi, maledizione!” ringhiò, azzardando un pazzo in avanti. “Non iniziare con i tuoi soliti giochetti da stronza proprio adesso.” Quella fu la goccia che fece traboccare il vaso, probabilmente. “Ho sentito abbastanza da desiderare che ci fossi finito tu in quel incendio, stronzo!” gli inveii contro, terribilmente glaciale, fissandolo dritto negli occhi; volevo che sentisse, che vedesse, tutto l’odio che ero capace di provare per una sola persona. La stanza piombò nel silenzio più assoluto, quasi come se tutti stessero trattenendo il fiato; Justin mi fissava impietrito, con uno sguardo che sembrava quasi stentare a riconoscere la ragazza che aveva di fronte, per quanto crudele fossi stata. Ognuno di loro mi osservava come se fossi la reincarnazione in gonnella di Freddy Krueger; sembravano quasi pronti a biasimarmi per ciò che avevo detto. Quasi fossi io la persona senza cuore della situazione. Arrabbiata da quell’atmosfera, lanciai uno sguardo a tutti quanti, sfidandoli apertamente a darmi contro per qualche motivo. Nessuno osò però fiatare – saggiamente, avrei aggiunto. Distolsi l’attenzione dalla faccia da cucciolo ferito di Justin, approfittando di quel attimo di stallo per ritornare al mio obiettivo principale: fuggire. Senza rimorsi o ripensamenti. Con uno scatto degno di Usain Bolt schivai i corpi immobili di Justin, Elia ed il signor Oliver, correndo in soggiorno; visti i loro tempi di reazione, probabilmente mi mancavano solo una decina di secondi prima che iniziasse l’inseguimento. Pregando le mie gambe di concedermi un ultimo sforzo, sorpassai Keaton e Jackson e mi lanciai sulle scale; le saltai due a due, senza curarmi dei passi veloci che sentivo provenire dalla cucina. Saltai gli ultimi tre scalini e scivolai sul pavimento verso la mia stanza; afferrai la chiave e mi ci catapultai letteralmente dentro, chiudendo la porta nel esatto momento in cui qualcuno iniziò a prenderla a pugni. “Carter, andiamo, apri!” mi richiamò Jackson, continuando a tartassare il legno di colpi. Fortunatamente per me Jackson era di statura piuttosto esile in confronto a quelle di Justin o Dante, quindi prima di arrivare allo sfondamento della porta ce ne sarebbe voluto di tempo. Ma a me bastavano giusto due minuti in più. Infilai al volo un paio di vecchie Vans da sotto al letto, correndo contemporaneamente verso l’armadio; lo svuotai di metà guardaroba, alla ricerca di un vecchio zainetto nero della Nike che usavo solitamente per le gite scolastiche fuori città. Quando lo avvistai, lo tirai da sotto un paio di jeans e lo aprì ai miei piedi, infilandoci giusto un giubbino, dei pantaloni da basket e un paio di mutande pulite. “Carter …” mugugnò ancora Jackson, continuando a percuotere la porta. Lo ignorai e tornai a concentrarmi sul mio armadio; buttai a terra gli ultimi vestiti rimasti e iniziai a tastare la superficie, alla ricerca del doppio fondo che avevo creato per metterci i miei risparmi. Nonostante Keaton sapesse che Tyreek non retribuiva giustamente me e Leanne per il nostro lavoro al Sanyo, segretamente invece lo faceva, quindi negli ultimi anni avevo avuto la possibilità di mettere da parte un bel gruzzoletto – più di cinquemila dollari almeno. Quando al tatto sentì una parte di legno un po’ graffiata mi bloccai, infilandomi quasi completamente nell’armadio; con le unghie mi aiutai a trovare i bordi dell’asse, così da riuscire a sollevarla completamente. La gettai sul letto ed iniziai a spostare i soldi nelle tasche dello zaino; le riempì più che potevo prima che la loro capienza arrivasse al limite. “Carter, per favore, parliamone” tentò ancora Jackson, rinunciando alla violenza sulla porta come soluzione. “Vattene via!” gli urlai in risposta, afferrando un giacchetto di jeans da mettere sopra la maglietta a maniche corte che avevo addosso. Infilai anche un paio di pantaloncini, giusto per evitare che durante la mia corsa qualcuno si imbattesse nelle mie ‘grazie’. Issai lo zaino su entrambe le spalle e mi affacciai sulla finestra, lanciando un ultima occhiata alla mia camera; Jackson aveva smesso di parlare ormai. Le soluzioni erano due: o aveva capito che era meglio lasciarmi in pace, o era corso a chiamare rinforzi. In entrambi i casi era comunque troppo tardi; stavo per mettere un punto alla mia storia, e non avrei permesso a nessuno di impedirmelo. Non volevo saperne più niente delle loro cazzate; non m'interessava nemmeno più sapere come fossero andate realmente le cose, né quanto Justin vi fosse dentro. Mi sarei dimenticata di tutti loro, in un mondo o l’altro, e mi sarei fatta una nuova vita; in fondo i bugiardi sono quelli che si scordano più facilmente. Avrei voluto dare un’ulteriore sguardo alla stanza che mi aveva ospitata negli ultimi tre anni, ma i colpi alla porta ricominciarono più furiosi e pesanti di prima – dovevano essere arrivati in rinforzi, alla fine. Così, senza nessun timore, mi arrampicai sul ramo grassoccio dell’albero che mi stava di fronte; mi trascinai vicino al tronco, iniziando la mia discesa verso terra – sempre il più in fretta possibile. Mi graffia le gambe e mi sbucciai un polpaccio contro la corteccia ruvida, ma non ci feci poi tanto caso; come un soldato ben addestrato, rimanevo concentrata sull’obiettivo che mi ero prefissata di raggiungere. Ad una decina di metri da terra mi lasciai cadere, atterrando fortunatamente – e stranamente, visto il mio precario senso dell’equilibrio – in piedi. Non mi diedi nemmeno il tempo di sollevare lo sguardo verso la finestra, nemmeno per accertarmi che non fossero già riusciti a buttare giù la porta; mi limitai a ricominciare a correre, più veloce che potevo, verso la fermata del taxi. Attraversai fulmineamente la strada, nascondendomi dietro le macchine parcheggiate sul ciglio per passare inosservata; saltai lo steccato dei vicini di Ian e mi avviai verso il parchetto abbandonato. Per fortuna, o sfortuna – dipendeva dai punti di vista – le strade erano quasi deserte; per fortuna, perché così non avevo impedimenti sul mio tragitto. Per sfortuna, invece, perché se fossero partiti alla mia ricerca sarei stata facilmente rintracciabile. Ma, nemmeno quello importava più, perché oramai ero già arrivata alla fermata ed un taxi stava giusto accostando alla strada; ne approfittai subito, non curandomi di chiedere al tassista se fosse in servizio o quella era la sua pausa. Mi buttai sul sedile – ricevendo anche un’occhiataccia dal omaccione alla guida. “All’aeroporto, grazie.” ____________________________________________ Il tassista parcheggiò malamente di fronte all’entrata dell’aeroporto Internazionale di San Diego, sbuffando per la ventesima volta solo negli ultimi dieci minuti di viaggio; si voltò – per quello che gli permetteva la sua stazza – verso di me, inarcando un sopracciglio. “Si, si, un secondo” bofonchiai, infilando la mano nella tasca dello zaino; afferrai una trentina di dollari e glieli lasciai sul palmo della mano. “Tenga il resto.” Quando mi richiusi lo sportello alle spalle, il tassista non aspettò nemmeno un secondo in più prima di schiacciare a pieno sull’acceleratore. La maglietta mi si sollevò sulle cosce – e mi congratulai mentalmente con me stessa per essermi infilata i pantaloncini; sistemai meglio lo zaino sulla spalla e, facendo slalom tra la moltitudine di persone che entravano ed uscivano, mi avviai incontro alla mia nuova vita. Non pensavo avrei avuto mai il coraggio di mettere fine a quella catena di bugie e sotterfugi che mi giravano attorno da anni; un po’ perché non pensavo arrivassero a coinvolgere praticamente tutte le persone che contavano nella ma vita, e un po’ perché amavo troppo mio fratello per fargli una cosa del genere. Ma quel pomeriggio le cose avevano superato anche la mia immaginazione e così mi ritrovavo da sola, mezza svestita, in un aeroporto, alla disperata ricerca di una meta, odiando praticamente il mondo. Non volevo nemmeno pensare alla possibilità che addirittura Leanne e Baja sapessero di tutta quella merda; il solo pensiero mi lanciò delle fitte acute allo stomaco che mi costrinsero a fermarmi in mezzo all’enorme sala principale. Dante aveva appiccato il fuoco alla nostra casa, uccidendo la mamma. E come se non bastasse, Justin lo aveva aiutato, per vendicarsi di chissà quale torto subito. Justin aveva ucciso mia madre, maledizione. Sembrava quasi che il mio cervello non volesse farsene una ragione, ma purtroppo la cruda e reale verità era quella, e Justin non ci aveva pensato su neanche un secondo quando mi aveva baciata per la prima volta. Né quando lo aveva fatto più e più volte negli ultimi due mesi. Né quando mi aveva chiesto di fidarmi di lui. Nemmeno una volta, da grande egoista quale era, aveva mai pensato a me. Così come nessuno di loro; l’unica cosa che aveva contato era mantenere le apparenze e pararsi il culo – detta volgarmente. E finalmente era arrivato il mio turno; solo che io non avevo mentito a nessuno per salvare la mia immagine. Ero solo stata travolta dalle azioni di qualcun altro, costretta a subirne le conseguenze. L’unica cosa che stavo facendo io, in quel momento, era correre verso una nuova vita – che non comprendeva nessuno di loro. Che non comprendeva San Diego. E tutte le sofferenze che comportava. Stavo solo cercando di salvare me stessa. Scossi la testa e tornai alla realtà, trovandomi di fronte agli occhi il tessuto bianco di una maglietta. Presa alla sprovvista saltai all’indietro, portandomi le mani al petto. “Te lo avevo detto che ci saremo rivisti presto” mi apostrofò lo sconosciuto, facendo un passo verso di me. La sua voce mi risultava stranamente familiare, e solo quando sollevai lo sguardo riconobbi nel mio ‘incidente’ il ragazzo del parchetto. Indossava ancora la stessa maglietta bianca e gli stessi pantaloni scuri, con il borsone che gli penzolava dalla mano sinistra; anche lui in fuga. Allungò una mano in mia direzione, sorridendomi dolcemente. “Sono Neal.” “Carter.” Mi sorrise ancora, quella volta sinceramente, abbandonando subito la presa sulla mia mano. “Allora, ancora in fuga?” “Decisamente” affermai, sollevando di nuovo lo sguardo su di lui. “E tu, ancora verso il concerto dei tuoi amici a Seattle?” “Mhm” mugugnò a bocca chiusa, spostando lo sguardo dai cartelloni degli orari ad un foglio che aveva in mano – che doveva essere il suo biglietto. Lesse qualche cosa scritta lì sopra velocemente, prima di riporre il foglio nella tasca dei jeans. Allora tornò a posare la sua attenzione su di me, piegando un po’ la testa per osservarmi meglio.”Allora, ti va un caffè?” Mi mordicchiai le labbra, abbassando per un momento gli occhi; la mia vita mi si stava sgretolando tra le mani, non avevo ormai più un luogo che potevo dire mi appartenesse, né tantomeno una meta. Un caffè - anche se schifoso come solo negli aeroporti sapevano fare - era probabilmente la cosa di cui più avevo bisogno in quel momento. “Certo.” _______ Si, come potete vedere sono proprio io (spero che qualcuno si ricordi ancora di me lol). Sono viva e vegeta, e dispiaciutissima per tutto questo tempo d'assenza - ormai ho anche perso il conto di quanto tempo è che non entravo qui su EFP. Purtroppo tra trasloco, scuola, problemi prima con il computer e poi con la connessione ad Internet, problemi familiari e le vacanze natalizie, non ho davvero avuto un minuto libero per poter aggiornare o dare qualche cenno di vita. Solo questi ultimi giorni, dove sono riuscita a ricavarmi un pò di tempo per me e serenità, ce l'ho fatta a rientrare - e anche a postare questo benedetto ultimo capitolo di Ablaze. Purtroppo non è certo il massimo, e sinceramente non convincee nemmeno me; non era quello che mi prospettavo inizialmente di scrivere. Ma, oltre al tempo, un'altra cosa che mi è mancata in questi mesi è stata l'ispirazione. Il capitolo lo avevo già iniziato, e la conclusione non è certo delle migliori, ma volevo almeno concluederer questa prima parte della storia per potermi così concentrare sulla seconda - con una mente più fresca sicuramente. E si, ci sarà sicuramente un sequel di Ablaze; anche perchè Carter in fuga verso chissà quale luogo non mi sembrava nemmeno il modo più adatto per concludere le cose. C'è ancora molto da scoprire, soprattutto su Justin; e si, bisognerà pur vedere che fine ha fatto Carter, perchè si, sul serio se ne sta andando via. Ha raggiunto il suo limite, e l'unico modo che ha trovato per salvarsi, è stato scappare. E poi c'è l'entrata in scena di questo Neal, che sarà uno dei nuovi protagonisti principali del sequel. E niente, spero che il capitolo non faccia proprio così schifo, e spero di rivedere qualcuno anche nel sequel. Grazie mille comunque, come sempre, alla bellissime personcine che hanno continuato a seguire questa storia - mi avete resa davvero contenta. E alla prossima. Bacioni P.s Buon Natale (in ritardo) e buon anno nuovo (in anticipo) lol |
Capitolo 28
*** SEQUEL. ***
Ebbene sì, sono di nuovo qui.
Ma, solo per annunciarvi, che il sequel di Ablaze è arrivato! D'ora in poi quindi, non aggiornerò più qui. Per chi fosse interessato a continuare a seguire la storia di Carter e Justin, può trovarla qui: Cinders. Ho già pubblicato il prologo. Grazie mille di nuovo a tutti. Vi adoro. Baci |
