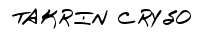Il sogno della Donna Rossa di Aleena
(/viewuser.php?uid=27691)
Disclaimer: Questo testo proprietà del suo autore e degli aventi diritto. La stampa o il salvataggio del testo dà diritto ad un usufrutto personale a scopo di lettura ed esclude ogni forma di sfruttamento commerciale o altri usi improri.
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** Ricordi d'Autunno ***
Capitolo 2: *** Il cimitero ***
Capitolo 1
*** Ricordi d'Autunno ***
 IL SOGNO DELLA DONNA ROSSA
IL SOGNO DELLA DONNA ROSSA

Capitolo I – Ricordi d'Autunno
Come in un sogno Takrin si era ritrovata ancora a camminare lungo quel viale, avvolta strettamente nella logora giacca rossa. Sapeva che non c'era nulla di onirico in quello che la circondava: il crocchiare delle foglie secche sotto gli stivali vermigli era un eco in scala del rumore dei rami secchi sbattuti dal vento o che cadevano, morendo su un letto giallo e porpora insieme a ciò che restava dell'estate.
Si era lasciata la strada alle spalle da un po' e procedeva su un sentiero di campagna che saliva dolcemente, serpeggiando attraverso campi coperti d'erba indurita dal freddo, brillanti al sole del mattino. Alle sue spalle il rumore della strada si attenuava man mano, respinto indietro da quella brezza gelida che le scostava i capelli bianchi dal viso, ghiacciandole il respiro in nuvole evanescenti. Non era tipo da modernità, Takrin. Spesso, nel corso della sua lunga esistenza, aveva pensato di provare a salire su un'auto, ma la paura l'aveva sempre fermata. Preferiva camminare. Non la scoraggiavano i quaranta minuti di strada che avrebbe dovuto affrontare in quella gelida mattina di fine ottobre: andarla a trovare era uno dei suoi rituali più antichi e consolidati, forse l'unico che la teneva ancora legata a quel luogo – probabilmente l'unica cosa piacevole che le fosse rimasta del periodo più bello della sua intera esistenza.
Con un sospiro Takrin scosse il capo, cercando di cacciare via i fantasmi del tempo che cercavano ancora una volta di schiacciarla.
«Se c'è qualcosa che non capisco è perché ti ostini a voler continuare a lottare per loro!» disse Astrea, fronteggiandola. Avevano il volto a un centimetro l'una dall'altra e si guardavano con un misto di ira e sorpresa, come se non fossero in grado di individuare nell'altra la persona che conoscevano da tutta una vita.
«Loro sono la nostra vera fazione... i nostri simili! Per gli dei, perché non lo vuoi capire?»
Takrin urlava. Astrea non l'aveva mai sentita gridare, ma dovette ammettere che l'altra ne perdeva in forza morale: era molto peggio quando la squadrava gelida e piena di disprezzo.
«Capire? Se c’è qualcuna che non vuole capire quella sei tu! Come fai tu a non rendertene conto? Ti stanno usando, Takrin! Vogliono il tuo potere, il tuo dono! Vogliono che ci uccidi tutti e poi faranno lo stesso a te. Sei troppo potente e intelligente per... »
«Per non rendermene conto? Oddei, Astrea, potrei dire lo stesso di te. Cosa credi, che ti lasceranno vivere nel mondo che stanno per creare? Che ti accoglieranno come se fossi davvero una di loro?»
«Io voglio evitare che altre città siano spazzate via da maghi e stregoni che considerano gli esseri umani meno che schiavi!» disse Astrea, accorata. Aveva il tono di chi cerchi di afferrare il vento, o di spiegare i colori ad un cieco.
«E vuoi farlo con la guerra?» domandò Takrin, sprezzante. Ora il suo tono era derisorio, intriso di un divertimento amaro. «Tu credi che sia giusto che noi moriamo per lasciare loro vivere?»
«Non deve andare così. Io... sono qui per trattare. Le loro condizioni sono...»
«Eque?» Takrin alzò le mani e spinse lontano da sé l'altra, con violenza, guardandola scivolare all'indietro, cercando di riprendere l'equilibrio. Era disgustata. «Vogliono il bando della magia, e aree controllate entro le quali rinchiuderci. Come bestie!» gridò, azzerando la distanza mentre in silenzio recitava un incantesimo. La sua mano destra prese a brillare di una luce verde, fredda e infetta.
«Non... loro... vogliono difendersi! Vogliono solo che bruciate i grimori, e...» Astrea incespicò, cercando la spada con una mano, freneticamente. Non la trovò: aveva accettato un incontro in stato di tregua e le armi non erano ammesse - almeno, quelle che fossero divisibili dall'ambasciatore.
«Lo so cosa vogliono. Ma noi non ci lasceremo uccidere» sibilò Takrin, muovendo la sfera acida fino a meno di un centimetro dal volto di Astrea prima di rendersi conto di cosa stava facendo. Tirò via la mano come se fosse stata lei stessa a ustionarsi e si allontanò, cercando il contegno che non si era resa conto di aver perso.
«Nessuno ha parlato di...» riprese Astrea, cauta. Era finita in ginocchio quindi provò a rialzarsi, lenta e circospetta.
«Quella è la nostra vita. L'Arte! E, per gli dei, sterminerò tutti gli esseri umani che oseranno solo tentare di portarmela via! Diglielo. Striscia da loro e diglielo!»
Il muro alla sua destra terminò bruscamente, lasciandosi dietro solo qualche ciottolo verde di muschio. Takrin alzò lo sguardo come faceva sempre, sfidando quella luce troppo fredda e bassa per il tempo necessario a guardarsi intorno.La valle si apriva come un sogno, sinuosa e colorata come una vecchia coperta stesa su un letto sfatto. La luce del mattino ne illuminava i contorni, delineandoli con una nitidezza che aveva del divino.
È in posti come questi che puoi trovare Dio, le aveva detto Astrea alla fine e solo in quel momento Takrin se ne era resa veramente conto - e aveva cominciato a osservare tutto con voracità, come una bambina che per la prima volta apre gli occhi.
Tuttora, a distanza di secoli, continuava a sorprendersi della bellezza di quel luogo, che riluceva di pace e silenzio nonostante le ossa dimenticate che riposavano sotto la coltre di foglie e terra. Forse per questo sfidò il sole e sorrise, provando una scintilla feroce di quella che definiva pace... finché i rumori della battaglia non presero a risuonarle nella testa.
«... per questo stanotte combatteremo. Per questo moriremo, cercando di portarci dietro quanti più invasori possibile!» tuonava Kars'ht davanti a loro, dritto e inflessibile come un dio vendicativo. Spire di luce verdastra circondavano le mani, il volto e il corpo dello stregone, rendendo la sua figura ancora più eterea e minacciosa.
Vuole spaventare tanto i nemici quanto gli alleati, pensò Takrin con rammarico, fermandosi un minuto prima di scuotere il capo. Era in prima fila, fra la delegazione della Torre Nera: qualcuno l'avrebbe di sicuro notata e il senso del discorso sarebbe andato a farsi maledire.
Non che fosse incoraggiante, secondo lei: trovava che le parole dell’Arcimago fossero un singolare miscuglio di vuoto e inutilità, troppo simili a quelle di un bravo politico - tanta scena, poca sostanza.
In fondo, lui è sempre stato più voce che braccio, si disse, e non poté impedirsi di sorridere.
Gasta le diede una gomitata, colpendola al ginocchio e facendole abbassare lo sguardo per incontrare quello del goblin, che la squadrava con l'aria di severo rimprovero. Takrin allargò di più il sorriso, sollevò le mani grigiastre in alto sopra la testa e fece partire un applauso. Dietro di lei esplose un boato di gioia violenta ed esultate timore. Compiaciuto, Kars'ht le indirizzò un cenno del capo e Takrin gli rispose sollevando il pungo in aria, un gesto che scoprì il serpente verde che le avvolgeva l'avambraccio, affondando i canini nel reticolo di vene al polso.
Il simbolo della Torre Nera. L'emblema dei Necromanti.
Vide il volto di Kars'ht irrigidirsi e se ne compiacque. Lasciò il braccio alzato fino a quando un mormorio basso e carico di timore le arrivò alle orecchie sensibili, quindi abbasso piano l'arto, voltandosi nuovamente verso il Maestro. Gasta aveva il volto livido e sembrava sul punto di scoppiare in una delle sfuriate che tanto l'avevano fatta piangere durante i primi anni alla Torre, ma si trattenne, conscio che una sola scintilla di caos avrebbe portato l'esercito allo sbaraglio.
«Se sopravvivi alla giornata giuro che ti strappo a frustate quella pelle grigia da bastarda dalle ossa. E lo farò senza usare la magia.» Il goblin aveva parlato con una vocetta bassa e stridula, talmente fievole da essere sovrastata dal sibilo degli amuleti e dalle voci che gridavano ordini. Gasta sapeva che Takrin l'avrebbe sentito: le sue orecchie fini, retaggio della sua metà oscura, erano ciò che le aveva fatto fare carriera all'interno della Torre. Quello, e il suo viso di una bellezza disarmante.
«Ho sempre apprezzato la tua nota sadica, Gasta» disse Takrin, sorridendo ancora. Il goblin tentò di ribattere poi distolse lo sguardo, stizzito: per quanto fosse un convinto sostenitore della superiorità fisica delle femmine della sua razza, Gasta non riusciva a fare a meno di apprezzare i tratti di quella ragazza. Quel sorriso era sempre stato la sua debolezza.
Qualcuno li stava chiamando, invitandoli a radunarsi. Lei e gli altri ventuno adepti della Torre Nera vennero inviati a far da supporto al contingente ovest, quello meno esposto: avrebbero dovuto essere la barriera contro eventuali attacchi provenienti dai boschi. Takrin ne fu lieta: quegli alberi erano da secoli dimora di spiriti della natura, che gli Elementalisti o i Druidi avevano sicuramente già istruito. Qualunque nemico fosse penetrato fra quella boscaglia non ne sarebbe uscito vivo.
Siryo.
Con un moto improvviso Takrin cominciò a correre scansando, senza troppa cura, chi le si parava davanti con un semplice gesto della lunghe dita affusolate, fino a raggiungere il piccolo avvallamento dove erano già riuniti i Druidi, intenti a recitare le loro preghiere alla Madre Terra.
«Siryo?» chiamò Takrin a voce alta, cercando di allontanare il senso di nausea e distogliendo più di un'apprendista dallo stato di concentrazione meditativa, guadagnandosi occhiate infuocate. Non se ne curò, come era suo modo. Se bastava una voce nel silenzio a farli perdere, come avrebbero fatto quando i sibili delle frecce e degli incanti, i tonfi delle macchine da guerra e delle esplosioni o le litanie di evocazione e i canti di guerra fossero arrivati a loro?
Non ci vorrà molto per saperlo, pensò, volgendo lo sguardo alla prima linea, dove già il combattimento infuriava. Stanno per essere messi alla prova, si disse e ne sorrise, sadica e divertita. Odiava gli inetti e i Druidi erano fra i più idioti e inutili esseri che il mondo magico avrebbe mai conosciuto. Figli della Terra! Come se a quel mondo fosse importato qualcosa di loro.
«Siryo?» chiamò ancora, stavolta a voce più alta, contrastando il senso di nausea e repellenza che i luoghi sacri le davano. Qualcuno la afferrò per una manica e la costrinse a voltarsi, prendendo poi a trascinarla senza alcuna grazia fino a un cerchio poco lontano. Allungando una mano rinsecchita, il vecchio Druido indicò la figura di un ragazzo, immerso nella Litania. Takrin si liberò dalla sua presa con uno strattone e, combattendo il disgusto e il dolore che l'attanagliavano, rimase ferma ad osservare il giovane, cullando in seno la soddisfazione di saperlo dalla sua parte.
Aveva vinto, finalmente!
Fu quel momento di compiacimento a distrarla. Persa nel sapore di quella vittoria a lungo sperata, non si accorse delle parole che venivano pronunciate.
Così, quando il pugnale le carezzò dolcemente la gola come un morso gelido, Takrin provò una vera, intensa paura, quanta non ne aveva mai sentita dal giorno in cui era riuscita a fuggire dal sottosuolo.
«Ti colgo impreparata, amica mia? Questo si che è straordinario» disse la voce di Astrea all'orecchio di Takrin – che, in un lampo di ira e disorientamento, comprese. Come aveva potuto non capire cosa stavano dicendo? Aveva passato tutta l'infanzia nel loro stradannatissimo monastero!
«Cantavano per voi...» disse Takrin, immobile. Tese ogni muscolo allo spasmo, cercando di riattivare tutte quelle corde di difesa che aveva allentato per un momento, fatalmente – e li sentì: la sua gente che gridava, attaccata alle spalle dai soldati umani e dalle dita di roccia e legno evocate dai Druidi.
Tradimento! gridò una voce dentro di lei, e fu come se una forza sorgesse direttamente dal suo cuore spingendola a tutto pur di trionfare. Facendo appello a ogni briciola del potere innato che aveva in corpo Takrin evocò una barriera di acido che le bruciò carne e ossa, provando solo soddisfazione quando scivolò lungo l'arma di Astrea fino al suo braccio, cominciando a scavare. Gli occhi del serpente presero a brillare, impietosi e carichi di brama, mentre le piccole narici si dilatavano all'odore del sangue di amici e nemici che già cominciava a macchiare la terra vergine, trasferendo un brivido di desiderio e passione direttamente al cuore di Takrin.
«Buffo, non trovi? Stanotte sarà un anno preciso che non ci vediamo. Le tradizioni sono dure a morire, vero?» disse Takrin con odio, caricando un incanto silenzioso che le fece rilucere le mani pian piano. «Avresti dovuto uccidermi quando potevi farlo, Astrea! Ora, finalmente, salderemo ogni conto.»
Chiuse gli occhi e rese omaggio, silenziosamente, alle anime che ancora vagavano su campi di battaglia dimenticati. Poteva vederle - era sempre stato il suo scopo - e sapeva che anche loro potevano, benché il tempo stesso li separasse.
Dunque chinò il capo e portò la mano alla bocca, alla fronte e poi, con un mezzo giro fluido, al petto, nel saluto rituale ai caduti. Uno di essi, un uomo dal viso duro congelato nell'atto di trafiggere il suo nemico, si voltò e le sorrise - un sorriso triste, carico di rimpianto e gratitudine.
Nessuno ormai li omaggiava più da secoli.
Nessuno ricordava.
«Il mondo è degli umani, e loro hanno la memoria e la vita breve» disse Astrea con un sorriso triste. Takrin, seduta accanto a lei, si allungò quel tanto che bastava perché le sue braccia potessero avvolgere il corpo dell'amica. Astrea iniziò a piangere: lunghi singhiozzi frammentati, carichi di disperazione.
Sedevano nel cortile del monastero che tanti anni prima avevano chiamato casa a osservare le foglie dell'autunno che cadevano lente.
«Ma noi ricordiamo. Noi saremo qui per così tanti anni che la memoria di quello che siamo, di quello che abbiamo fatto e costruito, non scomparirà mai. E poi lo racconteremo ai nostri figli, e loro, a loro volta...» disse Takrin, cercando di consolarla. Non era capace a farlo e non era difficile intuirlo: le sue parole suonavano vuote, prive di convinzione.
«Non userai la mia stessa dottrina contro di me, vero?» disse Astrea tra le lacrime, improvvisamente sollevata. Strinse a sé le braccia dell'amica come fossero l'unica cosa vera in un mondo in rovina e si guardò intorno, sbattendo con le ciglia le lacrime via dagli occhi. «Dovremmo farlo ancora, sai?»
«Cosa?»
«Vederci qui. Come una volta. Dovremmo farlo ogni anno.»
«È già stato un miracolo che i Druidi mi abbiano fatta entrare questa volta. Se non fosse stato per Siryo io...» una pausa. Astrea non poteva vederlo, ma la bocca di Takrin si era piegata in un sorriso amaro. «Non posso tornare qui, Astrea. Loro mi odiano. E sospetto che la cosa sia reciproca.»
«Allora troviamo un altro posto. Qualunque! Voglio solo poter parlare in pace con qualcuno che mi capisce... che mi conosce!»
«Hai Siryo.» Takrin aveva la voce spenta, lontana. Senza che se ne accorgesse, le sue mani presero a scivolare via dall'abbraccio.
«Anche tu. E questo stupido triangolo deve finire. Io non lo voglio, Takrin.»
«E lui non vuole me.»
«Proverò a parlargli. Io voglio solo...»
«Smettila di fare i capricci, Astrea. Non si può sempre avere tutto, né sistemare ogni cosa! E poi lui è appena stato iniziato.» Takrin si mise a ridere, allontanando con un gesto violento Astrea da sé. «Nessun Druido vorrà mai avere a che fare con un Negromante. Loro predicano la vita, noi manipoliamo la morte. Se anche ci fosse stato futuro, per me e Siryo non potrà mai più esserci.» concluse Takrin con un'alzata di spalle che mascherava tutto il dolore, sminuendolo. Cominciò a muoversi lentamente, il mantello verde acido che le ondeggiava attorno alla vita.
«Fra un anno tornerai? Alla piazza, dove giocavamo insieme da bambine... ci sarai?» le chiese Astrea con disperazione. Takrin sollevò ancora le spalle e si allontanò, lasciandola sola.
Dall'altra parte del cortile, un giovane elfo dai capelli color malva si alzò e mosse due passi, incerto. Poi si sedette e sospirò. Aveva perso Takrin per sempre, ma non ora: lei gli aveva voltato le spalle già da tempo, il giorno in cui aveva lasciato il monastero per imboccare il cammino sacrilego dei Necromanti.
Astrea, però, non l'avrebbe mai accettato.
Dodici passi e fu fra gli alberi, nuovamente. Non c'era però la campagna oltre, ma solo altra boscaglia, man mano più fitta.
La macchia era lì da così tanti anni che, rientrandovi, Takrin sentì di ritrovare un vecchio amico trascurato, ma mai veramente dimenticato. Una lingua d'asfalto correva dritta davanti a lei, perdendosi nella prospettiva d'ocra nebuloso e apparentemente infinito.
Qui i colori cambiavano drasticamente, come per un volontario intervento: non erano più le tinte del marrone e del giallo a regnare, ma quelle del rosso. Porpora, carminio, scarlatto, cremisi, vermiglio... era il suo colore a regnare ora.
Sorrise sollevandosi il cappuccio sul capo, a coprire i capelli candidi.
E mentre la sua figura si perdeva nella variopinta uniformità del bosco in autunno, Takrin si sentì finalmente libera e viva.
Come una foglia caduta.
Nel sottosuolo la vita era stata dura ma non l'aveva preparata di certo a quello che l'attendeva in superficie.
Sapeva bene qual era il suo ruolo nell'Underdark: tacere e servire senza mai alzare gli occhi o farsi vedere. Nessuno si aspettava che una mezzadrow come lei rimanesse in vita abbastanza da poter imparare a camminare da sola, eppure quel decennio c'era stata penuria di schiavi. Dunque lei puliva e si muoveva a testa bassa, avvolta nelle vesti grigie e stinte degli schiavi.
Indossare un abito colorato era stata la prima cosa che aveva fatto quando aveva conquistato la libertà. Takrin aveva sempre invidiato le Matrone Drow e i loro vestiti dalle tonalità cariche e sgargianti, che ostentavano camminando per le strade o nei salotti. Dunque quando la ribellione era iniziata e lei, furtiva e silenziosa come il suo sangue d'Elfo e Drow combinato la rendeva, era strisciata nella camera della sua signora e aveva tagliato la gola da un orecchio all'altro a lei e al suo amante nel sonno, non aveva resistito e s'era impadronita della prima cosa che aveva trovato, fuggendo senza osservare neppure cosa fosse.
Con quel pezzo di stoffa rossa aveva corso fra i dedali delle strade ed era scivolata nelle caverne oscure, dove i suoi occhi potevano vedere a breve distanza. Era emersa alla luce del sole che albeggiava e quella luminosità fievole aveva bruciato la pelle delicata che mai, in centotré anni, era stata esposta all'Astro della superficie.
I Druidi l'avevano trovata e curata. Le avevano insegnato a parlare e a tollerare il giorno, a non avere paura e a capire che il mondo non era quello in cui era sempre vissuta... e avevano provato a toglierle la stoffa dalle piccole manine di bambina per scoprire, poi, che nulla scatenava la furia della sua magia innata come cercare di sottrarle qualcosa che considerava suo.
Takrin non si fidava di loro – non si fidava di nessuno, per la verità. Vagava sola, aspettando il momento in cui sarebbe stata abbastanza grande e forte per andarsene, indossando la giacca rossa che aveva portato con sé dal sottosuolo. Una giacca da maschio!
L'ironia avrebbe potuto ucciderla.
Molte cose le erano rimaste dalla sua infanzia: un sarcasmo pungente, la convinzione che un Drow fosse sempre e comunque superiore a qualsiasi altra razza e la credenza che i maschi non erano altro che feccia inutile, se paragonati alle femmine – e forse era per questo che aveva legato con la piccola Elfa Astrea, che con lei aveva in comune metà della genia?
Eppure avrebbe indossato quella giacca perché l'aveva desiderata tanto, coi suoi colori feroci e vivi. L’amava.
E poi, dalla fuga aveva ricavato solo una tunica di un celeste così smorto da somigliare troppo al grigio.
|
 Piccolo spazio-me: Hola a tutti e ben ritrovati, spero.
Ho pensato a lungo se aggiornare questa storia o no e alla fine ho deciso che si, aveva decisamente bisogno di essere rivista.
L'ho corretta e spezzata, facendola diventare miniLong (una OS di più di settemila parole era pesante da leggere) quindi eccola qua. Rinnovata nella forma ma abbastanza invariata nel contenuto.
Sto pensando di farne una long, tempo permettendo... incrociate le dite per me perché ho tanta voglia di fare e troppo poco tempo, ora come ora! :S
Tornando a noi, ho meditato a lungo sulle parti dei ricordi: avevo inizialmente pensato di mettere il passato in ordine sparso, creando una sorta di "via dei ricordi" che, solo alla fine, avesse un senso logico e potesse essere ricondotta alla storia della vita di Takrin ma, alla fine, ho deciso di metterli in ordine più possibile cronologico, cercando comunque di mantenere l'associazione "camminata-ricordo"... in fondo lei ripercorre la sua vita attraverso i dettagli che le vengono in mente mentre raggiunge il cimitero, e siccome lei conosce com'è andata mi sembrava illogico che potesse pensarli in ordine strettamente cronologico :D
Ok, ho scritto un pippone infinito :D Tutte le ispirazioni dei contest (che trovate nell'introduzione) sono servite a darmi l'idea - non mi era mai successo con così tanti imput diversi *_* - e sono abbastanza contenta di come sia venuta... spero sia piaciuta anche a voi! Fatemelo sapere mi raccomando!
Al prossimo capitolo! :)
Grimorio: Libro di magia
Drow: splendidi ma malvagi elfi dai capelli bianchi e dalla pelle nera come l'ebano.
Elementalisti: Tipologia di maghi che esercita il controllo degli Elementali, creature leggendarie costituite da uno solo dei quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco.
Negromante: Mago o Stregone che esercita una forma di divinazione in cui i praticanti cercano di evocare spiriti o di riportare in vita i morti per varie ragioni.
Ars: la magia come viene definita da chi la pratica (“Arte”).
Mi trovate anche qui > RELEESHAHN
|
Ritorna all'indice
Capitolo 2
*** Il cimitero ***
 IL SOGNO DELLA DONNA ROSSA
IL SOGNO DELLA DONNA ROSSA

Capitolo II – Il Cimitero
C'era una vaga foschia che aleggiava alle pendici dei primi alberi, serpeggiando. “Gli spettri delle foglie” la chiamavano un tempo le vecchie signore – e chiudevano le imposte, scuotendo il capo e raccomandando ai bambini di aspettare che si diradasse prima di andare a raccogliere funghi o castagne.
Erano tempi diversi, quelli. Più silenziosi, più antichi, più profumati e carichi di superstizione. Takrin li rimpiangeva con una forza che andava al di là di qualsiasi amore avesse mai provato.
Una parte di lei viveva ancora in quell'epoca appena precedente al conflitto, e sempre più spesso si trovava a vagare lì con la fantasia, sognando che un semaforo fosse un lampione dai vetri colorati e le auto solo carrozze. Allora chiudeva gli occhi e si domandava cosa la tenesse ancora lì, perché avesse scelto quella vita.
Era il viso tondo e sorridente di Astrea che rivedeva, allora. La sentiva ridere e cantare, la rivedeva seduta accanto a lei, i piedi penzoloni oltre una finestra che non esisteva più, nel vuoto che le separava dalla piazza. Chiacchieravano per ore di tutto e di nulla e Takrin si sentiva bene, anche se non poteva saperlo.
Non ancora.
Crescere in un monastero condizionava la mente in modi che nessun devoto avrebbe mai compreso se non ne fosse uscito.
Takrin si alzava la mattina e cantava le lodi ai Cinque Aspetti della materia, tracciando stelle e simboli sacri nell'estasi del canto. Poi si vestiva, mangiava velocemente, si sciacquava volto e mani nel fiume e scendeva nel chiostro, dove le venivano impartiti i rudimenti dell'Arte. Poi pranzo, cena, bagno nel fiume e a dormire con le stelle. Avrebbe vissuto così tutta la vita se, una mattina, Astrea non le avesse proposto di accompagnarla al mercato.
Era più grande di lei di diciassette anni, Astrea – il che voleva dire che erano praticamente coetanee. Aveva una lista di piccoli animali che doveva procurarsi per rifornire i recinti del monastero e le serviva un aiuto. Takrin, con cui l’Elfa condivideva la camera da quando, meno di novant'anni prima, era fuggita dall'Underdark, aveva accettato di buon grado non appena aveva visto chi altro avrebbe fatto parte del gruppo.
Siryo era vicino al carro, intento a controllare le cinghie che tenevano legato il cavallo da tiro. L'elfo era quanto di più bello Takrin avesse mai visto, e Astrea era d'accordo: tante erano state le notti in cui avevano fantasticato su Siryo, immaginando gli amori e le avventure che ognuna di loro avrebbe vissuto con lui. Non c'era gelosia, non ancora: quelle sarebbe arrivata anni dopo.
Era stata una mattinata di una tranquillità che aveva del meraviglioso: avevano scherzato come solo vecchi amici sanno fare, scambiandosi battute e commenti maligni. Poi qualcosa aveva catturato lo sguardo di Takrin e la ragazza si era allontanata, abbandonando la mano di Siryo senza quasi accorgersene.
C'era un uomo che sedeva fra i cadaveri impalati di tre serpenti putrefatti, che esibivano alla luce del giorno l'osso bianco e spezzato che li aveva tenuti in vita. L'uomo agitava le mani e recitava una litania in una lingua che Takrin non aveva mai sentito, ma che trovava familiare in un modo sconcertante e disgustoso.
Si fece largo fra la folla assiepata fino alla prima fila e osservò, curiosa come non era mai stata. L'uomo terminò di recitare l'incantesimo e sparse sui rettili una polvere fine e maleodorante, che avvolse i cadaveri lentamente, come fosse dotata di vita propria. Questi presero a contorcersi immediatamente, sibilando furiosi e sputando goccioline di veleno.
La gente gridò, indignata, e Takrin si mosse in avanti, strappando senza accorgersene il pugnale che l'imprigionava dalla più vicina delle bestie, una serpe verde.
Quando le chiesero perché l'avesse fatto, rispose solamente che aveva avuto pena dell'animale; ma non era così e i Druidi lo capirono.
Il serpente, libero, si volse e attaccò la ragazza, che mise le mani davanti al volto per proteggerlo, offrendo il polso alla bestia. I canini che, gravidi di veleno, affondavano nella carne tenera furono un dolore che le frustate delle Matrone non avrebbero mai potuto eguagliare. Il veleno si diffuse, gelido e caldo a un tempo, attraverso le vene e fino al cuore, bruciandolo.
E mentre il serpente si avvolgeva attorno al braccio di Takrin, succhiando tutta la vita che gli occorreva per rigenerare il corpo morto, parte di quella nera fine che aveva incontrato contaminò l'anima della mezzadrow, cambiandola.
L'aria era umida nella macchia, carica dell'odore di funghi e foglie muffite. Contorti scheletri di spini e bassi arbusti sorgevano dai cumuli di fogliame e humus come sentinelle che ammonissero i viaggiatori, mettendoli in guardia sui pericoli della boscaglia. Takrin non li degnava che di una misera occhiata, ben attenta a dove metteva i piedi: la stradina era diventata un sentiero sterrato, coperto di foglie umide e terra bagnata. Qua e là, dove qualche temerario aveva tentato di condurre un veicolo, c'erano piccole buche colme di acqua stagnante, che mantenevano umida la terra e la costringevano a camminare lungo il ciglio. Non c'era più altro rumore, ormai, che il cinguettare di qualche uccello e il crepitio del legno secco.
E, più oltre, il lamento nostalgico e armonico del vento.
Una veste nera, da apprendista. Ancora una volta Takrin subiva il peso di non avere scelta.
Era nella Torre da ventisei anni, ormai, e sospettava che l'uomo che l'aveva condotta lì avesse commesso il più grave degli errori. Takrin non si sentiva in grado di operare la "magia grezza", quella forma di Arte che non richiedeva tramiti o amuleti, attingendo direttamente dalla forza vitale dell'incantatore che la evocava. Non era mai riuscita a richiamare nemmeno una stilla di acido, e quello era uno dei trucchi che insegnavano ai bambini.
Ai bambini, per gli dei!
Le avevano fatto credere di essere diversa... speciale! E lei, Takrin, aveva lasciato ogni cosa per seguirli in quel nero anfratto troppo simile all'Underdark, dove ogni cosa puzzava di fiori secchi ed erbe vecchie. Aveva abbandonato tutti quelli che conosceva, tutta la sua vita... e per cosa?
Siryo la disprezzava. Gliel'aveva detto quando, ad appena un anno dall'iniziazione, era riuscita a ottenere mezz'ora di libera uscita. "Sei la negazione di tutto ciò che è sacro, e lo accetti senza preoccupartene. Sputi sulle mani che ti hanno riportata alla vita e dici a te stessa che è la cosa giusta!" le aveva sussurrato, guardandola come se davanti a lui ci fosse qualcosa di oscenamente disgustoso.
Non che l'opinione comune fosse poi differente: il cittadino sputava ai piedi dei Necromanti, additandoli come ladri di cadaveri e profanatori di tombe. Che idioti! Come se la sua Arte fosse limitata a quello... ma si sa, gli esseri umani non vedono al di là di quello che il primo strillone gli urla in faccia!
Anche le altre genie non erano da meno: i pochi non-umani rimasti in città gestivano le scuole di Ars e i templi degli Dei Minori, e rinnegavano ogni legame con gli adepti della Torre Nera.
Siamo i reietti senza casta e dignità, pensava spesso Takrin. Senza amore. Come possiamo non amare l'odio?
Nella Torre non riportavano in vita i morti. Non usavano i cadaveri per oscuri riti agli Dei della notte o per mantenersi giovani e potenti nel tempo.
Non così spesso, almeno.
Semplicemente studiavano il buio e le forze sconosciute che dominavano la morte, cercando di plasmare la notte e l'aldilà, piegandole al loro volere. Takrin stessa aveva stillato gocce di veleno dalle vene nere che si estendevano, attraverso portali di tenebra, dalle oscure braccia della morte fino alle grandi sale in cima alla torre, dove nessuna luce era in grado di prevalere.
Non c'era nulla di malvagio in questo, era vero: ma l'esposizione a così tanto vuoto, a quel nulla gravido di presagi, era in grado di segnare chiunque. Persino Takrin, che non era stata molto più che un'assistente fino a quel momento.
Il ribrezzo per i luoghi sacri era il primo sintomo, quello per cui si diceva che i Necromanti fossero maledetti. Cominciava con un fastidio al petto, che diveniva oppressione quasi fisica e poi compressione alla testa e ai polmoni. Molti ne erano morti, finendo schiacciati dalla loro stessa tenebra.
Come spiegare al cittadino comune, magari umano, che tenebra e male non sono sinonimi? Come far capire che la luce è simbiotica alla vita, e l'oscurità alla morte? Impossibile.
Aveva provato a spiegarlo a Siryo e ad Astrea, ma non avevano capito. Le erano rimasti vicini, dapprima con il timore naturale che si ha verso chi abbandona un'idea comune, poi con quella familiarità distaccata che la lontananza bastava ampiamente a giustificare.
A Takrin stava bene. In effetti, quello che le importava era continuare ad avere una confidente... e a sperare che Siryo ingoiasse definitivamente l'orgoglio del quasi-Druido ferito e si accorgesse di lei, di come l'aveva sempre amato.
Non ci furono brusche interruzioni nel panorama d'alberi spogli, o cambi di rotta repentini. Semplicemente la strada si allargò via via da un lato, dilatandosi come il rumore della risacca. L'odore della salsedine cominciò a emergere dall'umidità prima timidamente, poi con una prepotenza che solo l'oceano poteva avere – ma era ancora la terra, ancora il bosco a irretirla.
Poi la radura si aprì alla sua destra, e Takrin seppe di essere arrivata.
«Mi ha detto che mi disprezza» disse Takrin con distacco, appoggiando il pesante bicchiere di vetro sul piano irregolare del tavolo.
«Siryo?» le chiese Astrea, per nulla spiazzata dal brusco cambio di argomento.
«Già.» Takrin aveva il volto segnato dalla stanchezza; le profonde occhiaie nere e una cera ancora più pallida del solito contribuivano ad amplificare il suo naturale colorito, rendendola quasi cadaverica, malaticcia. «Gli avevo detto che... che sentivo la sua mancanza. Che volevo... volevo... Lui mi ha detto che non riusciva a guardarmi più negli occhi. Ha detto che non credeva che... che sarei arrivata fino in fondo. Credeva che avrei rinunciato. Che non avrei accettato la carica di Maestra. Come poteva pensarlo?» Takrin aveva la voce rotta, quasi rantolante: sembrava sul punto di svenire, tanta era la fatica con cui le parole le uscivano dalla gola.
«Non riesce a capire come possiamo esserci allontanate tanto dalla via druidica. Anche con me ha tenuto il broncio, quando ho deciso che la mia strada era l'esercito» disse Astrea, osservando il volto dell'amica. I suoi occhi guizzavano veloci, squadrando ogni cosa nella stanza con la stessa rapida tenacia di un'animale in gabbia.
«Il broncio?» disse Takrin, abbassando la voce di un'ottava. Sibilava, tagliente come una lama. «Ci senti bene, Astrea? Sei ancora in grado di capire una frase o l’addestramento ti ha già atrofizzato il cervello? Mi. Odia. Non riesce a guardarmi in faccia. Credi che sia tenere il broncio, questo?»
«Non ti ha mai odiata, Takrin. Lui...»
«Mi ama, forse? Andiamo, sappiamo entrambe chi è che desiderava. Alle battute di quale delle due rideva. Chi ha scelto.»
«Non ho mai veramente avuto interesse per Siryo, e lo sai...» cominciò Astrea, sulla difensiva.
«Ah, ma questo non cambia nulla. Nulla! Lui vuole te, ha sempre voluto te! E ora mi punisce perché ho scelto la mia strada senza pensare a lui... a lui! Che non riesce nemmeno a guardarmi in faccia! Cosa ho che non va? Dimmelo!» il tono di Takrin si era abbassato ancora, indurendosi come ghiaccio. Ogni sua parola aveva lo scopo di ferire, e i bersagli erano Takrin stessa e Astrea. «Ho chiesto un bacio e una notte, non di più. Un bacio e una dannatissima notte, per gli Dei! E lui...»
«Se l’amore lo cerchi in un bacio o nel sesso ti sbagli, Takrin. È negli occhi. Perché gli occhi sono la prima cosa con cui l'hai trovato e l’ultima con cui ti vedrà. E i suoi occhi sono pieni d'amore e desiderio, quando si posano su di te.» disse Astrea, incapace di tacere oltre il segreto che conservava da anni.
«Che poeta che sei diventata nell'esercito» sibilò Takrin, beffarda. Batté perfino le mani, un suono vuoto e lugubre. «E comunque, che vorrebbe significare? Vorresti dire che sono cieca?»
«No, che non riesci a capire. Non gli hai dato possibilità, nessuna possibilità. Finché continuerai a credere a questo stupido triangolo, non avrai speranze.»
«Io credo nei fatti, non negli occhi, Astrea. E il fatto è questo.» Takrin scosse il capo e si alzò, rassettandosi la lunga giacca rosso fuoco che indossava sopra gli abiti civili. «È stato... beh, bello, immagino, parlare con te.»
«Vai già?» domandò Astrea, dispiaciuta.
«C'è una guerra che si avvicina, amica mia. Affila bene la tua lama, e comincia a pensare che padrone vuoi servire. Al prossimo anno.»
Il cimitero era come lo ricordava: piccole lapidi mezzo corrose dalla salsedine e affondate nel terreno morbido segnavano la posizione in cui i corpi riposavano, coperti da un soffice strato di terra e fogliame.
Era un luogo antico, quello: molti dei nomi incisi nella pietra in lingue perdute erano spariti da tempo, così come i discendenti di quelle anime dimenticate. Il bosco lo circondava quasi per intero, nascondendolo al mondo, proteggendolo come una cosa preziosa.
Sbucando dagli alberi il sentiero tornava visibile, bianco e pulito come fosse stato appena calpestato – e in qualche modo così era, perché Takrin poteva vedere le anime che lo affollavano, passeggiando, cercandosi, chiacchierando.
Non era un luogo per vivi, quello, ma guardandosi intorno non lo si sarebbe mai potuto dire: il sole, sorgendo dal mare, filtrava attraverso i rami delle piante e illuminava ogni cosa con la sua luce chiara e sicura, mentre il rumore della risacca e il soffio melodico del vento davano un senso di sicurezza che, nel mondo di macchine e suonerie che Takrin si era lasciato alle spalle, difficilmente si poteva trovare. Nemmeno il baratro che separava il promontorio dall'oceano poteva spaventarla.
Takrin ricordava come fosse ieri la prima volta che aveva visto il mare. Era stato lì, in quello stesso cimitero, il giorno in cui avevano sepolto Siryo. Con gli occhi che si ostinavano a restare asciutti, Takrin si era allontanata dalla sacerdotessa e si era affacciata a guardare giù, verso l'acqua. L'aveva trovata bellissima e, nel tumulto ribollente dell'oceano tempestoso, aveva riacquistato un po' di pace e di distacco – quel che le serviva per affrontare lo sguardo carico di rabbia e dolore di Astrea.
Era stata l'ultima volta che si erano viste fuori dal campo di battaglia. L'ultima in cui si erano guardate sapendo esattamente cosa si agitava nell'animo dell'altra e provando pietà per quel dolore.
L'ultima, prima della sua morte.
Takrin non sopportava i luoghi sacri, ma per lui avrebbe sofferto mille volte quella pena.
La cerimonia era stata veloce: dodici anime erano state legate al piccolo terreno, e dodici volte tante attendevano al limite del bosco che i carri venissero a ritirare i loro corpi per portarli all'ultima dimora.
Takrin li aveva visti fermi lungo la strada come sentinelle dolenti, intenti a cantare i loro stessi inni funebri in decine di lingue. Li aveva salutati e loro avevano fatto altrettanto, augurandole buona fortuna. Non c'era nessuna ostilità che sopravvivesse alla morte. Takrin lo trovava meraviglioso e confortane insieme: era la parte più bella dell'aver sviluppato quel dono – la capacità di comunicare con le anime dei caduti.
Siryo non era stato fra loro, né Takrin l'aveva ritrovato al cimitero: sembrava che la evitasse.
Non aveva mai più visto l'elfo da quell'ultima notte. Sospettava che stesse nascondendosi in qualche luogo lontano, o che avesse trovato il modo di raggiungere quel paradiso in cui lo attendevano i suoi dei. La ragazza non poteva biasimarlo: l'aveva vista lottare all'ultimo sangue con la donna che amava e colpirla ripetutamente, senza alcun briciolo di pietà o rimorso, e quell'immagine era stata l'ultima che i suoi occhi avevano registrato prima che un incantesimo lo colpisse in pieno petto, dilaniandolo.
Non gliel'avrebbe mai perdonato, Takrin lo sapeva.
Nemmeno Astrea c’era e questa era stata la sorpresa più grande: Takrin pensava che nulla al mondo l'avrebbe fatta mancare al funerale dell'Elfo che l'aveva amata così tanto. Dunque perché non era lì?
Si era fermata davanti alla lapide di Siryo, a rendere omaggio. Nonostante i dissapori sapeva che lui l'avrebbe apprezzato, dovunque fosse.
La lapide dell'Elfo era scheggiata alla base, dove qualcosa di pesante l'aveva colpita. C'era scritto il suo nome completo e l'elenco dei titoli di cui, in vita, si era fatto vanto. Takrin non degnò loro nemmeno di un'occhiata: si avvicinò alla pietra con uno svolazzo della lunga giacca rossa e si accucciò, spostando qualche foglia mezza marcia e un piccolo fungo bianco dalla base, indirizzando un pensiero antico a colui che aveva sempre amato.
«Avevi deciso tu per la guerra, vero?» domandò Astrea con voce bassa. Le era arrivata alle spalle senza che Takrin se ne rendesse conto, ma questo non la colpì poi molto: non era difficile farsi sorprendere da qualcuno che ormai viveva su un piano diverso dal proprio.
«Si.»
«L'hai fatto per Siryo.» Non era una domanda e Takrin non si sforzò di negare – non ne sarebbe valsa più la pena.
«L'ho fatto per te. O meglio, a causa tua. Non avresti dovuto sfidarmi» disse Takrin con distacco, osservando il mare come ipnotizzata – il suo odore la catturava, trasportandola lontano da quel dolore... da ogni dolore.
«Volevo solo la pace!» protestò Astrea a voce troppo alta. Qualcuno, fra gli uomini che assistevano al rito funebre, si voltò a guardarle.
«E io volevo il mio potere... e Siryo» disse con rammarico Takrin, avvolgendosi nella giacca vermiglia. Faceva freddo, lì... un freddo mortale – e lei sapeva il perché di quel gelo e del loro incontro.
Era Samhain e Astrea doveva sapere che in quella notte, secondo le antiche credenze druidiche, gli spiriti dei defunti erano slegati dalle costrizioni delle ossa nella bara e potevano vagare liberamente per la terra. Per questo era lì.
«Lui ti ha sempre amata» disse Astrea, stancamente, avvolgendola con le braccia gelide.
«Tornerai qui l'anno prossimo?» le domandò Takrin dopo un po', slegandosi dall'abbraccio.
«Se ci sarai» le disse Astrea, sorridendo tristemente.
«Ancora qui?» disse una voce divertita alla sua destra. Takrin non si voltò immediatamente: finì di mormorare una preghiera troppo simile a delle scuse e poi si spostò, lasciando tacitamente il posto all'amica. Non parlarono mentre Astrea rendeva omaggio: quello era uno di quei momenti in cui anche un sussurro avrebbe potuto dividerle per sempre.
Si alzarono quasi all'unisono e passeggiarono.
«Come hai passato questo anno?» chiese Astrea e Takrin alzò le spalle, attaccando a raccontare di quanto odiasse il mondo che c'era là fuori e invidiasse gli spettri del cimitero. Una tiritera vecchia, l'antico adagio che ogni anno si ripeteva, immutato. Astrea sorrise tristemente e scosse il capo, ma non replicò. Non lo faceva mai.
«E tu?» domandò Takrin, rallentando il passo. L'amica si adeguò alla sua andatura e, con la naturalezza di un copione già recitato, le disse che la sua vita non era poi granché. Che si sentiva bloccata, sola e dispersa, incapace di andare avanti. Non aggiunse altro, perché erano arrivate alla piccola lapide che era la loro destinazione.
Fu a quel punto che entrambe cominciarono a rilassarsi, quasi si fossero tolte un gran peso dalle spalle.
Senza che nulla potesse impedirglielo, entrambe iniziarono a ricordare.
Takrin aveva lo sguardo lontano, perso fra le foglie e i pensieri. Astrea sapeva che, nonostante la calma e la forza che amava ostentare, dentro di lei si agitava lo stesso tumulto che gravava sulla sua anima – un misto di vuoto e rassegnazione, e la malinconia che solo in un cimitero si può davvero provare. Eppure lì erano libere, due anime nude e fiere che non avevano timore di parlare di tutto e di nulla. E così fecero mentre, intorno a loro, sulla terra calava una lenta oscurità.
Takrin non avrebbe saputo dire quante ferite fossero state aperte nella sua carne, tanta era l'adrenalina, l'odio e la pena che le scorrevano nelle vene. Poteva valutare l'entità dei danni riportati solo attraverso il sangue che vedeva scorrere dai tagli sul corpo di Astrea.
Era stato un combattimento alla pari, nel corso del quale entrambe avevano lottato come se dall'esito dello scontro dipendesse l'esistenza stessa del loro credo. La loro morale.
Ora erano allo stremo, le membra schiacciate dallo stesso sfinimento. Come due riflessi gemelli allo specchio colpivano e paravano, cadevano e si rialzavano, stringendo i denti.
Una sola di loro era però vicina alla resa ed entrambe ne erano consce. L'esito dello scontro, della battaglia, dell'intero mondo era già stato deciso, e ben presto colei che apparteneva al passato sarebbe caduta.
Astrea scivolò al suolo, incapace di reagire. Le membra, ancora scosse dalla vibrazione dell'ultimo colpo, tremavano violentemente, annaspando lungo la pelle esangue di Takrin – che la sovrastava, stringendo fra le mani coperte di sangue i suoi vestiti, aggrappandovisi come fossero l'unica ancora di salvezza in mezzo al caos della battaglia.
«Abbiamo perso» disse Astrea in un rantolo fievole.
«I tuoi amici hanno ucciso i mei» ribatté Takrin, scivolando in avanti.
«No... noi. Noi non umani. Noi tutti abbiamo perso.» Ora Astrea e l'amica avevano il volto a meno di dieci centimetri l'una dall'altra.
«Già» disse Takrin, annuendo. In mezzo a tutta quella morte, a un passo dalla più grande perdita che avesse mai subito, tutto le sembrava più chiaro, più vero.
Più inutile.
«Takrin io... non voglio lasciarti.» disse Astrea, tossendo. Gocce di sangue le imperlavano la fronte, così simili a gioielli alla luce del tramonto.
«Va tutto bene» le disse Takrin, sforzandosi di sorridere. Nulla andava bene, ma alcune bugie andavano dette. Sopratutto alla fine. «Non ti lascerò sola» disse, senza riflettere.
«Non fare promesse che non... che non puoi mantenere» l'ammonì Astrea con un sorriso furbo. Sangue fresco le colava fra le mani, scivolando lungo il metallo della spada per metà infilata in quel corpo ancora acerbo. Astrea avrebbe voluto trattenerlo, arrestare quella morte che le avrebbe divise per sempre, ma non poteva. Era stanca, troppo stanca.
«Guardami, hey, guardami! Noi ci vedremo, mi hai capito? Samhain, ricordati Samhain! Ci vedremo dove... dove poggeranno il corpo» la voce di Takrin era rotta, adesso. Mille schegge di vetro, cariche di un dolore che era tutt'uno con la morte, la ferivano. Intimò «Resisti, per gli dei!» e poi crollò a terra, piangendo come mai aveva fatto in vita sua. «Fra un anno ancora, amica mia. Fra un anno...»
Ma nessuno più poteva sentirla, ora.
«Ci vediamo l'anno prossimo, amica mia» disse Astrea con un mezzo sorriso, carico in egual misura di tristezza e speranza.
«Già. Il prossimo anno...» disse Takrin, senza muoversi. Pareva riluttante ad abbandonare quel luogo – ma la notte stava per calare e il loro tempo era finito. Non era giunto il suo momento di riposare lì. Non ancora.
«Non puoi restare, Takrin» disse Astrea con quella dolcezza che l'aveva sempre contraddistinta, allungando la mano per afferrare la giacca rossa dell'altra.
Non poté farlo: il loro attimo era agli sgoccioli e già la sua figura cominciava a svanire.
«Mi cercherai?»
«Finché sarò...» disse Astrea, ma non riuscì a finire la frase: il velo sottile del tempo, che per quell'intera giornata le aveva unite, cominciava a ispessirsi.
Il bosco era silenzioso ora. Nessuna anima sussurrava più: tutti erano tornati alle loro dimore, a piangere la vita perduta. Persino il vento era calato.
Sorse la luna e Takrin si alzò. «Non è ancora il mio tempo» disse, con un sospiro rassegnato e si voltò a osservare la tomba.
C'era un ultimo omaggio che avrebbe dovuto rendere. Col cuore gonfio di angoscia, portò la mano al volto e poi al petto, allungandola infine verso la pietra tombale. Così protesa, assurdamente simile a un innamorato che tenda un fiore verso la sua amata, si chinò in ginocchio e toccò le parole incise nella pietra, vecchie e sbiadite dai secoli.
«Al prossimo anno» disse, poi si alzò e se ne andò, svanendo ben presto nella tetra oscurità della notte, lasciando dietro di sé una pietra tombale fredda che segnava il luogo in cui le ossa non avevano mai riposato.
Le foglie rosse si mossero al vento, ricoprendo le impronte lasciate sul suolo morbido. La coltre dell'autunno si stese sulla terra senza corpo e, per un attimo, ricoprì l'incisione scavata dal tempo, scivolandovi sopra come una carezza di fuoco e morte, come una promessa.
Quando infine i raggi della luna bagnarono il cimitero, c'era un velo di condensa a illuminare le due sole parole:
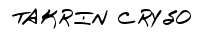
|
 Piccolo spazio-me: bene, eccoci alla fine. Spero che questa nuova versione sia migliore della precedente, priva di tutte quelle incongruenze e più fluida :)
Fatemi sapere cosa ne pensate e se vi piacerebbe vederla diventare una long (incentrata sul periodo precedente alla morte di Takrin, ovviamente).
Alla prossima!
|
Ritorna all'indice
Questa storia è archiviata su: EFP
/viewstory.php?sid=2893368
|