Kaleidoscope
(/viewuser.php?uid=181331)
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** Sirens ***
Capitolo 2: *** What the Hell? ***
Capitolo 3: *** Hero ***
Capitolo 4: *** You and I ***
Capitolo 5: *** May ***
Capitolo 6: *** Confessions ***
Capitolo 7: *** Infinite dreams ***
Capitolo 8: *** Stay ***
Capitolo 9: *** Save me ***
Capitolo 10: *** Pain ***
Capitolo 11: *** Stronger ***
Capitolo 12: *** Ever after ***
Capitolo 1
*** Sirens ***
NB. Da come avrete potuto leggere già nell'introduzione, questa storia è un sequel; per essere più precisi, fa da seguito a parachute: prima long che ho pubblicato e completato in questo fandom. Leggerla prima di kaleidoscope non è di certo obbligatoriamente necessario, ma vi consiglio comunque di farlo per poter avere poi le idee più chiare su cos’è successo prima che si arrivasse a “questo”. La protagonista, Harriet Carter, è un personaggio di mia invenzione, così come tutti i suoi familiari e alcuni dei suoi amici. Gli altri personaggi, ahimè, non mi appartengono. Il timeline, questa volta, è quello della 2S di Teen Wolf.
Buona lettura! kaleidoscope
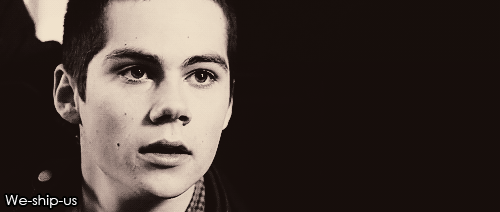 1. Sirens
È pazzesco come una semplice canzone riesca ad influenzare e modificare – anche radicalmente – il tuo umore. Voglio dire: succede sempre, no? Credi che sia una giornata come tante altre e senti che tutto va bene – sei anche vagamente felice – poi magicamente ti capita di infilare un paio di cuffie nelle orecchie, lo shuffle seleziona – bastardo – la canzone più triste dell’intera raccolta e puff: non sei più così felice. Te ne stai imbambolata ad ascoltare quelle note col cuore che rischia di cedere sotto il peso di tutte le sensazioni che proprio non riesci a gestire né a comprendere ed è allora che realizzi, che non importa quanto sorridi ed eviti di pensarci: hai problemi. Ora, non che avessi bisogno di The way – quella di Zack Hemsey, una delle canzoni più spacca-cuore che avessi sul mio cellulare – per rendermi conto di quanto fosse sul serio incasinata la mia vita: la situazione era già piuttosto chiara di per sé e quella stronzissima canzone servì come nient’altro che l’ennesima conferma della cosa, tanto che – irritata – premetti il tasto pausa dopo due minuti e mi sfilai le cuffie con stizza, riponendo tutto disordinatamente nella borsa, pur sapendo che di lì a poco mi sarei auto-insultata per quel gesto che mi avrebbe reso impossibile trovare il cellulare e slegare i nodi che si sarebbero stretti magicamente attorno alle mie cuffie. Ma non mi curai della cosa, ben decisa a distrarmi. Feci vagare lo sguardo tutt’intorno a me nella sala d’attesa del Beacon Hills Memorial Hospital, capace di diventare – in quegli ultimi due giorni – una specie di seconda casa per Stiles, che osservai addormentato come se nulla fosse su tre sedie accanto alla mia. A causa dei braccioli di queste ultime era obbligato a stare in una posizione scomodissima e per un attimo mi chiesi come facesse a dormire, ma non trovando risposta mi limitai ad allungare una mano verso i suoi capelli per accarezzarli – sempre nella speranza di potermi distrarre. Quando sentii Stiles mugugnare e muoversi appena appena nella mia direzione temetti di averlo svegliato, ma mi accorsi poi del fatto che ancora dormisse profondamente e indisturbata continuai con le mie carezze. Ma l’improvviso rumore di una porta che si apriva e chiudeva velocemente mi colse di sorpresa, portandomi a sobbalzare e interrompere i miei movimenti. Sollevando lo sguardo, scoprii fosse proprio la porta della stanza di Lydia e trovai sulla soglia niente di meno che il signor Martin. Nell’indecisione di riservargli un saluto o meno, mi limitai a ricambiare la sua occhiata curiosa, abbozzando un sorriso nella direzione di Melissa. «Da quanto tempo sono lì?», percepii che il padre di Lydia le chiedeva, facendosile vicino. «Stiles da quasi due giorni», mormorò la signora McCall, osservando brevemente Stiles sdraiato di fianco a me. Sentirle dire una cosa del genere riportò immediatamente alla mia mente l’immagine delle precedenti quarantotto ore che Stiles aveva trascorso al Beacon Hills Memorial Hospital, nell’attesa che Lydia si svegliasse. Cosa che, per fortuna, aveva fatto. «Harriet è arrivata poche ore fa», continuò Melissa, puntandomi con un dito mentre io fingevo – forse stupidamente – di non notarla. Sì, l’idea di raggiungere Stiles all’ospedale mi era venuta solo quel pomeriggio, quando finalmente libera dalla febbre – anche se ancora un po’ tramortita – avevo deciso di mettere fine ad inutili giornate trascorse da sola a letto, tra una lettura dei diari di Charles e una telefonata a mia madre Jenette. Oh sì, perché finalmente avevo potuto parlarle e soprattutto il coraggio per farlo non m’era venuto a mancare. Tuttavia, dalle mie labbra non era uscita mezza parola su mio padre, Philip. Osservai di sottecchi il signor Martin mentre annuiva per far comprendere che avesse capito, poi sentii Stiles muoversi ancora e capii quando si sollevò lentamente a sedere che quella volta si fosse svegliato sul serio. Improvvisamente divertita dallo spettacolo che era capace di diventare da appena sveglio, me ne rimasi in assoluto silenzio ad osservarlo mentre si stiracchiava allungando entrambe le braccia sopra la testa e poi si guardava intorno, sbadigliando sonoramente. Quando i suoi occhi finalmente giunsero sulla mia figura, ridacchiai divertita e feci ondeggiare le dita nella sua direzione in segno di saluto. Quando sgranò gli occhi rendendosi conto del fatto che fossi sul serio lì, scoppiai direttamente a ridere. «Buongiorno, straniero», lo apostrofai, facendogli pesare ancora una volta il fatto che per ben due giorni si fosse fatto vedere a malapena. Comportamento infantile da parte mia, lo ammetto. Ma piuttosto giustificato. «Che ci fai qui?», fu la sua unica domanda, alla quale risposi ironicamente com’era giusto. «Anch’io sono felice di vederti». Stiles s’imbronciò come un bimbo al quale veniva negato un giocattolo nuovo e d’istinto m’intenerii. Non ci andare giù pesante, Harry, mi ammonii, distendendo il viso. Era preoccupato per Lydia: la conosce da anni. Voleva esserle vicino. Non poteva passare tutto il suo tempo a pomiciare con te. Be’, non tutto il suo tempo, magari, mi risposi, rendendomi conto solo troppo tardi di quanto fossi stupida a conversare con me stessa. Ma tre quarti di questo? Due? Sono stata male anch’io! Stupida. Stupida, stupida, stupida. Alla mia espressione persa e distratta, Stiles rispose con le sopracciglia aggrottate. Ma quando si fu accertato di avere di nuovo tutta la mia attenzione, ripartì alla carica con l’irresistibile faccetta da cucciolo. «Sono felice di vederti», mormorò, e lessi sul suo viso l’indecisione: sorridere o restare imbronciato? Voleva sfoggiare l’espressione che mi avrebbe fatta sciogliere di più. Sei troppo intelligente, Stiles Stilinski. Ma alla fine non riuscì a decidere e lasciò perdere, cambiando argomento. «Ti senti bene? Fino a ieri avevi la febbre altissima», domandò, quella volta tradendo preoccupazione. Sorrisi. Sempre il solito. «Sto bene, tranquillo. E anche Lydia». L’ombra di un sorriso simile al mio attraversò il viso di Stiles, poco prima che distogliesse lo sguardo dal mio per sbadigliare nuovamente. «D’accordo», disse, strofinandosi gli occhi stanchi. «Hai fame?». Scossi la testa. «No, ho mangiato prima di venire qui». «Va bene. Io ho bisogno di mettere qualcosa tra i denti, però». Recepii le sue parole subito e le assimilai completamente nel momento in cui si alzò, sicuramente diretto alla ricerca di cibo. Mi limitai ad annuire silenziosa, credendo che sarebbe sparito subito chissà dove. Ma quando Stiles mi si posizionò di fronte, la sorpresa prese possesso del mio corpo e m’immobilizzò così tanto che presi coscienza di quanto fosse successo con molto ritardo. «Torno subito», sussurrò piegandosi su di me, le mani strette attorno ai braccioli della mia sedia e le labbra a pochi centimetri dalle mie. E poi lo fece: mi baciò. Fu nient’altro che uno sfioramento di labbra, così veloce che addirittura mi chiesi se non l’avessi solo sognato. Ma non ero ancora impazzita e sì, Stiles mi aveva baciata a fior di labbra in un luogo pubblico, sotto gli occhi di Melissa McCall. Sembrava l’avesse fatto senza nemmeno pensarci su, proprio come se fosse la cosa più naturale del mondo, e fu quello a destabilizzarmi così tanto. Non il bacio, perché di certo non era stato il primo – e speravo nemmeno l’ultimo – ma com’era successo. «Potrei svenire», fu l’unica cosa che riuscii a dire quando se ne fu andato, a voce speravo abbastanza flebile da non essere sentita da nessuno e con gli occhi bassi sulla mia maglia blu notte. Ma sfortunatamente sia Melissa che il signor Martin parvero cogliere quel mio commento, e se la mamma di Scott si limitò a sorridere intenerita, il padre di Lydia al contrario mise su un’espressione vagamente preoccupata. Forse fu proprio per quello che immediatamente mi misi in piedi e lo raggiunsi sulla soglia della stanza di Lydia. Ancora non lo so esattamente. «Buonasera, signore», salutai, mettendo su un sorriso che lui ricambiò presto. «Come sta Lydia?». «Bene. Ha ritrovato anche la forza di fare del sarcasmo», esalò, fingendo di essere scocciato. In realtà era felice. «Frequentate scuola insieme, vero?». Annuii, stringendomi le braccia al petto. Poi sorrisi ancora. Sorrisi di circostanza ma pur sempre sorrisi. Brava, Harry. «Abbiamo alcuni corsi in comune». E qualche esperienza soprannaturale, pensai, ma ovviamente evitai di dirlo, riducendomi a mettere su una smorfia contrariata. Passò qualche minuto di silenzio, poi il signor Martin prese fiato e parlò di nuovo. «È molto gentile da parte vostra». Si riferiva a me e Stiles. «Essere…». Immagino volesse dire “essere qui”. Magari pure “per Lydia”. Ma immagino anche che non lo saprò mai. Prima che il signor Martin potesse completare la sua frase, infatti, un urlo quasi disumano spezzò ogni cosa intorno a noi. Interruppe il suo discorso, il mio respiro e i movimenti di chiunque si trovasse nei paraggi. E tutto sembrò fermarsi magicamente, almeno finché il silenzio non tornò e tutti – seppur tramortiti – prendemmo la rincorsa verso la stanza di Lydia. Era chiaro fosse stata lei ad urlare e mentre irrompevo insieme al signor Martin, Melissa e Stiles nella sua stanza d’ospedale, pregai – forse inutilmente, forse no – che non le fosse successo nulla di male. Non ancora, per favore. Non potei dirlo con certezza. Non in quel momento. La stanza infatti era vuota, sembrava addirittura che nessuno ci mettesse piede da tempo. Le coperte sul letto erano disfatte, segno del fatto che Lydia si fosse alzata. Per andare dove? Mi chiesi subito. E fu allora che vidi la porta chiusa del bagno. Quando il signor Martin ci si diresse a passo spedito, capii subito che sapesse delle azioni di Lydia. Magari gli aveva detto di aver bisogno di una doccia. Ma lei non era nemmeno lì. L’acqua scorreva nella vasca da bagno: Melissa McCall si premurò di chiudere il rubinetto e poi riprese a guardarsi intorno. Riuscivo ad avvertire senza problemi il nervosismo di Stiles e avrei potuto giurare che gli stessi pensieri ci stessero attraversando la mente in quel momento. Non ancora, mi ripetei. Non ancora. Allora mi voltai verso destra e Stiles m’imitò. I miei occhi scuri e liquidi per le poche lacrime che già li riempivano si fusero col nero della notte, ben visibile attraverso la finestra spalancata. Lydia Martin era scappata. Precedevo Stiles di alcuni passi nella nostra corsa verso il parcheggio e la Jeep contro la quale se ne stava poggiato Scott ad aspettarci. Non c’era stato nemmeno bisogno che lo chiamassimo: l’urlo di Lydia non era certo passato inosservato ai suoi sensi iper-sviluppati e gli erano bastati pochissimi minuti per raggiungerci al Beacon Hills Memorial Hospital, esattamente il tempo che avevamo impiegato io e Stiles per procurarci la camicia da notte di Lydia ed evitare che Stephen Stilinski s’insospettisse nel vederci lasciare l’ospedale di tutta corsa. Proprio lui ci aveva infatti ordinato di andare a casa e noi avevamo finto di ubbidire subito. Poco importava poi che in realtà fossimo diretti da tutt’altra parte. Quando fu vicino a Scott abbastanza da poterlo fare, Stiles gli consegnò la camicia insanguinata con stizza e poi mi raggiunse dal lato del guidatore. Aprì lo sportello per farmi entrare e s’infilò in macchina a sua volta, seguito da Scott che gli si sedette al fianco. «Era questa che indossava?», domandò subito McCall, interrompendo il silenzio teso nel quale ci trovavamo bloccati. Stiles si limitò ad annuire, facendo aderire la schiena contro il sedile mentre sbuffava. Improvvisamente mi sembrava esausto, tanto che qualcosa m’intimò di provare a rassicurarlo in qualche modo. Ma non c’era nulla che potessi dire o fare per rimediare a quell’assurda situazione. Non quando io mi trovavo ad affrontarne una identica. «Nessuno le farà del male. Non di nuovo», mormorò Scott, che capii avesse intuito cosa ronzasse in testa a Stiles almeno tanto quanto me. In risposta alle sue parole annuii, sporgendomi tra i due sedili anteriori quel tanto che bastava ad essere più vicina ad entrambi. Mossi una mano verso il braccio di Stiles, sfregandola contro la stoffa della sua felpa nella speranza che capisse che – nonostante tutto – aveva anche me su cui contare. «Troviamola», ordinò, riservandomi uno sguardo veloce prima di ritornare seduto composto e mettere in azione il motore della Jeep. Quella volta fu Scott ad annuire semplicemente, poi provò a mettersi a lavoro affinché l’odore che Lydia aveva impresso sulla sua camicia da notte potesse condurci di nuovo da lei, ma in realtà non poté fare a meno di bloccarsi col naso a pochi centimetri dalla stoffa quando Stiles sobbalzò vistosamente e sollevando lo sguardo, tutti e tre individuammo la figura di Allison Argent illuminata dai fanali della Jeep. «Come l’ha saputo?», chiesi a nessuno in particolare, aggrottando le sopracciglia mentre la osservavo avvicinarsi a Scott. «Non l’hai chiamata tu?», domandò Stiles, voltandosi a guardarmi, improvvisamente sorpreso. Scossi la testa e, sotto lo sguardo incredulo di Scott, feci per provare a spiegarmi. Ma Allison me lo impedì. «Ho sentito che mio padre ne parlava con tre dei suoi uomini. Sono usciti con due SUV», esalò, e non appena ebbe finito di parlare, i visi di tutti si riempirono di terrore. «Stanno cercando Lydia?», provò a chiedere Scott, stupidamente speranzoso di star sbagliando. «No, sono andati a caccia». Non ci fu bisogno di aggiungere altro: velocemente Scott permise ad Allison di salire in macchina e con altrettanta fretta Stiles mise in moto, avviandosi verso nemmeno lui sapeva dove. Una domanda cominciò insistentemente a rimbombarmi in testa finché non la posi ad Allison. «Credono che si sia trasformata?», chiesi, e lei mi rispose con una scrollata di spalle. «Dopo così tanto tempo dal morso? È possibile, almeno?». Ma nemmeno per quella domanda la Argent aveva una risposta. E nemmeno Scott. «Io… io non lo so», balbettò, la voce rotta e il corpo che tremava accostato al mio. «Dovremmo parlarne con qualcuno che se ne intende». Stiles sbuffò. La cosa non era fattibile. E seppur in silenzio, acconsentii anch’io. Ma non per questo si perse d’animo, continuando a guidare nella direzione che Scott man mano gli indicava. Lo osservai brevemente riempirsi le narici dell’odore di Lydia, ma quando Stiles parlò, riportai tutta la mia attenzione su di lui. «D’accordo, lasciamo perdere», esordì, poco prima di porre la domanda che gli premeva di più. «Se Lydia si fosse trasformata, i tuoi la uccideranno?». «Può darsi». Quelle due parole suonarono alle mie orecchie come nient’altro che una condanna a morte e il tono improvvisamente incolore di Allison non aiutò. Pareva che la morte di Lydia fosse in quel momento molto più che probabile. Non mi rassicurò per nulla. «Ma non ne sono sicura. I miei non mi dicono niente», continuò Allison dopo qualche attimo, esprimendo alla perfezione tutta la sua frustrazione. «So solo che ne parleremo quando arriveranno gli altri». «Gli altri chi?», domandai allora, credendo che fossimo finalmente giunti a una svolta. Ma mi sbagliavo, e l’unica risposta che ricevetti fu l’ennesima scrollata di spalle. Allison non avrebbe potuto aiutarci più di così. Quando anche Stiles lo capì, si aprì in un: «Fantastico…» seguito da uno sbuffo scocciato e poi l’auto si riempì di silenzio ancora una volta. Per tutto il viaggio l’unica cosa che fummo in grado di fare fu pregare affinché almeno Scott riuscisse ad aiutare in qualche modo. Perché noi tre, lì, non potevamo proprio nulla. «Non è possibile». Queste le uniche parole che continuavo a ripetermi da quando Scott aveva ordinato a Stiles di parcheggiare la Jeep all’entrata della Riserva di Beacon Hills. Il posto dove mesi prima tutto era cominciato e dove quella sera l’olfatto di Scott ci aveva condotti, come per un tragico scherzo del destino. «Perché mai Lydia dovrebbe essere venuta qui?», pigolò Allison, la voce spezzata dai brividi di freddo mentre si stringeva le braccia al petto nella speranza di riscaldarsi un po’ di più. Mi ponevo la stessa domanda da ormai qualche minuto, ma pareva che nessuno dei quattro avesse una risposta valida da dare e perciò ci limitavamo a starcene tutti in silenzio mentre avanzavamo in direzione della vecchia casa Hale. Le foglie scricchiolavano sotto i miei piedi ad ogni passo ed una sensazione di pericolo non accennava a volermi abbandonare, ma non capendo cosa il mio istinto volesse comunicarmi, mi limitavo a starmene vicina a Stiles mentre avanzavamo nel bosco vuoto. Di Lydia non pareva esserci traccia, ma Scott giurava che il suo odore si fermasse lì. «Sei sicuro che è venuta qui?», domandò Stiles ancora una volta, voltandosi a fissare il viso del migliore amico. Voleva essere certo di non essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, mentre Lydia era chissà dove, magari in pericolo. Scoprii che i nostri desideri coincidessero ancora una volta. Scott rispose annuendo. «Deve essere così», mormorò, deciso. Ma non convinse Stiles, che: «Come faceva a sapere di questo posto?», chiese, scettico. «Con me non ci è mai venuta», aggiunse Allison, avvalorando la “tesi” di Stiles mentre mi rendevo effettivamente conto di come Lydia fosse quella che – per fortuna o meno – era riuscita a stare più lontana di tutti da quel mondo. «Forse…», ricominciò la Argent, deglutendo rumorosamente e guardandosi intorno. Tremava. Per il freddo o anche per la paura non riuscii a capirlo. Poi continuò a parlare, prendendo coraggio e con l’aria di qualcuno che cercava in tutti i modi di misurare le proprie parole. «forse sta cercando Derek». «Un alpha», realizzò Scott immediatamente, e ad Allison non restò altro da fare che annuire. Lo stomaco mi si strinse all’idea. Non riuscivo ad accettare il pensiero di una Lydia licantropo. «È istintivo cercarne uno, no?», sentii dire ancora, ma già la voce di Allison cominciava ad arrivarmi ovattata, come se fosse lontana miglia e miglia da me. E in effetti era così. Perché se fisicamente le ero solo pochi passi più avanti, la mia mente invece vagava di già in lidi sconosciuti, evitando di proposito quella conversazione affinché potesse proteggermi dai risvolti ai quali avrebbe portato. Con lo sguardo perso e distratto, osservai Stiles guardarsi intorno. Poi chinarsi sul terreno di foglie, scostarne un po’ con la punta delle dita lunghe ed infine trattenere un sospiro sorpreso. «Wow», mormorò, mentre poco a poco ritornavo vigile. Il chiacchiericcio di Allison e Scott s’era bloccato, dunque non avevo più bisogno di protezione. «Guardate cos’ho trovato». Non mi avvicinai, e Scott mi imitò. «È… un filo», spiegò Stiles ad Allison, inginocchiata di fianco a lui. Anche se mi dava le spalle, riuscii comunque ad immaginarlo mentre sfiorava in punta di dita il filo da lui trovato. «Sembra una trappola». Allora un improvviso spostamento d’aria mi distrasse così tanto che distolsi subito l’attenzione da Stiles ed Allison, intenti a confabulare teorie sulla vera identità di quel filo misterioso. Non li ascoltavo più, in effetti, né ci sarei riuscita a breve. Al contrario mi limitai ad urlare con tutto il fiato che avevo in gola, facendomi lontana da Scott con la paura che mi stringeva fin nelle viscere. Io, Allison e Stiles ci voltammo a guardarlo in contemporanea, ritrovandolo appeso a testa in giù. «Era proprio una trappola», fu l’unica cosa che riuscì a dire Allison, ancora col respiro accelerato almeno tanto quanto il mio. Avevo fatto spaventare troppo sia lei che Stiles. «Dio, amico, non l’ho fatto di proposito!», esclamò proprio lui, raggiungendomi vicino a Scott. Prese a guardarsi intorno per capire come aiutare McCall a scendere, ma prima che potesse riuscire a chiedere ulteriore aiuto a me ed Allison, l’espressione di Scott si freddò improvvisamente e capii che qualcosa di brutto stesse per succedere. «Sta arrivando qualcuno», mormorò Scott infatti, immobilizzandoci tutti. «Nascondetevi!». Per qualche attimo ci limitammo a guardarci intorno, sorpresi. Poi Scott ripeté il suo ordine alzando la voce un po’ di più e sia io che Allison e Stiles ci dirigemmo a grande velocità contro il tronco di un albero che reputammo grande abbastanza da coprirci tutti e tre alla bell’e meglio. Mi ritrovai schiacciata tra i corpi di Stiles ed Allison e solo in quel momento mi scoprii tremante: freddo e paura erano sul serio una coppia micidiale, oramai lo sapevo fin troppo bene. Stiles era l’unico a cui era permesso di sporgersi per osservare cosa stesse succedendo a Scott senza farsi vedere: io non provai nemmeno a muovermi, ma comunque me ne stetti in religioso silenzio, sperando di riuscire a carpire qualche parola. L’unica conclusione alla quale arrivai fu che quella che sentivo in lontananza era la voce di Chris Argent. E quando Allison lo sentì parlare trattenne il respiro. Passarono minuti che mi parvero interminabili, poi all’improvviso Stiles abbandonò il suo rifugio ed io strizzai gli occhi confusa. Ancora una volta ero riuscita a distrarmi, ma ciò non m’impediva di riprendere coscienza subito, tanto che mi decisi a seguire Stiles subito dopo Allison. Di Chris non c’era più traccia, ma comunque mi guardai attorno, ansiosa, mentre Stiles ed Allison provavano a liberare Scott e lui decideva invece di fare da solo. Con un solo colpo d’artigli recise infatti la corda che lo teneva legato a testa in giù ed il suo infallibile equilibro da lupo lo aiutò ad atterrare perfettamente sui piedi. Sotto le espressioni sbalordite di Stiles ed Allison, Scott mise su un sorrisino soddisfatto ed io ridacchiai mentre lo osservavo fare spallucce come se niente fosse e lo sentivo mormorare: «Grazie comunque». Poi ci diede le spalle e si avviò verso la vecchia casa Hale, salvo arrestare improvvisamente la sua camminata quando si rese conto che non lo stessimo seguendo. Si voltò di nuovo a guardarci, infossando le mani nelle tasche dei pantaloni e sollevando le sopracciglia, scettico. «Venite o no?». Affermativo, capo. Non avrei dovuto trovarmi lì, lo sapevo benissimo. Eppure eccomi: mercoledì mattina, otto meno venti, cimitero di Beacon Hills. Braccia incrociate al petto, capelli scompigliati dal vento e Stephen Stilinski al mio fianco. Agli Sceriffi non era concessa mai una pausa. Dovunque andassero e qualunque cosa facessero, morte e violenza li seguivano. Difatti, quella mattina Stephen non avrebbe dovuto lavorare, ma semplicemente portarmi a fare colazione fuori prima di scuola. Questo prima che ricevesse una chiamata capace di cambiargli totalmente la giornata. Dondolando annoiata sul posto, feci ruotare lo sguardo, ascoltando distratta i convenevoli che educatamente Stephen stava scambiando con un signore di mezza età e un ragazzo che aveva tutta l’aria di essere un mio coetaneo. Prima di quel giorno non ero mai stata al cimitero di Beacon Hills e capii quella mattina del sei novembre che avrei preferito mantenere le cose tali. Almeno per un altro po’. «Sono Lahey. Isaac Lahey». Quello era il nome del mio coetaneo: quello che aveva denunciato alla centrale di polizia un’intrusione notturna al cimitero colpevole di aver annullato il giorno libero dello sceriffo. Mentre ancora parlava, col capo chino e le spalle rigide – come se fosse teso e vagamente spaventato – strizzai gli occhi quanto bastava ad osservarlo meglio. Non l’avevo mai visto. Ma c’era anche da dire che ero a Beacon Hills da soli due mesi e non avevo chissà quale vita sociale. Mentre Stephen prendeva appunti sul suo block notes nero, me ne rimasi in silenzio ad ascoltare. «Isaac lavora per lei?», fu la prima domanda che lo sceriffo pose all’uomo anziano che affiancava Isaac, e solo allora posai il mio sguardo su di lui. Con la coda dell’occhio osservai che Isaac infossava il capo tra le spalle. Mai una volta i suoi occhi s’erano posati sull’uomo che doveva di certo essere suo padre. Ne sembrava terrorizzato, quasi. L’uomo annuì ed io riportai i miei occhi scuri sulla sua figura. «Quando non è a scuola. Dove dovrebbe essere tra venti minuti», berciò. Poi all’improvviso sembrò accorgersi delle occhiate curiose che gli stavo lanciando, perché i suoi occhi porcini si posarono su di me. «Proprio come questa ragazzina, suppongo». Non mi piaceva il suo tono di voce: era, senza alcun motivo apparente, sprezzante e pieno d’odio. Ma non mi feci intimidire, nemmeno dallo sguardo di Isaac aggiuntosi a quello di suo padre. Al contrario sollevai il mento e me ne rimasi in assoluto silenzio: non volevo dare a quell’uomo soddisfazione alcuna. Stephen mi rivolse una breve occhiata e poi si voltò nuovamente a guardare il signor Lahey. Fece per parlare, ma lui glielo impedì. «Chi diavolo è? Non voglio che assista all’interrogatorio», sputò, continuando – nonostante fosse rivolto allo sceriffo – a tenere gli occhi fissi su di me. Sentii una non indifferente ondata di rabbia riempirmi tutta e fu allora, poco prima di scattare, che capii fosse proprio quello l’obbiettivo di quell’uomo. Voleva che reagissi e gli procurassi un vero motivo per cui lamentarsi della mia presenza. Allora cercai di calmarmi. «Chissà cosa potrebbe raccontare…». Ma prima ancora che potesse finire, Stephen lo interruppe. «È la mia assistente», spiegò, e quelle quattro parole in croce mi sorpresero così tanto che per poco non urlai, sgranando gli occhi. Ma immaginavo di dover portare avanti la farsa, perciò mi sforzai di rimanere impassibile mentre deglutivo impercettibilmente. Gli occhi del signor Lahey non si erano mossi dalla mia figura nemmeno per un attimo e fu solo allora che mi chiesi come stessi andando. Potevo davvero sembrare l’assistente dello sceriffo? Che poi, a parte preparare caffè e rispondere alle telefonate, un’assistente cos’avrebbe dovuto fare? Di certo non assistere agli interrogatori. Cosa che parve capire anche il signor Lahey. Ma prima ancora che potesse provare a ribattere, Stephen lo interruppe. «È maggiorenne», mentì, regalando al padre di Isaac uno sguardo che fosse altrettanto duro e astioso. «E lavora per me. Fine della questione». Accantonato il momentaneo pericolo e messo a tacere quell’uomo insopportabilmente spocchioso, l’interrogatorio riprese come se nulla fosse e per la maggior parte del tempo fu Isaac a parlare e a rispondere alle domande dello sceriffo. Notai avesse una voce flebile e tremolante e l’idea che fosse sul serio spaventato – che non stessi solo costruendomi inutili castelli di carta – s’insinuò in me sempre più a fondo, ogni minuto che passava. Non ascoltai attentamente tutto ciò che Stephen e Isaac si dissero: mi limitai a starmene in silenzio ad osservare suo padre con la coda dell’occhio, nel terrore che trovasse qualcos’altro di cui lamentarsi, pur sapendo che non gli stessi dando alcun motivo per farlo. Possibile che quell’uomo sconosciuto fosse riuscito ad intimidire anche me? Come faceva Isaac a viverci insieme senza impazzire? Fu allora che notai un sospetto alone nero intorno al suo occhio sinistro. Lo stomaco mi si strinse in una morsa. No. Oh, no. Magari era stato un incidente. O magari… Feci per riportare gli occhi sul signor Lahey senza più nascondermi e spiarlo di sottecchi, ma prima ancora che potessi riuscirci fu lo sguardo di Isaac a catturare la mia attenzione e distrarmi. Sentivo in sottofondo la voce di Stephen – stava davvero parlando di lacrosse? – ma ero distratta, e Isaac proprio non sembrava da meno. Osservai nella direzione in cui erano puntati i suoi occhi azzurrissimi: improvvisamente mi sembravano ancor più pieni di paura e agitazione. Credetti che avesse visto qualcosa capace di spaventarlo ancor più di suo padre, ma tra gli alberi del bosco che osservava, immobilizzato, non trovai nulla. Allora tornai a guardare Isaac, con le sopracciglia aggrottate. «Scusi», lo sentii mormorare in direzione di Stephen, mentre distoglieva repentinamente lo sguardo dalla vegetazione circostante. Infossò le mani nelle tasche dei pantaloni scuri e sollevò le sopracciglia. «Mi sono solo ricordato che tra poco dovrei andare ad un allenamento». Lo sceriffo non mi sembrò per nulla convinto – proprio come me – ma ad ogni modo decise di non indagare oltre e donò un ulteriore sguardo al block notes nero che ancora stringeva tra le mani. «Un’ultima domanda», annunciò infine, ridonando tutta la sua attenzione ad Isaac. «Subite molti furti nelle tombe?». Isaac si strinse nelle spalle. Poi i suoi occhi si spostarono sulla buca scavata alla mia sinistra e a me venne istintivo imitarlo. «Qualcuno», sentii che mormorava, un po’ più tranquillo – forse all’idea che di lì a poco l’avremmo lasciato libero, chissà – mentre io indietreggiavo di un passo. Fino a quel momento non mi ero resa conto di essere così vicina alla buca. «Di solito prendono cose tipo i gioielli». Stephen aggrottò le sopracciglia. «Questa volta, invece?». «Il fegato». A fatica mossi gli ultimi passi verso l’aula di chimica, guadagnandone l’interno con aria stanca e affannata. Numerose paia di occhi mi corsero subito addosso e gli sguardi dei miei compagni descrissero alla perfezione la confusione che quella mia entrata in scena assolutamente poco consona aveva causato in loro. Tuttavia li ignorai tutti come se nulla fosse, puntando gli occhi scuri sulla schiena del professor Harris mentre istintivamente mi dirigevo – cercando di fare il meno rumore possibile – verso il banco in penultima fila occupato da Stiles. Il professore era di spalle, intento a muoversi agilmente tra le file di banchi, perciò ancora non aveva notato il mio vergognoso ritardo. Ma sapevo già che la cosa non sarebbe rimasta a lungo inosservata: al contrario temevo un suo richiamo infastidito più di ogni altra cosa. Sapevo di non poter evitarlo, eppure ci provai. Magari se sguscio velocemente accanto a Stiles…, pensai, non si accorgerà nemmeno del fatto che sono arrivata adesso. Ma ancora non avevo fatto i conti col Destino, sempre pronto a rifilarmi inadeguate sorprese nei momenti meno opportuni. Quando raggiunsi il banco occupato da Stiles, infatti, Harris ancora non aveva notato né me né il mio fiatone, ma in compenso la sconosciuta compagna di banco di Stiles mi guardò altezzosa al di sotto delle lunghe ciglia fulve. Presa di sorpresa dalla sua inaspettata presenza, di primo acchito rimasi immobilizzata con gli occhi scuri posati sul suo viso niveo spruzzato di lentiggini. Poi qualcosa si agitò dentro di me ed assunsi, quasi senza nemmeno volerlo, un’espressione contrariata. Come hai osato sederti di fianco a Stiles?, avrei voluto chiederle, ma per fortuna riuscii ad evitare. «Questo è il mio posto», sibilai però, rendendomi conto subito di non stare nemmeno provando a migliorare la situazione. Al contrario mi stavo mostrando scorbutica e prepotente nei confronti di quella ragazza sconosciuta, tanto che addirittura Stiles mi dedicò un’occhiata stranita che registrai a malapena, troppo concentrata nel fulminare con gli occhi la sua nuova compagna di banco. «Non mi pare che porti il tuo nome», mormorò proprio lei dopo qualche secondo, cogliendomi di sorpresa con quel tono per nulla indeciso. Non avrei mai detto che fosse capace di tenermi testa: sembrava una ragazzetta carina e indifesa e invece… Ma non avevo tempo da perdere con lei. «Senti, hai bisogno di un invito scritto per scollare il culo da questa sedia?», borbottai, muovendo un passo nella sua direzione senza che nemmeno me ne rendessi conto. Sul finale di frase mi ritrovai infatti così vicina al suo volto che mi sarei aspettata di vederla indietreggiare, quantomeno intimorita dal mio comportamento “minaccioso”. Tuttavia la rossa non batté nemmeno ciglio, il che riuscì ad infastidirmi ancor di più. Feci subito per aggiungere qualcos’altro, irritata e pronta a discutere per qualcosa di così stupido, ma Stiles – bravo come al solito a predire i miei movimenti – si limitò ad ammonirmi con uno sguardo infastidito e allora provai a rilassarmi, solo perché indirettamente mi aveva chiesto lui di fare così. «Sharon, potresti per favore lasciare il posto ad Harriet?», lo sentii chiedere alla rossa – a Sharon – e capii che, al contrario mio, stava usando la carta “gentilezza”. Non si poteva negare che fosse più furbo della sottoscritta, ma nonostante quanto fossi convinta del fatto che almeno lui avrebbe avuto successo, le cose non andarono affatto così. Difatti Sharon lo fissò inebetita per un solo, breve attimo. Poi il suo visino spruzzato di lentiggini si piegò in un’espressione vagamente imbronciata e la stronzetta esplose in un: «DOVE ALTRO DOVREI SEDERMI?» pronunciato a voce così alta che non potemmo fare a meno di ritrovarci immediatamente addosso tutta l’attenzione del professor Harris. Proprio ciò che avrei voluto evitare. Nell’esatto momento in cui i piccoli occhi azzurri del professore si fossilizzarono sulla mia figura, urlai internamente e maledii Sharon. Era finita, ne ero consapevole. «Signorina Carter! Che piacere vederla concedermi l’onore di assistere ad una delle mie modestissime lezioni», esclamò difatti, mentre l’unica cosa che avrei voluto fare io era scomparire. «Ha intenzione di sedersi a breve o vuole continuare ad oltranza col suo teatrino?». Avrei voluto rispondergli a modo come mi piaceva fare di solito, ma evitai: un nodo pieno d’imbarazzo mi stringeva la gola e gli occhi già pizzicavano, inumiditi da insopportabili lacrime. L’unica cosa che feci fu distogliere lo sguardo dal viso di Harris per puntarlo nuovamente su Sharon, che – non so ancora come né perché – sembrò immediatamente ritrovare un briciolo di buon senso e decise di togliersi silenziosamente dalle scatole, defilandosi chissà dove mentre io, in assoluto silenzio, prendevo posto di fianco a Stiles. «Credevo che non saresti venuta, ecco perché non ti ho tenuto il posto», lo sentii che mi spiegava velocemente, tenendo d’occhio Harris senza farsi notare. Subito feci altrettanto, osservandolo mentre ritornava come se niente fosse alla cattedra. Quanto lo odiavo. Rassicurai Stiles con una serie di parole alle quali non credevo io in primis, poi distrattamente lo ascoltai mentre continuava a parlarmi. Ma tutto ciò che colsi fu un: «Ero preoccupato per te» sussurrato che acquistò tutta la mia attenzione. «Ho avuto un problema», fu l’unica giustificazione che donai a Stiles, voltandomi velocemente a fronteggiarlo. «Te ne parlo dopo, promesso. Com’è andata con Jackson?». «È il solito menefreghista. E come se non bastasse fa finta di essere estraneo a tutta questa roba», mi rispose velocemente, subito dopo aver fatto spallucce. «Ma ha ragione lui». Aggrottai immediatamente le sopracciglia, più che confusa da quella sua spiegazione evasiva. Io gli avevo fornito davvero pochi dettagli sul mio contrattempo, ma Stiles proprio non stava agendo da meno. Lui e Scott avevano parlato con Jackson, senza di me, ma capire come fosse andato sul serio il loro confronto non mi sarebbe stato permesso prima della fine di scuola. Provai a chiedere ulteriori informazioni, sempre attenta a non farmi sorprendere da Harris impegnata in quella conversazione proprio durante lo svolgimento di uno dei suoi soliti test a sorpresa. Tuttavia le mie misure cautelari si dimostrarono tutte inutili nel momento in cui proprio il mio professore di chimica richiamò le nostri attenzioni, riprendendoci – proprio come gli piaceva un sacco fare – di fronte all’intera classe. «Ci vediamo alle tre per la punizione, signor Stilinski», furono le uniche parole che colsi, ed immediatamente le mie labbra assunsero la forma di una perfetta “O”. Com’eravamo potuti arrivare a quel punto? Feci per chiederlo, a nemmeno sapevo io chi, ma Harris ancora una volta mi anticipò, domandando: «Vuole unirsi a noi, signorina Carter?» ed io – vagamente terrorizzata dall’idea – mi limitai a scuotere la testa lentamente. Evidentemente soddisfatto da quella mia reazione atterrita, Harris si limitò a sorridere e poi si mise seduto – finalmente – dandoci il permesso di cominciare a lavorare sui test. Tuttavia non ebbi tempo di occuparmi della cosa, perché uno «Stai bene?» sussurrato e proveniente dalle mie spalle attirò immediatamente tutta la mia attenzione. Sentii il forte impulso di girarmi a controllare e lo feci, ruotando il capo di novanta gradi e trovandomi di fronte l’immagine di Jackson e Danny, seduti l’uno di fronte all’altro nel loro banco in ultima fila. Bastò l’espressione di Danny a farmi capire subito che fosse Jackson quello a “non stare bene”, perciò spostai lo sguardo su di lui ed immediatamente aggrottai le sopracciglia. Si teneva una mano premuta contro il naso, vittima probabilmente di un episodio isolato di epistassi. Ma allora perché Danny aveva in viso un’espressione così preoccupata? Lo capii nel momento in cui Jackson si mise in piedi, sempre con la mano premuta contro il naso, e poi corse fuori dall’aula senza nemmeno ascoltare i richiami del professor Harris. Un liquido denso e nero che difficilmente poteva essere sangue aveva imbrattato il foglio del suo test a sorpresa e sia io che Danny osservammo la macchia con occhi sgranati finché non fu tempo di metterci a lavoro. Cosa sta succedendo?, fu l’ultima domanda che mi posi prima di ritornare a fronteggiare il mio compito. Non appena ne ebbi l’opportunità, sgusciai fuori dall’aula di chimica e mi unii anch’io alla folla di persone intente ad affollare i corridoi della Beacon Hills High School durante il solito cambio d’ora. Quella giornata era appena cominciata e sembrava non dover finire più, ma nessuno intorno a me era giù di morale tanto quanto la sottoscritta. Non sapevo bene se fosse stata colpa del mio ritardo oppure del test di chimica che non era andato bene come volevo: fatto stava che non ero tranquilla e le condizioni instabili di Jackson e Lydia proprio non mi aiutavano a stare meglio. Sapevo che non avrei dovuto preoccuparmi – perlomeno, non per Jackson – ma non potevo impedirmi di farlo. Sospirando raggiunsi il mio armadietto: Allison era già lì intenta a trafficare con libri e quaderni ed io la salutai con un semplice sorriso amichevole. Mentre inserivo la combinazione per aprire la serratura e poi spalancavo l’antina, l’osservai con la coda dell’occhio tirare fuori dall’armadietto un lungo vestito nero ricoperto da una busta di cellophane. Immediatamente mi sentii a disagio, riconoscendo quello come l’abito che avrebbe indossato in occasione del funerale di sua zia Kate. Sapevo di star sbagliando ancora una volta, ma non potei fare a meno di provare dispiacere per lei e per come era finita. Non se lo meritava e lo sapevo, perciò scossi la testa per scacciare via quei pensieri e donai ad Allison l’ennesimo sorriso, nella speranza vana di poterla rassicurare almeno un po’. Lei mi ricambiò in silenzio poco prima di riportare l’attenzione sull’armadietto: un fogliettino di carta straccia aveva appena attirato il suo sguardo curioso ed io la osservai con la coda dell’occhio mentre lo prendeva tra le mani e ne leggeva il contenuto. Non le chiesi niente, ma quando Allison prese a ridacchiare di gusto la curiosità ebbe la meglio e decisi subito di chiudermi l’armadietto alle spalle per fronteggiare la mia amica senza l’impiccio dell’anta a dividerci. «Che succede?», le domandai velocemente, cercando di sbirciare sul foglietto. Non ne ebbi bisogno, tuttavia, perché Allison me lo porse dopo un ultimo accenno di risata. «Scott», sussurrò semplicemente prima che potessi leggere, e tutto ciò che quel semplice nome venuto fuori dalle sue labbra riuscì a comunicare, mi diede già la risposta. Lessi le parole “perché ti amo” con le labbra piegate in un sorriso. Quella era sicuramente la calligrafia di Scott e credevo di non averlo mai visto prima d’ora compiere un gesto così bello e romantico. Colpita, ridonai ad Allison il suo regalo ma, nel momento in cui feci per dire qualcosa, una voce sconosciuta m’interruppe. «Bel vestito», constatò, ed immediatamente sia io che la Argent ci voltammo nella direzione dalla quale proveniva. Ciò che ci trovammo di fronte fu un normalissimo adolescente dai capelli scuri e gli occhi chiarissimi, intento a fissare Allison – ed il suo vestito – attentamente. Proprio lei, non appena capì a cosa fosse riferito, donò allo sconosciuto un sorriso e – non sapendo come replicare – fece scorrere lo sguardo lungo tutta la sua figura finché non si scontrò con la Canon che il tipo teneva gelosamente tra le mani. «Bella videocamera», ricambiò allora, e il discorso cadde lì. Di nuovo provai a chiedere qualcosa ad Allison: non mi pareva di aver visto mai quel ragazzo sconosciuto prima d’allora, ma se lui le aveva parlato magari si conoscevano. Ed io non ne sapevo niente? Poco probabile, ma non impossibile. Provai a parlare, ma delle voci confuse provenienti dalle nostre spalle catturarono la mia attenzione e, purtroppo, anche quella di Allison. «È sua zia. La pazza che ha causato l’incendio e ucciso tutta quella gente», sentii, e nonostante il fatto che quelle parole m’avevano gelato il sangue nelle vene, mi voltai comunque alle mie spalle, cercando di rintracciare chi fosse l’autore di tutte quelle cattiverie. Due ragazze di colore erano intente a portare avanti quella sessione di pettegolezzi. Ma non le avevo mai viste prima d’allora, dunque non c’era molto che potessi fare. «Stai scherzando? Io sto seduta vicino a lei!», trillò una delle due, allarmata, e nel silenzio che era sceso momentaneamente, quella battuta acida raggiunse perfino le orecchie del ragazzo che solo pochi secondi prima aveva parlato ad Allison. Lo vidi infatti voltarsi ad osservare la situazione con occhi confusi, poi fissò nuovamente la Argent e mi spinse a fare altrettanto. Era ormai nient’altro che una statua di sale e mi sentii inutile: incapace di aiutarla. «Cambia posto», fu la risposta che la ragazza preoccupata ricevette, seguita da una risata divertita alla quale si unì poco dopo. A quel punto, per Allison fu troppo. La osservai chiudersi l’armadietto alle spalle con un tonfo, trattenere le lacrime e poi scappare letteralmente via senza che potessi fare niente per impedirglielo. Nemmeno urlare il suo nome riuscì a fermarla ed impotente, non potei far altro che ritornare a fronteggiare il mio armadietto chiuso. Sospirando tristemente ci poggiai contro la fronte, desiderando fortemente che tutto quello non fosse mai successo sotto lo sguardo leggermente allibito del ragazzo sconosciuto. «Ehi». Non appena fu vicino abbastanza da poterlo fare, Stiles salutò Scott a bassa voce e poi si inginocchiò alle sue spalle, velocemente seguito da me. Sembrava che l’essere in ritardo fosse il denominatore comune di quella giornata, tanto che ancora una volta m’ero ritrovata in tale scomoda situazione. Era il giorno del funerale di Kate Argent e sia io che Scott e Stiles avevamo deciso più o meno di comune accordo che ci saremmo stati – seppur dietro le quinte. Tutto per provare sempre e comunque a sostenere Allison. Fu proprio lei che mi sporsi istintivamente a guardare, nascosta alla bell’e meglio dai corpi di Stiles e Scott e dalla statua in pietra consunta che ci precedeva. La vidi seduta compostamente e in maniera rigida, le mani abbandonate in grembo, lo sguardo basso e il lungo vestito nero che già aveva mostrato a scuola. Sapevo che se fosse dipeso da lei avrebbe passato l’intera funzione in quella posizione – col viso al sicuro, protetto dai capelli scuri, libera di piangere senza vergognarsi – ma quando la figura di un uomo anziano le si parò di fronte reclamando la sua attenzione, Allison fu costretta a portare gli occhi nei suoi. «Chi diavolo è quello?», domandai presto, stupita da quella nuova presenza. Nuova a me, certo, ma di sicuro non al resto di Beacon Hills. Mi bastò infatti vedere quell’uomo intento a parlare con Allison per capire di come fosse originario del posto e, sicuramente, in stretti rapporti con gli Argent. Ma non ebbi tempo di ascoltare nessuna risposta perché proprio l’uomo misterioso voltò velocemente il capo nella nostra direzione e sia io che Stiles e Scott subito provvedemmo a nasconderci meglio dietro la vecchia statua in pietra, cercando di non sobbalzare troppo vistosamente. Quando il pericolo sembrò essere scampato, Scott disse: «Decisamente un Argent» e poi ritornò a sporgersi per tenere d’occhio la situazione, muovendosi però con cautela. Io e Stiles lo imitammo subito e catturammo lo sguardo color cioccolato di Allison, che sorrise al saluto di Scott senza però farsi notare troppo. Incoraggiato dal silenzio teso che ci avvolgeva, Stiles cominciò a fare teorie sui nuovi arrivati – come suo solito. «Forse è qui solo per il funerale. Magari lui e il suo gruppo sono quelli non violenti della famiglia, o qualcosa del genere», esalò, ma non sembrava molto convinto nemmeno lui. «Voglio dire: ci saranno degli Argent “tranquilli”. Spero». La sua arringa si chiuse in nient’altro che un sussurro, e allora deglutii. Non mi era ben chiaro perché, ma sapevo che le sue speranze fossero più che vane. Lo capii donando un ulteriore sguardo in direzione dell’uomo anziano seduto di fianco ad Allison, scrutando il suo volto severo e la posa di sufficienza che aveva assunto. Tutto lasciava pensare che non fosse di certo un pacifista. «Io so chi sono», affermò allora Scott, interrompendo il flusso dei miei pensieri. «Sono i rinforzi». Lo sapevamo. Tutti. Io in particolare. Anche Stiles che aveva provato a convincerci del contrario. Perfino Scott che dopo interi minuti di silenzio era giunto a quella conclusione più che ovvia. Eppure il tutto non ci aiutò a stare tranquilli. Al contrario, l’arrivo di altri Argent voleva significare solo una cosa: la guerra – quella vera – stava per incominciare, e i cacciatori volevano essere sicuri di non perdere più nessuno, dopo Kate. Volevano essere preparati. Proprio come avremmo dovuto essere noi. «Non ci credo». Una voce familiare mi riscosse all’improvviso e sobbalzai, distogliendo lo sguardo da Allison – sulla quale mi ero fossilizzata senza guardarla sul serio, persa nei miei pensieri – per voltarmi alle mie spalle, la direzione dalla quale la voce era venuta. Purtroppo però, non ebbi tempo di fare altro. «Mi rifiuto di crederci!», continuò Stephen, afferrando Stiles e Scott affinché si mettessero in piedi. Ecco perché la voce mi pareva familiare. Si trattava di niente di meno che lo sceriffo e come al solito, ci aveva beccati. Non avrei dovuto più stupirmi, eppure non ne ero in grado, tanto che me ne rimasi immobilizzata dalla sorpresa sotto il suo sguardo azzurro. «Harry. Tirati su». Sapevo che non avrei dovuto, ma tentennai. «Non costringermi ad usare le maniere forti anche con te». “Maniere forti” uguale: farsi trascinare da Stephen. Grazie ma passo. Mi misi in piedi velocemente, facendomi vicina ai tre uomini. Essersi fatti beccare era comunque sempre fastidioso e imbarazzante, ma perlomeno non avrei più dovuto nascondermi nel cimitero che mi era capitato, in un solo giorno, di visitare troppo spesso. Avrei voluto davvero rimanere lì, per Allison, ma allo stesso tempo la cosa mi metteva a disagio – assistere di nascosto al funerale. Non mi sembrava… giusto. Dunque meglio andar via con Stephen. Ecco perché lo seguii silenziosamente verso l’auto di pattuglia, imitata da Scott e Stiles. Stephen li lasciò andare solo quando fummo giunti alla macchina, intimando loro di prendere posto nei sedili posteriori, allacciare le cinture di sicurezza e tenere le bocche chiuse. Se fosse stata un’altra situazione avrei anche riso, ma allora mi sentivo semplicemente un nodo allo stomaco, perciò anch’io presi posto in assoluto silenzio al posto del passeggero. Quando anche Stephen entrò in macchina, provò a dire qualcosa e a mettere in moto per andare via, ma la voce di un agente glielo impedì. «4-1-5, Adam», annunciò una voce metallica, proveniente dalla radio di servizio posizionata sul cruscotto. Immediatamente il silenzio diventò pesante. Stiles e Scott, dietro di me, assunsero un’espressione confusa specchio di quella di Stephen, mentre io cercavo di dissimulare e mi fingevo impegnata ad allacciare la cintura di sicurezza. «Hai detto: “4-1-5, Adam”?», domandò lo sceriffo. «Problemi con un auto». Era stato Stiles a sussurrarlo. Il suo intento era quello di parlare silenziosamente, ma le sue parole avevano raggiunto sia me che, ci scommettevo, Stephen. Tuttavia lui fece finta di nulla, rimanendo in attesa di una risposta dalla radio. Io invece mi voltai a cercare i visi di Stiles e Scott con le sopracciglia aggrottate. Purtroppo però non ebbi tempo di dire né fare nulla. «Stavano trasportando una vittima d’infarto, ma andando in ospedale qualcosa li ha colpiti», sentii, e gli occhi mi si sgranarono in automatico. «Hanno colpito un’ambulanza?». Non era quella la domanda più importante, me ne resi conto subito. Piuttosto c’era da chiedersi: chi ha colpito un’ambulanza? Speravo che la risposta alla quale stavo pensando – sicuramente insieme a Scott e Stiles – fosse sbagliata. «Affermativo», confermò l’agente attraverso la radio, prima di continuare a parlare. «Sono qua davanti, adesso. Qualcosa li ha presi da dietro. C’è sangue dappertutto: proprio dappertutto». La voce dell’uomo si spezzò, divenendo ancor meno udibile attraverso la linea disturbata dal maltempo in arrivo. L’agente tradiva tutta la sua agitazione e nessuno meglio di me riusciva a capirlo. Tuttavia il suo atteggiamento non avrebbe portato a nulla di buono e Stephen lo capì subito, cercando di tranquillizzarlo e riportare la sua mente al lavoro. «Qual è la vostra posizione?», gli domandò, e allora l’agente – seppur ancora scosso – ritornò attento e gli rispose in modo esauriente. «Non ho mai visto niente di simile», concluse prima che il collegamento s’interrompesse, e un brivido mi corse immediatamente giù per la schiena, provocato da un improvviso spiffero di vento – e non solo. Stephen spense la radio, sospirando mentre si accasciava contro il sedile. Poi: «Devo andare», spiegò, voltandosi a guardarmi prima di girarsi alle sue spalle e dire: «In quanto a voi…». Ma la sua frase restò incompiuta, e seguendo il suo sguardo azzurro capii subito perché. I sedili posteriori della volante erano vuoti: Stiles e Scott erano sgattaiolati via in silenzio e nessuno di noi se n’era reso conto – io addirittura avevo pensato che lo spiffero di vento che sommato all’agitazione mi aveva fatta rabbrividire vistosamente fosse stato semplicemente casuale. Che povera illusa. «Li ammazzo», borbottò Stephen, mettendo in moto l’auto senza nemmeno lasciarmi il tempo di dire nulla. «Giuro che li ammazzo». Ti do volentieri una mano. Arrivammo sulla scena del crimine esattamente dieci minuti dopo. Il luogo era tenuto sotto stretta sorveglianza da diverse pattuglie della polizia e le luci delle auto risplendevano nel buio della notte, tutte condensate nel punto focale dello scenario. Quando vidi, le gambe divennero gelatina e dovetti aggrapparmi ad uno degli specchietti dell’auto di Stephen per non cadere, stravolta da quell’orrore. L’ambulanza biancorossa del Beacon Hills Memorial Hospital, quella coinvolta nell’incidente, si presentava agli occhi di tutti col portellone posteriore spalancato e distrutto. Ma non era quella la parte peggiore, no. All’interno di essa se ne stava un uomo visibilmente morto, la testa riversa e gli occhi chiusi. Le pareti del mezzo, un tempo candide, erano ora ricoperte e screziate di rosso. Il sangue di quell’uomo che i paramedici avevano tentato di salvare, imbrattava i muri dell’ambulanza e di fronte a quella vista sentii salirmi in gola un fiotto di bile. Se fossi stata sola penso che avrei anche rovesciato e mi sarei lasciata libera di abbandonarmi al crollo, ma una moltitudine di agenti – primo fra tutti Stephen – mi guardavano di sottecchi con espressione preoccupata e capii subito di essere obbligata a controllarmi. Anche perché non ero certo io quella meritevole di attenzioni. C’erano problemi più gravi. M’ero fatta lontana dalla scena, tuttavia, incapace di sopportare ancora quella vista terrificante. Eravamo al limitare del bosco, e lontana dalla folla di persone che affollavano il posto mi riscoprii intenta a riflettere. Era sul serio stata Lydia a compiere quella violenza così atroce? Si era trasformata in un mostro irriconoscibile e assetato di sangue? Perché non era successa la stessa cosa a Scott? Lydia era forse stata più debole? E Jackson, ora che Derek l’aveva morso, avrebbe seguito le sue orme? Ma allora perché sembrava stare così male? Quei pensieri erano solo uno scudo, tuttavia. Lo sapevo benissimo, anche se preferivo non ammetterlo. Mi faceva comodo arrovellarmi su questioni che non avrei mai potuto comprendere piuttosto che pensare a dove potesse essere Stiles e preoccuparmi a morte per lui. Era di gran lunga più conveniente, ma non era affatto ciò che avrei voluto fare. Lo compresi a pieno quindici minuti dopo, quando Stiles rifiutò la mia quattordicesima chiamata e decisi di lasciarmi andare al crollo mentale che già da tempo minacciava di accogliermi a braccia aperte. Non riuscii nemmeno ad impedirmelo: semplicemente scoppiai a piangere molto più forte di quanto mi sarei mai aspettata e con mani tremanti decisi di ricomporre il numero di Stiles. Non potevo credere che fosse successo qualcosa anche a lui, e a Scott. Quella non era un'opzione accettabile. Ma se stava bene, allora perché non rispondeva alle mie chiamate? Perché non tornava da me? «Stiles», gemetti ancora, non appena la segreteria mi diede il via. «Stiles, ho bisogno di sapere che stai bene. Ho bisogno di sapere che sia tu che Scott siete sani e salvi». Deglutii, cercando di calmare i miei sussulti. Tirando su col naso, mi passai una mano sul viso e strinsi più forte le dita attorno al mio cellulare. Lo premetti ulteriormente contro l’orecchio prima di riprendere a parlare, sperando che il mio pianto non fosse poi così rumoroso da attirare l’attenzione di qualcuno degli agenti nelle vicinanze. «Sono preoccupatissima», aggiunsi, balbettando quasi. «Anche tuo padre lo è. Stiles, rispondi». Un improvviso bip interruppe la registrazione e il respiro mi si mozzò in gola, facendo sì che anche la mia voce venisse meno. Il mio tempo era scaduto, anche quella volta. Quello era il quindicesimo messaggio che lasciavo in segreteria. Quella era la quindicesima volta che non ricevevo alcuna risposta. Avevo perso. «Ti prego…», mormorai a me stessa, completando la mia frase anche se sapevo che Stiles non avrebbe potuto sentirmi. O perlomeno così credevo, perché scoprii presto di starmi sbagliando. Difatti, ad un passo dallo scoppiare a piangere ancora – più forte di prima – sentii qualcosa sfiorarmi la spalla e prima ancora che me ne potessi rendere conto, mi ritrovai stretta in un abbraccio fin troppo familiare. Oh Dio. Oh Dio, oh Dio, oh Dio. Pensai immediatamente, stringendo le mie braccia attorno al corpo di Stiles come se ne dipendesse della mia stessa vita. Da dov’era spuntato? Ma soprattutto: stava bene? Mi aveva sentita piangere e parlare al telefono? Non ebbi la forza di porgli tutte quelle domande. «Mi dispiace», mi sentii dire, e allora lo strinsi più forte. Tutto questo finché la rabbia non riprese a montarmi dentro, accecandomi totalmente com’era successo interi minuti prima. Stravolta, mi feci lontana da Stiles e gli donai un’occhiataccia non troppo convinta. Avevo ancora gli occhi pieni di lacrime e le guance bagnate: di certo la mia cera era pessima e perciò non molto minacciosa. Ma me ne fregai. Stiles mi aveva fatta preoccupare a morte e volevo che lo capisse. «Sei un deficiente», sbottai, spintonandolo lievemente. «Si può sapere cosa cazzo ti è saltato in mente?». «Harry», provò a fermarmi, chiamando il mio nome con un tono di voce tranquillo. Ovviamente non ne volli sapere di stare calma. «No, ora stai zitto!», redarguii, puntandogli un indice contro. «Stavo morendo di paura. Lo vedi come sto? Uno schifo. Non devi fare mai più una cosa del genere!». Al mio: “Lo vedi come sto?” fu naturale, per Stiles, guardarmi – quella volta sul serio. Non so cosa vide sul mio viso, non voglio chiedermelo né saperlo, fatto sta che si rabbuiò di conseguenza e qualcosa dentro di me si spezzò. Capii solo in quel momento che c’eravamo fatti del male a vicenda. «Eravamo preoccupati per Lydia…», mormorò dopo qualche secondo, distogliendo lo sguardo dal mio viso. «Lo ero anch’io. Ma ero anche preoccupata per te. E per Scott». Compii qualche passo nella sua direzione, contrariata da quel suo improvviso allontanamento. «Non dovreste mettervici anche voi». Solo allora Stiles riprese a guardarmi. Eravamo così vicini che potei vedere i suoi occhi lucidi, e per poco la sorpresa non mi fece vacillare. «Mi dispiace», ripeté, non distogliendo mai – nemmeno per un attimo – gli occhi dal mio viso. Capii che non sarei riuscita a sostenere oltre quel suo sguardo senza crollare di nuovo, ecco perché mi affidai completamente a Stiles, stringendolo ancora tra le mie braccia e facendomi stringere a mia volta. «Ti odio», borbottai però quando fui nascosta contro il suo petto, asciugandomi le guance alla bell’e meglio. Stiles s’irrigidì contro di me, smise di accarezzarmi i capelli e poi provò a dire qualcosa. Allora lo fermai, facendomi lontana dal suo corpo quel tanto che bastava a guardarlo in viso. Quasi rinata, gli sorrisi e poi gli porsi una mano affinché la afferrasse. Quando lo fece, sperai di averlo tranquillizzato almeno un po’. Poi: «Andiamo da tuo padre», dissi, e insieme ci avviammo verso la meta. Insieme. Ancora. I’m getting weaker everyday,
yeah.
Ringraziamenti Agli Honor Society, perché la loro Kaleidoscope fa da titolo a quest’ennesimo viaggio che farò insieme ad Harriet e Stiles (e spero insieme a tutti voi). A Cher Lloyd, perché la sua Sirens fa da titolo/canzone citata in questo primo capitolo della storia. A Zack Hemsey, perché The way è TUTTO. In anticipo, a chiunque leggerà/seguirà/ricorderà/preferirà/recensirà. Note Il banner/gif non è di mia proprietà: non l’ho creato io, dunque non intendo – ovviamente – prendermene il merito. Su facebook mi trovate come Lena Harmon (ancora per poco, perché ho intenzione di ritornare ad essere la signora Kanbara anche lì. Ma vbb). Potete aggiungermi per spoiler, scleri vari e anche per farmi domande (sarò felicissima di rispondere a qualsiasi vostro quesito). Vi chiedo scusa per questo capitolo-papiro. Davvero. Quale sarà il contrattempo che ha impedito ad Harriet di arrivare in orario alla lezione di Harris? |
Capitolo 2
*** What the Hell? ***
NB. In caso aveste deciso di non leggere parachute, vi do qualche piccola informazione fondamentale per farvi capire alcune cose che potrebbero altrimenti confondervi. Da come potrete vedere di già nella prima scena di questo secondo capitolo, Harriet vive in casa degli Stilinski e tutto ciò è possibile grazie ad un corso di Intercultura per il quale è stata scelta proprio da Stiles e Stephen (anche il nome dello sceriffo è di mia invenzione). Per farvela breve: Stiles aveva problemi col francese e la professoressa Morrell gli ha proposto, per recuperare, di ospitare a casa sua uno dei ragazzi scelti per il progetto e alla fine (grazie a Stephen!) la scelta è ricaduta proprio sulla nostra Harry. A dire il vero le cose sono molto più complicate di così, ma non voglio spoilerarvi nulla di più e mi limito ad augurarvi buona lettura.
kaleidoscope
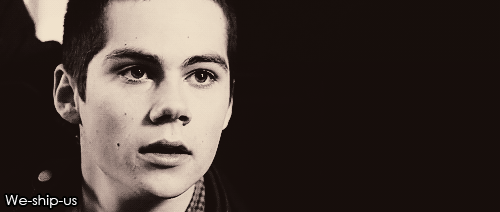 2. What the Hell?
Il mattino dopo mi svegliai esattamente un attimo prima che la sveglia suonasse, annunciandomi che fosse l’ora di mettermi in piedi e cominciare a prepararmi per quell’ennesimo giorno di scuola. Raramente mi capitava di svegliarmi in anticipo – di solito rimanevo a dormire anche dopo il suono della sveglia, riducendomi a dover poi prepararmi in fretta e furia per non arrivare a scuola in ritardo – perciò quella mattina mi capitò di approfittare con voglia di quell’occasione, spegnere la sveglia prima che suonasse e godermi per qualche minuto in più il pacifico silenzio in cui la casa era avvolta. L’orologio segnava le sette in punto ed io mi misi in piedi lentamente, aguzzando l’udito per comprendere se la casa fosse davvero vuota come sembrava. Vivevo a Beacon Hills da davvero troppo poco tempo per ricordare già a memoria i turni di Stephen: semplicemente credevo che quella mattina ne avrebbe avuto uno, ma non potevo esserne sicura. Ne ebbi comunque la conferma quando, dopo un attento giro dell’abitazione, la scoprii vuota sul serio. L’unica stanza popolata – oltre a quelle che visitavo io, ovviamente – era quella di Stiles. Per un attimo mi persi anche a guardarlo dalla soglia, la mano stretta sulla maniglia in ottone e un vago sorriso a piegarmi le labbra piene. Non potevo vederlo in viso, ma ero convinta che stesse ancora dormendo: lo si capiva dai lievi respiri che lo scuotevano dalla sua posizione rannicchiata sotto le coperte pesanti. Ormai lo conoscevo abbastanza da sapere che di lì a poco si sarebbe svegliato, perciò decisi di sgusciare via in cucina prima che potesse aprire gli occhi e trovarmi lì intenta a fissarlo. Forse stupidamente, ma la reputavo una cosa piuttosto inquietante. Ridacchiai tra me e me per quei pensieri come al solito stupidi, poi liberai uno sbadiglio mentre mi stiracchiavo le braccia allungandole sulla testa e mi coprivo poi le labbra educatamente. Non appena giunta in cucina, la prima cosa che attirò la mia attenzione furono le voci soffuse provenienti dalla tv: Stephen l’aveva guardata prima di uscire per lavoro proprio come al solito, tenendo il volume basso per non svegliare né me né Stiles. L’avevo visto farlo spesso e certe volte mi era anche capitato di accodarmi a lui perché non più capace di dormire. E sapevo bene come non fosse abituato a spegnerla: se ne dimenticava puntualmente e quella mattina scoprii che non fosse stato da meno. Scossi la testa divertita, avvicinandomi alla tv quel tanto che bastava a trafficare coi tasti del volume. Era sintonizzata su un canale locale e il primo telegiornale della giornata veniva trasmesso: pensai che sarebbe stato interessante ascoltare le nuove notizie riguardanti Beacon Hills mentre provvedevo alla colazione. Tornai dunque in cucina, aprendo il frigo alla ricerca di latte che poi misi a scaldare sul fornello. Ero ancora intenta a trafficare alla ricerca di biscotti quando le parole: “notizia dell’ultimo minuto”, “omicidio” e “Lahey” attirarono tutta la mia attenzione. Proprio non potei fare a meno di immobilizzarmi, ancora dando le spalle alla tv. Non potevo vederla – non ne avevo la forza – ma sentivo distintamente la voce di una giornalista dire: «Il corpo senza vita di John Lahey è stato rinvenuto questa mattina alle prime luci dell’alba da alcuni agenti di pattuglia. Si tratta dell’ennesimo caso di omicidio qui a Beacon Hills, ma sfortunatamente ancora non ci sono state fornite ulteriori informazioni. La polizia indaga». Allora non riuscii a sentire più nulla. Semplicemente rimasi a fronteggiare la tv – perché alla fine avevo deciso di voltarmi, sì – con gli occhi sgranati e un improvviso senso di disgusto alla base della gola. Nella mia mente si ripetevano senza mai fermarsi le poche immagini di quel servizio che avevo avuto occasione di vedere: il corpo straziato del signor Lahey, la sua auto malconcia e rivoli di sangue ovunque. Non avrei dimenticato mai quella visione. Inutile dire che quando Stiles mi raggiunse in cucina si preoccupò non poco. «Harry?», chiamò, raggiungendomi con passi indecisi. Ero ancora immobile di fronte alla tv e potevo immaginare senza sforzo quanto quella scena potesse essere inquietante. «Cosa succede?». Non potevo dirglielo. Non avrebbe capito ed io non volevo che capisse. Non aveva senso dispiacersi per una persona che nemmeno conoscevo e che, tra l’altro, non meritava nemmeno metà della mia solita apprensione. Ecco perché dopo qualche attimo di solo silenzio afferrai il telecomando e lentamente, facendo spallucce come se niente fosse, spensi la tv. Poi mi voltai a guardare Stiles, fingendo un sorriso. «Non è nulla», rassicurai, poco convincente. «Muoviamoci o faremo tardi a scuola». Magari John Lahey non meritava il mio dispiacere – anche se era giusto che fossi sconvolta dal fatto che esattamente un giorno dopo il nostro incontro, lui fosse morto – ma mi capitò di pensare immediatamente ad Isaac e a quanto potesse essere stravolto dalla cosa, nonostante tutto. Ecco perché decisi che quel mattino stesso a scuola gli avrei parlato. Arrivammo a scuola in orario, proprio come da piano. Quando misi piede all’interno della Beacon Hills High School, ero ancora più che convinta di dover parlare con Isaac – perché, non avrei saputo dirlo – perciò non potei che gioire quando Stiles mi salutò velocemente, defilandosi verso la classe di chimica perché dopo la punizione del giorno prima preferiva non arrivare in ritardo a lezione. Certo, mi dispiaceva non poter essere con lui, ma dovevo parlare con Isaac e non c’erano spiegazioni che potessi dare a Stiles – dal momento che non ne avevo nemmeno per me stessa. Semplicemente avevo bisogno di stare sola per un po’. La mia prima lezione del giorno sarebbe stata con la signorina Morrell, ma dal momento che ancora mancava qualche minuto prima dell’inizio, decisi che ne avrei approfittato per mettermi subito alla ricerca di Isaac. Non lo conoscevo affatto e l’avevo visto solo una volta, ma qualcosa in lui aveva fatto nascere dentro di me un lieve senso di preoccupazione che – inutile dirlo – s’era accresciuto con la notizia della morte del padre. Vagavo da un po’ quando finalmente lo vidi, intento a trafficare all’interno di quello che aveva tutta l’aria di essere il suo armadietto. I corridoi della Beacon Hills High School erano ancora affollatissimi, ma il suo profilo catturò immediatamente la mia attenzione, per la prima volta dopo ben due mesi passati in quel liceo. Non potevo vederlo bene, ma giurai che avesse un paio di occhi tristi ancor più del giorno precedente. Forse fu proprio per questa ragione che infine mi decisi a portare avanti la mia decisione e lo raggiunsi. Tuttavia, quando il momento di parlargli fu giunto, mi limitai semplicemente a deglutire rumorosamente e a dondolare sul posto. Come avrei rotto il ghiaccio? Scoprii solo allora di non essermelo mai chiesto. Proprio come capii che non avrei avuto occasione di trovare una risposta soddisfacente al mio quesito, perché proprio Isaac si accorse della mia presenza accanto a sé e si voltò a guardarmi prima ancora che potessi dire qualcosa. «Oh», mormorò semplicemente sottovoce, probabilmente riconoscendomi. «Tu sei…». Sorrisi debolmente prima di completare la frase per lui. Non poteva di certo sapere il mio nome. «Harriet». Gli porsi una mano e Isaac, seppur titubante, la strinse. «Ero all’interrogatorio, ieri». «Lo sceriffo ha detto che eri la sua assistente». «Ci avevi creduto davvero?», domandai velocemente, poco prima di provare il forte impulso di mordermi la lingua. Stephen aveva mentito ed io ne ero stata pienamente complice. Non era una cosa bella, perciò per quale assurdo motivo avevo ammesso il tutto con così tanta nonchalance? Cosa mi passava per la testa? «Veramente no», mormorò Isaac dopo qualche minuto, e qualunque mia preoccupazione si dissolse nel momento in cui lo vidi intento a nascondere – con scarsi risultati – un sorrisetto vagamente divertito. Mi tranquillizzai di riflesso. «Ti chiedo scusa. Non avrei dovuto esserci». Pur di continuare a non guardarmi in viso, Isaac si finse improvvisamente impegnato a recuperare un paio di libri dall’armadietto e poi se lo chiuse alle spalle con movimenti lentissimi e poco naturali. Infine fece spallucce, infossando le mani nelle tasche dei jeans. «Immagino che non importi», disse, e dopo il silenzio c’avvolse ancora. «Ti ho cercato oggi perché… Ecco, ho scoperto di tuo padre. E volevo che sapessi quanto mi dispiace». «Oh». A quel punto, la troppa sorpresa fece sì che trovasse il coraggio di fissare gli occhi nei miei ancora una volta. «T-Ti ringrazio. Davvero. È… molto gentile, da parte tua. Grazie». Il vederlo così poco a suo agio mi intenerì inspiegabilmente, tanto che gli sorrisi – forse in modo un po’ inopportuno. Pensai che avrei dovuto aggiungere qualcos’altro: magari rassicurarlo perché non c’era bisogno che mi ringraziasse così tanto per una gentilezza più che dovuta o chiedergli scusa per la mia fastidiosa invadenza, ma il suono della campanella non mi lasciò il tempo di fare nulla. «Farei meglio ad andare», mormorai dunque, passandomi nervosamente una mano tra i capelli. «Mi dispiace per... essermi intromessa. Non volevo, davvero. Ci–». «Harriet», m’interruppe Isaac – c’eravamo scambiati i ruoli: in quel momento ero io quella nervosa e balbettante – compiendo nuovamente il grande sforzo di puntare le sue iridi azzurre sulla mia figura. «Sei solo stata gentile. Nessuno ha osato farmi le condoglianze. Né parlarmi, a dire il vero. Sono… invisibile. Solo un altro viso che tutti dimenticano. Tutti, a parte te». A malapena repressi l’impulso di boccheggiare. Cos’avrei dovuto dire per non risultare una completa stupida? Dubitavo che ci fossero parole adatte, ecco perché mi risolsi a chinare il capo mentre sentivo le guance andarmi a fuoco. Fu solo in quel momento che notai i libri che Isaac s’era in precedenza tanto affannato per recuperare dall’armadietto e istintivamente sorrisi, di nuovo sollevata. Avevo trovato il modo di cavarmi da quell’impiccio senza ulteriori brutte figure. «Hai francese?», domandai dunque, sollevando nuovamente lo sguardo su di Isaac mentre puntavo il libro che stringeva tra le mani. «Sì», rispose lui, dopo averci pensato un po’ su. «Anche tu?». Annuii, sorridendo. «Vuoi che andiamo in classe insieme?». Isaac nemmeno si preoccupò di rispondermi. Semplicemente mi affiancò e insieme ci dirigemmo, in silenzio, verso la classe della signorina Morrell. Un paio di ore dopo raggiunsi il campo da lacrosse nel momento esatto in cui il coach Finstock annunciò con un lungo fischio l’inizio dell’allenamento di quel giorno. Sorrisi, rendendomi conto di essere nuovamente in perfetto orario mentre mi dirigevo verso le gradinate pressoché vuote. Pareva che i ritardi continui del giorno precedente fossero solo un vago ricordo. Era strano vedere così poca gente agli allenamenti: in genere anche chi non era in squadra si ritagliava del tempo per seguirli e scampare alle lezioni, ma quel pomeriggio d’inizio novembre mi ritrovai invece a farmi spazio su delle gradinate a dir poco desolate. Tuttavia non reputai la cosa un problema e anzi, decisi subito che mi sarei goduta al meglio quella “solitudine” mentre salivo il più in alto possibile e prendevo posto in un punto abbastanza isolato. Quando riportai gli occhi sul campo, trovai l’allenamento già nel suo pieno svolgimento, nonostante fossero passati solo pochi minuti. Trovare Scott in porta mi stupì e non poco dal momento che quella posizione era sempre toccata a Danny, ma mai come vederlo scattare fuori dal suo posto per correre verso l’attaccante di turno e atterrarlo sul terreno erboso. Di fronte a quella scena la sorpresa fu tanta che per poco non mi sollevai in piedi, rovesciando in terra i libri che avevo posizionato ordinatamente sulle mie gambe. Mentre il coach prendeva ad urlare come se fosse impazzito, però, mi coprii le labbra con una mano e corsi alla ricerca dello sguardo di Stiles. Se qualcosa stava succedendo lui l’avrebbe di sicuro saputo, ecco perché non appena i nostri occhi s’incontrarono lo squadrai con le sopracciglia aggrottate e le braccia allargate in un muto: «Che diavolo succede?» al quale lui rispose con una veloce scrollata di spalle prima di distogliere lo sguardo dal mio. Dopo essersi sorbito gli ammonimenti del coach, osservai Scott ritornare in porta a testa bassa e allora cercai di tranquillizzarmi, convinta che non avrebbe più compiuto scatti del genere per paura di qualche ritorsione – più che giusta – da parte di Finstock. Non riuscivo a capire che cosa gli fosse preso, ma decisi che avrei evitato di chiedermelo ancora: questo finché la scena non si ripeté una, due, tre volte ancora. Quando fu il turno di Isaac di correre verso la porta e Scott – di nuovo – abbandonò la sua postazione per raggiungerlo a tutta forza, non potei più impedirmi di scattare in piedi. I libri che fino a quel momento avevo tenuto stretti sulle mie gambe – facendo sì che le nocche addirittura mi s’imbiancassero – caddero a terra con un tonfo, ma non me ne curai, troppo allarmata dallo scontro che portò Isaac e Scott a cadere l’uno di fronte all’altro sul terreno erboso. «Scott!», urlai, posizionando entrambe le mani ai lati della mia bocca. «Cosa ti prende?».
Sapevo che non avrei ottenuto risposta, eppure posi quella domanda comunque. Gli occhi di Stiles corsero immediatamente sulla mia figura mentre né Scott né Isaac ricambiarono il mio sguardo. Semplicemente li vidi osservarsi a vicenda finché il coach non interruppe quel momento, fischiando così forte che a confronto le urla che tirò fuori pochi secondi dopo furono del tutto innocue. Tuttavia mi toccò pormi entrambe le mani sulle orecchie, così infastidita da decidere di sgattaiolare via da quel posto e rifugiarmi dentro scuola nell’attesa della lezione successiva di quel giorno.
Mi chinai a raccogliere i libri da terra, attenta a non sgualcirli mentre ancora sentivo Finstock rimproverare Scott. Tuttavia, quando all’improvviso il silenzio scese sul campo da lacrosse – così inaspettato da stupirmi – mi tirai in piedi in fretta e furia perché assolutamente vogliosa di sapere cosa l’avesse causato. O meglio: chi. Difatti, Stephen Stilinski si muoveva a passo spedito proprio verso il centro del campo, accompagnato da due agenti in divisa e occhiali da sole. Avrei voluto sapere cosa ci facesse lì a scuola, ma il solo riflesso di una chioma bionda e scompigliata m’invogliò nuovamente a squagliarmela. Sapevo benissimo chi fosse e ne ebbi la conferma quando ormai ero già alcuni passi lontana dal campo di lacrosse e Stephen aveva chiamato a raccolta sia Isaac che il coach. Avevo visto il motivo della mia fuga esattamente il giorno prima e la sua presenza invadente e fastidiosa aveva fatto sì che arrivassi in ritardo alla lezione di Harris. Non avrei più permesso che una cosa del genere accadesse. Non gli avrei più permesso di avvicinarmi. Victor Daehler non meritava nemmeno un quarto dei miei tempo e considerazione. Le parole del professor Fisher m’attraversavano senza che io riuscissi a donare loro un senso. Era praticamente il weekend e di norma la mia mente vagava di già in lidi lontani e per nulla legati alla scuola e alle pesantissime lezioni di fisica. Come se non bastasse, le preoccupazioni che Lydia, Jackson, Isaac, Scott – e sì, anche Victor – riuscivano a procurarmi, facevano sì che mi distraessi ancor di più. In genere riuscivo a comprendere concetti fisici anche complicati: mi bastava prestare attenzione alle lezioni ed impegnarmi poi a casa – alla fin fine era tutta questione di cervello ed io ne avevo, proprio come tutti, ma soprattutto decidevo di utilizzarlo. Se invece quel giorno qualcuno mi avesse chiesto di spiegargli la lezione, molto probabilmente avrei fatto scena muta. L’unica cosa che sapessi al riguardo era il tema: la legge di Boyle. E badate, lo sapevo solo perché suddette parole se ne stavano scritte a caratteri cubitali sulla lavagna nera come la pece. Il professor Fisher gesticolava durante la solita spiegazione prolissa, animandosi ad ogni nuova formula e dimostrando il suo infinito amore per la materia, mentre io lo guardavo con occhi persi, limitandomi ad annuire di tanto in tanto per fingere attenzione. Ero brava a farlo, almeno tanto quanto la mia compagna di banco – una biondina slavata di nome Suzanne, che aveva dimostrato e ammesso candidamente più volte di non capirci niente di fisica nemmeno con tutto l’impegno del mondo. L’unica ragione che la portava a seguire le lezioni del professor Fisher era l’assoluto bisogno di crediti extra. «In conclusione, possiamo affermare che all’aumento di pressione il volume di un qualsiasi gas diminuisce. E viceversa», blaterò il professore, e sebbene captai quelle sue parole ancora non riuscivo a capirle fino in fondo. Mi limitai ad incrociare i suoi occhietti neri e quando lo vidi ricambiare il mio sguardo fui costretta a sostenere il contatto visivo. Fisher continuò a parlare e allora annuii, come un perfetto automa. «Ma», camminò in direzione della lavagna e si mise alla ricerca di uno spazietto vuoto, «la temperatura di suddetto gas dev'essere costante».
Afferrò un gessetto bianco e disegnò un piano cartesiano, poi un quarto di cerchio all’interno di esso.
«Come definiamo trasformazioni di questo tipo?», domandò poi, e subito qualcuno dalle prime file gli suggerì che il nome giusto era “isoterme”. Quando Fisher si congratulò col ragazzo che aveva risposto, la mia mente ancora non recepiva attivamente ciò che mi succedeva intorno e continuai ad essere distratta anche mentre il professore spiegava che era possibile rappresentare una trasformazione isoterma su un piano cartesiano, esattamente poco tempo prima che chiedesse che tipo di grafico era quello che proprio lui aveva in precedenza disegnato. Qualunque studente capirà ciò che provai in quell’infinito millesimo di secondo prima che Fisher ritornasse con gli occhi porcini sulla mia figura, pronto a pormi una domanda di cui nemmeno lontanamente immaginavo la risposta. Quando un professore sta per chiamarti interrogato, che sia una cosa seria o meno, te lo senti. E quando non hai idea di come rispondere al quesito posto, ci sono ancora più probabilità che il professore di turno se ne renda conto e decida di chiamare proprio te, sadicamente. Ecco perché ringraziai tutti i santi del Paradiso nel momento in cui il mio telefono prese a squillare. Normalmente mi sarei vergognata a morte di una dimenticanza del genere: finire in aula senza il silenzioso per poi disturbare la lezione era una cosa che avevo sempre evitato, eppure quel giorno fu una salvezza. Si svolse tutto così velocemente che a malapena me ne accorsi: semplicemente distolsi lo sguardo dal viso paonazzo di rabbia del professor Fisher e lessi sul display il nome di Stiles. Poi mi misi in piedi alla velocità della luce e mormorando un: «Mi scusi» sincero, sgusciai fuori dall’aula. Non so cosa successe dopo – se il professore fece commenti o se mi beccai una nota di demerito – perché corsi via così velocemente da addirittura sentire le gambe indolenzite e non mi fermai finché la suoneria del mio cellulare non fece altrettanto, permettendomi di riprendere fiato solo nelle vicinanze della palestra. A quel punto pensai che avrei dovuto approfittarne per richiamare Stiles, ma non ne ebbi il tempo. Un messaggio da parte di Scott m’inchiodò sul posto con due sole semplici parole: Presidenza. Subito. E allora non feci altro che ubbidire. «Il padre di Isaac è morto. Isaac è uno dei sospettati». Non è stato lui. «Non possiamo saperlo, Harry. Ma dobbiamo aiutarlo comunque. Isaac è un licantropo». Non ci credo. «Derek l’ha trasformato. Se anche non ha ucciso il padre, potrebbe compiere un omicidio stanotte. Con la luna piena». Allison si schiarì la gola rumorosamente e solo allora mi riscossi, gli occhi lucidi e stanchi perché li avevo tenuti fissi nel buio sconfinato della notte, e la gola secca. La osservai distrattamente mentre mi puntava addosso le sue iridi color cioccolato e mi riservava un cenno del capo che recepii a malapena, persa nei miei pensieri com’ero. Tutta quella situazione aveva dell’assurdo. Isaac era un licantropo. Il ragazzino timido e spaventato col quale avevo conversato allegramente quella mattina stessa, l’orfano che aveva denunciato una sparizione di resti dal cimitero di Beacon Hills e che Stephen aveva interrogato proprio a tal proposito. Era un licantropo, anche lui. E gli Argent – non tutti – lo volevano morto. «Sei pronta?», sibilò Allison, riguadagnandosi almeno un po’ della mia attenzione. A quella domanda, non potei far altro che annuire. Sapevo cosa ci aspettava e cosa avrei dovuto fare. Lo sapevo perfettamente ed ero consapevole che quella fosse la cosa giusta. Ecco perché quando Allison prese la rincorsa verso l’altro lato della strada deserta, facendo scivolare gli anfibi neri sull’asfalto bagnato dalla pioggia che in quei giorni stava tenendo sotto assedio Beacon Hills, la seguii velocemente senza nemmeno pensarci un po’ su. Dall’angolino appartato dall’altro lato della strada, ci fermammo ad osservare un uomo vestito da vicesceriffo mentre scendeva giù dalla sua Toyota nera per esaminare le gomme, bucate da delle frecce scoccate perfettamente proprio da Allison. Da un po’ di tempo a quella parte si stava allenando duramente con l’arco, e i risultati si vedevano. Quell’uomo lavorava per gli Argent e il nostro obiettivo era quello di rallentarlo cosicché potessimo giungere ad Isaac per primi. Ecco perché Allison, dopo aver preso l’ultima briciola di coraggio indispensabile ad agire, si sporse dal muro dietro il quale ci nascondevamo in due e puntò l’arco verso il finto vicesceriffo. Trattenne il respiro qualche secondo e poi scoccò la sua freccia, nessuna traccia di rimorso in vista sul viso dalla pelle chiarissima. Sapeva che fosse la cosa giusta da fare e non se ne pentiva, proprio come me, che non ebbi alcuna reazione di fronte all’urlo di dolore che l’uomo emise nel momento in cui la freccia di Allison gli perforò una coscia. La cosa avrebbe dovuto terrorizzarmi – il non sentire niente – eppure non mi preoccupai affatto. Avevamo vinto quella battaglia e non c’era nient’altro di cui avessi bisogno. Allison la pensava esattamente come me, anche se evitò di dirlo. Semplicemente sorrise e poi si defilò nel buio della notte, seguita da me che oramai ero divenuta la sua ombra. Raggiungemmo l’auto che Chris e Victoria le avevano regalato per il suo sedicesimo compleanno e solo una volta all’interno telefonammo a Stiles, rassicurandolo. Andava tutto bene. Almeno fino a quel momento. Ero ancora immersa nel mio speciale limbo d’indifferenza quando raggiungemmo la desolata casa Lahey. Sapevo che ci avremmo trovato Scott – eravamo lì proprio per lui – e preferivo non pensare a ciò che avrei visto. Il mio amico dal viso trasfigurato, schiavo di istinti che a causa della luna piena non riusciva a sopprimere. Continuai a scacciare simili pensieri finché non ci ritrovammo all’interno di un’angusta e buia cantina, piena zeppa di oggetti vecchi e inutili, tutti contornati da un fastidioso velo di polvere. Ma quando le iridi giallo brillante di Scott si specchiarono nelle mie e potei osservare di sottecchi i canini sporgenti dalle sue labbra chiare, allora capii di non poter più scappare. Dovevo affrontare quella verità divenuta pesante tutt’a un tratto: ecco perché sostenni il suo sguardo finché lui stesso non interruppe il contatto visivo, concentrandosi su Allison. Istintivamente feci altrettanto, osservandola mentre s’inginocchiava di fronte a Scott, un solo borsone nero a dividerli. «Sei sicuro che sia l’unico modo?», la sentii domandargli con voce flebile, mentre trafficava con le catene all’interno del borsone. Scott ringhiò una risposta, poi voltò lo sguardo verso il buio alla sua sinistra. Curiosa, puntai la luce della torcia proprio lì e lo spavento che mi provocò ciò che vidi – o meglio, chi – per poco non me la fece scivolare tra le mani. Derek Hale era lì, le gambe lievemente divaricate e le mani infossate nelle tasche dei jeans. Non lo vedevo da quelli che mi sembravano secoli. Non mi feci domande, ma le risposte arrivarono comunque. Capii infatti che Scott non alludesse a Derek, ma al vecchio congelatore nelle sue vicinanze. Voleva che Allison lo incatenasse lì dentro, e la sola vista di Scott che vi si calava a sedere come se nulla fosse mi strinse il cuore così forte che per un attimo sentii il respiro mancarmi. Fu allora che mormorai delle scuse nemmeno troppo convinte e decisi che sì, dovevo scappare. Risalii i gradini in legno con gambe traballanti e mi permisi di liberare un sospiro solo quando credetti di essere sola. Ecco, appunto: credetti. «Che ti è preso?», mi domandò la voce ormai familiare di Derek, e d’istinto sobbalzai, voltandomi a fronteggiarlo alla velocità della luce. Sapevo che non l’avrebbe mai ammesso, ma era preoccupato per me. Me lo dicevano i suoi occhi, il tono di voce e la camminata che stava tenendo per seguirmi all’interno della piccola dimora Lahey. Ecco perché provai a tranquillizzarmi, regolarizzando respiro e battito cardiaco prima di parlare. «Come fai ad essere così tranquillo?», chiesi, sperando di distogliere la sua attenzione dalle inutili preoccupazioni che nutriva nei miei confronti – anche se decideva di non mostrarle. Quando lo vidi scrollare le spalle, capii di aver “vinto”. «Gli alpha hanno un maggiore autocontrollo», spiegò, avvicinandosi a me. «Anche durante la luna piena». Aveva capito subito che mi riferissi a quello e non avevo nient’altro da chiedergli al riguardo, ecco perché incrociai le braccia al petto e gli diedi le spalle, rivolgendo lo sguardo proprio alla tonda e brillante luna, alta nel cielo nero puntellato di stelle. Me ne rimasi in silenzio per un po’, lasciandomi trasportare ancora dal filo dei miei pensieri finché una domanda non si presentò insistente a farmi visita. «Credi che Isaac sia colpevole?». La pronunciai a voce alta, porgendola a Derek perché io non sapevo darmi risposta. Non potevo vederlo in viso, ma qualcosa mi comunicò che fosse intento a scuotere la testa. «Nient’affatto», mormorò, avvalorando la mia tesi. «Io so che è innocente. Lo sa anche Scott, grazie ai suoi sensi. Ma la polizia non la penserebbe altrettanto se dovesse visitare questa casa». Istintivamente aggrottai le sopracciglia. Distolsi lo sguardo dalla finestra e sciolsi la morsa soffocante in cui avevo tenuto le braccia fino a quel momento. Osservai Derek con la stessa espressione di confusione comparsa a farmi visita nel momento in cui aveva smesso di parlare. Cos’aveva casa Lahey che non andava? Lo chiesi subito a Derek. E: «Non c’è niente che io possa dire per certo», mi rispose lui, scrollando le spalle prima di riprendere a parlare. «Ma scommetto che nel profondo, i tuoi sospetti sono simili ai miei. E che i lividi di Isaac non hanno fatto altro che avvalorare la tua tesi». Subito sentii una specie di peso morto cadermi nel petto e appesantirlo così tanto che di nuovo, nel giro di pochi minuti, avvertii il respiro mancarmi e fui costretta a sgranare le labbra per guadagnarne almeno un po’. Un pizzicore piuttosto familiare m’infastidì gli occhi, che avvertivo già umidi e pronti a liberare delle lacrime più di disgusto che di dispiacere. I miei sospetti erano fondati. John Lahey maltrattava suo figlio. «C’erano…», pigolai interi attimi dopo, ma la voce mi venne a mancare e interruppi quella domanda, schiarendomi la gola prima di riprendere. «segni di lotta? Qui?». Negli occhi verdi di Derek passò un’ombra indecifrabile. Non capivo cosa avesse, ma ancora una volta pensai che fosse “semplicemente” preoccupato per me. La cosa mi mise più a disagio di quanto mi sarei mai aspettata. Derek annuì, distogliendomi dai miei pensieri. Poi mi donò la risposta che desideravo. «Di sotto specialmente. Il congelatore in cui si è fatto calare Scott è pieno di graffi, incrostati di sangue. Pare non sia il primo ad occuparlo». A quelle parole, un fiotto di bile tentò di risalirmi in gola, ma lo scacciai via con successo. «E qui in cucina c’erano bicchieri e piatti rotti, dappertutto. Me ne sono liberato». Ben fatto, avrei voluto dirgli. Ma non ne trovai la forza. Perciò portai avanti l’argomento principale, seppur a fatica. «Dobbiamo far sparire anche il congelatore. Se la polizia lo trovasse, avrebbero un movente servito su un piatto d’argento e per Isaac non ci sarebbe più via d’uscita», mormorai flebilmente, con grosse pause tra una parola e l’altra. Derek si rese perfettamente conto del mio immenso sforzo, ma non fece nulla per farmelo notare né pesare. Semplicemente, annuì non appena finii di parlare. «Me ne occuperò non appena la luna piena sarà passata», rassicurò, e prima ancora che potessi aggiungere qualcos’altro, il mio cellulare prese a squillare dal fondo della borsa. Mi feci lontana da Derek quanto bastava a nascondergli le mie mani tremanti intente a recuperarlo, poi un senso di sollievo prese possesso di me nel momento in cui lessi sul display il nome di Stiles. «Ehi…», non potei fare a meno di sospirare non appena ebbi risposto, giusto un attimo prima che Stiles mi sommergesse con i vari: «Come stai?» e «Tutto bene?» concitati. Cercai di rassicurarlo nel modo più convincente che potei, ma non riuscii a raggiungere il mio obbiettivo, tanto che dopo un lungo silenzio Stiles si risolse a chiedermi: «Vuoi che ti venga a prendere?». Avevo bisogno di lui e come al solito, l’aveva capito. «Sì». Ti prego. Quando Austin ci riservava una delle sue solite seratine noiose, io e Danielle decidevamo puntualmente di scampare alla noia comportandoci da perfette cretine. Ci divertivamo così ed andava bene: eravamo capaci di passare serate intere ridendo a crepapelle per immense stupidaggini, salutare persone che con conoscevamo solo per il gusto di sorbirci poi le loro occhiatine confuse oppure giocare al gioco di “indovina che vita”. Praticamente, prendevamo di mira una persona alla volta e da un solo sguardo provavamo ad indovinare che lavoro facesse, se fosse ricco o povero, se avesse figli o meno, ecc. Per l’appunto, provavamo ad indovinarne la vita. Fu esattamente ciò che mi ritrovai a fare quella sera, stravaccata nel sedile che fino a pochi minuti prima aveva occupato Derek. Stiles era venuto a prendermi a casa Lahey perché insieme ci dirigessimo alla centrale di polizia e anche se non so ancora spiegarmi perché, avevo chiesto a Derek di accompagnarci. Lui aveva acconsentito, occupando il posto di fianco a Stiles nel quale ero prontamente sgusciata io nel momento in cui li avevo visti scendere entrambi. Il piano era quello di aprire la cella di Isaac per liberarlo. Per riuscirci, Stiles avrebbe dovuto procurarsi la chiave, tenuta insieme alle altre nell’ufficio di Stephen, in una cassetta di sicurezza. All’entrata c’era una donna di colore intenta a sorvegliare i movimenti di ognuno: Stiles non poteva raggiungere l’ufficio del padre senza eluderne l’attenzione, ecco perché l’aiuto di Derek si era rivelato opportuno. Avevo osservato proprio lui poggiarsi contro il bancone in modo fintamente rilassato mentre distraeva con chiacchiere futili la bella donna; in realtà non era per nulla a suo agio nel fare amicizia e me lo comunicarono perfettamente le spalle tese sotto la giacca in pelle nera. Il passo concitato di una ragazzetta dai lunghi boccoli scuri attirò la mia attenzione e allora le rivolsi uno sguardo, decidendo che per evitare una spiacevole morte provocata dall’infinita noia avrei ripreso a giocare ad “indovina che vita”. Né Derek né Stiles avevano voluto che li seguissi all’interno della centrale, un po’ per non destare sospetti e un po’ perché avevano bisogno di qualcuno che facesse da palo all’esterno e che potesse tenere la situazione sott’occhio proprio da lì. Ecco perché avevo acconsentito senza fare troppe storie, anche se mi stavo annoiando a morte. La ragazzina aumentò il ritmo dei suoi passi prima di sorpassare la Jeep e sparire dal mio campo visivo e allora mi misi all’opera, costruendo congetture su quanti anni avesse, che scuola frequentasse, se fosse fidanzata e cose così. Tuttavia, quella volta non trovai una soluzione al gioco né esso riuscì a portarmi il suo solito divertimento. Al contrario m’immobilizzai con gli occhi fissi in un punto morto nel momento in cui realizzai la terribile somiglianza che legava quella sconosciuta ad Allison. Quel nome fece scattare un sonoro campanello d’allarme nella mia mente. Come stava? Era ancora sola con Scott? Col trasformato Scott? Dal momento che l’avevo lasciata a casa Lahey per seguire Derek e Stiles non potevo saperlo, ma sperai comunque che stesse andando tutto per il meglio mentre mi stringevo un po’ più forte nel cappotto a quadri. Credetti di aver raggiunto una nuova forma di tranquillità diversi – e noiosi – attimi dopo, ma capii immediatamente che suddetta sensazione non sarebbe durata poi molto nel momento in cui il suono della campana d’allarme proveniente dalla centrale cominciò a rimbombarmi nelle orecchie seguito dal mio cuore palpitante, che prese a battere così forte che temetti mi sarebbe scoppiato nel petto da un momento all’altro. Di fronte a quel vero campanello d’allarme non me lo feci ripetere due volte: feci pressione sulla maniglia dello sportello quel tanto che bastava ad aprirlo e poi sgusciai fuori dalla Jeep azzurro cielo, preoccupandomi a malapena di richiudermi lo sportello alle spalle con un tonfo leggero. Corsi così forte in direzione della centrale di polizia che sentii quasi il cuore risalirmi in gola, ancora più che intento a battere furiosamente, in preda all’ansia e alla paura. Ancora non so come ci riuscii, ma raggiunsi Stiles in relativamente poco tempo. Sì, Stiles, perché era di lui maggiormente che mi preoccupavo. Sapevo che Derek se la sarebbe cavata benissimo anche da solo e me lo confermò il vederlo piuttosto tranquillo di fronte ad un Isaac dal viso trasfigurato pronto a dirigersi verso Stiles, accasciato sul pavimento verde bottiglia della centrale. Terrorizzata, provai il tremendo impulso di urlare, ma prima ancora che potessi riuscirci Derek schiacciò sotto la suola delle scarpe una grande siringa in vetro e poi liberò un ringhio potentissimo, gli occhi rossi brillanti e i canini bene in vista. La risposta di Isaac non si fece attendere: da mostro desideroso di uccidere si trasformò immediatamente in cucciolino smarrito e lo osservai accucciarsi sul pavimento con la testa nascosta tra le mani mentre un improvviso moto di tenerezza prendeva possesso di me. Era quello il potere di un alpha? Me lo chiesi a lungo, lo sguardo terrorizzato ancora puntato sull’ampia schiena di Derek. Continuai così finché Stiles non parlò, attirando nuovamente la mia attenzione su di sé. «Come hai fatto?», boccheggiò, scoccando un’occhiatina nella direzione di un Isaac dal viso sudato e dagli occhi nuovamente azzurri e tristi. «Sono un alpha», furono le uniche parole che si lasciò sfuggire Derek, ancora tranquillo proprio come se nulla fosse successo. E allora non potei far altro che annuire. Era un alpha e si vedeva. Tuttavia, ciò non attenuava affatto la mia immensa confusione. All my life I’ve been good but now,
oh – I’m thinking: “What the Hell?”.
Ringraziamenti Mi aspettavo un'accoglienza diversa per questo sequel, è inutile negarlo, ma probabilmente è stata colpa mia dato che ho fatto trascorrere troppo tempo tra questo e parachute. Pazienza. Ringrazio comunque gilraen_white che è stata tanto buona da lasciarmi due parole sul primo capitolo, e anche chiunque abbia inserito la storia tra le seguite. Spero possa piacervi quanto e più del prequel. D'ora in poi (almeno finché avrò capitoli pronti) gli aggiornamenti avverranno ogni domenica. Note La canzone citata/titolo è quella di Avril Lavigne, What the Hell?. Ci tengo a specificare che – nemmeno in questo caso – tutta la canzone è collegata al capitolo, proprio come non lo era Sirens in quello scorso. Semplicemente la frase citata mi è sembrata adatta ed eccola qui. |
Capitolo 3
*** Hero ***
Da parachute: Davo le spalle a Derek, quando gli risposi, e capii che non avrei potuto far di meglio di così.
«Lo trasformerai», spiegai, posando i gomiti sulle ginocchia scoperte e infreddolite mentre intrecciavo le dita delle mani. «Adesso ne hai il potere, no? Il tuo obbiettivo è sempre stato questo, fin dall’inizio». […] «L’obbiettivo era vendicare mia sorella […]. Aiutare Scott [...]. E proteggere te […]. Io ti conosco, Harriet […]. La mia famiglia e la tua sono sempre state al comando di Beacon Hills. Certo, c’erano anche altri rappresentanti della società, come famiglie di cacciatori e di altri esseri soprannaturali, ma principalmente tutto il potere scorreva nelle nostre mani. Questo finché non abbiamo sfiorato il declino. Tuo padre ha lasciato la famiglia senza un erede che potesse prenderne il comando e gli Hale sono stati decimati nell’incendio di sei anni fa. Potrebbe sembrare strano, ma le nostre disgrazie ci hanno uniti ancor di più. Ecco perché quando Thomas mi ha chiesto di aiutarlo a portarti qui e riprendere potere su Beacon Hills, io ho acconsentito». Credevo avrebbe continuato a parlare e raccontare, ma poi capii non ci fosse nient’altro da aggiungere e conclusi con l’aprirmi in un sorrisino beffardo. Cercavo inutilmente di nascondere la mia delusione. «Alla fine è sempre quello il punto. Potere», osservai, con una nota ben evidente d’amarezza nella voce. Ancora una volta, Derek ignorò la mia battuta […]. kaleidoscope
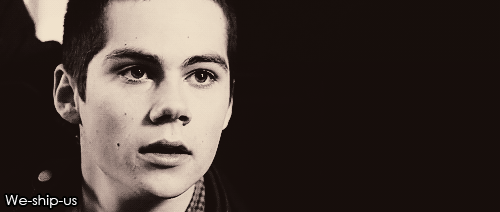 3. Hero
Non avrei mai pensato di poter dire una cosa del genere, ma educazione fisica poteva essere una bella materia. Bastava semplicemente prenderla per il verso giusto, ritrovarsi un insegnante “fantasioso” tanto quanto Finstock ed evitare esercizi imbarazzanti e/o impossibili perché tutto filasse liscio come l’olio. L’avevo scoperto da quando mi ero trasferita a Beacon Hills, comprendendo con mia grande sorpresa che il problema alla base del mio odio viscerale e a momenti immotivato verso educazione fisica nascesse direttamente dai miei professori: gente che non aveva mai fatto sul serio il suo lavoro, limitandosi a costringere le classi a due o tre inutili giri di corsa prima di lunghissime partite di pallavolo alle quali dovevi partecipare obbligatoriamente se non volevi ritrovarti con un debito al secondo quadrimestre. E lo sanno tutti che io odio la pallavolo. Finstock era diverso. Si occupava maggiormente di lacrosse, certo – perché quella era la sua grande passione – ma quando si trattava di dover fare lezione con l’intera classe, la faceva sempre nel migliore dei modi. E, non osavo dirlo ad alta voce, ma credevo di adorare le sue lezioni di educazione fisica. Erano stancanti, sì, ma anche divertenti e sempre innovative. Mai una volta avevamo fatto gli stessi esercizi, cosicché l’attenzione fosse sempre alta e di conseguenza anche la voglia di fare movimento. Mentre mi dirigevo in spogliatoio quel sabato mattina, mi chiesi proprio cosa ci avrebbe riservato quel giorno. «Ehi, Als», mormorai all’improvviso, voltandomi alle mie spalle solo per inquadrare la figura di Allison, intenta a seguirmi in assoluto silenzio. La sera prima non l’avevo più vista e fino a quel momento mi era sembrata piuttosto pallida e preoccupata, ma avevo scelto di non preoccuparmi anche per lei. Voltandomi a guardarla in quel momento, però, qualcosa mi disse che avevo profondamente sbagliato. «Va tutto bene?», le domandai già all’erta, spingendo verso il basso la maniglia d’ottone dell’ingresso perché potessimo entrare anche noi nello spogliatoio femminile del liceo. Al suono di quelle mie parole, Allison si riscosse, seguendomi all’interno mentre annuiva convulsamente. «Sì, sì», mi rassicurò, per nulla convincente. «Sono solo un po’ pensierosa». Prese posto di fianco ad un paio di borse color prugna ed io l’affiancai, posando le mie accanto a lei. Poi mi liberai della felpa pesante, lasciandola sull’attaccapanni. Alcune delle nostre compagne di classe erano lì in spogliatoio, ma nessuna ci prestava particolarmente attenzione: erano tutte intente a chiacchierare le une con le altre di cose come al solito frivole e non facevano niente per includere né me né Allison. Eravamo ancora “quelle nuove” e lo saremmo rimaste a lungo. «A cosa pensi?», chiesi, prendendo posto di fianco ad Allison subito dopo aver sospirato sommessamente. Recuperai il vecchio paio di Converse che utilizzavo per educazione fisica dalla borsa, poi mi liberai delle scarpe che indossavo e del jeans scuro. Allison nel frattempo aveva tirato fuori la tuta che avrebbe messo di lì a poco, sempre in assoluto silenzio. Quando cominciai ad infilare i miei leggins sportivi, però, decise di parlarmi. «Ieri a casa di Isaac è successa una cosa strana», raccontò con voce strozzata, liberandosi della maglia e cambiandola velocemente col top bianco che le avevo di già visto indossare in occasioni come quella. «Ho visto una cosa strana». Aggrottai le sopracciglia, liberandomi a mia volta della t-shirt che avevo indossato quel giorno. Quel cambiamento repentino mi fece rabbrividire per il freddo e la pelle nuda del mio ventre e delle mie braccia si riempì immediatamente di pelle d’oca, tanto che anch’io mi affrettai ad indossare il crop top fuxia che avevo scelto per quel giorno. «Cosa hai visto?», domandai ad Allison, senza guardarla in viso perché troppo impegnata ad allacciarmi le Converse. «Una… creatura». Non chiedetemi perché, ma la cosa non mi stupì affatto. Oramai era una cosa “normale”, per me, che la gente vedesse creature. «Un altro licantropo», mormorai dunque, tranquilla perché nessuno stesse ascoltando la nostra conversazione. «No! No. Non si trattava di un licantropo», esclamò Allison mettendosi in piedi velocemente, mentre dentro di me un nuovo moto d’agitazione cominciava a crescere. «Aveva la coda». «La...».
Provai a ripetere, ma la voce mi venne a mancare, proprio come il respiro.
«Già», assentì Allison, annuendo debolmente poco prima di stringersi le braccia al petto. Una nuova creatura. Un essere dotato di coda. Assurdo. Sempre di più. «Anche Scott l’ha vista?», domandai dopo qualche minuto, cercando disperatamente di recuperare la mia lucidità persa. «Sì, era con me». «E non ha idea di cosa possa essere?». «No», sussurrò Allison, sciogliendo la morsa nella quale aveva tenuto strette le braccia fino a quel momento solo per raggiungermi nuovamente sulla panca. Si lasciò sedere di fianco a me mentre liberava una scomoda verità: «Siamo tutti così poco esperti…». E la cosa, prima o poi, ci si rivolterà contro. «Andiamo, voi due. Stilinski, Reyes. Alla parete». Il “muro” – così decisi che l’avrei chiamato – era ciò che avremmo dovuto affrontare quel giorno durante l’ennesima lezione di educazione fisica in compagnia del professor Finstock. Non c’era stato bisogno che ce lo dicesse perché la cosa era a dir poco evidente: eccetto quel muro montato chissà quando, la palestra era completamente vuota e priva di attrezzi. Non c’erano step né coni né tappetini da esercizio: solo quella parete che, Finstock lo confermò solo in seguito, ci saremmo allenati a scalare. Se non fosse stato per le funi di sicurezza alle quali avremmo potuto affidarci durante l’esercizio, avrei già dato di matto data la mia più che evidente paura dell’altezza, ma sapendo delle precauzioni che Finstock s’era assicurato di avere, non potevo far altro che aspettare con impazienza il mio turno alla parete. Allison e Scott c’erano già saliti – divertendosi un sacco come al solito – mentre allora toccava a Stiles ed Erica, una biondina che proprio non conoscevo. Prima che Stiles potesse allontanarsi del tutto da me gli dedicai un sorriso, poi spostai gli occhi sulla piccola figura di Erica. Non credevo di aver avuto lezioni con lei prima di quel mattino, ma c’era anche da dire che una persona così silenziosa e timida sarebbe facilmente potuta passare inosservata, dunque non esclusi da principio l’idea di averla già vista. Piuttosto me ne rimasi a fissarla mentre incespicava sulle varie sporgenze della parete: sembrava così disperata che improvvisamente il cuore mi si strinse in una morsa. Perché non avanzava? Stiles aveva già compiuto il cammino due volte mentre lei aveva percorso a malapena un metro. Quando avvertii dei lamenti sommessi abbandonarle le labbra, cominciai seriamente a preoccuparmi. Ma mi bastò voltare velocemente lo sguardo attorno a me perché l’idea di attirare l’attenzione di qualcuno mi abbandonasse alla velocità della luce. Erano tutti distratti, nessuno escluso. Intenti a chiacchierare tra di loro o a battibeccare scherzosamente come Allison e Scott. Preoccupati da inesistenti doppie punte come Lydia o lontani da tutto e tutti come lo era Jackson, che mi persi ad osservare più a lungo degli altri perché il suo stare completamente in disparte – anche se non avrei dovuto – mi preoccupò. Quando però i lamenti di Erica si trasformarono in sonori gemiti, non potei far altro che ritornare con gli occhi su di lei, ancora ferma dove l’avevo lasciata e soprattutto scossa da tremiti incontrollabili. Per fortuna non ci fu bisogno che attirassi io l’attenzione di Finstock e degli altri perché essi stessi si mossero verso la parete quel tanto che bastava ad accerchiare Erica nel modo meno soffocante possibile. La sentivo ancora piangere sommessamente, ma non c’era nulla che potessi fare per aiutarla. «Erica? Stai bene?», la richiamò il coach con un tono di voce parecchio titubante, muovendo un ulteriore passo nella sua direzione. «Soffri di vertigini?». «Le vertigini sono una disfunzione all’interno dell’apparato vestibolare. Il suo è solo panico», commentò Lydia, facendosi avanti immediatamente di fronte all’intervento scorretto del nostro professore. Certe volte i suoi modi di porsi mi facevano venir voglia di schiaffeggiarla – nonostante quanto le potessi voler bene o essere preoccupata per lei e per ciò che le stava capitando in quell’ultimo periodo – ma quello non era affatto il momento giusto perché discutessimo, perciò mi limitai a scoccarle un’occhiata infastidita alla quale lei rispose con una smorfia. «Erica?», chiamò ancora il prof, senza perdersi d’animo. Erica ancora tremava dall’“alto” della sua posizione, ma si sforzò comunque di balbettare uno: «S-Sto bene» per nulla convinto. «Coach, è pericoloso. Lei soffre di epilessia», mormorò Allison allora, e quella nuova scoperta fece ritornare a galla uno dei tanti ricordi sfocati che avevo collezionato da quand’ero lì a Beacon Hills. Conoscevo già Erica e tutte le mie sensazioni a riguardo furono confermate: avevo sentito parlare di lei e del video nel quale l’avevano inclusa senza che lei lo sapesse, riprendendola durante una delle sue crisi peggiori. I tre quarti della Beacon Hills High School aveva visto quel filmato divenuto virale e alla cosa era succeduta una vera e propria catastrofe con la quale io – per fortuna – non avevo nulla a che fare. «Perché mai non lo sapevo? Epilessia!», sbottò il prof a denti stretti, cercando inutilmente di non farsi sentire dalla diretta interessata. «Erica, va tutto bene. Devi… devi saltare giù dalla parete. C’è un tappeto, qui per terra. Coraggio», la invogliò, riportando l’attenzione su di lei e aspettando con impazienza che Erica ubbidisse senza ulteriori problemi. La guardai tremare qualche attimo ancora, poi socchiuse gli occhi e semplicemente si lasciò andare all’indietro, atterrando coi piedi traballanti sul materassino nero posizionato sul pavimento in parquet chiaro. Nel vederla giù dalla parete, Finstock tirò un sospiro di sollievo, aprendosi poi in un: «Non è successo niente, hai visto? Stai benissimo» al quale Erica nemmeno si sforzò di rispondere. Semplicemente si liberò delle funi di sicurezza e poi sgusciò via dalla folla di persone strette intorno a lei ma totalmente disinteressate alla sua condizione. Non guardò nessuno in faccia anche se sentiva addosso gli occhi di tutti: semplicemente sparì, lasciandosi dietro una scia non indifferente di risatine sarcastiche per cui nessuno venne – vergognosamente – punito. Finstock aveva mentito: Erica non stava bene, affatto. E anche se così fosse stato, sapevo che la cosa non sarebbe comunque durata a lungo. «Stiles?».
Al terzo richiamo, il diretto interessato si premurò di distogliere lo sguardo dal punto indecifrabile che aveva fissato con parecchia insistenza fino a quel momento e mi rivolse un’occhiata frettolosa, ancora completamente distratto. Era perso nei suoi pensieri e si vedeva, ma ci tenevo a sapere cosa mai potesse preoccuparlo così tanto nella solita fila di bici parcheggiate davanti scuola. Ecco cosa gli chiesi mentre insieme ci dirigevamo verso l’ingresso della Beacon Hills High School, lui con la cartella grigia in spalla ed io con solo un paio di libri tra le mani.
«Isaac parcheggiava sempre lì la sua bici», mi spiegò Stiles all’improvviso, indicandomi con un dito il punto in cui aveva guardato finché non l’avevo distolto dalla sua “trance”. Osservai più attentamente e difatti notai un posto vuoto tra i tanti occupati. Il pensiero di Isaac tornò ad angosciarmi più forte che mai ed immediatamente mi chiesi se stesse bene. Avrei tanto voluto saperlo, ma sentivo che Stiles non mi avrebbe molto facilmente dato le risposte che volevo, perciò decisi che avrei preso la cosa molto alla larga nell’attesa di vedere dove saremmo finiti. «È assente, oggi?», domandai dunque, riportando i miei occhi scuri sul viso di Stiles. Lui si limitò a fare spallucce, poi proseguì in direzione della porta. Camminava lentamente, rilassato: non eravamo affatto in ritardo e potevamo assolutamente prendercela comoda e chiacchierare ancora un po’. «Sparito nel nulla, più che altro. Ieri Finstock lo cercava», raccontò con invidiabile nonchalance. «Non mi stupirei se fosse di nuovo nei guai». Se io ero preoccupata, Stiles al contrario era del tutto spensierato. Inconsapevolmente mi ritrovai ad invidiarlo. «Quindi non sai dov’è?», chiesi, desiderando di non aver mai parlato non appena quelle parole mi abbandonarono le labbra. Ahia, pensai, cercando inutilmente di nascondere un’espressione eloquente. Non ero riuscita nel mio intento di nascondere la preoccupazione che provavo nei confronti di Isaac, difatti Stiles la notò e sollevò un sopracciglio con aria scettica e anche vagamente infastidita.
«Perché dovrei?», borbottò poi, distogliendo lo sguardo dal mio viso solo per cercare – con scarsi risultati – di nascondermi un broncio tenerissimo.
Quella era la mia occasione per salvarmi in calcio d’angolo e ovviamente non me la sarei lasciata scappare. «Non so!», trillai, tradendo immensa agitazione mentre mi perdevo a gesticolare furiosamente ed arrancare dietro Stiles – che, vagamente offeso, aveva accelerato il passo e se ne fregava delle mie gambe corte. «Pensavo fosse nostro amico. In fondo l’abbiamo salvato dagli Argent». Conclusi la mia filippica con un tono di voce lieve e – speravo – convincentemente dispiaciuto. Quando Stiles arrestò il passo, credetti sul serio di essere riuscita nell’intento, ma la sua espressione tesa mi liberò subito di quella speranza vana. «Appunto, la nostra parte l’abbiamo fatta. Non è più un problema nostro», furono le uniche parole che mi rivolse, serissimo in volto. Inutile dire che mi infastidirono e non poco. Non era più un problema nostro? Da quando in qua agivamo solo per fini personali? «Quindi è un problema di Derek, adesso? Credi davvero che se ne occuperà?», non potei fare a meno di domandargli, muovendo passi nella sua direzione quanti ne bastavano a fronteggiarlo al meglio. «Per quel che ne sappiamo l’ha trasformato per puro divertimento!». Stiles, ancora tranquillissimo, si limitò a scrollare le spalle. Poi infossò le mani nelle tasche dei pantaloni chiari e disse: «Non lo so e non mi interessa. È superfluo preoccuparsi di cose che non ci riguardano minimamente. Dobbiamo pensare di più a noi stessi. È giusto così». Avrei voluto con tutta me stessa urlargli contro. Tuttavia qualcosa nelle sue parole mi spinse a considerare l’idea che non stesse dicendo delle complete assurdità come i fiumi della rabbia crescente volevano farmi credere a tutti i costi. Certo, non ero completamente d’accordo con lui e con l’idea di ignorare completamente i nostri compagni – be’, definire Isaac un amico sarebbe stato esagerato e fin qui c’arrivavo anche da sola – ma concordavo con lui sul fatto che avremmo dovuto un po’ di più pensare a noi stessi. Quanto tempo era che non lo facevo? «Forse hai ragione», ammisi perciò a bassa voce, chinando il capo mentre mi lasciavo sfuggire delle scuse vagamente dispiaciute. «Volevo solo sapere come stava Isaac». Ma adesso ho deposto l’ascia da guerra, pensai, nascondendo con scarsi risultati un sorrisino divertito. Non volevo discutere con Stiles per delle sciocchezze come quella, ma scoprii ahimè che lui non fosse dello stesso avviso. Difatti, qualsiasi mio tentativo di “tregua” andò bellamente a farsi benedire nel momento in cui lo vidi voltarmi le spalle proprio come se non ci fossi e riavviarsi verso scuola a passo spedito, tutto intento a sbuffare sonoramente e borbottare tra sé e sé. Ovviamente non ci vidi più dalla rabbia e mi affrettai a raggiungerlo, afferrandogli un braccio non appena mi fu possibile di modo che potessimo affrontarci faccia a faccia. «Si può sapere cosa diavolo hai?», gli urlai in pieno viso, attirando sulla mia figura parecchie paia di sguardi. Non diedi attenzione a nessuno, però, mentre Stiles si limitò a guardarsi intorno finché i soliti ficcanaso di turno non si furono quasi tutti dileguati. Alla fine si liberò della mia presa sul suo braccio con uno strattone e rispose alla mia domanda, parlando chissà perché a bassa voce. Mi sarei aspettata che mi rispondesse per le rime e invece quella volta mi sembrò lui quello tra i due alla ricerca di tregua. «Nulla!», parlò tra i denti, facendosi così vicino a me che potei osservare bene ogni particolare del suo viso. «Solo che mi infastidisce vederti preoccupata per persone che non lo meritano affatto. Pensi sempre a tutti e ti metti all’ultimo posto, hai i nervi a fior di pelle e sembri nell’attesa costante di una catastrofe dalla quale non uscirai viva. Io vorrei solo che tu fossi tranquilla. Non dico felice, perché con tutto quello che dobbiamo affrontare ogni giorno la vedo un po’ dura, ma almeno spensierata. Perché te lo meriti, e mi dispiace non riuscire a fare nulla per aiutarti». Di fronte a quella dichiarazione non potei far altro che restarmene in completo silenzio a fissare Stiles con le labbra dischiuse e un’espressione stralunata. C’erano un sacco di cose che avrei voluto e dovuto dire, ma come al solito in quei casi qualcosa mi bloccò e non mi permise di dare libero sfogo alle mie emozioni. Perciò mi limitai semplicemente a sussurrare il nome di Stiles, allungando velocemente una mano nella sua direzione quando lo vidi indietreggiare all’improvviso. «Lascia perdere», m’interruppe, evitando che mi avvicinassi ulteriormente a lui. «Scusami, devo andare a lezione. Ci vediamo dopo». Era sparito dalla mia vista prima ancora che me ne rendessi sul serio conto. Entrai in caffetteria con lo sguardo basso, sperando invano che l’usuale folla di persone intente a riempirla durante l’ora di pranzo potesse coprire il mio ingresso e renderlo inosservato. Da ormai ore vivevo in quella condizione: glissavo i saluti di chiunque potesse volermi parlare, evitavo gli sguardi di tutti e preferivo non cercare la presenza di nessuno. La felice idea di comportarmi in quel modo non era venuta a me, ma a Stiles – che aveva finto che non esistessi fino a quel momento; io avevo semplicemente deciso di assecondarlo. Ecco perché quando osservai la caffetteria praticamente deserta non potei far altro che imprecare, allungando inutilmente il passo verso la mensa. Magari correndo avrei potuto afferrare qualcosa da mangiare al volo e poi sgattaiolare via ancora, senza dovermi invece fermare a tavola con Stiles e Scott – come da abitudine – rendendo il tutto molto ma molto imbarazzante. Purtroppo però le mie speranze erano vane, com’era chiaro che fosse. In una stanza desolata la mia figura frettolosa attirò infatti tutta l’attenzione di Scott, che presto chiamò il mio nome a gran voce mentre si sbracciava affinché lo vedessi. Scoprire che fosse solo al tavolo mi lasciò stupita: Stiles aveva avuto la mia stessa idea, per caso? Aveva saltato il pranzo solo per non dovermi vedere? E poi perché diavolo era così arrabbiato con me? Preoccupato okay, lo accettavo e capivo. Ma offeso a quella maniera? Quando presi posto di fianco a Scott non avevo trovato risposta nemmeno alla metà di quelle domande, anzi: nella mia mente se ne creavano sempre di nuove, facendo sì che fossi silenziosa e distratta tanto da non aver toccato il mio cibo nemmeno un po’. «Cos’hai?», sbottò Scott allora, riscuotendomi dalla fitta rete di pensieri capace di rendermi quasi apatica. Quasi sobbalzai al suono della sua voce, ma nulla in confronto a cosa sentii nell’individuare Stiles seduto a pochi tavoli dal nostro. La tranquillità che avevo provato nel vedere Scott solo svanì nel giro di un attimo: mi bastò realizzare che Stiles fosse lì in caffetteria e capire poi che avesse cambiato tavolo per me. Sapevo di non averne motivo, ma mi sentii comunque in colpa. «Non è nulla», cercai però di rassicurare Scott prima che mi trovasse intenta a bruciare con lo sguardo la schiena di Stiles, focalizzandomi al contrario sul pranzo ancora intatto. Ma la mia bugia non convinse affatto Scott, che si risolse a sbuffare sonoramente. «Sprizzi tensione da tutti i pori», spiegò poi, parlando con le sopracciglia sollevate. «E non offenderti, ma è fastidioso». Sospirai sconfitta. A volte quasi dimenticavo dei suoi superpoteri. «Ho… discusso con Stiles», ammisi a malincuore. Sapevo benissimo che Scott non mi avrebbe mai permesso di evitare l’argomento. «Riguardo a cosa?». Scrollai le spalle. «È semplicemente preoccupato per me». Intenta a giocare distrattamente col mio cibo, sentii a malapena Scott mugugnare qualcosa d’indefinito. Mentre aspettavo che riprendesse a parlare non potei fare a meno di riportare gli occhi sulla schiena di Stiles, sperando che Scott non avrebbe notato la cosa. Potevo senza problemi ammettere a me stessa di odiare quella nostra situazione da “separati in casa” e anche dirmi tranquillamente quanto Stiles mi mancasse – nonostante tutto – ma lasciare che anche Scott capisse mi avrebbe semplicemente fatta morire dall’imbarazzo. Ecco perché non appena lo sentii riprendere a parlare, subito portai i miei occhi nei suoi. «Quindi è per questo che vuole a tutti i costi distrarsi e divertirsi?», domandò, confuso proprio come lo diventai io immediatamente. Aggrottai le sopracciglia, non riuscendo proprio a capire cosa stesse dicendo. «Mi dispiace, Scott, non ti seguo», mormorai infatti, aspettando poi che mi desse spiegazioni. «Stiles vuole che andiamo a pattinare, stasera. Dice che ha bisogno assoluto di divertirsi. Ecco perché è lì a contrattare con Boyd da interi minuti», Scott indicò il tavolo che occupava Stiles e in seguito, il ragazzo di colore che gli sedeva di fronte, «Non ti ha detto nulla?». Deglutii. Non mi aveva rivolto la parola, come avrei potuto saperlo? Scott però non era a conoscenza di quel particolare ed io decisi di continuare a tenerlo all’oscuro della cosa. «No, non ne ero… non ne ero al corrente», balbettai, cercando però subito di ritrovare un contegno. «E comunque non mi sembra una cattiva idea. Non ti va di andare?». Scott si limitò a scuotere la testa, distogliendo lo sguardo dal mio viso poco prima di partire alla ricerca di parole adatte da dire. Io mi limitai ad aspettare, ascoltando il suo silenzio capace di mille parole. «No, penso che mi piacerebbe… ma non so se riuscirei a divertirmi. Con tutto quello che succede ultimamente…», tentò di spiegare poi, rendendo più chiaro ciò che di già sospettavo. Capivo benissimo come si sentisse, ecco perché decisi di non rigirare ulteriormente il coltello nella piaga e misi su un sorriso, convinta a sviare l’argomento “mille preoccupazioni del momento”. «Puoi sempre provarci, no?», domandai, e allora Scott provò a ricambiare il mio sorriso sincero. «Anche tu», aggiunse, lasciandomi senza parole. Sapevo che avesse ragione, ma sapevo anche che non avrei avuto la possibilità di seguire i suoi consigli: non quella volta. Non sapevo come spiegargli una cosa del genere, ecco perché mi limitai a boccheggiare finché la figura di Stiles non fu a due passi da me e finii con l’immobilizzarmi del tutto. In un’altra occasione avrei visto il suo arrivo come una vera e propria salvezza, in quel momento invece me ne rimasi a fissarlo in viso come la perfetta stupida che ero mentre lui faceva altrettanto senza proferire parola. Mi chiesi a lungo chi avrebbe posto fine a quel momento di stallo e trovai la mia risposta in Erica, o perlomeno in ciò che ne era rimasto di lei: della ragazzina timida e spaurita dell’ora di educazione fisica, quella che soffriva di epilessia e attacchi di panico, quella che andava in giro senza un filo di trucco e indossando abiti trasandati. La ragazza che fece il suo ingresso in caffetteria indossando un completo di pelle e vertiginosi tacchi a spillo, quella che si mosse ancheggiando e rifilando sorrisetti maliziosi a chiunque, non aveva niente della ragazza che avevo conosciuto appena il giorno prima. Eppure la riconoscemmo tutti comunque, rimanendo fermi a fissarla finché lei non se ne ritornò da dov’era venuta portando con sé gli sguardi persi di tutti. Ero ancora imbambolata e confusa quando Stiles e Scott decisero di seguirla verso chissà dove, ma i loro movimenti repentini mi risvegliarono presto dalla trance in cui ero caduta e perciò mi alzai in piedi anch’io per seguirli. Erica si mosse con estrema nonchalance fino all’entrata di scuola – sapeva di averci alle calcagna, ma quello non sembrava essere un problema per lei: sembrava al contrario che volesse essere seguita. Capii il perché quando si diresse verso una Camaro nera che ormai conoscevo fin troppo bene, prendendo posto di fianco a nientemeno che Derek Hale. Prima che andassero via, Derek ci sorrise, imitando Erica. Era felice: al suo esercito si era infatti aggiunto l’ennesimo soldatino. Avevo corso come non mai, tanto da sentirmi l’acido lattico nei polpacci e il cuore in gola. Ma non me ne curavo, anzi. Ero felice che quel dannato si agitasse tanto nella mia cassa toracica, facendo rimbombare dei battiti forsennati contro il silenzio spettrale della Riserva di Beacon Hills. C’ero tornata perché dovevo. Ormai tutto era collegato, ogni azione mi portava lì. Qualsiasi cosa andava ricongiunta a Derek. Non sapevo cosa gli fosse preso esattamente – perché all’improvviso stesse cambiando così tanto – ma ero certa di avercela con lui a morte. Non poteva semplicemente andarsene in giro a trasformare degli adolescenti in licantropi, come se poi fosse nulla e anzi, come se stesse facendo loro nient’altro che un regalo. Certo, la super-velocità e tutte le altre cose belle della licantropia – dubitavo che poi fossero così tante – potevano avere una certa attrattiva, ma l’altro piatto della bilancia era così colmo di cose brutte e pericoli che continuavo a chiedermi senza sosta perché mai Erica ed Isaac avessero accettato il morso senza farselo ripetere due volte. E non trovavo risposta sensata. Scott mi aveva detto che Derek non si sarebbe fermato tanto presto, che perché il suo branco fosse completo gli sarebbe servito almeno un altro beta, ma io avevo preferito non credergli. Mi ero finta sorda di fronte alle sue preoccupazioni, sentendomi una stupida ingenua nel momento in cui Stiles ci aveva fatto capire la verità: Boyd quel giorno era assente, Derek l’aveva trasformato. Finalmente il suo branco era degno di essere considerato tale. Ma io ancora stentavo ad accettarlo. Volevo che me lo dicesse lui, Derek, guardandomi negli occhi. Volevo che confessasse, che ammettesse la verità, che mi desse la conferma di quanto già da tempo sospettavo. Mi aveva detto solo un mucchio di cazzate per tenermi buona. E io gli avevo creduto. Ma era giunta l’ora di smontare quel teatrino, finalmente. Avrei affrontato Derek e risolto tutto. Ecco perché ero corsa a casa Hale, fingendo invece che me ne sarei rimasta al sicuro in casa dello sceriffo come mi aveva ordinato di fare Stiles. Ma non potevo starmene con le mani in mano – non più – non mentre sia lui che Scott si rendevano utili per Boyd, buttandosi alla ricerca di quest’ultimo. Dovevo contribuire anch’io, dovevo parlare col diretto responsabile. Derek. Quel nome mi fece sussultare, ma non quanto ciò che mi ritrovai di fronte. O meglio, chi mi ritrovai di fronte. Jackson Whittemore se ne stava fermo immobile di fronte alla porta d’ingresso dell’ormai distrutta casa Hale, alla ricerca di risposte che già sapevo nessuno gli avrebbe dato. Dovetti strizzare gli occhi più di una volta per convincermi del fatto che lui fosse sul serio lì, a pochissimi passi da me, dove meno mi sarei aspettata di poterlo trovare. Poi la verità mi colpì con violenza ed io scappai letteralmente a nascondermi dietro un grosso albero nel momento stesso in cui la porta di legno bruciato si aprì di fronte a Jackson, rivelando nient’altro che le figure minacciose di due uomini armati. Cacciatori, realizzai immediatamente, ancor prima di vedere anche Chris Argent in quella casa, col suo solito sorriso minaccioso in volto. Le mie paure divennero tutte immediatamente realtà e allora non potei far altro che scappare, come al solito, mentre tentavo di ricacciare indietro un urlo di terrore e non cadere nel bel mezzo di una foresta che nonostante tutto ancora conoscevo poco. Corsi ancora una volta, senza meta almeno finché non realizzai di dover raggiungere Scott alla pista di pattinaggio dove sapevamo tutti lavorasse Boyd. Avevo bisogno di qualcuno, di una presenza amica, e sapevo bene che in quel momento fosse McCall l’unico su cui potessi contare sul serio. Stiles era a casa di Boyd, solo, ed io non avevo idea di dove fosse. Ma sapevo dov’era la pista di pattinaggio di Beacon Hills e mi ci diressi come se all’improvviso ne dipendesse della mia stessa vita, sempre più convinta del fatto che fossi nient’altro che una ragazzina debole che aveva bisogno di continuo aiuto e compagnia. Ciò che mi ritrovai di fronte sulla pista di ghiaccio non fece altro che confermare tutte le mie supposizioni.
«Ma non capite? Non lo sta facendo per voi! Sta solo aumentando il suo potere: lo fa per lui. Vi fa credere di darvi un dono e invece vi ha trasformati in un branco di cani da guardia!».
Riconobbi la voce di Scott ancor prima di poterlo vedere coi miei stessi occhi. La sentii rimbombare tra le pesanti pareti della struttura vuota, come se fosse nient’altro che un ringhio feroce, distorta com’era dalla licantropia. Scott era trasformato e stava combattendo, tentando di far capire ad Erica e Isaac una verità che loro non erano ancora in grado di accettare. Sussultai nel vederli che si rimettevano in piedi a fatica mentre Derek – che mi dava le spalle – osservava il tutto come se nulla fosse, le gambe lievemente divaricate sul ghiaccio della pista e le mani comodamente sistemate nella tasche della giacca in pelle nera. Avrei voluto urlargli contro in quel momento. Dirgli che aveva rovinato la vita di tre ragazzini per sempre, che era un codardo e un egoista, che mi aveva mentito e ferita, ma non lo feci. Me ne rimasi in silenzio, con gli occhi pieni di lacrime, ad aspettare una replica da parte di Derek che sapevo sarebbe arrivata. «È vero», lo sentii dire infatti, e quelle due parole mi colpirono subito dritte al cuore, mozzandomi il respiro. Era vero. L’aveva ammesso. Ma la stoccata finale doveva ancora arrivare. «Si tratta sempre di potere». Il freddo della pista da ghiaccio all’improvviso era niente in confronto a quello che mi agguantò il cuore in una morsa. So let me go,
I don’t wanna be your hero.
Ringraziamenti
A chiunque mi abbia fatto conoscere Hero perché (almeno questo me lo ricordo bene *sob*) è successo proprio quando ne avevo più bisogno, ovvero durante la stesura di questo capitolo pieno di angst per i miei amatissimi Derriet. Cioè, è perfetta. Note Siccome mi sono dimenticata di dirvelo nei capitoli precedenti (e quando mai?) ne approfitto per lasciarvi qui il link all’ultima shot che ho scritto, sempre collegata a questa serie ma un po’ più avanti col timeline. Precisamente, è ambientata alla 4x02 e vi consiglio di leggerla se volete avere una minima idea di come saranno diventati Harriet&co. a quel punto (in maniera molto ipotetica, vi avviso, perché non è detto che le cose andranno sul serio così). Ma comunque c’è baby!Derek, come potete resistere? Il titolo è Back. But different. Spero vi piaccia. Penso si sarà capito bene, da questo capitolo soprattutto, quanto io tenga al rapporto tra Harriet e Derek. Il loro è un legame un po’ strano: Derek c’è stato fin dall’inizio per lei, seppur sempre a modo suo, e alla fine si sono affezionati l’uno all’altra. Harriet soprattutto, per quanto odi ammetterlo, si è legata a Derek e ha imparato dopo tanti sforzi a fidarsi di lui, soprattutto dopo la chiacchierata da mare di feelings che potete trovare nel capitolo 19 di parachute. Tuttavia questo Derek è completamente diverso da quello che Harriet credeva di aver conosciuto: è un alpha assetato di potere - l’unica cosa alla quale le aveva detto di non essere assolutamente interessato - e per lei questa delusione sarà davvero difficile da accettare, dato che (da come avrete potuto facilmente capire) si sente tradita da quello che, parafrasando la canzone meravigliosa, aveva cominciato a considerare un po’ come il suo eroe. PS kaleidoscope avrà in tutto, compreso l'epilogo, dodici capitoli. Ed io ne ho già scritti dieci, yay me! Ciò significa che gli aggiornamenti avverranno regolarmente ogni domenica e che se tutto continua ad andare così meravigliosamente bene, comincerò ben presto a lavorare al sequel. Sono fin troppo eccitata. |
Capitolo 4
*** You and I ***
Da parachute: «I Carter pianificavano da tempo di attirarti a Beacon Hills, lo sai. Ma c’è una cosa che non ti ho mai detto: io ero coinvolto. E non ero l’unico». […]
«Di cosa stai parlando?», sussurrai flebilmente, giusto poco tempo prima che Derek prendesse a raccontarmi una storia che mai avrei potuto immaginare di dover ascoltare. […] «[…] quando Thomas mi ha chiesto di aiutarlo a portarti qui e riprendere potere su Beacon Hills, io ho acconsentito […]. Ma alla fine il piano non è stato messo in atto: gli Stilinski hanno scelto te di loro spontanea volontà e la mia collaborazione non è più servita. Tuo nonno ha guadagnato due piccioni con una fava».  «Hai parlato con Derek?». […] «Ho scoperto che lui e mio nonno sono molto legati». «Fantastico». […] «E che Thomas gli aveva chiesto aiuto per riportarmi qui. Cosa che poi non è successa perché c’avete pensato tu e Stephen». «Il che mi fa sentire un tantino in colpa». kaleidoscope
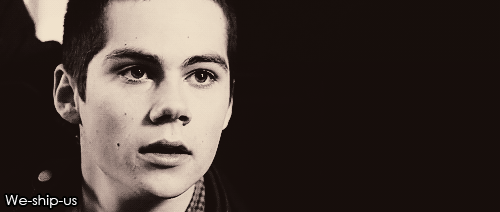 4. You and I
Quel sabato pomeriggio uscii dalla Beacon Hills High School da sola, sforzandomi di individuare il più velocemente possibile la macchina di mio cugino Walter tra la folla soffocante del parcheggio. Stavo letteralmente scappando, come al solito, ma non c’era niente che in quel momento desiderassi di più. Dunque perché evitarlo? Liberai un sospiro di sollievo alla vista di mio cugino: se ne stava poggiato contro la sua utilitaria metallizzata e non appena mi vide agitò le dita nella mia direzione in un saluto a cui risposi con un semplice sorriso striminzito. Lo conoscevo da pochissimo, ma già sentivo di volergli un gran bene e sapevo che stare con lui quel giorno mi avrebbe distratta ben bene dalla marea di problemi che già da un po’ di tempo rischiava di sommergermi, facendomi annegare. Ecco perché quando nostro nonno Thomas ci aveva invitati entrambi a pranzo, non me l’ero fatto ripetere due volte prima di dire sì. «Ciao, cugina», mi salutò Walt non appena l’ebbi raggiunto, sporgendosi a darmi un abbraccio e scompigliandomi allegramente i capelli. Lo fulminai mentre me li sistemavo alla bell’e meglio, affrettandomi in direzione del posto del passeggero. Volevo allontanarmi da quella scuola e da Stiles il prima possibile. Non sopportavo più di vederlo che mi ignorava senza che sapessi bene perché. Avevo assoluto bisogno di distrarmi. «Muoviamoci, dai», borbottai comunque, prendendo posto in auto e fingendo che non fosse nulla. «Nonno ci aspetta». Walt mi si sedette al fianco, riservandomi una lunga occhiata confusa prima di mettere finalmente in moto. «Che cos’hai? Non ti ho mai vista così impaziente per un pranzo in famiglia», osservò, e Dio solo sapeva quanto ci avesse visto dannatamente giusto anche quella volta. Mi conosceva a malapena, eppure mi capiva meglio di quasi chiunque altro. Tanto da sapere che non fosse l’idea di rivedere quella famiglia che avevo ritrovato da pochissimo a farmi stare così tanto in ansia. Non potei far altro che trattenere uno sbuffo infastidito, completamente esposta dinanzi ai suoi occhi ambrati. Cavoli, non lo sopportavo quando faceva così. Mi beccava sempre. Rifuggii il suo sguardo mentre masticavo un’imprecazione e me ne rimasi in silenzio, convinta a non dargli più corda né tantomeno ad ammettere ciò che era già piuttosto evidente. Ma non volevo assolutamente dargli soddisfazione. A tutti i costi. «E Stiles dov’è? Pensavo sarebbe venuto anche lui, come al solito». Ma a quel punto restarmene zitta mi fu impossibile. Mi voltai a cercare nuovamente il viso di mio cugino con un diavolo per capello e gli occhi spiritati, quasi. Aveva nominato l’unica persona della quale avrei preferito non parlare e in quel momento lo odiai così tanto da credere addirittura di volerlo uccidere a mani nude. Alla fine dovetti inscenare una sottospecie di training autogeno per tranquillizzarmi tanto da non sbraitargli contro come in realtà avrei voluto fare. «Io e Stiles non ci parliamo da ieri», borbottai, incrociando le braccia al petto con aria più che stizzita. «Chiusa parentesi». Walter capì subito di dover lasciar cadere l’argomento ed io gliene fui immensamente grata, anche se ancora una volta tenni i miei pensieri per me, limitandomi a fissare fuori dal finestrino la Beacon Hills del sabato pomeriggio che mi sfrecciava accanto. «Sento che non è solo Stiles a preoccuparti», mormorò comunque Walt dopo qualche minuto, quando già mi ero abituata più che bene a quel silenzio piacevole e rilassato. Il suono della sua voce mi fece sobbalzare e mi voltai a guardarlo di scatto, non convinta di volergli ancora parlare dei miei problemi. Ma aveva ragione: non era solo Stiles ad innervosirmi tanto. «Non voglio obbligarti, ma sai che con me puoi sfogarti», mi rassicurò ancora, continuando a parlare perché incoraggiato dal mio silenzio eloquente. Distolsi di nuovo gli occhi da quelli di mio cugino, mentre mi sentivo avvampare dall’imbarazzo. Mi stavo comportando da stronza mentre lui voleva semplicemente che mi sfogassi e stessi meglio. Sospirai, torturandomi le dita in grembo e allo stesso tempo riflettendo su come avrei cominciato a spiegargli ciò che mi sentivo dentro. «È che mi manca la mia famiglia», dissi infine, provando subito dopo l’immediato impulso di mordermi la lingua dalla vergogna. Ma cosa andavo blaterando? Anche Walter era la mia famiglia! Strizzai gli occhi, dandomi più volte della stupida. Qualcuno lassù mi voleva bene, comunque, perché mio cugino non sembrò stizzirsi affatto per quel commento e anzi, annuì con l’aria di chi – ancora una volta – aveva capito tutto. Rimase in silenzio, permettendomi di continuare senza farmi pressioni. E subito ne approfittai per rimediare a quella mia terribile gaffe. «Mi manca il Texas», ritrattai. «Mi manca la mia vecchia, monotona e normale vita. Dove non ero nient’altro che una liceale coi classici problemi da teenager. Qui invece sono tutt’altro. Ed è così frustrante e stancante…». Non avevo chiesto che mi succedesse tutto quello. Non avevo mai desiderato trasferirmi in una città che mi avrebbe cambiato la vita con tutte le sue creature soprannaturali. Non volevo dover convivere con dei poteri che ancora non sapevo come gestire né tantomeno abituarmi all’idea che un giorno sarei stata a capo di un’intera famiglia di chiaroveggenti. Non ero stata creata per seguire quelle tradizioni, ma avevo capito già da tempo di poter fare davvero molto poco per cambiare le cose. Quella ormai era la mia vita, e finché non fossi tornata in Texas avrei dovuto fare di tutto per viverla al meglio e soprattutto per tenere al sicuro non solo me stessa ma anche tutte le persone alle quali tenevo. «Lydia è sempre più strana e non sappiamo cos’abbia. Non si è trasformata, quindi dovrebbe tornare a star bene. Ma non ci riesce, e non c’è niente che io possa fare per aiutarla. Si rifiuta persino di parlarmi». Anche lei, aggiunsi mentalmente, ma tenni quell’osservazione per me. Non volevo risultare a Walter ancor più patetica di così. «Poi Derek se ne va in giro a trasformare ragazzini! L’ha fatto con un tipo che credevo potesse diventare mio amico… E ora non so nemmeno se è ancora vivo o meno. Lo odio così tanto, Walt». La voce quasi mi si spezzò su quell’ultima frase e mio cugino non ci mise molto a capire quanto sul serio tutta quella situazione mi facesse stare male. Lo vidi che mi riservava una lunga occhiata dispiaciuta mentre svoltava nella via della casa di nonno Thomas, poco prima di riportare l’attenzione alla strada e fare per parlarmi. «Ma Derek adesso è un alpha, Harry», mormorò cauto, come se avesse paura di indispettirmi con quelle parole pregne di verità. «Ed è giusto che si crei un branco, se lo fa stare bene. Non è per questo che ce l’hai con lui e lo sai». Un’altra volta ancora non potei far altro che incassare il colpo, distogliere lo sguardo dal viso di mio cugino e lasciarmi andare a fuoco dall’imbarazzo. Walter Edwards mi conosceva molto meglio di quanto mi sarebbe piaciuto ammettere. E di nuovo era riuscito a centrare perfettamente il nocciolo della questione. Era vero: non ce l’avevo con Derek perché si stava costruendo un branco – una famiglia – ce l’avevo con lui perché mi aveva tradita. Mi aveva detto un mucchio di cazzate. E aveva irretito dei ragazzini; menti facili da plagiare. Non riuscivo ad accettarlo. Ma non sarei mai stata capace di ammetterlo ad alta voce, perciò strinsi i pugni per trattenermi e cambiai nuovamente argomento, com’ero bravissima a fare quando i discorsi diventavano troppo spinosi per essere portati avanti senza problemi. «Stiles si preoccupa per me in continuazione e questo, paradossalmente, non fa altro che allontanarci», sussurrai, mentre il dispiacere mi serrava lo stomaco. «Jackson è anche lui sempre più strano. Per non parlare poi di quanto mi fanno stare male le continue bugie che rifilo a Stephen… E mio padre! È tutto troppo, davvero. Non so se posso farcela a continuare così». A quel punto, Walt si limitò a schioccare la lingua contro il palato e poi spense l’auto, scendendo subito in strada. Successe tutto così velocemente che a malapena mi accorsi del fatto che fossimo finalmente arrivati alla magione Carter. Feci per scendere, ma la figura di Walter di fronte al mio sportello mi impedì qualsiasi movimento. Come diavolo aveva potuto essere così veloce? Alla fine fu lui ad aprirmi e a porgermi una mano affinché lo raggiungessi fuori – una mano che afferrai subito senza esitazioni. «Certo che ce la fai, Harriet», mi disse mio cugino quando gli fui nuovamente di fronte, stringendomi la mano ed infondendomi una sicurezza inaspettata. «Non sei sola». «Non sapevo se ti piacessero i marshmallows, perciò ho evitato di metterli. Mi dispiace». Afferrai la tazza ricolma di cioccolata calda che mi porgeva Thomas, accoccolandomi meglio sul divano ad angolo mentre mia nonna Sarah ne approfittava per sistemarmi meglio il plaid addosso. Avevamo pranzato tutti e quattro insieme per poi trasferirci in salotto, al calore del camino e in compagnia di una buonissima cioccolata calda. Per me, senza marshmallows. «Va bene così», scrollai le spalle, trangugiandone un lungo sorso. «Grazie». Thomas annuì con un sorriso, poi prese posto di fianco a me mentre Walter se ne stava su una poltrona lì vicino, tutto preso dal suo cellulare oltre che ovviamente dalla cioccolata calda. Avrei voluto sapere chi fosse a distrarlo così tanto, ma mio nonno catturò subito tutta la mia attenzione. «Derek sta creando un branco, quindi», mormorò con estrema nonchalance, mentre a me invece tornava la voglia di dare di matto. Ma ancora una volta avrei dovuto controllarmi. «Così pare», borbottai come se niente fosse, lanciando un’occhiataccia in tralice a Walt, che continuò a fingersi ancora occupato col suo maledettissimo cellulare. Sapevo fosse stato lui a parlare a nostro nonno di Derek, e lo odiavo più che mai per quella sua pugnalata. «Ciò ti preoccupa?». Ricercai gli occhi azzurri di Thomas Carter con espressione scioccata. Io? Preoccupata per Derek? E quando mai? «Assolutamente no. Non m’interessa più nulla di Derek», soffiai, carica di veleno. «Tu, piuttosto. Perché non mi hai detto di conoscerlo?». Mio nonno scrollò le spalle, non interrompendo mai il nostro contatto visivo. Voleva dimostrarmi di non avere assolutamente nulla da nascondere, ma sapevo benissimo che non fosse così. «Non ce n’è mai stata occasione». «Be’, mi sarebbe piaciuto che tu me lo dicessi comunque. Ho saputo del suo coinvolgimento nel piano da lui e non da te che sei mio nonno!», trillai, ovviamente stizzita. Tanto che la tazza cocente mi tremolò tra le mani e per poco non finii a rovesciarne tutto il contenuto sul divano in pelle. Sospirai, tentando di riacquistare una calma che ormai avevo perso. «Un piano che alla fine non è stato messo in atto. Che senso aveva parlartene, quindi?», sviò ancora Thomas. Era evidente di come volesse evitare l’argomento, ma ancora non ero pronta a permettergli di scappare così. Mi aveva promesso che mi avrebbe sempre detto tutto ciò che desideravo sapere, ed ora era quello che mi premeva di più. Quel piano. E nient’altro. «Chi altro era coinvolto?», chiesi dunque, approfittando del silenzio che seguì quel mio quesito per prendere un altro sorso di cioccolata. «Oltre a Derek? La Morrell, la tua professoressa di francese». Oh mio Dio. Mio nonno dovette leggermi lo sgomento in faccia, perché si aprì subito in un ghigno consapevole. Nonna Sarah, dal canto suo, riprese a carezzarmi la schiena nella speranza di tranquillizzarmi almeno un po’. Una speranza piuttosto vana la sua, ma apprezzai comunque il gesto. «Scommetto che avresti preferito non saperlo», osservò Thomas dopo un po’, mentre io mettevo da parte la cioccolata – mi si era all’improvviso chiuso lo stomaco – e cercavo di ingoiare il fiotto di bile risalitomi in gola. La Morrell era parte del piano che mio nonno aveva messo su per potermi riportare a Beacon Hills. Marin Morrell. La mia professoressa. L’organizzatrice del corso di Intercultura che mi aveva fatta arrivare in California e convivere con gli Stilinski. Non riuscivo a crederci. E avevo assoluto bisogno di cambiare argomento. «Di mio padre che mi dici?». Ancora una volta, Thomas si limitò a scrollare le spalle. Prima di rispondermi, sorrise ad una domestica accorsa a liberarsi delle nostre tazze vuote. Poi riportò tutta la sua attenzione sul mio viso. «Qui non s’è visto». Aggrottai le sopracciglia. Nel puzzle di cose che credevo non sarei mai riuscita a capire, mio padre era senz’altro il tassello più confuso. Dannazione. «È andato solo da zia Erin. Perché?», domandai, a non sapevo nemmeno io chi. «Perché sapeva che mia madre e mio padre l’avrebbero mandato via a calci nel culo». Mio cugino riuscì inaspettatamente a strapparmi una risatina con quella sua osservazione, ma in compenso si guadagnò un’occhiataccia da parte di nostro nonno. Il che mi fece ridacchiare ancor di più. «Sono sempre stati molto legati», lo corresse Thomas, ritornando poi a fissare me. Ma improvvisamente sembrava non avere più poi così tanta voglia di portare avanti l’argomento, perché sviò com’eravamo bravissimi a fare entrambi. «Comunque, come vanno le tue visioni?». «Magnificamente. Sono regolari e normali. Niente più cose strane o terrificanti», descrissi, stringendomi di più il plaid addosso. Ero tranquilla, finalmente. «Purtroppo sento che la cosa non durerà ancora a lungo, bambina». Ma mio nonno provvide subito a rovinare tutto. Tanto che mi accigliai immediatamente. «Perché?». Thomas fece spallucce, poi si mise in piedi e subito nonna Sarah lo seguì. Il momento “stiamo in famiglia” era finito. «Non lo so. Non ho più tutto questo potere. Ma tu sì», mi disse, prima di sparire del tutto. Non appena i miei nonni abbandonarono la mia visuale, cercai gli occhi di Walter. Lui si limitò a riservarmi un’occhiatina comprensiva, poi mi raggiunse sul divano e mi strinse a sé. Sapeva meglio di chiunque altro quanto diavolo fossi terrorizzata da tutta quella storia di poteri e responsabilità, ma non disse nulla – perché sapeva quanta poca forza avessi di discuterne, in quel momento. Semplicemente mi rimase al fianco finché non sprofondai in un sonno ricolmo di sogni.  Stiles era infuriato. Già. Ancora. Ce l’aveva col mondo. E sapeva che se non si fosse fatto lontano al più presto da quella sottospecie di modello mancato che si ostinava chissà perché a fare il meccanico, avrebbe finito per esplodere senza via di ritorno. Si sentiva proprio come se fosse una bomba ad orologeria, il cui tempo di esplosione si accorciava sempre più. Tic, tac. Tic, tac. Non sapeva chi o cosa lo infastidisse di più, dato che a quel punto la sua rabbia era degenerata tanto da diventare generale e rivolta a tutti. In primis a se stesso. Oh sì, perché era irritato a morte da se stesso. E ce l’aveva anche con Harriet, ovviamente, la quale non perdeva mai occasione per attirare pericoli su di sé, neanche fosse una dannatissima calamita. Lo faceva preoccupare così tanto che alle volte credeva che gli sarebbe venuto un infarto. Non poteva sopportare l’idea che le succedesse qualcosa di male, ma Harry ancora sembrava non capirlo del tutto. Ed erano finiti ad ignorarsi per molto più tempo di quanto Stiles avrebbe potuto sopportare, entrambi troppo cocciuti e spaventati per fare il primo passo e provare a risolvere la questione.
Ma Stiles non ce l’aveva solo con lei, no. Sarebbe stato troppo semplice. Stiles ce l’aveva anche con Erica – da morire – e soprattutto ce l’aveva con Derek, che trasformandola l’aveva resa una stronza. Una stronza che non si era fatta scrupoli a distruggergli la Jeep. E ancora, Stiles ce l’aveva con quel dannatissimo meccanico che non riusciva proprio a ricordare chi gli avesse consigliato di vedere. Dannato lui e dannata la sua sete di soldi. E dannato anche chiunque l’avesse spedito lì. Stiles raggiunse la porta che poi l’avrebbe condotto ai bagni a grandi falcate, non perdendo tempo a far scivolare una mano sulla maniglia mentre dentro ancora si sentiva ribollire di rabbia. Ma le sue dita persero subito il contatto con l’ottone, ritrovandosi a scivolare su qualcosa di così viscido da farlo rabbrividire. «Grande», imprecò immediatamente, osservando con aria disgustata le dita impregnate di quel liquido trasparente e viscoso. Non aveva idea di cosa fosse, e qualcosa gli diceva che forse sarebbe stato meglio non scoprirlo. «Davvero molto igienico. Mandi avanti un’impresa di qualità, amico!». Ma il belloccio continuò ad ignorarlo, fingendosi troppo impegnato a lavorare sulla sua dannatissima Jeep. Stiles gli rifilò l’ennesimo insulto e poi si chiuse la porta alle spalle, asciugandosi la mano sulla felpa rossa e afferrando subito il cellulare dalla tasca dei jeans chiari. Prima che potesse scrivere un messaggio, comunque, il suo sguardo ambrato fu catturato da una foto. Essa ritraeva il padrone di quel postaccio con indosso nientemeno che la divisa dei Cyclones, la squadra di lacrosse della Beacon Hills High School. Tipico, pensò Stiles poco prima di riportare tutta la propria attenzione al cellulare. Ma all’improvviso non aveva idea di cosa volesse scrivere né a chi dovesse inviare quel messaggio. E in più, le sue dita non ne volevano più sapere di rispondere ai comandi del suo cervello quasi atrofizzato. Stiles si sforzò di muoverle sul touchscreen mentre cercava in tutti i modi di non andare nel panico, ma non importava quanto ci provasse: erano immobilizzate, come quando fuori fa troppo freddo. E la cosa terribile era che lì dentro non faceva affatto freddo. Il cellulare gli scivolò tra le mani prima ancora che potesse rendersene conto sul serio, cadendo sulla moquette con un lieve tonfo. Stiles ne seguì la discesa con gli occhi, poco prima di riportare lo sguardo di fronte a sé. L’officina era divisa da un’ampia vetrata e da lì Stiles poteva vedere chiaramente il belloccio che ancora lavorava, come se niente fosse. Fece per chiedergli aiuto, ma il suo urlo gli rimase incastrato in gola alla vista di una zampa squamata e dotata degli artigli più lunghi che avesse mai visto prima d’allora. C’era una creatura sulla sua Jeep, una creatura dall’aria minacciosa e sconosciuta. «Ehi!». Di nuovo provò ad urlare e ad avvertire il meccanico prima che fosse troppo tardi, ma anche le corde vocali gli sembravano all’improvviso immobilizzate. Nonostante quanto si sforzasse, non riusciva nemmeno più a parlare. Né a stare in piedi. Stiles rovinò sulla moquette senza riuscire ad impedirselo, ma ancora una volta fece di tutto per non farsi prendere dal panico e continuare a lottare. Sentiva le proprie forze abbandonarlo sempre più, eppure fece di tutto per scivolare sul pavimento finché non riuscì a raggiungere il proprio cellulare e a vedere che – nell’altra stanza – anche il belloccio aveva ormai perso la capacità di muoversi e se ne stava immobilizzato a terra proprio come lui, mentre la creatura lo squadrava con aria soddisfatta: era riuscita a disattivare il sostegno della Jeep e la osservava nella sua lenta discesa verso il corpo del meccanico. L’avrebbe schiacciato. Sarebbe morto. Stiles riusciva a pensare solo a questo mentre lo sentiva chiedere aiuto sommessamente e combatteva contro le proprie forze per digitare il numero del 911. Ma era ormai così debole e c’era così poco tempo prima che la Jeep raggiungesse il pavimento che alla fine Stiles non poté far altro che arrendersi, strizzando gli occhi perché – non importava cosa sarebbe successo dopo – non voleva assolutamente assistere ad ulteriori spargimenti di sangue. Non l’avrebbe permesso. «911, qual è la sua emergenza?». Quella voce arrivò come un fulmine a ciel sereno e subito Stiles riaprì gli occhi, improvvisamente rincuorato. Ce l’aveva fatta: la chiamata era partita e anche se non avesse aperto bocca, sapeva che un’auto di pattuglia sarebbe comunque partita dalla centrale di polizia per assicurarsi che lì fosse tutto a posto. Forse aveva ancora possibilità di salvarsi. Fece per sospirare, sollevato, ma il respiro gli si mozzò in gola alla vista improvvisa della creatura di fronte a sé. Gli era molto più vicina di quanto Stiles avrebbe potuto sopportare: si era mossa con passo agile e silenzioso, cogliendolo completamente di sorpresa e facendolo sobbalzare dalla paura con uno strillo acuto. Per un lunghissimo attimo, Stiles credette di essere spacciato. Pensò che la creatura avrebbe ridotto in poltiglia l’unica porta di vetro che li separava e poi si sarebbe avventata su di lui, finendo ciò che col meccanico non aveva ancora completato. Un omicidio. Ma la creatura non provò nemmeno a raggiungerlo, anzi. All’improvviso si fece lontana dalla porta e sparì, come se fosse di colpo terrorizzata da qualcosa che Stiles non poteva capire. Nemmeno si sforzò di dare un senso a ciò che era successo, tra l’altro: era troppo stanco e semplicemente mollò la presa, lasciando che finalmente il buio l’avvolgesse.  Aprii gli occhi di scatto, boccheggiando alla ricerca dell’ossigeno che quella visione mi stava rubando completamente. Stiles. Stiles era in pericolo e aveva bisogno di me. Dovevo correre da lui e assicurarmi che stesse bene. Mi portai una mano al petto, cercando di tranquillizzarmi un po’ prima di svegliare Walter. Mi si era addormentato al fianco e non volevo che anche a lui prendesse un colpo nel vedermi in quelle condizioni. Aspettai quindi che i battiti del mio cuore tornassero quantomeno regolari e poi mi liberai del plaid in pile, mettendomi in piedi anche se mi sentivo le gambe molli come gelatina.
«Walt», chiamai scrollandolo per le spalle, prima piano e poi – secondo dopo secondo – sempre più forte. Dormiva profondamente e dovetti sforzarmi davvero molto per riscuoterlo dal suo sonno. «Walt!», quasi strillai infatti, e grazie a Dio dopo quel mio urlo mio cugino ritornò nel mondo dei vivi. Osservai il suo viso che, nella penombra lasciata dal fuoco quasi estinto del camino, si distendeva – ancora rilassato dal sonno – e poi vidi al contrario la sua espressione accigliarsi non appena mi vide. Dovevo avere un aspetto orribile: capelli scompigliati, occhi lucidi e vestiti spiegazzati. Ma non m’importava. Mi interessava solo di aiutare Stiles, in quel momento. «Che succede?», mi domandò Walter, disfacendosi anch’egli del plaid ma non provando nemmeno a mettersi in piedi. Cosa che invece avevo bisogno che facesse al più presto. «Devi alzarti. D-Dobbiamo andare», balbettai, distogliendo lo sguardo da mio cugino e cominciando a muovermi freneticamente per il salotto alla ricerca di tutte le mie cose. Non c’era più tempo da perdere, e quando riparlai lo capì finalmente anche Walt. «Stiles è in pericolo». «Harry?». Stiles mi riservò una lunga occhiata confusa, come se non riuscisse a credere che sul serio fossi lì di fronte a lui. E sapevo benissimo che aveva ragione di farlo: d’altronde lui non mi aveva chiamata per dirmi di quell’incidente né di dove fosse e non poteva certo immaginare che mi trovassi lì a causa di un’altra delle mie visioni. Non ebbi tempo né forza di dirglielo, semplicemente gli corsi in contro il più velocemente possibile e mi tuffai praticamente tra le sue braccia non appena ne ebbi occasione. Sembrava stare bene, ma volevo accertarmene con le mie mani prima di poter cantare vittoria. Le braccia di Stiles si strinsero subito attorno ai miei fianchi ed io chiusi gli occhi, sentendomi finalmente al posto giusto mentre le mie narici si riempivano dell’odore di Stiles – che mi era mancato da morire – e il mio cuore ritornava a battere tranquillo. «Dimmi che stai bene», implorai comunque, ancora non del tutto decisa a mollare la presa. La stretta di Stiles si rafforzò immediatamente e una sua mano corse tra i miei capelli lunghi, strappandomi un sospiro. «Cosa ci fai qui?». Aveva evitato di rispondermi. Me ne resi conto subito, ma non me la sentii proprio di infierire. Semplicemente mi feci lontana dal nostro abbraccio, desiderando che la mia delusione restasse nascosta. «Ti ho sognato. Ho riconosciuto il posto e mi sono catapultata qui», gli spiegai, con la voce che già tremolava e gli occhi lucidi. «M-Mi dispiace». Le mani di Stiles si chiusero subito sulle mie guance, prima ancora che potessi scappare del tutto ai suoi occhi. Mi costrinse a sostenere il suo sguardo e quando reputò che gli stessi donando l’attenzione che voleva, riprese a parlare. «Di cosa?», mi chiese, ed io tirai su col naso nella speranza che ciò potesse aiutarmi a trattenere delle lacrime che all’improvviso sentivano un fortissimo bisogno di straripare dai miei occhi. «Di non essere arrivata in tempo», mormorai alla fine, sventolando bandiera bianca. Mi ero arresa, ormai, e le due lacrime che bagnarono non solo le mie guance ma anche le dita di Stiles ne erano la prova lampante. «Ehi, smettila», mi redarguì lui subito, non perdendo tempo ad asciugarmi le guance già umide con le dita. «Sei arrivata in tempo». Scossi la testa, afferrandogli le mani con le mie. «Non è vero. Sarebbe potuto succederti di tutto. Ed io–». La mia frase morì direttamente sulle labbra di Stiles, che ritrovai sulle mie così all’improvviso da non poter far altro che sgranare gli occhi, comunque totalmente incapace di farmi lontana da quel piacevolissimo contatto che mi era mancato molto più di quanto avessi creduto. Strinsi le mani di Stiles tra le mie e finalmente mi lasciai andare, tranquilla, ma quel nostro contatto s’interruppe fin troppo presto. «Non voglio più vederti piangere», mi redarguì Stiles, muovendo ancora i pollici sulle mie guance per asciugarle del tutto. Ma io quasi non lo ascoltavo più. A momenti non gli lasciai nemmeno il tempo di finire di parlare perché mi rituffai sulle sue labbra, ben decisa – finalmente – a non lasciarlo andar via tanto presto. Un’ostinazione la mia, che Stiles accolse con estrema gioia. Tanto che ricambiò il mio bacio senza farselo ripetere due volte, quella volta senza trattenersi e stringendomi a sé ogni minuto che passava un po’ di più. «Oddio», mormorò quando alla fine fummo costretti a separarci, entrambi alla ricerca di ossigeno. Aveva il fiato corto e lo sguardo ancora fisso sulle mie labbra. E non l’avevo mai visto più bello di così. «Mi sento un coglione ad averti evitata così a lungo mentre avrei potuto fare questo tutto il tempo». Di nuovo le dita di Stiles si mossero sulle mie guance, raggiungendo questa volta anche le labbra, che attraversò in una carezza capace di strapparmi diversi brividi. Avrei voluto sorridere e sentirmi finalmente tranquilla come avrei dovuto – avevamo chiarito, andava tutto bene tra di noi – ma ancora c’era qualcosa che mi faceva stare in ansia. Il ricordo costante di quella mia ultima visione. «Cos’era quella creatura?», sussurrai quindi, sapendo che se non ne avessi parlato con Stiles non mi sarei mai sentita in pace con me stessa. Troppi dubbi mi affollavano la mente dolorante e avevo bisogno di liberarmi non solo di quelli ma anche dei miei soliti brutti presentimenti. Lui semplicemente scrollò le spalle, facendosi lontano da me e rifuggendo il mio sguardo scuro. «Non lo so. I suoi occhi… sembravano quelli di un rettile», descrisse. Poi tornò a guardarmi, curioso di vedere come avrei reagito a quella notizia. «È stato così strano. Era come se…». «Cosa, Stiles?», incalzai, pur sapendo bene quanto lui avrebbe preferito troncare lì il discorso. Ma io al contrario non avevo nessuna intenzione di arrendermi. Non quella volta. Tanto che alla fine fu Stiles a cedere. «Era come se mi conoscesse». «Carter, piantala». Il sorriso mi si cristallizzò sul viso al suono improvviso di quel rimprovero e gli occhi di Stiles subito abbandonarono i miei per correre ad analizzare la figura apparentemente scocciata di Bobby Finstock. «Di fare cosa, prof?», gli domandai, sebbene mi sentissi ancora piuttosto intimidita dal tono con cui mi aveva ripresa. Come se poi sul serio stessi facendo qualcosa di male! Il coach inarcò un sopracciglio con aria scettica, come se trovasse irritante il mio far finta di nulla. Ma io sul serio non riuscivo a capire perché all’improvviso ce l’avesse tanto con la sottoscritta. «Me lo distrai con la tua sola presenza! E lui», indicò Stiles, al che mi sentii andare a fuoco perché iniziavo a capire bene cosa lo irritasse tanto del mio – o meglio dire del “nostro”? – comportamento, «deve restare concentrato sul gioco. Proprio come me». «Ma…», provai ad obbiettare, ancora per niente decisa ad ammettere le mie colpe. Okay. Magari io e Stiles ci eravamo fatti un poco poco prendere la mano con tutti gli sguardi e i sorrisini che ci eravamo scambiati fin dall’inizio della partita di lacrosse, e magari i nostri sussurri potevano aver infastidito Finstock… Ma che colpa ne avevamo sul serio? Eravamo insieme; tutto il resto passava in secondo piano, anche senza che lo volessimo. «Sparisci», ordinò il coach, e allora non potei far altro che abbandonare la panchina con un sospiro sconfitto. Salutai Stiles con un innocentissimo bacio sulla guancia e mi rifugiai sugli spalti, il più lontano possibile dal professor Finstock – e da Stiles, purtroppo. Individuai subito Allison tra la folla, ma evitai di raggiungerla quando vidi che sedeva di fianco a suo nonno Gerard. Quell’uomo mi intimidiva tanto da rendermi ben consapevole del fatto che non sarei sopravvissuta ad un’intera serata accanto a lui. Ecco perché evitai di raggiungere la mia amica, decidendo di rimanermene in disparte quando scoprii che lì intorno non ci fosse nemmeno la minima traccia di Lydia. Rimasta completamente sola cercai di concentrarmi sulla partita, ma il mio sguardo correva fin troppo spesso alla figura di Stiles – non riuscivo a pensare ad altro che a lui – e molto spesso ci ritrovammo ancora, seppur lontani, occhi negli occhi. Il che era bellissimo e mi strappò più di un sorriso. Avevo tenuto un posto libero per Stephen, nella speranza che potesse raggiungermi anche quel giorno per dare supporto morale alla squadra del figlio, anche se quest’ultimo continuava a restare sempre relegato in panchina. Il che mi fece ripensare al rimprovero che Finstock mi aveva rifilato solo pochissimo tempo prima. Perché mai preoccuparsi tanto del fatto che distraessi Stiles quando non aveva nemmeno intenzione di farlo scendere in campo? Il rumore di qualcuno che occupava il posto di fianco al mio mi impedì di trovare una risposta a quel quesito. «Finalmente ce l’hai fatta! La partita è già–». Quello di fianco a me non era Stephen Stilinski. Mi resi conto di come fosse decisamente troppo giovane e troppo biondo per essere il padre di Stiles quando già era troppo tardi. La voce mi si spezzò in gola, impedendomi di continuare a parlare mentre un familiare senso di terrore correva ad artigliarmi lo stomaco. «Cosa ci fai qui?», riuscii comunque a soffiare, cercando di non ricambiare lo sguardo di Stiles. Me lo sentivo addosso ed era preoccupato di vedermi insieme a quello che per lui era un perfetto sconosciuto, ma non volevo che le cose peggiorassero. Victor Daehler mi riservò un sorriso soddisfatto, facendo spallucce come se niente fosse prima di decidersi a darmi la risposta che cercavo. Osservai le sue fossette con un brivido che mi correva giù per la schiena: quella volta mi aveva in trappola, dopo avermi tanto cercata in quegli ultimi giorni, alla fine mi aveva accerchiata nell’unico posto da cui sapeva che non avrei potuto scappare – non senza attirare fin troppe attenzioni sulla mia figura. «Questa è la squadra di mio fratello, credevo di avertelo già detto», mormorò infine, mentre distoglievo lo sguardo dal suo viso e mi fingevo attenta ad una partita della quale in ogni caso non avrei capito un tubo. Ovviamente Victor non mi aveva mai parlato di suo fratello e in generale non mi aveva mai parlato di sé: forse era anche per quello che la sua presenza mi terrorizzava. Fin dal primo momento non mi era sembrato affatto un tipo affidabile e il conoscerlo così poco di certo non aiutava a scrollarmi di dosso i miei pregiudizi. «Non m’interessa», liquidai comunque, perché era vero. Non lo conoscevo né mi interessava farlo. «Perché devi essere sempre così prevenuta nei miei confronti, Harriet?». Sentii che Victor si muoveva al mio fianco – lo capii dalla zaffata di profumo da uomo che m’investì le narici – e di conseguenza scivolai anch’io sul mio sedile, a disagio. «Tu non mi piaci. Per niente», mormorai, cercando di mantenere un tono di voce fermo e deciso – ma fallendo miseramente. «E non credi che mi meriti almeno una possibilità per dimostrarti che non sono il Satana in borghese che credi? Vorrei solo poterti conoscere meglio. Perché... mi interessi». Strizzai gli occhi, desiderando all’improvviso che Victor potesse sparire. Non ce la facevo ad affrontarlo in quel momento. Non ce l’avrei fatta mai. «Possiamo parlarne un’altra volta, per favore? Sto cercando di seguire», pregai quindi, fingendomi ancora una volta interessata alla partita di lacrosse. Ma Victor non cedette – non era abituato a darla vinta tanto facilmente. Anzi, mi si fece ancor più vicino dopo aver soffocato un risolino divertito. «Quando avrai l’ennesima occasione per scapparmi?», mormorò contro il mio orecchio, strappandomi l’ennesimo brivido e rubandomi nuovamente la parola. «Non mi avevi detto di avere un ragazzo». Mi si fece lontano, tornando a sedersi in maniera più o meno composta mentre io cercavo invano di trattenere un sospiro di sollievo. Seguii la sua figura di sottecchi, cercando di capire se mi stesse prendendo in giro ancora una volta. «Non te l’ho detto perché non ce l’ho», risposi infine, tenendo lo sguardo fisso sul suo viso pallido, nell’attesa spasmodica di capire dove diavolo volesse andare a parare quella volta. Vidi la sua espressione distendersi, poi Victor fece spallucce e distolse gli occhi nerissimi dal mio viso. «Oh, allora suppongo sia solo uno spasimante. Devo temerlo?», domandò, ancora con lo sguardo fisso verso chissà dove. «Si può sapere di chi stai parlando?». Solo allora le pozze nere di Victor ritornarono a soffocare i miei occhi marroni. Mi guardò molto più a lungo di quanto fossi pronta a sopportare, poi con un dito mi indicò la panchina. «Del tizio che si sta alzando proprio in questo momento», disse, e capii con immenso orrore che si riferisse a Stiles. Stiles che stava andando via senza nemmeno degnarmi di uno sguardo. Stiles che – ancora una volta – avrebbe dovuto essere con me e non da solo. «Chi diavolo era quel tizio?». Mi aspettavo quella domanda, solo non così all’improvviso. Tanto che non potei far altro che sobbalzare sotto lo sguardo ambrato di Stiles, stringendomi più forte le braccia al petto. Eravamo nel parcheggio della Beacon Hills High School e il freddo di quella sera di inizio novembre si faceva sentire fin dentro le ossa. Stiles non mi perse di vista un attimo, squadrandomi con un’espressione che in un’altra situazione mi avrebbe messa a disagio e non poco. Sembrava infuriato, ma sapevo bene di non avere nessuna colpa. «Solo uno che si è fissato con me», liquidai, decisa a non volergli – ancora – parlare di Victor. Anche perché cosa diavolo avrei potuto dirgli? Io per prima lo conoscevo a malapena. Ma quel mio comportamento non convinse affatto Stiles, che mosse l’ennesimo passo nella mia direzione con tutta l’aria di uno che non aveva la benché minima intenzione di lasciar cadere l’argomento. Per fortuna comunque, prima che potesse continuare a tenermi sotto torchio con quel suo interrogatorio serrato, Scott McCall attirò tutta la nostra attenzione. «Ragazzi, ce l’abbiamo!», esclamò, prendendo a sfogliare velocemente le pagine del bestiario di Gerard Argent, il libro che in quei giorni tanto c’eravamo affannati a cercare e che invece se ne stava al sicuro nella usb del nonno di Allison. In tanto di formato pdf. Non si poteva certo dire che il vecchietto non fosse al passo coi tempi. «Ma che lingua è?», mormorò Stiles qualche attimo dopo aver cercato – inutilmente – di dare un senso alle parole riflesse sullo schermo del suo Mac. Provai anch’io a capire di che lingua si trattasse, ma non riuscii a venirne a capo. Non capivo una sola parola di quel testo che aveva tutta l’aria di essere scritto in latino, o magari in greco. Di certo c’era che nessuno dei tre conoscesse quella lingua antica – e quasi sicuramente morta – e che quindi eravamo ancora al punto di partenza, senza lo straccio di un indizio sull’identità della creatura che stava portando scompiglio nelle nostre vite. «Si chiama kanima». Il suono di quella voce mi fece sobbalzare ancor più dell’imprecazione di Scott: quest’ultima me l’ero aspettata, l’apparizione improvvisa di Derek no. Mi voltai a guardarlo lentamente, ancora poco convinta del fatto che lui fosse sul serio lì. Ma quando lo vidi avanzare nella nostra direzione con Erica al fianco dovetti rassegnarmi all’evidenza: non stavo sognando, non quella volta. «Lo hai sempre saputo!», berciò Stiles allora, dedicandogli un’occhiataccia che mi fece aggrottare le sopracciglia. Perché sembrava avercela con lui così tanto? Derek comunque non si scompose. «L’ho capito quand’è scappato vedendo il suo riflesso». Ci volle poco perché anche Scott capisse. «Lui non sa che cos’è». «O chi è». Per un brevissimo istante provai quasi pena per quella creatura. Poi mi resi conto della mia stupidità e scossi la testa, fingendo indifferenza. Strinsi un po’ più forte le braccia al petto – come per proteggermi da chissà quale pericolo – poi mossi l’ennesimo passo nella direzione di Derek ed Erica. «Cos’altro sai?», gli chiesi, e solo allora i suoi occhi verdi ritornarono sulla mia figura. Fece spallucce, non riuscendo a sostenere il mio sguardo, anche se si sforzò fino all’ultimo di dimostrare il contrario. Non l’avevo mai sentito più lontano di così. «Solo storie. Voci». «Ma è come noi?», intervenne Scott, ponendo un quesito senz’altro molto interessante. «È un mutaforma, sì. Ma è… un errore». «Un abominio», lo corresse Stiles, e Derek annuì. Aveva perfettamente ragione. E non c’era nient’altro da aggiungere, tanto che dopo averci riservato l’ennesima occhiata inespressiva, Derek fece per andare via ed Erica subito gli fu dietro. Ma l’urlo di Scott li fermò entrambi. «Dobbiamo collaborare in questa storia. Magari dirlo agli Argent!», propose, disperato tanto da arrivare a proporre di allearsi col nemico. Vidi l’espressione orripilata di Derek e subito gli impedii di parlare, ben sapendo che avrebbe finito semplicemente per aggredire Scott. Senza risolvere nulla. «Possiamo chiamare i miei», lo anticipai, ma anche quella che credevo una buona idea venne prontamente bocciata dall’alpha. «Non chiameremo proprio nessuno», borbottò, riservandomi una lunghissima occhiataccia prima di riprendere a scappare. «Me ne occuperò io. Troverò quel mostro. E lo ucciderò». Quel nuovo Derek mi piaceva sempre meno. Ain’t nobody in the world tonight
but you and I. Ringraziamenti A youtube, che mi piazza canzoni arrrrandom che io poi posso usare per i capitoli. You and I è di John Legend, quindi grazie anche a lui. Ma grazie soprattutto a Sam Smith, che mi ha ispirato come pochi nella stesura di questo capitolo (soprattutto delle ultime scene). You’re the man, Sam. ♡ E grazie anche a gilraen_white e Axelle_ che sono DUE TESORI GRANDISSIMI. Note Se non avete letto parachute, alcune cose di questo sequel potranno lasciarvi almeno per un attimo un po’ confusi. Me ne rendo conto ed è proprio per questo che sto cercando non solo di spiegare meglio che posso durante i capitoli le questioni più piccanti, ma anche di inserire qua e là roba dal prequel, cosicché possiate afferrare almeno i punti più importanti senza dovervi sorbire l’intera storia (roba che se la leggeste mi fareste felicissima, ma onestamente mi rendo conto di non poter pretendere tanto). Il leone che sputa fuoco lassù è nient’altro che il simbolo della famiglia Carter; che, per chi ancora non l’avesse capito, è una famiglia di chiaroveggenti. Harriet parla molto di sfuggita di questo simbolo nel capitolo 20 di parachute, ma siccome immagino che questo dettaglio vi sia sfuggito (com’è giusto che sia) ho preferito specificarlo qui. Riguardo i poteri di Harriet: la sua è una capacità, quella di prevedere il futuro attraverso “visioni”, della quale lei non si è mai resa conto prima di giungere a Beacon Hills. La famosa cittadina californiana ha infatti risvegliato tutti i suoi poteri (ecco spiegato perché nonno Thomas la voleva lì a tutti i costi) e l’ha costretta a fare i conti con una realtà che lei sente giorno dopo giorno diventare sempre più dura e pericolosa. Da come avrete potuto notare, mi avvalgo dell’uso della terza persona per descrivere ciò che vede Harry nei suoi sogni e n o n userò questo metodo per nessun’altra cosa, cosicché possiate rendervi conto subito del fatto che quando il pov è diverso, si tratta solo di un’altra delle tante visioni di Harry. Visioni che saranno separate dal suo pov, scritto sempre in prima persona, da quei divider bellissimissimissimi coi lupetti blu che ho trovato in internet. ♡ Spero così di rendervi il tutto meno fastidioso e confusionario possibile, e spero anche di aver spiegato bene tutto ciò che volevo. In caso contrario comunque vi chiedo scusa e ne approfitto per ricordarvi del mio profilo facebook (di cui vi lascio il link sotto!) dove potete cercarmi e chiedermi tutto ciò che v’interessa sapere, su kaleidoscope e non. Victor Daehler è un personaggio che ho ripescato direttamente da parachute (anche lui) e che già lì avevo inserito non per niente. Qui lo vedrete moooolto di più, e capirete il perché già nel capitolo prossimo (anche se a dire il vero potreste arrivarci già ora perché avete la soluzione proprio sotto agli occhi). Io comunque non vi aiuto perché mi piace tenere alto il mistero. *risata malefica* |
Capitolo 5
*** May ***
Da parachute: […] da partecipante all’Intercultura qual ero, mi era stato affidato un tutor che mi avrebbe spiegato tutto ciò che c’era da sapere sull’esperienza. […]
«Il mio nome è Marin Morrell: mi occuperò io di te, per quest’anno». Il mio sorriso si estese ancor di più. Non chiedetemi perché, ma la Morrell mi aveva fatto fin da subito una buonissima impressione. Mi ispirava fiducia e autorevolezza. Sapevo fin da quel momento che con lei mi sarei trovata bene. «Oh, quindi sarà lei il mio tutor. È grandioso». kaleidoscope
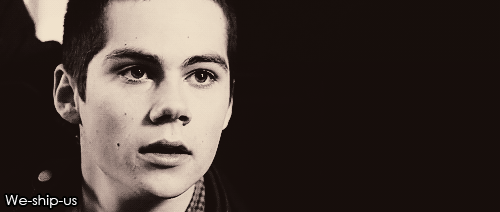 5. May
Non appena io ed Allison arrivammo in classe quel lunedì mattina, gli sguardi preoccupati di Scott e Stiles ci corsero addosso ed io capii subito che ci fosse qualcosa che non andava – anche se non avevo idea di cosa. Perciò mi limitai a fissarli entrambi mentre si stringevano con aria agitata attorno a Lydia e mi chiedevo cosa diavolo stesse succedendo sul serio. Questo almeno finché Scott non puntò frettolosamente alle sue spalle: allora capii tutto immediatamente. Isaac ed Erica erano lì, dietro di loro, e avevano in viso un’aria tutt’altro che pacifica. Subito un brivido mi corse giù per la schiena, anche se cercai di nasconderlo mentre sgusciavo seduta di fianco ad Allison. «Cosa diavolo ci fa Isaac, qui?», non potei far altro che chiederle in un sussurro. Insomma, non era più ricercato dalla polizia? E come mai Stiles non ne sapeva nulla? O forse lo sapeva ma aveva deciso di non parlarmene? «Non lo so», soffiò Allison, voltandosi nuovamente a controllare la situazione. «Non so nemmeno cos’abbiano in mente lui ed Erica». Ma non è niente di buono. Questo avrebbe voluto aggiungere la Argent, ma evitò – non c’era certo bisogno di evidenziare l’ovvio ancor di più. Deglutii tesa, tanto da non prestare la benché minima attenzione alle continue frecciatine malefiche del professor Harris. «Adesso vi unirete in gruppi per una serie di esperimenti», lo sentii pronunciare ad un certo punto, e capii subito quanto quell’idea avrebbe potuto finire per ritorcersi contro di noi. Non sapevo cosa volessero Erica ed Isaac, ma ero sicura del fatto che dovessero restare lontani da Lydia. E sarebbe stato davvero molto difficile far sì che ciò succedesse, con Harris che poteva posizionarla a caso con uno dei due – o peggio con entrambi. Forse fu anche per questo che nel panico improvviso da “Voglio accalappiarmi il compagno migliore” che colpì l’intera classe, subito scattai in piedi, ben decisa ad occupare il posto di fianco ad Isaac che Erica aveva lasciato vuoto per sedersi – proprio come da ordine di Harris – al fianco di Scott. Mi confusi facilmente fra la folla di studenti quasi impazziti ed ero già a meno di un passo dal banco di Isaac quando ahimè mi sentii afferrare davvero poco dolcemente per un polso. «Non ci provare nemmeno». Non ebbi nemmeno bisogno di voltarmi a guardare Stiles per capire che appartenesse proprio a lui quel tono di voce scocciato ed infastidito. Sospirai sconfitta, voltandomi a guardarlo subito dopo aver visto il posto di Isaac riempirsi. Per quel giro avevo perso la mia occasione. Sconsolata, presi posto di fianco a Stiles. Non avevo la minima voglia di sorbirmi un’altra delle sue prediche, eppure sapevo che di lì a poco me ne avrebbe riservata una. «Qualunque cosa succeda, sta’ lontana da Isaac. E da Erica», ordinò, cercando i miei occhi scuri nonostante quanto provassi a sfuggirgli. «Harry, mi hai capito?». Aveva alzato la voce molto più di quanto mi sarei aspettata e non potei far altro che sobbalzare sotto il suo tono, mentre mi voltavo di scatto a cercare il viso di Stiles. «Cosa vogliono da Lydia?», pigolai, confusa e spaventata a dir poco. «Derek crede che sia lei il kanima. Isaac ed Erica hanno il compito di provare ad immobilizzarla», spiegò Stiles, fingendosi comunque indaffarato col progetto assegnatoci da Harris mentre io al contrario ero incapace di muovere anche solo mezzo muscolo. «Se il veleno non fa effetto, allora è lei». «Ma–». La mia replica mi rimase bloccata in gola a causa di Harris, togliendomi il respiro e facendomi sentire proprio come se stessi all’improvviso soffocando sotto lo sguardo chiarissimo del mio professore di chimica. «Mi dispiace, piccioncini», soffiò, osservando me e Stiles l’uno di fianco all’altra pochi secondi prima di riportare gli occhi nei miei. «Carter, tu con Lahey». Non appena il prof finì di parlare, Stiles s’irrigidì al mio fianco e una sua mano corse nuovamente a stringermi il polso. Uno dei suoi incubi peggiori si era appena avverato, ma io proprio non potevo dire altrettanto. Volevo parlare con Isaac e paradossalmente, Harris aveva appena esaudito il mio desiderio. Mi feci lontana da Stiles con un’ultima occhiata dispiaciuta, poi presi velocemente il posto del compagno di Isaac. Sentivo gli occhi di Stiles incendiarmi la schiena, ma non importava quanto si sarebbe preoccupato per me: sapevo badare a me stessa e potevo aiutarli a proteggere Lydia; volevo che lo capisse anche lui. «I-Isaac», balbettai quando gli fui al fianco, cercando di non farmi intimidire troppo dalla sua figura ora così spaventosa. Non potevo credere che fosse cambiato così tanto – anche lui; che un morso fosse bastato a renderlo ciò che non era affatto. «Non farlo». Isaac si voltò subito verso di me, piantandomi gli occhi azzurrissimi sul viso. Il suo sguardo mi mise a dir poco in imbarazzo, tanto che provai il forte impulso di interrompere quel contatto visivo tanto invadente. Lo sentivo quasi come se volesse guardarmi dentro e non andava bene: non potevo scoprirmi così tanto. «Non fare cosa, Harriet?», mi chiese in un sussurro, facendosi molto più vicino a me di quanto sarei riuscita a sopportare. Tanto che indietreggiai d’istinto, muovendomi sull’alto sgabello del laboratorio di chimica col cuore che mi batteva ormai a mille. Ero sicura che Isaac potesse sentirlo distintamente e che si compiacque dell’effetto che mi stava facendo, perché lo vidi nascondere malamente un sorrisino soddisfatto. Il che mi fece infuriare all’improvviso. Chi diavolo si credeva di essere? Non gli avrei permesso di prendersi gioco della sottoscritta! «Lo sai che Lydia non è colpevole», sputai quasi, sostenendo il suo sguardo senza più paura e facendo scorta di tutto il coraggio che m’era rimasto. Dovevo mostrarmi forte, senza più vacillare. Non potevo dargli quell’ennesima soddisfazione. «Proprio come non lo eri tu per la morte di tuo padre». Speravo che puntare sulla compassione avrebbe dato i suoi frutti, ma Isaac era sul serio cambiato tanto quanto temevo. Lo vidi restare totalmente impassibile di fronte alla menzione del padre: addirittura scrollò le spalle come se niente fosse e prese a giocare con una delle ampolle posizionate di fronte a noi. Inutile dire che non ci stessimo dedicando per niente al progetto di Harris, ma ovviamente avevamo entrambi cose molto più importanti alle quali pensare. «Non si tratta proprio della stessa cosa, credo». «È esattamente la stessa cosa. Lydia è solo una ragazzina. Lo siamo tutti». A quel punto, gli occhi di Isaac tornarono subito nei miei. E di nuovo l’intensità di quelle iridi azzurre mi fece vacillare, per quanto odiassi la cosa da morire. «È una ragazzina che, molto probabilmente, quando vuole si trasforma in una lucertola mannara e va in giro ad uccidere gente. Dobbiamo solo fare una piccola prova per accertarci che Lydia sia sul serio tanto innocente quanto credi. Non la uccideremo, Harriet. Per ora». L’improvviso ding della campanella di Harris mi fece sobbalzare, spezzandomi il respiro in gola ed impedendomi ancora una volta di replicare a quanto mi era stato detto. Rimasi per molto più tempo del lecito con gli occhi sgranati fissi in quelli di Isaac, convinta sempre più di non essere riuscita a risolvere niente per quanto lo volessi. Mi aveva detto che non avrebbero ucciso Lydia… Per ora. Riuscii a scivolare via da quel banco solo quando Stiles mi raggiunse, sfiorandomi lievemente la spalla e riportandomi finalmente alla realtà. Cercai di sorridergli grata, ma ero così tanto immobilizzata dalla paura che non ebbi nemmeno il coraggio di guardarlo in viso mentre correvo quasi verso uno dei pochi banchi vuoti dell’aula. Sapevo che le mie speranze fossero più che vane, ma nel profondo desideravo di poter restare sola per almeno quel giro. Quando lo sgabello di fianco a me si riempì, quindi, non potei far altro che trattenere un sospiro sconfitto. «Oh», mormorai, incapace di aggiungere qualcos’altro di più intelligente nel momento in cui mi ritrovai di fianco nientemeno che il ragazzo che aveva parlato con Allison pochi giorni prima, complimentandosi con lei per l’abito nero che avrebbe indossato al funerale di sua zia Kate. «Sei tu», aggiunsi, sentendomi ancora più stupida per quella battuta senz’altro inopportuna. Il ragazzo annuì, poi mi fissò a lungo coi suoi intensi occhi verde mela. «Non credo che abbiamo avuto già occasione di presentarci», mormorò infine, facendosi vicino a me tanto che fui subito costretta a porgergli una mano. «Sono Harriet». «Matt», ricambiò la mia stretta, poco prima di ritirarsi al suo posto come desideravo, «Conosci mio fratello, vero?». Ancora lievemente scombussolata da tutto quello che stava succedendo, mi voltai a cercare il viso pallido di Matt con le sopracciglia aggrottate. Suo fratello? «Scusami, non ti seguo», sussurrai infine, sospirando mentre fingevo di interessarmi ai rimproveri di Harris. «Vi ho visti insieme alla partita di lacrosse! Ma forse mi sono semplicemente sbagliato», spiegò Matt, e il suo parlarmi della partita di lacrosse fece illuminare una spia di pericolo nella mia mente. «Fai finta che non ti abbia detto…». Lo interruppi prima che potesse finire. Speravo di sbagliarmi – anche se ne dubitavo – ma non potevo permettergli di cambiare argomento finché non avessi scoperto la verità. «Aspetta», gli ordinai frettolosamente, correndo a stringergli in maniera del tutto involontaria un braccio tra le dita. «Come si chiama tuo fratello?». «Victor». Il silenzio nel quale mi rinchiusi, con gli occhi sgranati e la bocca all’improvviso prosciugata, diede a Matt il permesso di portare avanti quella conversazione come se niente fosse. «Allora, lo conosci?». Avrei dovuto rispondergli e lo sapevo. Ma non ne ero in grado, e quasi sorrisi riconoscente ad Harris quando – con l’ennesima scampanellata – affermò che fosse giunto il tempo di un altro scambio di coppia. Scappai da Matt e dall’intera classe con passi concitati e il fiato corto, mentre ancora sentivo la domanda del fratello di Victor rimbombarmi in testa. «Lo conosci?». Purtroppo sì. Lydia sta andando dalla Morrell per una consulenza. Fatti trovare lì molto CASUALMENTE, se puoi. Spero tu stia bene. Lessi il messaggio di Stiles così tante volte da non riuscire a tenere più il conto, con un sorriso soddisfatto che mi piegava le labbra sempre più ad ogni rilettura. “Spero tu stia bene” mi aveva scritto, e già solo da quelle parole potevo capire quanto fosse preoccupato per me – ancora. Sapevo che fosse una cosa stupida ed infantile, ma puntualmente non potevo che essere felice di come Stiles si preoccupasse sempre per me, anche se alle volte me lo meritavo davvero troppo poco. Scossi la testa, grata di potermi distrarre dal mio vagabondaggio fitto di pensieri cupi e decisa a dedicarmi al compito che mi aveva affidato Stiles mentre mi dirigevo a passi spediti verso l’ufficio della professoressa Morrell. Leggere il suo nome sul display del mio cellulare aveva illuminato una lampadina nella mia mente: giacché Lydia era lì, avrei potuto approfittarne per parlarle. Due piccioni con una fava. Fu solo quando finalmente giunsi alla meta che mi resi conto di aver corso decisamente troppo, nemmeno stessi scappando da una valanga di problemi che avrebbe finito poi per sommergermi e togliermi il respiro. Avevo il fiato corto e i capelli scompigliati, ma nel non individuare da nessuna parte la graziosa figura di Lydia Martin proprio non riuscii a tranquillizzarmi subito come avevo sperato di fare. Mi aggirai invece con passi pesanti nella sala d’attesa dello studio, finché non decisi di fronteggiare la porta d’ingresso dell’ufficio e la vidi attraverso il vetro. Lydia sedeva di fronte a Marin Morrell e mentre quest’ultima le mostrava dei fogli, aveva in viso l’aria più scocciata di sempre. Dovetti trattenere una risatina di fronte a quella scena, mentre liberavo un sospiro sollevato all’improvvisa consapevolezza che Lydia stava bene ed era al sicuro. Decisi che l’avrei aspettata finché non fosse uscita, per poi inventarmi qualcosa che avrebbe giustificato il mio seguirla in ogni dove per il resto di quella stressante giornata. Stavo ancora pensando ad una scusa fattibile quando la voce di Lydia m’inchiodò sul posto, facendomi sobbalzare sulla sedia che avevo occupato alcuni minuti prima, innervosita dal mio stesso vagare per l’intera sala d’attesa. «Cosa ci fai tu qui?», mi domandò, ed io subito smisi di torturarmi le unghie come facevo sempre quand’ero persa nei miei pensieri per cercare i suoi occhi verdi. Vidi Lydia scrutarmi con un’aria un tantino disturbata, mentre incrociava le braccia al petto e faceva scontrare la punta dei suoi stivaletti in pelle sulla moquette della sala. «E-Ehi», mormorai, con la voce quasi tremante mentre cercavo di sostenere il suo sguardo. Alle volte Lydia Martin mi metteva ancora i brividi. «Com’è andata?». «Solito», scrollò le spalle, infossando poi le mani nelle tasche della giacca, «Mi hai seguita?». «NO!», quasi esplosi, «Devo parlare anch’io con la Morrell. Mi aspetti?». «Se non ci metti un’eternità». Riservai un sorriso vago a Lydia, felice del fatto che non avessi dovuto insistere per trattenerla lì con me. Mentre mi dirigevo verso l’ufficio della nostra professoressa di francese con lunghi passi pesanti, l’osservai che prendeva posto su una delle tante sedie nella sala d’attesa e cominciava ad arricciarsi una ciocca di capelli attorno all’indice con aria annoiatissima. Ma più mi avvicinavo alla Morrell e meno pensavo a Lydia, finché – di fronte al legno della porta d’ingresso – l’immagine della Martin venne completamente spazzata via dalla mia mente per essere sostituita da un forte nervosismo. Volevo davvero parlare con la mia tutor? E per dirle cosa, esattamente? Non ebbi nemmeno tempo di pensarci né di scappare come avrei voluto fare in realtà che già avevo – quasi senza rendermene conto – annunciato la mia presenza con un paio di colpi sul legno ed oltrepassato la porta sotto invito di Marin. «Harriet!», mi disse proprio lei non appena mi riconobbe, riservandomi un grande e bellissimo sorriso. «Accomodati pure». Di nuovo feci come mi diceva, prendendo posto di fronte a lei mentre cercavo di non evitare troppo il suo caldo sguardo marrone. Ma solo quando la Morrell mi rivolse di nuovo parola capii di non poter più fuggire. «Ho bisogno di parlarle», mormorai quindi, torturando l’orlo della mia felpa mentre non osavo distogliere gli occhi dal viso della mia prof. «Sono qui per questo», mi rassicurò subito lei, sempre sorridendo. «Solo vorrei capire in che veste. Professoressa, psicologa, tua tutor?». Mi mossi a disagio sulla sedia, deglutendo rumorosamente mentre mi chiedevo quante altre personalità avesse la Morrell oltre alle tre che mi aveva appena elencato. Sapevo per certo che ne avesse almeno un’altra e non aspettai più a dirglielo: subito scoprii le mie carte. «Vorrei che mi parlasse come amica di mio nonno». Per quanto fosse brava a non farsi scalfire mai da nulla, quella volta anche Marin dovette piegarsi all’immensa sorpresa che l’aveva colta. L’osservai boccheggiare per qualche attimo, mentre cercavo di capire cosa volessi sentire o veder succedere. Non ne avevo idea. «L’hai saputo, quindi», mormorò infine la professoressa, lasciando che annuissi per darle una conferma della quale non aveva poi così bisogno. «Me l’ha detto lui». «E cosa vuoi che aggiunga?». Non aveva intenzione di aprirsi. Scrollai le spalle. «Non lo so. Mi dica lei se c’è qualcos’altro da aggiungere. Qualcos’altro che non so». Perché era proprio quello che temevo di più: i segreti. Temevo ce ne fossero molti altri e avevo bisogno di risposte, prima che queste mi venissero gettate addosso nel mio momento di maggior debolezza, cogliendomi impreparata e lasciandomi ferita e scandalizzata – com’era già successo. Non so se Marin colse il mio terrore, fatto sta che non fece nulla per farlo diminuire. Al contrario, col suo “lavarsi le mani” non fece altro che spaventarmi ancor di più. «Non è compito mio parlarti di cose che non mi riguardano, Harriet. Ho organizzato il corso di Intercultura per riportarti qui a Beacon Hills e ho fatto in modo che alla fine ci fossero alte probabilità che venissi scelta proprio tu, perché me l’aveva chiesto Thomas. Ci conosciamo da un sacco di tempo e non dico mai di no agli amici». Quella era una storia che avevo già sentito e non avevo intenzione di ascoltarla nuovamente. Volevo sapere di più. «Quindi non l’ha fatto anche lei per un suo tornaconto?», chiesi, quasi provocandola perché volevo che si scoprisse. Ma ancora una volta Marin Morrell non cedette. La vidi trattenere un sorrisino mentre scuoteva la testa con aria divertita per poi prepararsi a rispondermi nuovamente. «Senz’offesa, Harriet, ma non vedo cosa potrei guadagnare dalla tua presenza qui», mormorò. «L’ho fatto per poter aiutare la tua famiglia. Loro hanno bisogno di te». A quelle ultime quattro parole fui io, invece, a cedere. Mollai la presa e distolsi lo sguardo dalla professoressa come già volevo fare da tempo, guardandomi intorno finché i miei occhi corsero al vetro della porta d’ingresso dell’ufficio e una felpa a righe grigie e nere catturò tutta la mia attenzione. Era Stiles. Smisi immediatamente di torturarmi l’interno guancia e scattai in piedi, mentre salutavo frettolosamente la Morrell e quasi correvo fuori, sperando di non essermi sbagliata. Avevo bisogno che Stiles fosse lì e nemmeno sapevo bene perché. Scoprii che le mie richieste fossero state – grazie a Dio – esaudite quando lo vidi intento a supplicare Lydia, la quale alla fine decise di cedere alle sue preghiere e lasciò che lui la trascinasse verso chissà dove. Riuscii a fermarli per un soffio. «Dove andate?». Lydia fu la prima a darmi le attenzioni che cercavo. «In biblioteca, a quanto pare», borbottò, alzando gli occhi al cielo. «Vengo con voi». Ci provai. Ma scoprii presto che Stiles avesse, ancora una volta, piani ben diversi per la sottoscritta. «No, resta qui. Sta arrivando Allison», mi disse, e mi bastò guardarlo negli occhi per capire che nemmeno quella volta avrei potuto dirgli di no. Quindi lo lasciai andare: lo vidi che conduceva una scocciata Lydia per i corridoi della Beacon Hills High School e desiderai stupidamente che al contrario potesse essere rimasto lì con me mentre aspettavo Allison, completamente da sola. Avevo all’improvviso un forte bisogno di parlare con qualcuno. E avevo sperato inutilmente che quel qualcuno potesse essere Stiles. «Che cosa fai?». Stiles mi sembrò all’improvviso così tanto preoccupato che subito, non appena lo sentii parlare, smisi di osservare Derek e il resto del suo branco attraverso il vetro che fino a quel momento ci eravamo contesi, entrambi ben decisi a tenere costantemente d’occhio la situazione. Sapevo non ce l’avesse con me – non avevo fatto nulla – perciò mi limitai a cercare la figura di Allison. La trovai ancora accanto a noi, che tratteneva lacrime e stringeva tra le mani tremanti il proprio cellulare. Mi si strinse immediatamente il cuore a quella vista. «Credo…», cominciò a spiegare, ma la sua voce tremolante si perse immediatamente nel vuoto. «Devo chiamare mio padre». Stiles si animò immediatamente. «Ma se ti trova qui, Scott–». Allison nemmeno lo lasciò finire. «Lo so. Ma cosa dovremmo fare? Non sono qui per spaventarci!», pigolò, esausta mentre puntava nuovamente all’esterno di casa McCall. Subito dopo scuola ci eravamo tutti – compresi Jackson e Lydia – rifugiati lì, ma Derek e i suoi beta ci avevano trovati in un batter d’occhio. Di nuovo li osservai attraverso il vetro della porta d’ingresso: non si erano mossi dal vialetto, erano lì per uccidere Lydia – che aveva fallito il test – e lo sapevamo bene tutti. «Non le faranno del male», mi sentii quasi in dovere di dire, mentre tornavo dritta per cercare lo sguardo terrorizzato di Allison. «Ora vado lì fuori e gli parlo». Avevo già una mano sulla maniglia ed ero ben decisa a portare avanti il mio piano – ancora ero convinta che le mie parole potessero sul serio servire a qualcosa, che Derek mi avrebbe dato ascolto quando invece non aveva voluto accontentare nemmeno Scott – quando una mano di Stiles corse nuovamente a stringermi il polso. «Sei impazzita?», mi chiese, impedendomi di muovermi e costringendomi al contrario ad indietreggiare, facendomi così lontana dalla porta e dal mio obbiettivo che dovetti trattenere un urlo di frustrazione. «Ho bisogno di parlargli, Stiles». Mi riferivo a Derek, ovviamente, ed ero così sincera che penso lo capirono tutti subito. Ma Stiles non cedette. «Dovrai fartelo passare. Non ti darò letteralmente in pasto ai lupi», borbottò, prima di voltarsi velocemente a fronteggiare Allison. «Ecco cosa faremo invece. Tu sparerai ad uno di loro». Lo sguardo color cioccolato della Argent non poté fare a meno di riempirsi subito di incredulità. I miei occhi scuri corsero invece alla balestra che ancora Allison stringeva tra le dita. Stiles voleva che la usasse. E anche se odiavo ammetterlo persino a me stessa, la sua era un’idea niente male. «Non pensano che reagiremo. Se uno di loro viene colpito, se ne andranno di sicuro. Dai, spara», aggiunse, avvalorando la sua tesi tanto da riuscire quasi a convincere Allison. «A chi?», le sentii chiedere, mentre ritornava ad osservare il branco attraverso il vetro. Stiles sembrò pensarci un po’ su, poi la imitò – subito seguito da me. «A Derek. Spara a lui. Possibilmente in testa». Subito strinsi tra le dita il merletto delle tendine di casa McCall, irritata a dir poco. Ma prima ancora che potessi intervenire, ci pensò Allison a bocciare quella stupida idea. «Se Scott ha afferrato una freccia, ci riuscirà anche Derek», obiettò, in tutta sincerità. Tanto che Stiles non poté far altro che sventolare bandiera bianca. «D’accordo, spara ad uno degli altri tre». «Erica». Non ebbi bisogno di pensarci su nemmeno per un attimo. Quel nome abbandonò le mie labbra subito, con così tanta facilità che quasi mi sorpresi di me stessa. Avrei voluto che Allison colpisse proprio lei, ma il mio lieve sussurro si perse nell’agitazione di ciò che successe subito dopo. «Vuoi dire “uno degli altri due”», mormorò Allison, e la vidi aggrottare le sopracciglia mentre ancora ispezionava il buio della strada su cui era posizionata casa McCall. Stiles scosse la testa. «Voglio dire tre». Non ci pensai su due volte. Tornai ad osservare l’esterno alla velocità della luce e ciò che vidi mi fece all’improvviso gelare il sangue nelle vene. Due beta. C’erano solo due beta al fianco di Derek. Erica e Boyd. «Dov’è Isaac?», chiesi infine, la voce resa tremolante dalla paura di una risposta che già credevo di conoscere troppo bene. Una risposta che arrivò solo pochissimi millesimi di secondi dopo, quando uno spostamento d’aria improvviso mi fece rabbrividire mentre sentivo Allison trattenere un urlo di terrore e provare inutilmente a difendersi dalla figura trasformata di Isaac Lahey. Mi voltai ad osservarli così velocemente da sentirmi la testa girare ed ebbi appena il tempo di vedere Allison che cadeva al suolo disarmata prima di rendermi conto che Isaac stesse puntando proprio a me. Ancora non so bene come diavolo ci riuscii, ma gli sfuggii. Semplicemente scivolai lontana dalla sua presa e corsi più veloce che potevo verso le scale, senza badare alla paura che mi attanagliava tutti i muscoli nella speranza di immobilizzarli per sempre o alla preoccupazione per Stiles e ciò che Isaac avrebbe potuto fargli mentre io fuggivo. Cercai di non pensare a niente e semplicemente corsi verso il piano di sopra, dove sapevo che avrei trovato Jackson e Lydia – erano loro che andavano protetti in quel momento, al resto avrei potuto pensare dopo. Ma non avevo fatto i conti con la nuova forza di Isaac, che subito dopo aver messo al tappeto anche Stiles mi raggiunse a metà della scalinata e mi afferrò una caviglia tanto forte da farmi gemere di dolore mentre lo sentivo distintamente trascinarmi indietro, finché non persi l’equilibrio e caddi di peso, battendo la testa su uno degli scalini tanto forte da credere di vedere addirittura le stelle. L’ultima cosa che vidi poco prima che tutto diventasse nero e mi lasciassi andare all’immensa stanchezza che mi aveva colta all’improvviso furono gli anfibi neri di Isaac, che scavalcava il mio corpo come se fosse nient’altro che una vecchia bambola di pezza e saliva al piano di sopra indisturbato. Ripresi conoscenza dopo quelle che mi parvero immediatamente delle ore. Sentivo la testa pulsare così tanto – ancora – che nonostante quanto fossi confusa e frastornata, mi ricordai subito perfettamente di cosa mi era capitato. Isaac. Quel nome risuonò nella mia mente come un ringhio, mentre digrignavo i denti con aria infastidita e cercavo inutilmente di muovermi. Ero ancora malamente gettata a terra, la testa dolorante e una guancia incollata allo scalino che avevo colpito nella mia violenta caduta. Per un attimo credetti che non mi sarei rialzata mai più, ma subito scacciai via quel pensiero: non era il momento adatto per essere debole. Raccolsi quanta più forza possibile nelle braccia, mettendomi seduta su uno degli scalini più in basso dopo immensi sforzi. Mi portai una mano alla testa velocemente, quasi sospirando dal sollievo quando riportando le dita di fronte ai miei occhi le trovai immacolate. Per un attimo avevo temuto di essermela rotta: il dolore era così tanto da rendermi sia la vista che i pensieri annebbiati. Ma a quanto pareva non stavo sanguinando, dunque nel peggiore dei casi mi sarei beccata nient’altro che un bel bernoccolo. Di nuovo decisi che non fosse quello il momento più giusto per pensarci. Mi guardai attorno velocemente, mentre un nuovo senso di paura correva a stringermi le viscere mentre mi rendevo conto di essere – almeno all’apparenza – completamente sola. Non c’era più traccia di Stiles né di Allison, perlomeno non lì. Allora i miei occhi corsero subito al piano di sopra. Era lì che dovevo andare e lo capii pienamente quando un paio di voci mi riempirono le orecchie: una delle due apparteneva ad Erica. Erano tutti ancora lì. Mi misi in piedi con non pochi sforzi, arrancando sugli scalini mentre mi tenevo ben stretta al corrimano in legno. Ma quando giunsi alla fine di quella rincorsa trovai di fronte ai miei occhi una scena abbastanza inaspettata. Erica Reyes era a terra, immobilizzata, mentre Allison si prendeva gioco di lei chinata alla sua altezza. «Credevo fossi una veggente», sentii che le sussurrava all’orecchio, e quell’ultima parola mi ghiacciò il sangue nelle vene così tanto che quando Allison individuò la mia figura sulla soglia della camera di Scott, ancora ero nient’altro che un’imperturbabile statua di sale. La consapevolezza di doverle dire tutto su chi ero sul serio mi aveva completamente e improvvisamente immobilizzata. «A proposito di veggenti, Als…», incominciai, pregando chiunque fosse in ascolto affinché potesse darmi tutta la forza che mi serviva per portare avanti quel discorso nel modo giusto. I wish you’d stop running away from your problems
and run to me instead. Ringraziamenti Grazie a Spotify e alla playlist Epic Classical che è tipo il Paradiso e mi ha aiutata tantissimo durante la stesura delle prime scene di questo capitolo, ma soprattutto grazie ai The story so far che mi sono ritornati in mente quando verso la fine ero come al solito in preda alla disperazione da: “Che cavolo di canzone inserisco stavolta?”. La May che dà il titolo al capitolo e che è citata alla fine appartiene a loro. Note Il Courier New sarà utilizzato sempre e solo per gli SMS, ammesso e non concesso che ce ne saranno degli altri. Questo capitolo mi convince davvero molto poco, ma era proprio necessario che lo scrivessi perché da come avrete potuto leggere voi stessi, parecchi nodi vengono al pettine e scopriamo sempre nuove cose. Harry confronta la Morrell, Victor ha finalmente un motivo ben più che valido per essere parte di questa avventura e finalmente anche Allison scoprirà tutta la verità! A proposito di questo: succederà nella prima scena del capitolo nuovo, nel quale tra l’altro farà la sua apparizione un’altra delle nostre “vecchie” conoscenze. Chi pensate che possa essere? |
Capitolo 6
*** Confessions ***
Da parachute: Philip Carter era il nome di mio padre, l’uomo che, dopo aver visto mia madre mettere alla luce Cassandra e in seguito me, aveva deciso pochi giorni dopo la mia nascita di essere più interessato alla sua carriera di musicista che alle tre donne della sua vita. Non l’avevo mai conosciuto né credevo ne avrei mai avuto l’occasione.
 Philip Carter era lì di fronte a me.  «Sono scappato in Texas perché volevo disperatamente una vita normale, che non avesse niente a che fare col soprannaturale di cui è piena Beacon Hills. Credo che almeno da questo punto di vista potrai capirmi […]. Ero un secondogenito costretto ad ereditare poteri che non volevo e a vivere una vita che era stata già programmata per me e non avrei mai – mai – sopportato di vederti fare la stessa fine. Quando sei nata, io… ho avuto paura. Tanta paura. E lo so – lo so – che ho sbagliato, e mi dispiace, sul serio: te lo giuro. Ma non sarei stato in grado di fare nient’altro» […]. «ho una sorpresa per te: non solo i secondogeniti possono ereditare poteri di chiaroveggenza. Avrebbe potuto averne anche Cassandra. Ma tu no, hai lasciato la tua famiglia senza informarti sulla cosa e hai lasciato noi compiendo lo stesso sbaglio un’altra volta ancora. Ci hai abbandonate per nulla, ne sei consapevole? […]». kaleidoscope
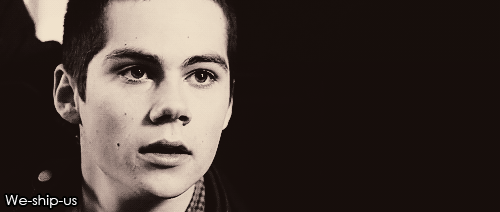 6. Confessions
«Non ci posso credere». Quattro parole. Quattro parole in risposta al monologo di mezz’ora che avevo messo su per spiegare tutto ad Allison, per mettere anche lei – una delle migliori amiche che avessi – al corrente di quasi tutto quello che per decisamente fin troppo tempo le avevo nascosto. O meglio, per metterla al corrente di tutto quello che fino a quel momento avevo omesso di dirle. Strinsi i pugni lungo i fianchi ed indurii la mascella, sentendomi la testa pulsare con una fitta ben più dolorosa delle altre. Avrei solo voluto trovare Stiles e farla finita, rifugiarmi a casa e dormire più o meno per sempre – perlomeno, finché non fossi stata meglio – ma non potevo: avevo delle confessioni con le quali dover fare i conti. Ricercai lo sguardo di Allison: non si era mossa di un millimetro ma ancora tremava, gli occhi lucidi e l’aria a dir poco sbalordita. Potevo capire quanto per lei fosse dura dover fare i conti con quell’amara scoperta – avevo affrontato anch’io quella situazione e ancora credevo di non averla pienamente superata – ma ciò che le avevo detto era la verità, e avevo assolutamente bisogno che lei lo capisse. Ecco perché non esitai a dirglielo. «È la verità, Allison», pronunciai in un sussurro tremolante, ma la Argent non ebbe alcuna reazione. Ed io presi quel suo silenzio di tomba come un ennesimo invito a portare avanti quella conversazione. «Io–». «Sta’ zitta». Ma quando Allison mi interruppe bruscamente – prima ancora che potessi cominciare sul serio – capii di aver totalmente frainteso il suo atteggiamento. «Posso dimostrartelo», soffiai, mentre già sentivo la speranza abbandonarmi. Cosa avrei fatto se non mi avesse creduta? Oppure se credendomi, Allison si sarebbe convinta del fatto che fossi troppo pericolosa perché potessimo restare amiche? Cosa avrei fatto se mi avesse abbandonata? Non riuscivo nemmeno ad immaginarlo. Non potevo perderla. «Stai zitta, Harry. Per favore, solo un attimo. Ho bisogno di… metabolizzare. Non è che non ti creda. Perché non dovrei? Perché mai dovresti dirmi certe cazzate?». Ripresi colorito sempre più ad ogni nuova parola di Allison, liberando un sospiro involontario verso la fine del suo fiume di domande. Mi credeva. Mi sentii all’improvviso così tanto sollevata da dover trattenere un sorriso. Ma evitai di aggiungere qualcos’altro. «Una chiaroveggente. La mia migliore amica. Un licantropo. Il mio ragazzo». … e ci pensò Allison a portare avanti quella conversazione. «Mio Dio. Stiles cosa diavolo è?». Ridacchiai divertita a quella domanda, ma mi ricomposi quasi subito. Purtroppo non c’era tempo per scherzare. «Stiles è semplicemente Stiles», e lo capì anche Allison non appena finii di parlare. La osservai mentre si prendeva la testa tra le mani con aria combattuta, scompigliandosi i capelli e prendendo a svarionare. Sciorinò un sacco di frasi confuse che non riuscii a cogliere mentre la guardavo roteare su stessa e cominciavo a sentirmi impotente. Dovevo aiutarla a capire. Assolutamente. «Pensa a qualcosa!», trillai all’improvviso, e il mio tono di voce risvegliò immediatamente Allison dalla sua trance. «Come?», pigolò, voltandosi a guardarmi con un’espressione a dir poco confusa in viso. «Pensa…», cominciai, ma mi resi conto subito della mia gaffe. «No, non pensare. Non sono ancora in grado di leggere la mente». Vidi subito gli occhi color cioccolato di Allison sgranarsi, riempiti dalla sorpresa sempre più. «Non ancora? Ciò significa che potresti?». Mi strinsi nelle spalle. Non ero sicura di quella cosa, ma così mi avevano detto mio nonno e Walt. E tali parole avrei riferito ad Allison. «Se mi impegnassi a fondo, sì». «Oh mio Dio». Prima che potesse riprendere a sclerare, la distrassi. «Pensa a qualcosa che farai». «Nell’immediato futuro?». «Anche fra trenta secondi». «O domani?». Annuii. «O doman–», provai a dirle, ma le parole mi morirono in gola alle immagini improvvise che mi riempirono la retina, accompagnate da una fitta lancinante alla testa. Quello che vidi era un posto che conoscevo fin troppo bene: avvolto dalla natura, ricolmo di panchine in marmo e con esattamente al centro una fontana bellissima. Era il parco di Beacon Hills; Stiles mi ci aveva portata durante una delle poche tranquille domeniche che eravamo riusciti a trascorrere insieme ed io mi ero totalmente innamorata del posto. Mi portai le dita alla tempia gelata, cercando di concentrarmi a fondo affinché quella visione improvvisa non svanisse. E fu allora che li vidi: Allison e Scott, abbracciati all’ombra di un salice piangente. Oh mio Dio. «Vuoi andare al parco con Scott, domenica. Ma non è un posto troppo affollato? Gli uomini di tuo padre sono…». Ovunque. Questo avrei voluto dire. Ma Allison non mi lasciò il tempo di finire. «Non se ci imboschiamo sulla collin–oh mio Dio. Come diavolo… Non l’avevo detto nemmeno a Scott!», disse, sempre più infervorata ogni secondo che passava. C’avevo visto giusto, ancora una volta. «Posso prevedere il futuro, Als. È la verità», le ripetei, ben sapendo che a quel punto non avrebbe più avuto motivo di dubitare di me. «Anche quand’è così incerto?», mi domandò, ed io non potei far altro che annuire lievemente. «Perché non me l’hai detto prima?». Scrollai le spalle, distogliendo gli occhi da quelli color cioccolato di Allison prima che lei potesse leggere nei miei l’ombra del senso di colpa. «Non mi sembrava mai il momento adatto per farlo. Stanno succedendo un sacco di altre cose. E tu hai già i tuoi problemi». Con la coda dell’occhio, vidi Allison scuotere la testa con aria vagamente infastidita. Poi mi si avvicinò e allora dovetti per forza riprendere a guardarla. «E tu i tuoi, Harry», osservò, stringendomi un braccio. «Sono tua amica e voglio esserci sempre per te. È questo che fanno le amiche, no? Si sostengono a vicenda». «È per questo che ho deciso di dirti tutto», e le sorrisi sinceramente, incapace di fare altro. Allison non ci pensò su due volte a ricambiarmi. «Chi altro lo sa?». «Stiles, ovviamente. E Scott. Anche Derek. E penso che Jackson sospetti qualcosa», conclusi, ripensando con un vago senso di paura alla sera del Ballo d’Inverno, quando avevo usato i miei poteri di fronte ad un confusissimo Jackson. Sapevo che qualche dubbio su cosa fossi sul serio gli fosse rimasto, ma non aveva mai osato chiedermi nulla. Semplicemente non gli interessava. O perlomeno così credevo. «Siamo un gruppo ristretto, allora», proclamò Allison, e quella sua frase mi strappò subito un brivido. Non eravamo un gruppo così ristretto come credeva lei. C’erano anche i Carter: la mia famiglia. Anche loro erano a conoscenza di tutto. Ma non lo dissi ad Allison. Ancora una volta decisi di omettere alcune verità. Mossi le mani sul petto di Stiles quanto bastava a farlo indietreggiare, portandolo lontano da me di modo che le nostre labbra non fossero più un tutt’uno. Era domenica sera ed eravamo soli in casa, nel letto di Stiles e… la situazione rischiava un attimo di sfuggirci di mano. A meno che non mi fossi al più presto inventata qualcosa per distrarlo dal nostro piacevole intrattenimento. Col respiro corto mi guardai attorno nella stanza in penombra, cercando affannosamente un qualsiasi pretesto di chiacchiera. Tutto pur di non pensare più a quante cose avremmo potuto fare in quella stanza, su quel letto… «Hai fatto i compiti?», chiesi all’improvviso, con la voce così stridula che Stiles non poté fare a meno di sgranare gli occhi, preoccupato. Ancora lo tenevo lontano dal mio viso con le mani, ma non appena mi sentì parlare provò di nuovo a riavvicinarsi a me. Cosa che gli impedii, stringendogli più forte la felpa pesante tra le dita. «Harry, dai», tentò di pregarmi, ma non avevo intenzione di desistere. «Seriamente», mi leccai le labbra secche, sperando di racimolare il minimo di forza di volontà che mi sarebbe servito per portare avanti quel discorso senza capo né coda, «Li hai fatti? C’è un esercizio di chimica che…». «D’accordo, che succede?». «Niente!». Di nuovo il tono di voce stridulo e poco convincente. Mi maledii mentalmente per il mio essere così poco brava a raccontare cazzate mentre Stiles si liberava dalla mia stretta, allontanandosi da me fin troppo. Volevo che mi stesse lontano, ma non così tanto. Sospirai. Me l’ero andata a cercare. «È stata una settimana infernale, scusami», borbottai quasi dopo un po’, cercando di scacciare dalla mente le immagini confuse di quegli ultimi sette giorni – dai quali ancora non sapevo come avessi fatto ad uscire viva. Stiles sembrò percepire il mio stato d’animo, perché subito vi ci si adattò e mi ritornò vicino, tranquillizzandomi – come sempre – con la sua sola presenza. «Non preoccuparti», sussurrò vicinissimo al mio viso, accarezzandomi una guancia così lievemente che per un attimo credetti di aver solo immaginato quel tocco. Gli sorrisi, seppur non molto convinta, sollevandomi poi quanto bastava a raggiungere le sue labbra. Mi bastò riprendere a baciarlo perché decidessi di mandare al diavolo una volta per tutte ogni mia inutile paturnia mentale. Stiles – inutile dirlo – sembrò apprezzare immediatamente, perché non ci pensò su due volte prima di ricambiare il mio bacio. Gli strinsi le braccia attorno al collo, sollevandomi poi quanto bastava a rendermi facile il colpo di reni che ribaltò completamente la situazione. Sorrisi, sistemandomi meglio sulle gambe di Stiles mentre le sue mani correvano a stringermi dolcemente i fianchi. Ma prima ancora che potessi spegnere il cervello completamente, ciò che vidi mi distrasse di nuovo. «Non hai ancora cominciato i compiti», osservai, facendomi lontana dalle labbra di Stiles con aria preoccupata. Speravo di sbagliarmi, eppure sapevo nel profondo che non fosse così. Ormai conoscevo Stiles tanto bene da sapere che quando la sua cameretta era così in ordine – senza libri rovesciati ovunque e lo zaino sottosopra – era solo perché non aveva guardato nemmeno di striscio i suoi compiti. E per quanto stupido potesse sembrare, non volevo che trascurasse la scuola. Stiles sbuffò, contrariato da quel mio comportamento assillante. Poi si tuffò di schiena sul letto, affondando nel cuscino a cui era tanto affezionato da avergli dato addirittura un nome. Per un attimo quel pensiero mi fece sorridere intenerita. «No, mamma, non li ho ancora cominciati. Contenta?», borbottò infine distraendomi. «Sono già le nove di sera, Stiles». «E quindi? Li farò dopo cena, promesso. Non ne abbiamo nemmeno così tanti». Mi mossi – quasi a disagio – sulle sue gambe, puntandogli le mani a palmi aperti sul petto per potermi sostenere meglio. Ciò che stavo per dire non gli sarebbe piaciuto per niente, ma ancora una volta speravo inutilmente che le mie supposizioni fossero sbagliate. «Ti sei dimenticato dell’analisi di francese». E la mia non era certo una domanda. «Quale… Oh merda». Scossi brevemente la testa, poi feci per mettermi in piedi, ma Stiles me lo impedì afferrandomi velocemente un polso. «Dove vai?». Gli donai subito un’occhiata incredula, come a chiedergli silenziosamente se mi avesse sul serio appena fatto una domanda tanto stupida. «A prendere la mia analisi, no? Almeno la copi», spiegai spicciola. Possibile che non ci arrivasse? Feci per liberarmi dalla sua stretta, ma Stiles al contrario l’intensificò ancor di più, attirandomi di nuovo sulle sue gambe. «Resta ancora un po’ qui, dai. Tra poco ci mangiamo qualcosa di veloce e poi facciamo i compiti». «Stiles…». Non potevo cedere. Non– «Papà tornerà a notte fonda, possiamo restare svegli quanto vogliamo». Ma certo che potevo cedere. «Ti odio», mormorai, ritornando al mio posto e cercando nuovamente le sue labbra. E lo odiavo davvero, perché che mi piacesse o no alla fine l’aveva sempre vinta lui e sentirmi così debole tra le sue mani mi metteva addosso una paura non indifferente. Stiles aveva così tanto potere su di me da terrorizzarmi. «Dovresti dimostrarmi più spesso il tuo odio, se i presupposti sono questi», lo sentii sussurrare ad un passo dalle mie labbra, quando ci separammo alla ricerca di ossigeno. «Scemo», borbottai, lasciandogli una manata sul petto mentre mi rimettevo di schiena. Cambiai idea subito, però, preferendo rifugiarmi sul petto di Stiles, che mi accolse tra le sue braccia senza farselo ripetere due volte. Sorrisi, socchiudendo gli occhi mentre mi sistemavo meglio contro il suo corpo, almeno finché… «Cavoli, hai i piedi gelati!». … i miei piedi non sfiorarono quelli nudi di Stiles. Lo sentii sollevare la testa per osservarli, per poi tornare a guardare il mio viso con gli occhi sgranati dalla sorpresa. «E le calze di lana», aggiunse, non riuscendo proprio a credere che nonostante le calze i miei piedi potessero essere sul serio così freddi. Eppure era quella la triste verità. Sorrisi divertita, tirando fuori le mani dalle lunghissime maniche della felpa a righe di Stiles. Era pieno novembre e avevo freddissimo, quindi gliel’avevo rubata con estremo piacere – anche perché era bellissima. «Ho anche le mani fredde», gli dissi, porgendogliele e permettendogli di prenderle tra le sue, grandissime e calde. «Sempre». «Povera piccola», osservò Stiles, portandosi le mie mani alle labbra e lasciando un bacio sul palmo che immediatamente mi fece andare a fuoco tanto che capii subito di non essere più in grado di parlare né di agire. Ma per fortuna ci pensò il campanello a salvarmi in calcio d’angolo. Sobbalzai al suono proveniente dalla porta d’ingresso, cercando velocemente lo sguardo ambrato di Stiles. «Chi potrà mai essere?». Lui subito scrollò le spalle, poi si mise in piedi velocemente. «Vado a vedere. Non ti muovere», ordinò, e prima ancora che me ne potessi rendere conto era sparito. Ancora un po’ scombussolata da tutti gli eventi di quell’ultimo quarto d’ora, feci come Stiles mi aveva chiesto, restandomene a letto a respirare il suo odore. Stiles era sul serio ovunque. Chiusi gli occhi, più stanca di quanto non mi fosse sembrato fino a quel momento, ma la mia calma durò decisamente troppo poco. Un paio di iridi azzurre mi riempirono la retina, accompagnate da una zazzera di capelli biondi e scompigliati che conoscevo davvero fin troppo bene. Sapevo benissimo chi fosse l’uomo della mia visione, e la sua giacca di pelle nera non fece altro che confermare ogni mio dubbio. «Harry». Aprii gli occhi di scatto quando sentii Stiles richiamare il mio nome, con un’aria trafelata che subito mi preoccupò non poco – aveva corso per raggiungermi. Mi misi seduta nel letto riservandogli un’occhiata confusa, ma prima ancora che potessi fargli anche solo mezza domanda, ci pensò lui a sanare qualsiasi dubbio. «Tuo padre è qui». Ed io l’avevo appena visto. «Erano secoli che non mettevo piede qui dentro». Quelle parole improvvise di Scott mi spinsero a sollevare lo sguardo dal menù plastificato che stavo osservando con attenzione estrema, alla ricerca infruttuosa di qualcosa di buono da ordinare. Era impossibile però che riuscissi a scegliere una sola di tutte quelle squisitezze. Quindi accettai di buon grado la distrazione che mi offrì Scott, subito seguito da Stiles. «Sapevo che avresti apprezzato», lo sentii dire infatti, mentre prendeva velocemente posto di fianco al suo migliore amico. Quel mercoledì – liberi stranamente presto da qualsiasi impegno scolastico – avevamo deciso di pranzare al Layla’s, un fast-food di Beacon Hills che a giudicare dalla carta da parati consumata in più punti e dall’arredamento molto anni ’50, aveva l’aria di essere lì da moltissimo tempo. Non era quello a renderlo un posto speciale, comunque, quanto più il fatto che fosse lontano quindici miglia dal centro abitato e dunque il posto perfetto per passare del tempo insieme ad Allison senza la paura costante che qualcuno dei suoi parenti potesse beccarci. «Di cosa state parlando?», domandò proprio lei all’improvviso, muovendosi di fianco a me sul comodo divanetto in pelle color salmone. Scott scrollò le spalle, riservandole una lunga occhiata. «Niente», liquidò. «Quando avevo dieci anni sono stato qui insieme ad una mia cara amica». «Oh, e chi è? La conosciamo?». Subito la curiosità prese possesso di me. Ma Scott si limitò a scuotere la testa. «No. Abbiamo perso tutti i contatti dopo che sono andato a vivere con mio padre quello stesso anno», raccontò, distogliendo lo sguardo dal mio viso sul finale e concentrandosi sul giallo acceso del tavolo che dividevamo in quattro, come se questo potesse svelargli chissà quale oscuro arcano. «Mi dispiace», sussurrai in automatico – quasi senza potermelo impedire – e allora gli occhi scuri di Scott corsero di nuovo a cercare i miei. Mi dispiaceva sul serio. «Non è nulla», scrollò nuovamente le spalle, «Passiamo ad argomenti seri. Cosa ne facciamo di Jackson?». Già, perché era quello il motivo principale del nostro pranzo improvvisato, no? Era principalmente a causa di Jackson che avevamo avuto bisogno di organizzare quella stramba riunione. Jackson che era il kanima, anche se inconsapevolmente. Jackson che non si era trasformato in licantropo ma in una creatura di gran lunga più pericolosa e soprattutto controllata da un padrone che non avevamo la minima idea di chi potesse essere. «Io continuo a proporre di ucciderlo», Stiles si fece avanti, sollevando una mano come se stesse partecipando ad una strana votazione. Subito lo fulminai con lo sguardo, incrociando più strette le braccia al petto. «Ed io continuo a bocciare la tua idea», borbottai, subito affiancata da Allison. Entrambe ci guadagnammo un’occhiataccia da parte di Stiles. Ma prima che potessimo prendere a bisticciare sul serio, Scott riportò la nostra attenzione su questioni di gran lunga più importanti. «Ragazzi, sul serio. Come abbiamo intenzione di aiutarlo? Sappiamo a malapena cos’è». «E nemmeno lui lo sa», aggiunsi. «Né ha idea di chi lo controlli». «O forse non lo ricorda». Forse. Non potevamo saperlo. Né quello né milioni di altre cose. Stiles sbuffò, adagiando la schiena contro il divanetto color salmone. «È convinto di essere un licantropo che non riesce a trasformarsi a causa di Lydia». «Gli facciamo capire che non è così?», domandò Allison, abbastanza retoricamente. Scott annuì. «Dobbiamo almeno provarci». «Non sarà facile per via dell’ordinanza restrittiva», borbottò Stiles, e al ricordo di quella pena inflittagli dal signor Whittemore – il divieto che avevano di quasi respirare la stessa aria di Jackson – un sorriso furbo m’increspò le labbra. Avevo avuto un’idea. «Voi avete un’ordinanza restrittiva nei confronti di Jackson», cominciai, indicando velocemente Scott e Stiles – che già avevo visto sbiancare un po’. «Io no». Jackson Whittemore avrebbe dovuto vedersela con la sottoscritta. «Lydia è riuscita a tradurre solo questo. Credetemi, era molto confusa». Continuai a scorrere i vari titoli esposti in quell’angolo della biblioteca di scuola, fingendomi disattenta ai bisbigli di Allison quando in realtà non stavo prestando attenzione a null’altro. Scott afferrò il tablet che lei gli porgeva, cominciando a leggere il testo del bestiario tradotto da Lydia – che, nemmeno troppo sorprendentemente, avevamo scoperto conoscesse un bel po’ di latino antico. «Cosa le hai detto?», domandò McCall, mentre Stiles accanto a lui fingeva di leggere un libro dall’aria molto polverosa. Allison scrollò le spalle, guardandosi ansiosamente intorno prima di riprendere a bisbigliare. Quegli incontri segreti erano un’ansia continua. «Che siamo tra i giocatori di una community online che combatte creature mitiche». A quella notizia Stiles si animò subito. «Io sono tra i giocatori di una community online che combatte creature mitiche», raccontò, ed io immediatamente mi ricordai di tutti i discorsi che mi aveva fatto su un certo videogioco chiamato LoL e su come avesse già inserito mio cugino Niall nella lista di persone che gli stavano simpatiche dopo che ci avevano giocato insieme a casa di mia zia Erin. Ridacchiai, ma l’entusiasmo generale fu subito smorzato da Scott, che velocemente riportò la nostra attenzione su questioni ben più serie. «C’è scritto come scoprire chi controlla il kanima?». «Non proprio. Ma Stiles ha ragione sugli omicidi». «Sì!», esultò Stiles, agitandosi così tanto che dovetti schiaffeggiarlo perché si calmasse. «Smettila», lo redarguii con un’occhiataccia, ritornando poi a fissare Allison affinché si spiegasse. Non avevamo molto tempo. «Il kanima viene chiamato “strumento di vendetta”. Lì è narrata la storia di un prete sudamericano che lo usava per le esecuzioni a morte nel suo villaggio…». «Bene. Visto? Forse non è poi così male», tentò Stiles, ma purtroppo nessuno di noi tre era speranzoso quanto lui. Allison in primis. «… finché il vincolo non divenne tanto forte da fargli uccidere chiunque volesse», continuò, e subito anche Stiles cambiò idea. «Male. Molto, molto male». «Il punto però è questo: il kanima in realtà dovrebbe essere un lupo mannaro, ma non può esserlo». A quel punto non potei far altro che aggrottare le sopracciglia, confusa. «Perché mai?», domandai, sperando che Allison potesse darmi la risposta giusta. Ma ci pensò Scott a sanare ogni mio dubbio. O quantomeno, ci provò. «“Finché non risolve ciò che nel suo passato lo ha fatto manifestare”», lesse, direttamente dal testo tradotto da Lydia. Quelle parole mi confusero ancor di più. «Cosa diavolo significa?». «Se questo vuol dire che Jackson ha bisogno di milioni di ore di terapia… Be’, avrei potuto dirvelo anch’io», mormorò Stiles, ma nessuno gli diede sul serio retta. «E se invece avesse a che fare coi suoi genitori? Quelli biologici, intendo», propose invece Allison, al che mi voltai verso Stiles e Scott. Loro conoscevano Jackson da molto più tempo di noi. «Io non ho idea di cosa gli sia successo». «Forse Lydia ne sa qualcosa!». «E se non sa niente neanche lei?». I dubbi di Scott erano abbastanza validi, lo capii subito. Proprio come capii fosse ormai giunto il tempo di prendere in mano la situazione e tenere fede alle mie parole. «Meglio chiedere a Jackson stesso», asserii, facendomi lontana di un passo dallo scaffale ricolmo di libri dietro il quale ci eravamo nascosti tutti. «Vado a parlargli». Allison non esitò un attimo. «Vengo con te». E Stiles, a quelle parole, si tranquillizzò tanto da evitarmi l’ennesima inutile predica. Lo osservai mentre raggiungevo Allison, vedendolo che tratteneva a stento uno sbuffo risentito. Era sempre il solito. «Io provo a parlare con Lydia, allora», annunciò, e non potei far altro che annuire nella sua direzione. Meglio provarle tutte. A quel punto, l’unico cucciolo smarrito era Scott. «Io cosa diavolo faccio?», domandò, quasi imbronciandosi sul finale. Allison gli sorrise, afferrandogli una mano. E i miei occhi corsero subito a quelli di Stiles. «Hai un compito da recuperare, ricordi?», la sentii chiedere al suo ragazzo, e quella domanda mi risvegliò dalla mia trance abbastanza da poter riprendere il controllo di me stessa. «Buona fortuna», conclusi, sempre con gli occhi fissi in quelli di Stiles – che a sua volta non osò interrompere il contatto finché non ci salutammo con un sorriso. Di fortuna ne avremmo avuto bisogno tutti e quattro. Avanzai al fianco di Allison fino alla porta blu dello spogliatoio maschile, quella dietro la quale solo pochi secondi prima avevamo visto sparire Jackson. Ci scambiammo un veloce sguardo d’intesa prima che lei prendesse l’iniziativa e spingesse la mano sulla maniglia, ma a dire il vero prima ancora che potesse anche solo provarci, la porta si aprì da sola di fronte ai nostri occhi ed io rischiai un infarto. «Oh mio Dio!», strillai, portandomi una mano sul cuore impazzito all’improvvisa apparizione di Matt. Avrei riconosciuto quegli occhi verdi tra mille. «Mi avete fatto prendere un colpo», soffiò lui in contemporanea, poi osservò sia me che Allison – soffermandosi molto più attentamente su quest’ultima. Quasi fin troppo attentamente. «Belle scarpe», le disse, indicando le decolletè in camoscio grigio che Allison si era sfilata per poter essere più silenziosa. La vidi che se le stringeva al petto un attimo prima di indossarle. Oramai non potevamo più nasconderci. «Mi facevano male i piedi», si giustificò, e Matt subito le sorrise serafico. «Ecco perché non metto mai i tacchi». Aggrottai le sopracciglia. «Come?». «Lascia stare», liquidò. «Hai sentito della festa underground? Mi hanno detto che in consolle ci saranno grandi dj». Incrociai più strette le braccia al petto. Non solo quel ragazzino ci stava facendo perdere tempo inutilmente, ma mi stava anche ignorando. L’irritazione mi distrasse ben presto dalla loro conversazione, tanto che me ne persi un bel pezzo. Almeno finché un nome non riportò a galla tutta la mia attenzione. «Ci sarà anche Victor», mormorò Matt all’improvviso, e i suoi occhi verdi mi inchiodarono letteralmente sul posto. «Fantastico», dissimulai, fingendo che non me ne importasse niente di quella strabiliante notizia. «Spero verrai anche tu. A lui farebbe piacere», continuò Daehler, mentre Allison si accigliava ogni secondo sempre più. Nemmeno lei sapeva nulla di Victor… «Come no», conclusi, e Matt finalmente decise di togliersi di torno, dandoci appuntamento a domenica mentre andava via di tutta fretta. Non appena fu fuori dalla mia visuale tirai un sospiro di sollievo, rilassando le spalle e sciogliendole dalla tensione che Matt mi aveva messo addosso. Da quando avevo scoperto chi fosse suo fratello non potevo fare a meno di sentirmi agitata anche in sua presenza. Decisi che non ci fosse più tempo per quei pensieri, comunque, e feci per aprire la porta dello spogliatoio maschile e catapultarmici dentro. Ma Allison subito me lo impedì afferrandomi un polso. «Entro io. Tu resta qui fuori a controllare che non venga nessun altro», ordinò, e subito richiamai il suo nome in un ringhio infastidito. Dovevano smetterla tutti di lasciarmi sempre in panchina. Ma Allison non ne volle proprio sapere di darmi una possibilità. «Ti prego, non abbiamo tempo da perdere», soffiò, già un piede dentro lo spogliatoio. «Vado dentro e gli parlo. Tu resta qui». Sventolai bandiera bianca, lasciando che si chiudesse la porta blu alle spalle e combattendo all’improvviso con l’impulso di raggiungerla lì dentro. Me ne rimasi con le orecchie attente a qualsiasi suono inopportuno e gli occhi vigili, credendo che il tempo non volesse passare mai. La chiacchierata di Allison e Jackson sembrò durare degli interi secoli, almeno finché un bel po’ di rumori e qualche urlo non attirarono la mia attenzione e il tempo sembrò al contrario immobilizzarsi del tutto. Ero già un piede dentro lo spogliatoio – pronta a correre in aiuto di Allison – quando di nuovo qualcuno mi bloccò. «Ferma». Era Scott. Senza aggiungere altro, mi sorpassò spingendomi indietro sulla soglia ed io ubbidii. Me ne rimasi ferma lì a guardarlo mentre raggiungeva Jackson a grandi falcate per dargli subito la lezione che si meritava. Il resto furono solo urla, calci e pugni. Da entrambe le parti. «La gente non si faceva problemi con me». Ma quella voce improvvisa mi risvegliò dalla mia trance, permettendomi di trovare un nascondiglio efficace dietro un angolo non appena la riconobbi come appartenente ad Erica Reyes. «Lo sai che avevo la cotta più grande del mondo per te?», la sentii che continuava a dire, e subito non potei fare a meno di chiedermi con chi stesse parlando mentre trattenevo il respiro e speravo che non mi scoprisse, nascosta lì dietro ad origliare. Ma prima ancora che potessi sporgermi per vedere coi miei occhi chi fosse il suo sconosciuto accompagnatore, Erica continuò a parlare e me lo comunicò lei stessa. «Per te, Stiles». Mi si mozzò il respiro in gola. E sentii subito qualcosa di molto simile ad un mix letale di rabbia ed irritazione prendere a sconquassarmi lo stomaco. «Non mi hai mai notata, nemmeno una volta. Esattamente come non mi noti adesso». Ci furono pochissimi secondi di silenzio, poi di nuovo tutto tornò ad essere urla e colpi sferrati con rabbia. Avrei dovuto uscire dal mio angolino e lo sapevo, aiutare Stiles ed Erica a trattenere Scott e Jackson e a tenerli lontani prima che potessero finire di ammazzarsi a vicenda… ma non ci riuscii. Stare dietro le quinte era molto più facile, finalmente lo capivo. «Basta! Cosa pensate di fare? Jackson, calmati! Cosa succede qui?». Quando sentii la voce di Harris, arretrai ancor di più. Non sarei uscita dal mio nascondiglio. Non in quel momento. Non potevo affrontare anche lui. I suoi rimproveri smorzarono finalmente i toni e sentii il silenzio scendere nel corridoio, almeno finché Matt non provvide ad interrompere la pace. «Ti è caduto questo», lo sentii mormorare, senza la minima idea di cosa stesse parlando. Ma ci pensò Harris a metterlo subito a cuccia. «Vi voglio tutti in punizione», ordinò, e solo quando sentii il rumore dei suoi passi sempre più lontani, trovai il coraggio di uscire allo scoperto. Istintivamente cercai Stiles per primo e lui mi trovò immediatamente, raggiungendomi così velocemente che a malapena riuscii a svoltare l’angolo. «Va’ via da qui», mi disse ad un passo dal viso, così vicino a me da spingermi ad indietreggiare nuovamente verso il mio nascondiglio. Scossi la testa, anche se sapevo che avrei finito per cedere. Come al solito. «Voglio stare con voi, Stiles». «Non puoi. Tuo padre ti aspetta», mi ricordò subito, e il cuore mi si strinse a quella dolorosa consapevolezza. Mio padre mi aspettava. Ed io avrei preferito lui a Stiles. Rifuggii il suo sguardo, concentrandomi sulle mie – all’improvviso interessantissime – Converse. Avrei voluto dire a Stiles che avevo bisogno di lui per affrontare la mia famiglia al massimo delle forze, ma non ci riuscii. Semplicemente mi limitai a deglutire il fiotto di parole che mi si erano annodate in gola mentre ricacciavo indietro lacrime d’irritazione. Stiles mi sollevò il viso con entrambe le mani, passandomi i capelli lunghi dietro le orecchie. «Ce la farai», mormorò, sempre ad un passo dalle mie labbra. «Anche senza di me». Un’altra volta ancora aveva capito tutto alla perfezione. «Harry». Le chiavi di casa mi scivolarono di mano, finendo sul pavimento nell’ingresso di casa Stilinski con un tintinnio che mi fece sobbalzare ancor di più dallo spavento. Conoscevo quella voce ormai fin troppo bene. A rallentatore mi voltai alle mie spalle per cercare il viso di Philip Carter e non appena i suoi occhioni blu si fusero coi miei, sospirai. Quella era davvero una pessima idea. Ma ormai non potevamo più scappare dalle nostre responsabilità. Né lui né io. «Entriamo dentro», ordinai in un sussurro, e gli feci strada nella desolata casa dello sceriffo. Quando Philip si era presentato a sorpresa lì, solo pochi giorni prima, eravamo finiti a parlare di tutto e niente. Finché non avevo finalmente compreso il perché della sua visita: ancora non aveva avuto il coraggio di telefonare a mia madre e a mia sorella Cassandra per dire loro tutta la verità. Proprio come non ce l’avevo avuto io. «Ti trovi bene qui?». Scivolai fuori dal mio baratro di pensieri, annuendo nella direzione di mio padre mentre mi disfacevo dello zaino di scuola e del cappotto invernale. «Molto più di quanto avrei mai immaginato. Perché me lo chiedi?». «Perché non l’ho mai fatto», scrollò le spalle, prima di riprendere col suo interrogatorio serrato, «Che tipi sono gli Stilinski?». Sembrava interessato sul serio. Ed io gli diedi le risposte che pensavo si meritasse. Almeno in quell’occasione. «Stephen è meraviglioso. È lo sceriffo». «Lo so». Ignorai completamente quell’interruzione. «Lavora sempre un sacco, ma lo fa con piacere. Dovrebbero esserci più persone come lui». «E Stiles?». Il pensiero mi corse a Stiles e me lo immaginai a scuola, in punizione con Harris. Non doveva starsela passando bene. Ma per fortuna non era solo. Con lui c’erano Scott, Allison… Jackson, Erica, Matt– «Stiles è fantastico», dissi di getto, prima che mi venisse la malsana idea di correre nuovamente a scuola per accertarmi che Stiles stesse bene. «State insieme?». «No», risposi senza nemmeno pensarci, poi però riflettei su ciò che avevo appena detto e cambiai versione: «Non credo». «Ma tu ci tieni comunque a lui». Sgranai gli occhi, cercando il viso dalla pelle abbronzata dell’uomo che – nonostante tutto – era mio padre. Cercai un segno – uno qualunque – ma non vi trovai nulla che potesse farmi capire e mi limitai a boccheggiare sotto i suoi occhi chiarissimi. «L’ho capito quando sono venuto qui pochi giorni fa. Sobbalzavi ogni volta che Stiles ti si faceva lontano. E lui non ti ha tolto gli occhi di dosso nemmeno per un attimo, come per assicurarsi che stessi sempre bene», mi spiegò Philip, e lasciai che un silenzio di tomba c’avvolgesse entrambi non appena decise di chiudere bocca. Non sapevo cosa dire, se non che – sorprendentemente – mio padre aveva saputo leggermi come se mi conoscesse da una vita. Il che era così lontano dalla realtà da stringermi il cuore in una morsa dolorosissima. Distolsi lo sguardo dal viso di Philip, cacciando a fondo delle lacrime inopportune mentre mi dirigevo verso la camera di Stiles, indicandogli la via. Sistemai le ultime cose in silenzio, ma quando ci accomodammo entrambi davanti al pc per mettere finalmente in atto il nostro piano, dovetti rompere quella pace momentanea. «Siediti un po’ più lontano», ordinai a mio padre, e quasi mi sembrò di vedere il suo sguardo rabbuiarsi. Mi sentii subito in dovere di spiegargli perché. «Così mamma e Cass non ti vedranno subito». Allora Philip annuì, spostandosi dal pc – e da me – di modo che fosse fuori dalla visuale della webcam. «Sei sicura di volerlo fare?», mi domandò dopo un po’, puntandomi i suoi occhi addosso tutto il tempo. «Sì, e tu?», ma io gli risposi decisa e ricambiai il suo sguardo cristallino senza timore, tanto che anche Philip mi sembrò all’improvviso più convinto che mai. «Assolutamente». Bene, pensai, facendo partire la videochiamata. Insieme avremmo detto a Jenette e Cassandra tutta la verità. Ed io non avrei dovuto più nascondere nulla a nessuno. Mi sarei tolta dal petto l’ennesimo peso. Sia mia madre che mia sorella avrebbero capito tutto, e almeno un altro piccolo tassello del puzzle incasinato in cui si era trasformata la mia vita da quand’ero lì a Beacon Hills sarebbe corso al suo posto. «Mamma, ascolta. C’è una persona che vuole vederti». Interruppi la parlantina di Jenette, dopo averla lasciata sfogarsi a ruota libera su tutto e tutti. Cassandra le sedeva al fianco e l’osservai mentre aggrottava le sopracciglia di fronte a quel mio annuncio improvviso. Poi riportai l’attenzione al viso di mia madre. «Di chi si tratta? Non dirmi del padre di Stiles: sono impresentabile!», chiese, cominciando poi – come al solito – ad imparanoiarsi da sola. Era la maga dei film mentali. Cassandra ridacchiò, punzecchiandola con un gomito. «Dai, ma’. In ogni caso sei troppo vecchia per lo sceriffo». In un’altra situazione avrei riso di un’altra delle solite battutacce della mia sorella maggiore, ma in quel momento me ne rimasi impassibile ad osservarle attraverso lo schermo del Mac di Stiles. Non potevo perdere la concentrazione. Dovevo confessare tutto. «Non iniziate», le rimproverai, impedendo loro di cominciare a bisticciare come al solito. «Sono qui con papà». Philip prese quel mio annuncio improvviso come un invito a palesarsi, perché non appena ebbi finito di parlare riprese posto di fianco a me e lasciò che sia mia madre che mia sorella potessero vederlo. Non tolsi gli occhi nemmeno per un attimo dai loro visi sconvolti, e un senso di oppressione mi pesò sul petto all’improvviso silenzio che cadde nella stanza di Stiles. «Cosa ci fai lì?». Fu mia madre a trovare per prima il coraggio di parlare, anche se tutto ciò che pronunciò fu quella domanda ricolma di astio. Per lei doveva essere un colpo durissimo guardare sua figlia – quella che aveva cresciuto completamente da sola – accanto all’uomo che l’aveva lasciata, dicendole di preferire alla sua famiglia una carriera da musicista. Sapevo che ci fosse molto di più dietro quella storia e cominciavo quasi a capire perché Philip avesse abbandonato non solo Jenny ma anche Cass e me – anche se non lo giustificavo – ma comunque mi sentii un mostro di fronte alle espressioni deluse delle due donne più importanti della mia vita. «Sono tornato a Beacon Hills per nostra figlia, Jenny», mormorò Philip all’improvviso, distraendomi dai miei pensieri e riportandomi alla realtà – una realtà nella quale gli occhi mi si erano riempiti di lacrime così tanto da offuscarmi la vista. «È mia figlia», lo corresse subito mia madre, e quell’affermazione non migliorò di certo la situazione. «E non chiamarmi Jenny». Phil provò a replicare, ma prima che potesse dar fiato alla bocca lo bloccai con un gesto. «C’è una cosa che devo dirvi», parlai sia a mia madre che a Cass, guardandole attraverso i miei occhi scuri e lucidi di lacrime. Sentivo sempre più di star sbagliando su tutta la linea, con loro due. Ma ormai dovevo andare avanti e dire tutta la verità. «Che sta succedendo, Harry?», chiese mia sorella in un sussurro, ed io le riservai un brevissimo sguardo prima di dar loro le risposte che si meritavano. «Ho conosciuto i Carter. Mi hanno portata loro qui. Erano d’accordo con la professoressa che ha organizzato l’Intercultura. Avevano bisogno di me affinché potessi risvegliare i miei poteri». «Poteri? Non ci credo. Hai fatto anche a lei il lavaggio del cervello. Non cambi proprio mai, Philip». Jenette non mi avrebbe creduta mai. Quella consapevolezza mi spezzò il cuore tanto da togliermi il dono della parola. A portare avanti quella dolorosa conversazione, comunque, ci pensò subito Philip. «Non le ho fatto proprio nulla!», esclamò, alzando la voce tanto da farmi sobbalzare vistosamente. «Harriet ti sta solo dicendo la verità! I Carter posseggono poteri di chiaroveggenza da generazioni. E lei ha appena risvegliato i suoi». «Chiaroveggenza!», sputò mia madre, alzando la voce ancora di più. Provai il forte impulso di tapparmi le orecchie con le mani. Non volevo sentire più nulla. «Dove sono le telecamere?», domandò mia sorella, e di nuovo tornai ad osservarla. «Non è uno scherzo, Cassandra». Ma per quanto mia sorella fosse tranquilla, Jenny al contrario non ne voleva sapere proprio più nulla di tutta quella storia. «Questo è davvero troppo», proclamò. «Harry, fai le valigie. Massimo domenica ti rivoglio qui ad Austin. E tu», indicò mio padre con l’indice, «sta’ lontano da mia figlia». Quelle parole mi fecero infervorare a dir poco. Il mio incubo peggiore si stava avverando: Jenette voleva portarmi lontana da Beacon Hills e soprattutto da mio padre, che lontano da me ci era stato già per decisamente troppo tempo. Non avrei mai permesso che una cosa del genere potesse succedere. «Mamma, il mio posto ora è qui. Ho bisogno della mia famiglia». Ho bisogno di mio padre, avrei voluto dire, ma non ne ebbi il coraggio e mi limitai a guardare Phil di traverso, donandogli un’occhiata che forse gli fece intendere molto più di quanto avessi voluto. «Siamo noi la tua famiglia», osservò allora mia madre, ma la sua voce era diversa dal solito – non c’era nulla della dolcezza abituale che da sempre mi aveva riservato. L’avevo delusa e lei stava facendo altrettanto con me. Ci stavamo ferendo a vicenda. «Siete anche voi la mia famiglia», la corressi, e quella per Jenny fu la stoccata finale. La guardai mentre sgranava gli occhi e restava a fissarmi con le labbra socchiuse per quelli che mi sembravano secoli, come se non mi riconoscesse più. Infine sembrò ricomporsi e scosse la testa prima di riprendere a parlare, mentre io mi sentivo morire dentro ogni secondo sempre più. «Pazzesco», esalò, puntando gli occhi sulla figura di Phil. «Alla fine sei riuscito a portarmene via almeno una». I’ve been telling you so many lies – ain’t nothing good, it’s all bad.
And I just wanna confess ‘cause it’s been goin’ on so long. Ringraziamenti Alle magnifiche personcine che hanno recensito i capitoli passati e che continuano a seguire questa storia facendomi sempre immensamente felice. ♡ La canzone citata in questo capitolo si chiama Confessions (ma va’?) ed è di Usher, ma potete anche evitare di ascoltarla perché è abbastanza trash AHAHAH. L’ho inserita solo perché c’ho ‘na fantasia che proprio ve dico fermateve e perché le due frasi citate alla fine ci stavano meglio di tutto ciò che avevo pensato d’inserire io, quindi va così. Note Potete leggere degli avvenimenti del Ballo d’Inverno nel capitolo 19 di parachute. Per chi non l’avesse capito (soprattutto quelli di voi che non hanno letto parachute) quando Harry parlando di suo padre dice: “Ed io l’avevo appena visto” intende dire che l’uomo della sua visione improvvisa è proprio lui, suo padre, Philip Carter. Capelli biondi scompigliati, occhi azzurri e giacca di pelle onnipresente. Il Layla’s è un luogo di mia invenzione e l’amica della quale parla Scott nella scena 3 è un’altra delle OCs da me create che spero di far conoscere a questo fandom, prima o poi. Perché sì, insomma, sto scrivendo un’altra long. Ed è Liam!centric. Ecco, l’ho ammesso. LoL sta per League of Legends: l’ho già citato in parachute e qui ce l’ho rimesso perché ci stava proprio a pennello. Per chi non lo sapesse, è un videogioco online e Stiles ci ha giocato insieme a Niall – cugino di Harriet – nell’epilogo di parachute. Per qualsiasi dubbio su Philip, Jenette, Cassandra o quello che vi pare, chiedetemi e vi sarà detto. Spero che anche quest’altro Sunday-Special possa piacervi *si sente molto Joe Sugg*. Parlando di Joey, SCUSATEMI ma devo piazzarmi davanti a youtube nell’attesa spasmodica del nuovo video. PS Ho sentito il forte bisogno di scrivere degli Starriet in versione genitori&sposini e be’, l’ho fatto. L’OS che ho pubblicato è ovviamente ambientata diversi anni dopo kaleidoscope e a proposito ci tengo a specificare che ciò che vi è narrato va preso molto con le pinze, nel senso che nulla vi assicura un matrimonio Starriet né tantomeno dei pargoletti. Ho voluto semplicemente fare un piccolo esperimento, poi chissà come andranno sul serio le cose… Spero apprezzerete, comunque! Trovate l’OS qui: A day in the life of Stiles & Harriet. ♡ |
Capitolo 7
*** Infinite dreams ***
Da parachute: Walter […] di anni ne aveva ventidue e possedeva – al contrario mio – una sorella minore di nome Natalie.
kaleidoscope
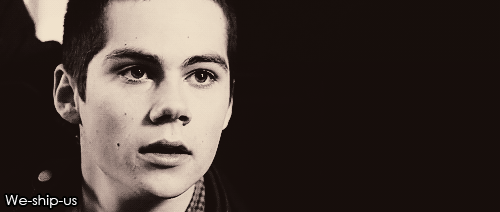 7. Infinite dreams
«Ma che roba è?». Sollevai gli occhi stanchi dal mio hamburger, riservando a Stephen un lungo sguardo confuso. Lo vidi che fissava stranito il panino che Stiles gli aveva portato dal drive-through, come se fosse tossico o avariato. Cercai subito spiegazioni da Stiles, proprio come Stephen, voltandomi alla mia sinistra per osservarlo. «È vegetariano», dichiarò lui con fin troppa enfasi, come se dirlo in quel modo avrebbe fatto cambiare opinione allo sceriffo. Era venerdì sera e siccome quest’ultimo avrebbe avuto a che fare con l’ennesimo turno di notte, sia io che Stiles avevamo deciso di tenergli compagnia cenando insieme a lui alla centrale di polizia con dell’immancabile cibo-spazzatura. Be’, almeno per noi, osservai, guardando il mio hamburger ipercalorico e sentendomi un tantino in colpa per quello vegetariano che era capitato a Stephen. «La prossima volta ci mando Harry, al drive-through», osservò proprio lui, disfacendosi del panino che a quanto pareva non aveva più intenzione di mangiare. Dovetti trattenere una risatina, mentre Stiles invece non perdeva tempo per fulminare sia me che suo padre con lo sguardo. I due continuarono a bisticciare ancora a lungo, ma mi persi gran parte della loro conversazione. Erano passate poco più di ventiquattro ore dalla mia fallimentare videochiamata a casa, eppure la mia mente era ancora quasi completamente focalizzata su quel momento. Non riuscivo a pensare ad altro. «Non condividerò delle informazioni riservate con un adolescente!», esclamò Stephen ad un tratto, alzando la voce così tanto da risvegliare subito tutta la mia attenzione. «Sarebbero quelle dietro di te?». Stiles si sporse sulla sedia, cercando di avere una visuale migliore sul tabellone alle spalle dello sceriffo. Mettendo da parte il mio cestino di patatine fritte, cercai anch’io di buttare un’occhiata alle varie foto che lo riempivano, ma ci capii poco e niente. Erano solo volti sconosciuti e frecce rosse che li collegavano l’uno all’altro. Non avevo idea di cosa potesse significare. «Non guardate», ordinò lo sceriffo, ed io subito ubbidii – non avevo bisogno di deludere un altro adulto. Mi finsi concentrata sulle rimanenze del mio hamburger, mentre Stiles continuava a dare del filo da torcere a suo padre. Come tipo sempre. «Perché non puoi essere come Harriet?», lo sentii mormorare tra i denti, e prima ancora che potessi ritornare a fissare Stephen, sentii gli occhi di Stiles corrermi addosso. Ma non ricambiai quello sguardo, perché sapevo bene cosa avrei trovato nel fondo delle sue iridi ambrate: tristezza. In quelle ultime ore ero stata così spenta e persa nei miei cupi pensieri da sembrare quasi l’ombra di me stessa, e Stiles non poteva fare a meno di sentirsi impotente di fronte a quella mia reazione. Che mia madre e mia sorella non credessero alla verità che dopo tanti sforzi avevo voluto dire loro insieme a mio padre, era stato per me un duro colpo. E purtroppo, non c’era niente che Stiles potesse fare per migliorare quella situazione. «Vedo le frecce che indicano le foto», osservò, non appena capì per l’ennesima volta. Allora lo sceriffo si arrese. «Ho scoperto qualcosa, va bene? Il meccanico e la coppia assassinata avevano qualcosa in comune». «Tutti e tre?». Aggrottai le sopracciglia, e la mia espressione confusa si accentuò ancor di più quando Stephen rispose alla domanda del figlio con un cenno d’assenso. Fin troppo strano. «Lo sai come dico sempre, Stiles. “Uno è un incidente, due è una coincidenza–». Ricordi non troppo lontani mi scoppiarono in testa all’improvviso. Certo che Stiles lo sapeva: lui stesso mi aveva già recitato quel mantra non tanto tempo prima. Tanto che, prima che Stephen potesse finire di parlare, completai io la formula per lui. «… tre è uno schema”». Stephen restò a fissarmi finché Stiles non lo riportò alla realtà, chiedendogli delle spiegazioni necessarie a dissipare la confusione generale. «Il meccanico, il marito e la moglie avevano tutti e tre ventiquattro anni». «Ma il signor Lahey no», osservò subito Stiles, e al ricordo improvviso di John Lahey misi su un’espressione inorridita. Per quel poco che l’avevo conosciuto mi aveva dato l’impressione di essere una persona pessima, ma comunque ancora non riuscivo a realizzare completamente che fosse morto. Misi da parte il resto della mia cena, lo stomaco ormai irrimediabilmente chiuso. «Ciò mi ha portato a pensare che: A) Quell’omicidio non era collegato; o B) L’età era una coincidenza», affermò Stephen, abbandonando poi la scrivania attorno alla quale c’eravamo riuniti per quella strana cena. Frugò velocemente in un cassetto e ritornò con un fascicolo tra le mani che subito porse a Stiles. «Poi ho scoperto questo, che sarebbe C). Sapevi che Isaac Lahey aveva un fratello maggiore di nome Camden?». Aveva?, mi chiesi subito, sperando inutilmente che le mie supposizioni fossero sbagliate. Non ebbi il coraggio di controllare il fascicolo io stessa, comunque, lasciando che a comunicarmene il verdetto ci pensasse l’espressione di Stiles. E come avevo di già immaginato, ciò che vidi sul suo viso non mi piacque per niente. Ancor meno di ciò che disse. «“Morto in combattimento”», lesse in un sussurro, e subito mi sentii un po’ morire anch’io. «E se fosse vivo, indovina oggi quanti anni avrebbe?», domandò Stephen allora, ed io capii immediatamente dove volesse andare a parare mentre lo guardavo posizionarsi di fronte alla tabella ricolma di foto. «Ventiquattro», mormorai, mentre Stiles lo raggiungeva. «Quindi devono essersi diplomati lo stesso anno, ci hai pensato?». Io c’avevo pensato. E avevo pensato anche ad altro. «Magari andavano a scuola insieme». Gli occhi azzurri di Stephen subito mi corsero addosso. «Magari alla Beacon Hills High School», tentò, e prima ancora che me ne potessi rendere conto sul serio era riuscito a racimolare tutti i documenti degli archivi datati 2006 – l’anno del diploma dei tre ragazzi assassinati dal kanima. «Ecco, l’ho trovato!», trillò Stiles all’improvviso, sollevando un fascicolo azzurro prima di prendere ad esaminarlo attentamente. «Studiavano tutti alla Beacon Hills». «Anche il fratello di Isaac». «Okay, quindi forse si erano visti a scuola. Ma qual è il legame? Erano amici?». Stephen sospirò, rimettendosi a sedere con aria all’improvviso esausta. Non doveva essere affatto facile, per lui. «Forse frequentavano gli stessi corsi. Forse–», si immobilizzò, gli occhi fissi su un pezzo di carta che di nuovo non ebbi il coraggio di analizzare. «–avevano lo stesso insegnante». «Harris». Quel nome mi fece di nuovo rabbrividire e inorridire insieme. Ma non ebbi tempo per dire né fare nulla, perché ci pensò subito lo sceriffo a portare avanti quella conversazione. «Prendi l’annuario del 2006», ordinò a Stiles con aria concitata. «Mi servono tutti i ragazzi del corso di chimica». Di nuovo capii immediatamente. «Se ci sarà un’altra vittima…», cominciai, ma non ebbi il coraggio di dire ciò che in fondo sapevamo tutti potesse succedere. Al che ci pensò Stiles a concludere la mia frase. «… sarà uno di loro». Non appena la Jeep si fermò davanti allo studio veterinario del dottor Deaton, misi piede fuori dall’abitacolo e seguii Scott e Stiles nella loro camminata tranquilla verso l’edificio. Era sabato pomeriggio e subito dopo scuola avevamo deciso di andare a far visita al capo di Scott, all’uomo che da sempre aveva dimostrato di saperne molto di più di quanto sembrasse sul mondo del soprannaturale. «La vostra idea è pessima, lo sapete?», domandai retoricamente all’improvviso, prima che potessimo entrare nella clinica, stanca del silenzio pesante che aveva accompagnato sia me che Scott e Stiles durante tutto il viaggio in macchina. «Ehi», mi apostrofò subito Stiles, voltandosi a donarmi un’occhiata stizzita. «non è stata una mia idea! E lo so, è un suicidio». Scott sospirò, facendo scivolare la mano sulla maniglia della porta d’ingresso. «Non cominciate. Dobbiamo andare al rave di domani. Jackson ci sarà, e sicuramente anche colui che lo controlla». «È proprio questo il problema», sussurrai, pensando con orrore alla festa underground della quale in precedenza già mi aveva parlato Matt Daehler. Scott non perse occasione per provare a rincuorarmi con uno dei suoi soliti sorrisi. Servì a molto poco, ma apprezzai comunque il gesto. «Tranquilla, Comandante», proclamò, poco prima di continuare a farci strada verso l’interno della clinica. «Non ci andremo disarmati». Ed era proprio per quello che eravamo lì, no? In cerca di difese, avevamo deciso di rivolgerci a Deaton, ben sapendo che lui ci avrebbe aiutati – come già aveva fatto un bel po’ di volte. Lo osservai mentre ci accoglieva nel suo studio, stringendomi le braccia al petto e guardandomi attorno con aria curiosa mentre Deaton scambiava saluti di rito con Scott e Stiles. Quella in cui mi trovavo sarebbe potuta sembrare perfettamente una normalissima clinica veterinaria, eppure dentro di me sapevo che quell’edificio nascondesse molto di più. Proprio come il suo proprietario. Riportai i miei occhi scuri sulla sua figura, osservandolo mentre porgeva una boccetta di liquido trasparente a Scott. «Questa rallenterà Jackson. Te ne dovrai occupare tu», gli disse, prima di afferrare un altro contenitore in vetro, quest’ultimo ricolmo di una strana polvere nera. Lo porse a Stiles, con mia grande sorpresa. «Questa invece è per te». Nemmeno quella volta riuscii a mettere freno alla mia curiosità. «Di che si tratta?». Al suono improvviso della mia voce, Deaton cercò i miei occhi e mi donò una lunga occhiata confusa. Era la prima volta che c’incontravamo e non erano nemmeno state fatte le dovute presentazioni, ma non c’era tempo per quei convenevoli e il veterinario lo capì subito. «È polvere di frassino», mi spiegò, facendosi più vicino a me di un passo. «Creerà una barriera che né Jackson né il suo padrone potranno oltrepassare». «Wow. Sembra una cosa piuttosto stressante. Non potremmo trovare un compito leggermente meno stressante per me?», osservò Stiles all’improvviso, e immediatamente pensai di dirgli che l’avrei fatto io al posto suo, ma me ne rimasi zitta. Sapevo che mai e poi mai mi avrebbe permesso di entrare in azione. Sia Scott che Deaton gli donarono un’occhiata incredula, al che lui non poté far altro che arrendersi con un sospiro sconfitto. «D’accordo, cosa devo fare? Spargerla intorno all’edificio e pregare che funzioni?». Deaton scosse lievemente la testa. «Devi crederci». A quell’affermazione enigmatica, sentii Stiles trattenere un’imprecazione. Ma non ebbi tempo per rassicurarlo: volevo scoprire cosa Deaton avesse in serbo per me. «Io che faccio?», gli chiesi quindi, ridonandogli tutta la mia attenzione. «C’è della polverina di fata anche per me?». Di nuovo sia Scott che Deaton evitarono di rispondere. Il veterinario addirittura si accigliò, con aria vagamente infastidita. Non aveva nessun senso dell’umorismo. Stiles invece scosse la testa. «La ignori», ordinò a Deaton, liquidando la questione con un cenno veloce. «Lei resterà a casa». Povero illuso, pensai immediatamente. Ma in realtà la povera illusa ero io. «Oh, merda. Merda». Cercai immediatamente gli occhi di Stiles, distogliendo lo sguardo dalla serranda ormai completamente chiusa del garage di casa Stilinski. Solo pochi millesimi di secondo prima c’avevo visto sparire dietro Stephen, immobilizzata da ciò che ci aveva confessato e dall’aria distrutta che aveva. L’avevano licenziato. Aveva perso il suo posto da sceriffo ed era successo tutto a causa di Stiles, sebbene odiassi dover credere ad una cosa simile. Fu proprio il suo sguardo che cercai, salvo pentirmene poi quando lo trovai lucido di lacrime che sapevo non avrebbe liberato. Quella consapevolezza mi strinse il cuore ancor di più. «Stiles», sussurrai, azzerando la distanza che ci separava per prendergli il viso tra le mani. Volevo che mi guardasse e che capisse che ero lì, accanto a lui, come sempre. «Non–». «Non dirlo», m’interruppe, lasciandomi interdetta mentre portava le sue mani sulle mie e tentava di allontanarmi da sé. «Certo che è stata colpa mia. Mio padre ha appena perso il lavoro per me, perché sono stato tanto stupido da rubare un veicolo della polizia e beccarmi un’ordinanza restrittiva. Dannato Jackson». Avrei dovuto dirgli che non era così e provare a farlo stare meglio, ma sapevo che non fosse quella la verità – e già da tempo avevo promesso a Stiles che gli avrei detto sempre nient’altro che quella. Glielo dovevo. Ecco perché semplicemente me ne rimasi zitta a stringergli il viso tra le mani, ancora vicina a lui che per quanto lo volesse non era riuscito ad allontanarmi. «Te la senti di andare al rave?», gli chiesi infine, lanciando un’occhiata veloce alla Jeep nei pressi della quale ce ne stavamo ancora immobilizzati. Prima che Stephen ci inchiodasse sul posto col peso opprimente delle sue confessioni, eravamo diretti proprio lì, pronti a mettere in atto il piano peggiore nella storia dei piani peggiori. Guardando negli occhi lucidi di Stiles, però, non potei fare a meno di chiedermi se non avesse cambiato idea riguardo all’andare. Ma: «Devo», concluse lui in un sussurro, ed io non potei far altro che annuire mentre lo lasciavo libero. «Resto qui», gli dissi, sperando di riuscire a rassicurarlo almeno un po’. E ci riuscii, perché Stiles mi afferrò all’improvviso una mano con aria estremamente riconoscente. «Grazie», mormorò forzando un sorriso. Subito lo ricambiai e anche se non aveva bisogno di ringraziarmi, non glielo dissi. Mi limitai a sfiorargli le labbra con un lento e casto bacio. «Sta’ attento», lo pregai in un sussurro, prima di raggiungere finalmente Stephen dentro casa. Almeno per quella sera, il mio posto era lì accanto a lui. Mi tuffai sul divano con un sonoro tonfo, sistemandomi comodamente vicino a Stephen mentre gli rubavo gommose dal sacchetto che reggeva tra le mani e cercavo di capire cosa diavolo dessero in tv di domenica sera. Continuai a mangiucchiare in silenzio, tutta concentrata nella visione di quello che aveva tutta l’aria di essere un film horror di serie Z. Fu proprio Stephen ad interrompere la mia attenta analisi, con tanto di sopracciglia aggrottate e labbra corrucciate. «Saresti dovuta andare con Stiles», disse, e quell’osservazione mi tolse il dono della parola per ben più di un attimo. M’immobilizzai con l’ennesima gommosa ad un passo dalle labbra, boccheggiando al pensiero improvviso di Stiles. L’avevo lasciato andare ad un rave con kanima e padroni assassini in giro, pregandolo che stesse attento, ma non potevo sapere sul serio che ci avrebbe provato – riuscendoci, oltretutto. «Lui non mi voleva tra i piedi in ogni caso», sospirai, scrollando le spalle come se niente fosse. «Va bene così». Stephen scosse la testa, distogliendo lo sguardo dal mio viso per puntare nuovamente gli occhi azzurri sulla tv. Quando mi aveva vista rientrare in casa, non aveva potuto fare a meno di riservarmi un’occhiata stupita. Non mi aveva chiesto niente, comunque, ed io mi ero convinta ancor di più di aver fatto la cosa giusta mentre cenavamo insieme e mi sembrava di vederlo stare già un po’ meglio. Magari un po’ di compagnia era ciò che gli serviva. Non ne ero convinta, ma dovevo quantomeno provare a stargli accanto. Proprio come lui aveva sempre fatto con me, fin dal primo momento in cui ero giunta a Beacon Hills. Proprio come aveva fatto soprattutto in quegli ultimi giorni. «Credo comunque che ti saresti divertita di più a discutere con lui piuttosto che a passare la domenica sera a mangiare gommose con questo vecchio musone», osservò, e allora non potei fare a meno di ridacchiare, rubandogli l’ennesima caramella dal sacchetto. «Non sei vecchio, Stephen. E nemmeno musone, a dire il vero». «Ma non sono proprio di compagnia, stasera». Annuii. «È giusto così. Credimi, lo capisco. Anch’io…». M’immobilizzai. Stavo per dirgli che anch’io ero stata piuttosto triste in quei giorni? Meglio evitare. Non volevo attirare l’attenzione su di me, come al solito. Ma Stephen aveva già capito tutto. «Anche tu sei stata giù, ultimamente», completò. «L’ho notato». Certo che l’ha notato. «Se vuoi parlarmene, sono tutt’orecchi. Lo sai, piccola». «Riguarda i miei». Quelle parole mi abbandonarono le labbra in un soffio improvviso, senza che riuscissi a controllarle. Non appena calò nuovamente il silenzio, Stephen si disfece delle gommose e si voltò a fronteggiarmi. Ma non disse nulla, lasciando che fossi io a parlargli di mia spontanea volontà. E lo feci, perché sapevo bene di potermi confidare con lui. «Sai quanto per me è stato meraviglioso e tragico allo stesso tempo conoscere mio padre. E sai anche che nonostante tutto ho deciso di mettere da parte l’orgoglio e dargli una possibilità. L’ho fatto perché ho capito di aver bisogno di lui. Cosa che al contrario mia madre non comprende». «Cosa intendi?». Sospirai, cercando di combattere con gli occhi già lucidi. Mi mossi a disagio sul divano, ravvivandomi i capelli nell’attesa di trovare altro coraggio utile a farmi continuare su quella strada. Anche se fino a quel momento le parole m’erano venute fuori con la violenza di un torrente, allora mi fermai a riflettere prima di parlare. Dovevo misurare bene ciò che avrei detto e stare attenta a non rivelare a Stephen niente di soprannaturale. Non potevo commettere anche con lui l’errore che già avevo compiuto con mia madre e Cassandra. «Un po’ di giorni fa Phil è venuto qui per confessarmi di come ancora non avesse avuto il coraggio di telefonare a mia madre per dirle che fosse vivo, qui e soprattutto insieme a me. Proprio come non ce l’avevo avuto io. Ecco perché alla fine abbiamo deciso di comune accordo di risolvere il problema insieme. Ci siamo piazzati davanti al pc e abbiamo videochiamato a casa. Mia madre l’ha presa malissimo», raccontai infine, omettendo numerosissimi dettagli ma svelando comunque una mezza verità. L’espressione di Stephen si corrucciò all’improvviso. «Mi dispiace da morire, piccola». Tirai su col naso, cercando di trattenere le lacrime con immensi sforzi. Dispiaceva anche a me. «Non ho il coraggio di richiamarla. Temo che non mi risponderà. Non potrei sopportarlo», confessai, incapace di continuare a fissare Stephen. Tenni lo sguardo piantato sulle mie mani, ma lo vidi comunque spalancare le braccia affinché mi stringessi a lui e non me lo feci ripetere due volte. «Magari per ora è meglio così», lo sentii mormorare contro i miei capelli, mentre una prima lacrima – solitaria ancora per pochissimo – scendeva a bagnarmi una guancia. «Prova a darle tempo. Vedrai che si risolverà tutto». Lo spero.  Scott McCall corse fuori dal magazzino rumoroso come se ne andasse della sua stessa vita, e in effetti era proprio così. Quella sera – a quel rave maledetto – si stava letteralmente giocando la vita al lotto.
Ansimò, piegandosi sulle ginocchia nell’immensità del parcheggio deserto e silenzioso, alla ricerca di un respiro che temeva non sarebbe più riuscito a recuperare. E le sue paure divennero presto realtà all’improvviso stridere di freni sull’asfalto che gli riempì le orecchie; il fiato gli si mozzò in gola e gli occhi gli bruciarono da quant’era intensa la luce dei fanali che si trovò puntati addosso. Una luce sempre più vicina, sempre più… Il tonfo dell’auto contro il suo corpo fu rumoroso e inaspettato. La botta lo rese incosciente in un attimo, mandandolo a terra come se fosse un misero burattino. Scott batté la testa sull’asfalto e in quello stesso momento, dall’auto che l’aveva investito, scese una donna. Indossava eleganti decolletè dal tacco non troppo alto e un completo nero molto fine. Si chiuse lo sportello alle spalle con un tonfo rumoroso e poi ticchettò nei pressi del giovane beta, smuovendogli il corpo smorto con un piede non appena fu tanto vicina da poterlo fare. Ma solo alla fine Harriet poté vedere di chi si trattava sul serio: Victoria Argent sorrideva soddisfatta del suo operato, il viso pallido illuminato dal candore della luna alta nel cielo.  «Harry?».
Sgranai gli occhi al suono della voce di Stephen, improvvisamente risvegliata da quell’ennesima atroce visione. Cercai di regolarizzare il respiro e non far trasparire nemmeno un minimo di tutta la mia preoccupazione, distogliendo lo sguardo dalla tv illuminata e cercando brevemente gli occhi chiari dello sceriffo. «Scusami», mormorai, mettendomi in piedi in fretta e furia. «devo fare una telefonata urgente». «D’accordo», Stephen si limitò ad annuire, «Va tutto bene?». «Certo». Finsi un sorriso, poi sgattaiolai in camera mia. Impazzii per qualche minuto alla ricerca del cellulare, salvo poi trovarlo sommerso da una cascata di libri che non mi ero scomodata di riordinare. Non ebbi tempo di pensarci in quel momento e semplicemente mi limitai a comporre il numero di Stiles, sempre in cima alla lista dei miei contatti. Avevo bisogno di sentire la sua voce e sapere che andasse tutto bene, anche se già ne dubitavo. Ma quando Stiles ignorò tutte le mie chiamate, mi sentii quasi crollare il mondo addosso. Cercai di non cadere nel panico mentre cominciavo a vagliare qualsiasi altra possibilità e giunsi solo infine alla soluzione dell’arcano: sarei dovuta andare a quel rave da sola per accertarmi che fosse tutto a posto. Ma da chi mi sarei fatta accompagnare? Esclusi subito Stephen e tutti i miei parenti, pensando a Lydia per un solo breve attimo. Non potevo chiedere a lei. Ma allora… Dei ricci biondissimi e un paio di occhi neri come la pece mi saltarono in testa all’improvviso, incendiandomi le vene di adrenalina. Ero pronta a consegnarmi nelle mani del nemico e compiere quella pazzia? Per le persone a cui tenevo, quello ed altro. Fu pensando ciò che composi il numero di Victor Daehler. «Pronto?». «Victor, sono io». Dall’altro capo del telefono ci furono interminabili minuti di silenzio. Ma alla fine – molto probabilmente dopo aver controllato il display con aria incredula – Victor decise di riprendere a parlarmi. «Non ci posso credere», mormorò, ma io non avevo tempo per quei giochetti e subito lo interruppi. «Dove sei?». «Stavo per uscire, a dire il vero. Perché me lo chiedi? Non sarà mica che vuoi unirti a me?». Stentavo a crederci anch’io. Trattenni un brivido di terrore e rimandai giù la bile, sforzandomi di parlare ancora. Fin lì avevo fatto un buon lavoro. «Se stai andando al rave in periferia, sì». Sentii Victor ridacchiare. «Certo che sto andando lì», confermò poi, gongolando quasi. «Dammi il tuo indirizzo, ti passo a prendere». Istintivamente, il mio cuore aumentò i battiti. Gli avrei rivelato dove vivevo, permettendogli così di invadere un altro luogo a me caro? Non se ne parlava proprio. «Non sono a casa», mentii in un sussurro trafelato, ingegnandomi alla ricerca dell’ennesima bugia da propinargli, «Vediamoci alla Beacon Hills High School». «Tuo fratello non ti somiglia per niente». Ruppi il silenzio all’interno dell’abitacolo all’improvviso, senza nemmeno pensarci troppo su. Ma allo sguardo incuriosito di Victor puntato su di me, non potei far altro che pentirmi di ciò che avevo appena detto. Come da accordo, Daehler era venuto a prendermi di fronte scuola ed io ero stata brava a glissare qualsiasi tentativo di conversazione mentre lo osservavo di sottecchi intento a guidare verso il rave in periferia. Non volevo che mi parlasse, ma avevo scoperto ben presto che il silenzio di quell’auto fosse di gran lunga peggiore e avevo dato vita ad una nuova conversazione. Pentendomene l’attimo dopo. «Mio fratello?», mi domandò Victor, con un’aria confusa che subito m’insospettì. «Matt», bisbigliai, già non più così sicura di ciò che avevo detto. Che figura ci avrei fatto se Matt mi avesse raccontato una bugia? «È tuo fratello, vero?». Victor svoltò in una via buia e desolata, stringendo più forte le mani sul volante e facendo spallucce. «Be’, non proprio». Lo sapevo. Trattenni a malapena un ringhio infastidito, stringendo i pugni dalla rabbia. Quel Matt credeva davvero di potermi prendere in giro così? Prima di esplodere, cercai di dare un senso a quella situazione. «Cosa intendi?». «È stato adottato». «Oh». Dopo quel mio mormorio insensato cadde di nuovo il silenzio, almeno finché Victor non decise di spezzarlo nuovamente. «L’hai conosciuto a scuola?». Mi limitai ad annuire, il che diede occasione al più grande dei Daehler di continuare a parlare indisturbato. «Mi aveva detto che ci saresti stata anche tu, stasera. Ma non gli ho voluto credere». «Era per lui che eri sempre presente alle partite di lacrosse?». All’improvviso tutto aveva senso. Victor annuì debolmente, rallentando nei pressi del grande magazzino che già avevo visto. Trattenni il respiro dall’improvvisa ansia ritornata a farmi visita. «Ti sembra così strano?», mi chiese Victor, distraendomi tanto che per poco non gli sorrisi con gratitudine. Feci spallucce, cominciando a trafficare con la cintura di sicurezza, pronta a scendere e combattere se ce ne fosse stato bisogno. «Non è nemmeno in prima squadra…», provai a dire, ma Daehler m’interruppe prontamente. «È mio fratello», mormorò deciso. «Voglio sostenerlo comunque». Quelle parole mi tolsero letteralmente il fiato. Erano così poco da Victor che non potei far altro che sgranare gli occhi sulla sua figura, chiedendomi cosa diavolo avrei dovuto dirgli a quel punto almeno finché delle immagini ben diverse mi esplosero sulla retina. Derek e Boyd sedevano l’uno di fianco all’altro, inginocchiati sull’asfalto e nascosti da un muro in cemento massiccio. Avevano l’aria di essere feriti entrambi e si scambiavano parole che non riuscivo a sentire per quanto m’impegnassi. «Victor», soffiai non appena la visione sparì, lasciandomi con un Boyd che si metteva in piedi per correre chissà dove mentre io a mia volta scendevo fuori dall’auto – ben presto imitata dal suo padrone. «comincia ad entrare. Ti raggiungo sub–». Le parole mi morirono in gola al tocco ghiacciato che mi strinse il polso. Victor aveva circumnavigato l’auto alla velocità della luce e mi aveva raggiunta, lasciandomi in trappola ed impedendomi di scappare. «Scherzi?», domandò trattenendo a stento una risata divertita mentre io mi sentivo il sangue gelare nelle vene e il cuore prendere a battere come un forsennato. «Tu vieni con me, tesoro. Siamo qui come coppia». A quell’ultima parola, la stretta di Victor sul mio polso si accentuò così tanto da farmi scappare un gemito. Ma paradossalmente, fu proprio il dolore a risvegliarmi. Digrignai i denti, cercando di ricordare al meglio tutti gli insegnamenti che mia cugina Natalie mi aveva riservato in merito alla difesa personale. Poi, con uno scatto veloce che sorprese anche me oltre che Victor, riuscii a liberarmi dalla sua presa e gli mollai un pugno dritto sul naso. «Ti piacerebbe», mormorai, col fiato corto e la mano dolorante – ma comunque soddisfattissima degli evidenti risultati ai quali i miei allenamenti con la sorella di Walter stavano portando. Abbandonai il fianco di Derek non appena riconobbi la figura di Stiles. Mi dava le spalle, ma ero sicura che si trattasse di lui anche senza guardarlo in viso e non me lo feci ripetere due volte prima di raggiungerlo di corsa. Alla fine – anche grazie alle mie visioni – ero riuscita a trovare Derek ed insieme avevamo provato ad aiutare Scott, ma nonostante tutte le atroci immagini che i miei poteri mi avevano permesso di vedere, non ero riuscita a capire dove Victoria Argent avesse portato il mio amico per poterlo torturare in santa pace. Perché era proprio quello che stava facendo: l’avevo visto coi miei stessi occhi e la consapevolezza di non poter far nulla per mettere fine a quell’atrocità immonda mi faceva sentire malissimo. «Stiles», soffiai, quando ebbi finalmente raggiunto l’unica persona fra tutte capace di farmi stare bene e mi ritrovai stretta tra le sue braccia. Lo sentii mormorare il mio nome con un tono a dir poco sorpreso, prima che mi allontanasse dal suo corpo per potermi guardare bene in viso. «Cosa ci fai tu qui?», mi domandò, ma non ebbi occasione di rispondergli perché Derek – che ormai ci aveva raggiunti – mi rubò la parola. «Dov’è Jackson?». Stiles guardò l’alpha brevemente, sempre tenendomi stretta a sé mentre tentava di racimolare un po’ di coraggio. «L’abbiamo perso», confessò infine, ed io non potei far altro che trasalire. «Abbiamo perso anche Scott». Lo sguardo di Stiles s’adombrò all’improvviso e credo che provò subito a chiedermi spiegazioni, ma non posso esserne sicura perché in quell’esatto momento un’ennesima visione mi portò ben lontana da lì. Scott era a terra, completamente trasformato e incapace di rimettersi in piedi per dare a Victoria Argent ciò che si meritava sul serio. Lo vidi cercare di fare forza sulle braccia inutilmente mentre la madre di Allison gli riservava chissà quali parole di scherno, almeno finché Scott non riuscì finalmente a raggiungere il suo obbiettivo e si sollevò sulle ginocchia, liberando uno degli ululati più forti che l’avessi mai sentito emettere. Quello riuscii a sentirlo benissimo. Proprio come Derek. «Scott», sussurrò infatti, con un’improvvisa quanto dolorosa consapevolezza. Quell’ululato era una disperata richiesta di aiuto. «Sta morendo», compresi. Stiles si agitò ancor di più. «Cosa diavolo stai dicendo?». Ma Derek evitò che cominciasse a straparlare come suo solito. «Spezzalo», si limitò ad ordinargli, senza che io capissi minimamente a cosa diavolo si riferisse. La reazione di Stiles mi confuse ancor di più. «Non esiste!», strillò, e allora Derek fu costretto ad usare le maniere forti. Alzò la voce ancor più di lui. «SCOTT STA MORENDO!». «L’ho v-visto, Stiles», balbettai, cercando inutilmente di trattenere le lacrime. «Spezzalo». Glielo ordinai anch’io, anche se non avevo idea di cosa significasse. Semplicemente mi fidai di Derek. E Stiles si fidò di me – ancora una volta – perché solo un secondo dopo s’inginocchiò ai nostri piedi e dissolse il cerchio che come da ordine di Deaton aveva costruito intorno al magazzino, servendosi della polvere di frassino che… aveva intrappolato Derek. Realizzai la cosa con un secondo di troppo di ritardo, non appena lo vidi oltrepassare il confine e sparire verso chissà dove. Di nuovo non me lo feci ripetere due volte: donai un’ultima veloce occhiata a Stiles e poi rincorsi Derek, pronta a non sapevo nemmeno io cosa. Quando lo trovai intento a combattere con Victoria, temetti di essere arrivata troppo tardi. «Si fermi!», urlai, così forte da sentirmi dolere la testa. Mi sentivo così impotente che scoppiai a piangere, ma scoprii ben presto di sbagliarmi. Il mio urlo stridulo infatti servì a distrarre Victoria tanto che questa, dopo avermi dedicato una lunga occhiata inespressiva, lasciò andare Derek e si defilò velocemente. Anche quella volta eravamo chissà come riusciti a cavarcela. Siamo da Deaton. Vieni qui prima che puoi, ti prego. Cacciai il cellulare in tasca dopo aver inviato quell’sms a Stiles, pregando perché lo leggesse presto e corresse in mio aiuto, pronto a portarmi via da quel posto e dalle scene con le quali mi costringeva a confrontarmi. Non avrei sopportato di osservare Scott privo di sensi un attimo di più, come non riuscivo più a stare al fianco di Derek come se niente fosse. Mi strinsi maggiormente le braccia al petto, deglutendo mentre muovevo grandi passi sulla moquette dello studio veterinario. Gli occhi verdi di Derek non mi persero di vista nemmeno per un attimo, ma io non osai ricambiare il suo sguardo curioso. Almeno finché non mi rivolse la parola all’improvviso. «Ti sento addosso l’odore di quel biondino». M’immobilizzai pensando a Victor e chiedendomi dove fosse finito. Scacciai via dalla mente quell’immagine quando finalmente compresi di non volerlo sapere. Allora sciolsi le braccia lungo i fianchi e fronteggiai Derek, fingendo una nonchalance che non possedevo più da tempo. «Smettila di annusarmi», pigolai, molto più in imbarazzo di quanto avessi creduto. Derek mise subito su un’espressione infastidita. «Non ti sto annusando», mi rimbeccò, inchiodandomi sul posto con un’occhiataccia delle sue. «È il tuo corpo che lo sprigiona da sé. Quello, e l’odore di paura». Paura? Aggrottai le sopracciglia, muovendo un ulteriore passo nella direzione di Derek. Era seduto su uno sgabello posizionato contro il muro mentre io ero in piedi e – almeno all’apparenza – lo sovrastavo con la mia figura. «Non ho paura», gli dissi, sincera come raramente riuscivo ad essere con lui. «Non ora. Ma ce l’hai avuta prima, quand’eri insieme a Victor. So che non è stato molto tempo fa perché l’odore che hai addosso è ancora abbastanza forte», osservò Derek, ed io rabbrividii sotto il peso di quella spiacevole verità. All’improvviso mi sentivo completamente esposta a lui, così nuda da aver bisogno che qualcuno mi proteggesse dai suoi occhi scrutatori. «Dovresti smettere di vederlo». Non dipendeva da me, ma evitai di dirglielo. Semplicemente distolsi lo sguardo dal suo viso pallido – mi arresi – e mormorai un flebile: «Grazie per l’interessamento». Innalzai il solito muro che mi divideva dal resto del mondo, il sacco a pelo che mi chiudevo attorno per proteggermi dall’esterno. O perlomeno ci provai. «Harri–». Derek provò a richiamarmi, distraendomi e facendomi vacillare. Ma non gliel’avrei permesso. Non ancora. «Sul serio, evita», ordinai, così perentoria che l’alpha non si sognò più nemmeno per scherzo di provare a contraddirmi. Al contrario si chiuse in un silenzio a lui fin troppo familiare: un silenzio che io apprezzai moltissimo, ma che ahimè non durò abbastanza a lungo. «L’ho morsa». Un improvviso campanello d’allarme m’esplose nel cervello, ma tentai di ignorarlo. Non fasciarti la testa prima di averla rotta, Harry. «Chi?», domandai quindi a Derek, cercando di pensare positivo almeno per una volta. «Victoria Argent». Quel nome mi spezzò il respiro in gola. Milioni di sensazioni s’affollarono dentro di me, ma alla fine una sola riuscì a prevalere sulle altre. La rabbia. Una rabbia cieca. «Tu COSA?», quasi urlai, raggiungendo di nuovo Derek ed osservandolo con gli occhi spiritati. Non potevo credere a ciò che mi aveva appena confessato in un sussurro. Ancora speravo che fosse tutto parte di uno scherzo di cattivo gusto. «Stava cercando di ucciderci! Cosa volevi che facessi?». Derek scattò in piedi, arrabbiato come e forse anche più di me mentre indicava Scott e cercava inutilmente di farmi ragionare. Lo guardai con quello che dovette sembrargli disgusto, mentre i primi conati di vomito già cominciavano a sconquassarmi lo stomaco. «È la madre di Allison», riuscii a dire solamente, prima che la bile riuscisse infine a raggiungermi la gola obbligandomi – con mio grande piacere – a correre fuori da quella stanza diventata all’improvviso soffocante. Sentivo il peso delle confessioni di Derek agguantarmi la gola in una morsa, ma me ne fregai mentre correvo nella hall e finivo a rovesciare anche l’anima nel cestino dei rifiuti. I couldn’t hear those screams
even in my wildest dreams. Ringraziamenti Agli Iron Maiden, perché tipo ogni parola (?) dell’album Seventh son of a seventh son rispecchia la situazione di Harriet ed io lo adoro come se non ci fosse un domani. Infinite dreams ne fa parte (ASCOLTATELA *fa terrorismo psicologico*). Ai Marianas Trench (♡), la mia band preferita – che ho conosciuto proprio grazie ad Harriet e Stiles e che mi ha accompagnato ancora una volta nella stesura di questa storia. Non so a chi dovrei essere più grata, davvero. Note Ormai l’avrete capito che mi piace disseminare collegamenti con parachute qua e là, dunque, se ci tenete a leggere della prima volta in cui Stiles ha recitato ad Harriet il famoso mantra dell'«Uno è un incidente, due è una coincidenza, tre è uno schema», andatevi a leggere il capitolo 9. Il fatto che nella scena 2 Scott chiami Harry «Comandante» è nient’altro che l’ennesimo riferimento a parachute. E potete leggere di questi due bimbi bellissimi dei McCarter nel capitolo 18. Le gommose sono una cosa che ad Harriet non deve mai mancare, da come potrete anche capire leggendo Tè e orsetti gommosi, ovvero la shot – scollegata da tutto questo ma sempre con protagonisti gli Starriet – che ha dato inizio a questa magica avventura, pubblicata quasi per scherzo e che poi mi ha e ci ha portati fin qui. Natalie Edwards, da come avrete potuto capire, è la sorella di Walter. Da come già accennato in parachute, è più piccola di lui di due anni – Walt ne ha 22 – e scopriamo qui che sta aiutando Harriet con degli specialissimi allenamenti di difesa personale. So che è tutto molto nebuloso, finora, ma non disperate: vedrete Natalie molto presto ed imparerete a conoscere anche lei. ♡ Chi mi conosce sa che Molto forte, incredibilmente vicino è il mio libro preferito e che – proprio come con tutte le cose che mi piacciono – proprio non posso fare a meno di rendergli omaggio ogni volta che posso attraverso le schifezzuole che scrivo. A questo proposito ci tengo quindi a specificare che la figura del “sacco a pelo” che Harry usa chiudersi addosso per proteggersi dal mondo esterno non è di mia invenzione, bensì di quel grandissimo uomo di Jonathan Safran Foer. *scuoricina* Come sempre, ribadisco che per ogni dubbio e domanda potete scrivermi dove vi pare e piace e che trovate l’album coi vari prestavolto sul mio profilo facebook. |
Capitolo 8
*** Stay ***
It’s easy to love someone when they’re happy.
What’s hard is loving someone when they’re suddenly crying in the middle of the night because everything came crashing down at once. kaleidoscope
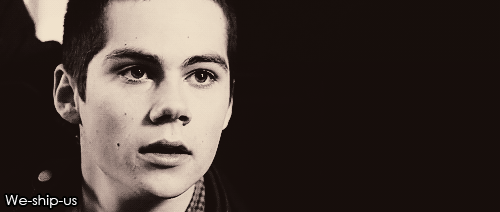 8. Stay
«Non possiamo salvare Jackson». Ormai lo sapevo. Scott mi aveva ripetuto così tante volte quella dannatissima frase che questa quasi mi era entrata dentro, ma ancora non aveva avuto il coraggio di scalfire il pesante velo della mia consapevolezza. Ascoltavo le parole di Scott e sapevo che dicesse la verità, ma non riuscivo a farmene una ragione. Non riuscivo ad accettare di dover perdere qualcun altro. Ma in fondo, come salvare un ragazzo che non ha nessun interesse proprio nell’essere salvato? «Non possiamo neanche ucciderlo. Io ho visto molte cose, Scott, ma mai niente di simile. Non so nemmeno se possiamo fermarlo». Sussultai a quelle parole, all’improvviso consapevolissima della presenza di Derek Hale di fronte a me. Quella sera Scott non aveva nessuna voglia di affrontare Derek da solo e aveva chiesto a me di accompagnarlo alla vecchia stazione dove lui e il suo branco s’erano accampati da tempo. Ancora non mi spiegavo con quale coraggio gli avessi detto di sì. «Forse dovrebbero occuparsene gli Argent», propose il beta allora, ed io non potei far altro che sussultare di dolore all’improvviso cognome di Allison. E di Victoria. Scacciai via dalla mente gli intensi occhi azzurri della consorte di Chris, cercando di non far trasparire il dolore che già da troppo tempo mi pesava sul petto come un macigno. Ma quando gli occhi verdi di Derek si specchiarono all’improvviso nei miei, non potei far altro che vacillare visibilmente. «L’ho trasformato io. È colpa mia», mormorò, e sapevo che stesse parlando direttamente a me – anche se fingeva di rispondere a Scott; che si stesse colpevolizzando per ciò che aveva fatto non solo a Jackson ma anche – e soprattutto – alla signora Argent. Io lo sapevo, Scott no. Ecco perché tentò di giustificarlo. «Tu non l’hai trasformato in questo! È successo a causa del suo passato». Mi morsi le labbra a sangue nella speranza di trattenere un gemito, stringendomi convulsamente le braccia al petto, tentando di proteggermi da non sapevo nemmeno io cosa. «Quella è solo una leggenda, non è così semplice». Scott non sapeva nulla, ma capì comunque. «C’è qualcosa che non mi vuoi dire?», domandò, muovendo un passo nella direzione di Derek mentre io al contrario indietreggiavo. «Perché credi sempre che io ti nasconda qualcosa?». L’alpha assunse un’aria quasi stizzita. Un’aria che proprio non si poteva permettere. Cercai di farglielo capire con la peggiore delle mie occhiate torve, ma non raggiunsi il mio obbiettivo bene tanto quanto Scott, che si fece subito valere a parole proprio come avrei dovuto fare io già da diverso tempo. «Perché mi nascondi sempre qualcosa, ecco perché!», urlò quasi, e a quelle parole non potei far altro che donare a Derek l’ennesima occhiata carica di significati. Scott stava dicendo la verità – ancora – e lo sapevamo tutti benissimo. Derek gli stava sul serio nascondendo qualcosa. Ma non era l’unico. «Forse lo faccio per proteggerti», sussurrò l’alpha, di nuovo inchiodandomi sul posto coi suoi smeraldi profondi e privandomi di ogni facoltà di movimento – impedendomi di scappare. Quella era la sua scusa preferita. L’ho fatto per proteggerti e tutto tornava a posto. O perlomeno, così credeva Derek. «Far parte del tuo branco non vuol dire “niente segreti”?». Evidentemente no. L’alpha scosse la testa piano, poi si mise in piedi e mosse un passo nella direzione di Scott. Non mi guardò più ed io gliene fui grata mentre continuavo ad indietreggiare, a farmi sempre più lontana da lui. Quello era l’unico modo che conoscessi per mettermi al riparo. «Andate a casa e state attenti: arriva la luna piena. Per come vanno le cose, ho la sensazione che non sarà come le altre». Cadde il silenzio. Pesantissimo e imbarazzato. Durò per molto più tempo di quanto sarei mai stata pronta a sopportare, almeno finché non capii di dover prendere personalmente in mano la situazione. Afferrai le dita di Scott, attirandolo a me velocemente. «Andiamo via», gli ordinai, e il beta non se lo fece ripetere due volte. Semplicemente mi seguì. Voltammo le spalle a Derek e provammo ad abbandonare quella vecchia e desolata stazione, ma proprio la sua voce c’inchiodò sul posto dopo due miseri passi. «Harriet, aspetta», quasi pregò, e sentii la sua voce e i suoi occhi incendiarmi la schiena. «Posso parlarti un attimo?». Lasciai andare la mano di Scott, ancor più velocemente di come l’avevo afferrata in precedenza, e mi voltai di nuovo a guardare Derek – con non so quale coraggio. Stupido, pensai, mentre Scott al mio fianco s’irrigidiva sempre più. Decisi di donargli un’occhiata e un sorriso non troppo convinto, nella speranza che potesse tranquillizzarsi. Non so cosa vide esattamente sul mio viso, ma qualunque cosa fosse lo fece scappare. Ed io ne fui soddisfatta. «Vado a recuperare la macchina. Ti aspetto fuori», mormorò, poco prima di sparire e lasciarmi sola con Derek, proprio come avevo inconsciamente desiderato e temuto che succedesse. «Cosa c’è?», gli chiesi con voce flebile non appena fummo sul serio soli, cercando di sovrastare il silenzio di quell’immensa e polverosa stazione mentre avanzavo di un passo nella sua direzione, gli occhi lucidi e le braccia costantemente strette attorno al petto. Derek mi esaminò per qualche attimo – facendomi sentire completamente nuda come suo solito – poi mosse anche lui un passo verso di me. «Gli hai detto di Victoria?». Rispose con un’altra domanda, com’era sua abitudine, quando già eravamo molto più vicini di quanto credevo che sarei stata pronta a sopportare. Ma a quel suo quesito cambiai improvvisamente idea e fui la prima ad azzerare la distanza che ci separava. Tanto che quando gli parlai nuovamente, ero a poco più di una spanna dal suo viso. «Se l’avessi detto a Scott, a quest’ora saresti un lupo morto», sibilai, ma non appena finii di parlare la scintilla di coraggio che m’era bruciata dentro fino a quel momento si estinse all’improvviso, lasciandomi spossata e spaventata tanto che fui costretta a farmi di nuovo lontanissima da Derek. «Grazie», sussurrò lui, e quella parola fu la goccia che fece definitivamente traboccare il vaso. Avrebbe potuto non aggiungere nient’altro e sarebbe finito tutto così, con me che gli ridavo le spalle e tornavo a casa insieme ad uno dei miei amici più cari. E invece no, Derek aveva parlato e mi aveva ringraziata. Mi aveva ringraziata perché ero una persona orribile. E non avrei mai potuto accettarlo. «Non osare ringraziarmi», sputai, voltando di tre quarti il capo per incendiarlo con uno sguardo da sopra la spalla. «Non l’ho fatto per te: l’ho fatto per Scott. Mi sento uno schifo e non voglio che per lui sia altrettanto». Scese il silenzio – di nuovo – e gli diedi le spalle – di nuovo – convinta ad andarmene. O perlomeno così credevo. Ad un passo dalla libertà, invece, sentii di nuovo l’impellente bisogno di parlargli. «Derek», lo richiamai quindi, sentendo il dolore aumentare ad ogni lettera di quel suo dannatissimo nome. L’alpha nemmeno si scomodò a rispondere, perciò fui sempre io a portare avanti quella dolorosa conversazione. «Farai meglio a tenere anche tu la bocca chiusa». Schivai all’ultimo secondo un pugno in pieno viso, il respiro affannato e gli occhi sgranati perché proprio non riuscivo a credere di essere stata tanto fortunata e tanto pronta per salvarmi da quel terribile colpo sferrato da mia cugina Natalie, nonché la mia allenatrice personale da un po’ di tempo a quella parte. Scattai indietro per farmi lontana dalla donna senza pietà nella quale era capace di trasformarsi durante i nostri “match”, ma non servì a granché: Nattie mi raggiunse con un balzo e mi atterrò sul tappeto rosso nel seminterrato di casa Edwards, quello che da sempre avevamo utilizzato per i nostri allenamenti improvvisati. «Oggi sei distratta da far schifo», soffiò ad un passo dal mio viso, sovrastandomi con la sua figura affannata e sudata – almeno tanto quanto me. «Non c’è gusto a picchiare un manichino». Sbuffai, togliendomela di dosso con poca gentilezza. Se c’era una cosa che avevo già imparato bene di Natalie, era che lei della gentilezza se ne fregava altamente. «Grazie, eh», la rimbeccai, punzecchiandole – sempre poco giocosamente – la spalla. Nattie alzò gli occhi al cielo, sciogliendosi lo chignon disordinato. Fine degli allenamenti. Complimenti, Harry, l’hai esaurita. «Ma di cosa mi ringrazi? Piuttosto scusati con me. In genere mi diverto a farti nera, ma oggi sei una palla. A che stai pensando?». Era la sorella minore di mio cugino Walter, dovevo aspettarmi che anche lei fosse brava a leggermi dentro tanto quanto il fratello e forse pure di più. Eppure quelle sue attenzioni mi mozzarono il respiro in gola, tanto che dovetti riaccasciarmi di nuovo sul tappeto per tentare di regolarizzarlo. «A niente, Sensei», le dissi poi, prendendola in giro con quel nomignolo che lei mi aveva confessato di adorare. Difatti la vidi mettersi in piedi con un sorriso malcelato sulle labbra piene. «Non puoi mentirmi, mia piccola allieva», fece il vocione da vecchio maestro di kung fu – quello che già tante volte mi aveva propinato, facendomi morire dal ridere – ed io scossi la testa mentre la osservavo recuperare del cibo da uno zainetto blu, «Seriamente, Har. Sfogati con la tua cuginetta preferita». Accettai il pacchetto di patatine che mi porgeva Natalie, rimettendomi seduta di fianco a lei prima di incominciare a mangiare. «Pensavo che quel posto appartenesse di diritto ad Oriesta». Nattie scrollò le spalle, per niente colpita dalla mia osservazione “cattiva”. «Ori è solo una pazza. Tu preferisci me, anche perché ti insegno ad essere forte. Non negarlo». «Convinta tu», svicolai, infilandomi una manciata di patatine in bocca pur di non ammettere che fosse proprio Nat la mia cugina preferita. Anche perché sarebbe stata una bugia: volevo bene anche ad Oriesta, come a ciascuno di tutti i componenti della stramba famiglia che avevo ritrovato da poche settimane a quella parte. Alla fine riuscii a distogliere l’attenzione di mia cugina da quell’ostico argomento, ma non dal fulcro della nostra conversazione. Non dal motivo che l’aveva indotta ad interrompere il nostro allenamento settimanale prima del tempo. «Cofa f’è che ti furba?», mi domandò infatti dopo un po’, senza nemmeno avere la decenza di mandare giù le sue patatine prima di riprendere a parlarmi. Risi istintivamente di quant’era adorabilmente maschiaccio. Poi partii alla ricerca di qualcosa da raccontarle, qualcosa che sarebbe potuto piacerle tanto da distrarla dalle confessioni che proprio non mi sentivo di fare. «L’altro giorno sono riuscita a mettere KO uno», dissi infine, soddisfatta del mio lavoro mentre mettevo da parte le patatine e mandavo giù interi litri di acqua. Dopo quella mia rivelazione improvvisa, anche Nattie – stranamente – lasciò perdere il suo cibo e strabuzzò gli occhi nocciola sulla mia figura spossata dall’allenamento e assolutamente impresentabile. «U-Uno?», balbettò, incredula a dir poco. «E perché mai sei così triste?». Mi rubò la bottiglia d’acqua dalle mani ed io glielo lasciai fare, rabbuiandomi all’improvviso pensiero di ciò che le avrei detto di lì a poco. Mi fissai le mani screpolate, nell’attesa che il coraggio che mi serviva per continuare a portare avanti quella conversazione venisse a me. «Perché un altro, poco tempo prima, ha messo KO me», dissi infine, e allora da Nat ricevetti nient’altro che silenzio. «Era un licantropo». «E cosa pretendi: di diventare più forte di loro?», Natalie soffocò una risata improvvisa ed io non potei fare a meno di ricercare la pelle olivastra del suo viso genuinamente divertito, «Posso insegnarti tutto il jiu-jitsu del mondo, cuginetta, ma non faccio miracoli». «Lo so», risi anch’io di riflesso; con Natalie mi era impossibile non farlo, «è che sono stanca di sentirmi sempre così debole–». Mia cugina m’interruppe ancor prima che potessi continuare a pronunciare parole che ancora non conoscevo. «Non sei debole. L’hai dimostrato in più di un’occasione». E il suo tono di voce era così deciso che quasi le credetti. Sapevo che non si riferisse solo ai nostri allenamenti – o ai risultati positivi ai quali questi stavano portando – e non potei far altro che sorriderle, grata per le sue parole confortanti. «Dov’è Walt? Quasi mi mancano le sue prese in giro», domandai poi dopo una manciata di minuti, reputando il silenzio di quel seminterrato decisamente poco tipico. Non c’era stato un allenamento tra me e mia cugina che non venisse interrotto da quel testone di suo fratello, giunto – puntuale come un orologio svizzero – ad infastidirci coi suoi scherzi da eterno bambino. Ma a quanto pareva quel giorno le cose non sarebbero andate così. «Non me lo chiedere, guarda. È tutto preso da una tipa, mi pare si chiami Sandra o Sheila», esalò Nattie all’improvviso, mettendo definitivamente da parte le sue patatine come se la fame le fosse passata all’improvviso. Io la osservai mentre si rimetteva in piedi velocemente, ansiosa di sapere cos’altro mi avrebbe detto riguardo la vita sentimentale di mio cugino Walter. «Non sta mai in casa e quando c’è, parla al telefono con lei. Non l’ho mai sentito così distante». «Quanti anni ha, questa tizia?». Natalie scrollò le spalle. «Non lo so di preciso, ma è più piccola di lui sicuramente. Frequenta la tua stessa scuola». La mia… Quasi mi sentii sbiancare. «Nattie», mormorai, prima ancora che i miei pensieri potessero trovare una fine. «Questa tipa non si chiama Sharon, vero?». Non avevo idea di come mi fosse venuto di pensare proprio a quella rossa malefica, ma decisi di tentare comunque e togliermi quell’atroce dubbio. Attesi una risposta da parte di mia cugina con trepidazione, ma prima ancora che potesse parlare fu il suo viso a darmi una risposta. Sembrava genuinamente confusa. Magari il mio era solo un terribile abbaglio. «Oddio, non lo so», mormorò Nattie comunque, facendo scemare tutta la mia sicurezza. «Potrebbe essere Sharon, Sheila o… No, aspetta». Osservai la sua espressione cambiare completamente e non potei far altro che aggrottare le sopracciglia. «ci sono! Si chiama Shanti. Shanti Jādūgara». Non era Sharon. Non era la ragazza che mi aveva rubato il posto che spettava a me di diritto. Avrei dovuto esserne sollevata, no? Al contrario un presentimento ancor peggiore prese possesso di me. Avevo già sentito quel cognome da qualche parte, ne ero sicura. E un paio d’ore più tardi, mentre scansavo vestiti troppo scollati esposti da Macy’s, capii dove. Nei diari del mio bisnonno. La porta d’ingresso di casa Martin si aprì con un fruscio veloce, dieci secondi netti dopo il trillo del campanello, manco Lydia fosse stata appostata lì dietro già da tempo in attesa del mio arrivo. La vidi riservarmi una lunga occhiata da capo a piedi prima che riportasse gli occhi verde sporco nei miei. «Ho assoluto bisogno di bere», borbottò all’improvviso, quasi schifata mentre indicava con un cenno rapido l’outfit che avevo deciso di sfoggiare in occasione della sua festa di compleanno. «Devo dimenticare quest’eresia al più presto». Alzai gli occhi al cielo. Sapevo che Lydia non avrebbe mai apprezzato sul serio il completo nero con casacchina paillettata e immancabili Converse che avevo scelto per quella sera, eppure non me l’ero proprio sentita di agghindarmi con la gonna e il top elasticizzato e scollatissimo che mia cugina Natalie mi aveva costretto a comprare da Macy’s. La Martin avrebbe dovuto semplicemente farsene una ragione. «Auguri, Lyd», mormorai, scoccandole un bacio sulla guancia prima di scappare letteralmente dalle sue grinfie – solo dopo aver afferrato, proprio come lei, un bicchiere stracolmo di punch. Il quale rischiai seriamente di rovesciare per intero sul costosissimo parquet di casa Martin nel momento in cui delle labbra che conoscevo già fin troppo bene mi travolsero con un bacio improvviso e capace di strapparmi definitivamente il respiro. Ma la sorpresa lasciò ben presto il posto all’eccitazione, come mi succedeva puntualmente in presenza di Stiles. Ricambiai il suo bacio profondamente, trascinandolo verso un tavolino per liberarmi del bicchiere di punch prima di finire a fare danni. Il tutto senza mai interrompere il contatto da sogno tra le nostre labbra. Questo almeno finché non ebbi decisamente fin troppo bisogno di ossigeno. «Mi sei mancato», soffiai contro le sue labbra, tenendolo stretto a me e non osando allontanarmi da lui di nemmeno mezzo centimetro di più. Mi era mancato sul serio e non volevo che fossimo lontani ancora. Non volevo che diventasse un’abitudine. Stiles sorrise intenerito, reprimendo uno dei suoi gesti più abituali: giocare coi miei capelli. Lo vidi osservare con aria contrita lo chignon ordinato nel quale li avevo costretti e il suo sguardo quasi dispiaciuto mi fece venir voglia di ridere. «Odio quando li leghi, non posso passarci le mani e sentire che ti sciogli a poco a poco», borbottò, nascondendo malamente un broncio tenerissimo dei suoi. Gli baciai la punta del naso, incurante di poterlo macchiare di rossetto come già avevo fatto con le sue labbra che subito mi affrettai a pulire in punta di dita. Dio, quelle labbra… Le osservai per molto più tempo del lecito prima di rendermi conto di doverci dare un taglio per non sembrare una pazza infoiata. Allora ridiedi la mia attenzione al viso di Stiles, poi ai suoi capelli cortissimi. «Io vorrei che tu li facessi allungare», sussurrai pochissimi attimi dopo, passandoci le mani attraverso e ridacchiando del solito solletico che sentii sul palmo. Stiles mi sembrò ad un passo dal rispondermi ancora, ma la voce improvvisa di Scott lo fece fermare con un’imprecazione tra i denti. «Sempre tra i piedi quando non dovrebbe», mi sembrò di sentirlo borbottare, e non potei fare a meno di nascondere il viso contro il suo petto mentre ridevo di gusto e salutavo cordialmente il migliore amico del mio ragazzo. «Comandante!», mi ricambiò lui, battendomi il cinque prima di rivolgersi a Stiles. «Le hai già detto cosa abbiamo scoperto?». Quella domanda mi gelò all’improvviso, tanto che mi feci lontana di scatto dal corpo di Stiles e recuperai il mio bicchiere di punch dal tavolino alle nostre spalle. Sentivo che di lì a poco avrei avuto anch’io “assoluto bisogno di bere”. «No, ovviamente. Non me l’ha detto», borbottai, degnando Stiles di una velocissima occhiataccia. Lui capì subito l’antifona e cominciò a spiegarsi. «In qualche modo il kanima è legato all’acqua. Tutte le sue vittime erano parte della squadra di nuoto del 2006. Quella a cui John Lahey faceva da allenatore». Prima ancora che potessi cercare di articolare una minima frase di senso compiuto, Scott aggiunse: «Ha paura dell’acqua» ed io cercai ancora un po’ di ragionare prima di aprire bocca. «Chi controlla il kanima potrebbe essere un’insegnante, quindi. O uno studente di quell’anno che ce l’ha particolarmente coi nuotatori e con l’acqua», conclusi, guadagnandomi nient’altro che cenni d’assenso. Nessuno disse più nulla ed io buttai giù il punch tutto d’un sorso, sentendo l’impellente bisogno di procurarmene subito dell’altro per non pensare più alla dolorosa evidenza del fatto che di quella situazione, più cose scoprivamo e meno capivo. «Che facce». La voce cristallina di Lydia mi colpì all’improvviso, ma mi risvegliai completamente dalla mia trance fitta di pensieri solo nel momento in cui Scott si voltò a salutarla con un debole sorriso. Distolsi velocemente lo sguardo da Jackson ed evitai di chiedermi ancora dove potesse essersi nascosto Matt – l’avevo evitato per tutta la sera, terrorizzata da morire all’idea di ciò che avrebbe potuto dirmi riguardo a Victor; temevo che avrei potuto rivederlo lì a quella festa e il solo pensiero mi faceva rischiare un mancamento. «Come diavolo fate a non divertirvi?», borbottò la Martin, ondeggiando sui tacchi a spillo nella nostra direzione. Si fermò a pochi passi da me e Scott – seduti l’uno di fianco all’altra – riservandoci uno sguardo infastidito. Poi ci porse un bicchiere di punch ciascuno. Non osai rifiutarlo, ma nemmeno buttarlo giù in gola come in realtà avrei voluto. Sapevo che avrei finito solo per peggiorare – e di molto – la situazione. «Ne ho già bevuti cinque!», trillai difatti, la voce più stridula del solito e l’aria stordita. «Finirai per farmi ubriacare». Lydia allora si limitò a strizzarmi un occhio. «Meglio. Chissà che tu non diventi un po’ più divertente». «Sei una strega». «Ma mi adori comunque». Semplicemente sorrisi, incapace di dare torto a Lydia. Mi aveva completamente in pugno, ma non l’avrei mai ammesso ad alta voce. Tanto che quando Scott attirò la sua attenzione all’improvviso, gliene fui più che grata. «Io non posso bere», le disse, provando inutilmente a restituirle il punch. Inutile dire che Lydia non gli diede retta. «Ma per favore. È la mia festa di compleanno e voglio che vi divertiate! Via quei musi lunghi, su». La Martin mise su un tono di voce così tanto perentorio che all’improvviso né io né Scott provammo più a desistere. Voleva che ci divertissimo? Dovevamo quantomeno provarci. Fu pensando a questo che scrollai finalmente le spalle, buttando giù tutto d’un sorso l’intero contenuto del bicchiere. Scott fece subito altrettanto e poi – non soddisfatto – domandò altri due bicchieri di punch a Lydia. Lei lo accontentò di buon grado e continuammo a bere, almeno finché non sentii tutto intorno a me prendere a girare vorticosamente e capii di essere irrimediabilmente ubriaca. Dovevo esserlo, perché ciò che mi ritrovai all’improvviso di fronte agli occhi non poteva essere vero. Lei non poteva sul serio essere lì. «Mamma?», soffiai comunque, cercando di mettere bene a fuoco l’immagine sbiadita di mia madre Jenette. La vidi, lì di fronte a me, bellissima come sempre e affiancata da Cassandra. E capii subito che niente di tutto quello fosse vero, se non nella mia mente. Se non in un’altra delle mie abituali visioni. «Proprio te cercavo», mormorò Jenny, inchiodandomi sul posto con le sue iridi scure – e il peso della sua voce mi fece scivolare il bicchiere vuoto per metà dalle mani sudate. «C-Che ci fai qui?», riuscii a balbettare dopo un’infinità di tempo. Ma non ricevetti alcuna risposta da parte di mia madre, e allora decisi di tentare con mia sorella. Ma riuscii solo a pronunciare il suo nome in un sussurro: «Cassandra?». Nemmeno lei si degnò di rispondermi. Rimase semplicemente immobile di fronte a me, fissandomi da parte a parte coi suoi occhi tanto simili ai miei da farmi star male. Almeno finché Jenette non riprese a parlare, col tono pieno d’astio che già le avevo sentito rivolgermi solo pochi giorni prima. «Volevo dirti dal vivo quanto mi hai delusa e ferita col tuo comportamento», esalò, e nell’improvviso silenzio che cadde dopo quelle parole simili a lame mi sentii morire e gli occhi mi si riempirono di lacrime che sapevo già non sarei riuscita a trattenere. «Mamma…», sibilai, con la voce difatti già rotta dal pianto. Tesi le dita nella sua direzione, provando ad avanzare di un passo nonostante quanto mi sentissi immobilizzata sul posto. Ma le successive parole di Jenny mi gelarono completamente, impedendomi qualsiasi tipo di movimento. «Non chiamarmi così, Harriet. D’ora in poi non avrai più una madre. Sei una bugiarda». Bugiarda. Quell’aggettivo ebbe lo stesso identico peso di uno schiaffo in pieno viso, tanto che mi sentii le guance bruciare dalla rabbia e gli occhi nuovamente fiammeggianti. «No che non lo sono!», le urlai, con un coraggio che nemmeno pensavo più di possedere. Ma il mio tentativo di ribellione venne ben presto stroncato da Cass. «Sei una traditrice», aggiunse, spezzandomi le dita che ancora tenevo tese nella loro direzione con la sua cattiveria. «Hai preferito papà a noi, che ti abbiamo cresciuta senza mai lasciarti sola». «Non ce lo meritavamo e lo sai». Avevo il viso ormai zuppo di lacrime e la vista più annebbiata che mai, ma non mollai la presa. Non ancora. «Non ho preferito nessuno!», urlai al contrario, sincera come poche volte lo ero stata nella mia vita. «Non ho intenzione di abbandonarvi». Ma di nuovo le mie parole non servirono a nulla. Mia madre, per nulla scalfita né da quelle né tantomeno dalle mie lacrime, si limitò a scrollare le spalle prima di darmi la schiena e cominciare ad andarsene come se n’era venuta – in perfetto silenzio. Prima di sparire però, volle darmi il colpo di grazia. «Forse tu non hai intenzione di abbandonarci», mormorò. «Ma noi sì». «Magari capirai come ci si sente». Cass aveva appena appena finito di parlare quando la visione si dissolse all’improvviso di fronte ai miei occhi, lasciandomi circondata da nient’altro che fumo. Ritornai alla realtà, una realtà nella quale gli occhi mi bruciavano a furia di trattenere lacrime e la musica proveniente dalla casa di Lydia era sempre più alta. Proprio come la voce che di fianco a me continuava a chiamare il mio nome imperterrita. «HARRY!». Scott, realizzai all’improvviso. E sussultai, sgranando gli occhi sulla sua figura e vedendolo sul serio – finalmente. Era ancora lì accanto a me, non mi aveva abbandonata. Non anche lui. «Stai bene?», mi domandò, stringendomi le spalle tra le mani tanto che quasi rabbrividii sotto il suo tocco. Ero nuovamente cosciente, ma comunque incapace di rispondergli. McCall lo capì, tanto che non si fece problemi a portare avanti completamente da solo quel suo interrogatorio serrato. «Cos’è successo? Cos’hai visto?». Ma neanche per quelle nuove domande avevo risposta. Cos’era successo? Cosa avevo visto? Un altro pezzo di futuro? Sperai ardentemente di no, trattenendo il respiro e le lacrime almeno finché non mi sentii soffocare. «Niente», soffiai infine, sforzandomi di mantenere il contatto con le iridi nere di Scott. «Tu come stai?». Glielo chiesi non solo perché m’interessava ma anche e soprattutto perché avevo bisogno di distrarmi. E il beta probabilmente lo capì, perché mi lasciò andare le spalle ma non osò farsi lontano e negarmi quell’implicito desiderio. «Non bene», rispose, facendo sì che la mia attenzione potesse finalmente spostarsi su qualcosa di diverso da me e i miei mille problemi. «Ma non è colpa della luna piena. Io… non capisco». Neanch’io, Scott. Neanch’io, avrei voluto dirgli. Ma evitai. Me ne restai in silenzio ancora per innumerevoli attimi, almeno finché non riuscii a regolarizzare il respiro e i battiti forsennati del mio cuore. Poi riportai gli occhi sul viso adombrato di McCall. «Possiamo cercare Stiles?». Che capissimo le cose sempre quand’era troppo tardi lo realizzai proprio quella sera, quando la festa di compleanno di Lydia stava quasi per giungere al termine ed io ero ancora lì a schivare tocchi indesiderati e a cercare di non sentire nessuno degli schiamazzi chiassosi degli invitati, totalmente impazziti sotto il potere di una bevanda all’apparenza innocua come il punch. Era stato quello a provocare la mia terribile visione: mentre cercavamo Stiles, infatti, Scott ne aveva avuta una a sua volta e ciò l’aveva destabilizzato tanto ch’era finito a ringhiarmi contro di lasciarlo in pace e di continuare da sola a cercare Stiles. “Ho bisogno di trovare Lydia”, mi aveva detto, ed io l’avevo accontentato, correndo lontana da lui col cuore che mi rimbombava nel petto come un martello pneumatico. Ma in quel momento eravamo di nuovo lì, insieme – come sempre da quando tutto era iniziato – ad osservare una scena che mai avremmo creduto di poter vedere. Gli schiamazzi della folla divennero silenzio assoluto nel momento in cui Matt Daehler fu trascinato in piscina, nonostante i suoi continui avvisi riguardo al fatto che non fosse in grado di nuotare. Mentre si dimenava come un pazzo nell’acqua, non potei far altro che osservare la scena col cuore in gola e le dita di una mano strette fortissimo sul braccio di Stiles. Sentivo che se non ci fosse stato lui accanto a me, avrei finito con lo sgretolarmi. Ma il peggio doveva ancora arrivare e lo capii pienamente nel momento in cui Jackson Whittemore andò in soccorso di Matt. Non ebbi nemmeno tempo di provare paura: il suo salvataggio fu così veloce e preciso che tutto sfumò in un intenso brivido che mi percorse la schiena nel momento in cui li vidi: Jackson e Matt, kanima e padrone, l’uno di fianco all’altro. Durò un battito di ciglia, ma capii tutto immediatamente – finalmente. Capii tutto proprio come Scott e Stiles. Per quanto assurdo fosse, era Matt. Era Matt che quasi fin dall’inizio, c’era stato sotto il naso – insospettabile. Era Matt al quale non avevamo mai nemmeno lontanamente pensato. «È lui», mormorò Scott semplicemente, e non ci fu proprio nient’altro da aggiungere. Solo una domanda mi riempì la testa all’improvviso: a quel punto, cosa diavolo avremmo fatto? Non ebbi forza di pensarci.  L’ascensore del Beacon Hills Memorial Hospital annunciò la fine del suo ennesimo viaggio con uno scampanellio sonoro ed Allison Argent ne uscì fuori con passo all’apparenza sicuro. Non voleva che qualcuno capisse quanto si sentiva morire all’idea di ciò che avrebbe trovato ad accoglierla in quel posto d’Inferno, ma capì di aver fallito completamente quando gli occhi azzurro intenso di suo padre l’investirono all’improvviso. Lui aveva già capito tutto.
Allison tremò mentre gli si avvicinava lentamente, deglutendo lacrime amare sotto lo sguardo spento e addolorato di Chris. Lui non riuscì a sostenere lo sguardo della figlia a lungo: quando questa l’ebbe quasi raggiunto, infatti, si voltò alle sue spalle ad osservare la sagoma di un corpo coperto completamente da un ammasso di coperte soffici. Anche Allison lo guardò e quella vista le fece immediatamente risalire bile e lacrime in gola. «No», soffiò, sforzandosi di raggiungere finalmente Chris e restare tutta intera. «No, papà. N-No…». Ma già si sentiva spezzarsi e cedere mentre gli occhi le si inumidivano e la voce tremolava sotto il peso insopportabile di un dolore non meritato. Allison avanzò di altri due o tre passi, finché Chris non poté più scappare al suo sguardo, stringendo i denti e le chiavi della sua auto tra le dita così forte da farsi male. Sperava ingenuamente che il dolore fisico potesse prevalere su quello emotivo, spegnendolo. «Mi dispiace», esalò semplicemente Chris – o meglio il fantasma di quest’ultimo – incapace di aggiungere null’altro. Credeva non ci fosse niente di adatto da dire, ma Allison sapeva che non fosse così. Suo padre le doveva un sacco di cose, un sacco di spiegazioni. «Se è una perversa prova di addestramento», provò a dire, col respiro accelerato e il viso ormai zuppo di lacrime, «me lo devi dire, papà. ME LO DEVI DIRE!». Voleva la verità, Allison. Nient’altro che quella, per quanto avrebbe potuto farle male – più di così? Sperò immediatamente di no. Chris rimase in silenzio, osservandola come se fosse nient’altro che un uomo attorniato dai sensi di colpa. Sembrava che non gli fosse rimasto nient’altro, nemmeno la voce. Ma Allison non poteva accettarlo, pretendeva che lui le parlasse. Avanzò ancora nella sua direzione – fino ad azzerare completamente quel poco di distanza che ancora li separava – e gli piombò addosso, colpendolo al petto mentre si sentiva le gambe traballare e il cuore salirle fino in gola. Voleva che Chris soffrisse, che provasse dolore proprio come lei. Ma lui stava già soffrendo a sufficienza, tanto che i colpi della figlia non lo scalfirono neanche lontanamente. Come se niente fosse, si limitò ad afferrarle le mani gelate, obbligandola a stare ferma. Ma Allison non ne era in grado. «Mi dispiace», cantilenò poi nuovamente, e ripeté quelle due parole così tante volte che sembrarono perdere completamente di significato alle orecchie di tutti. Gli dispiaceva. Ed Allison sapeva benissimo che fosse vero, ma non riuscì a capirlo. Non in quel momento. Non capiva più niente, se non che aveva perso anche sua madre e che non si era mai sentita più sola e spezzata di così. Urlò dal dolore, provò di nuovo a colpire Chris con foga e solo alla fine si arrese. Mollò la presa e si accasciò contro il corpo tremante del padre, cercando di non sentire le sue ripetute scuse e di chiedergli perché. Voleva un motivo. Doveva essercene uno, solo che lei non lo conosceva. Harriet Carter sì.  Urlai tanto che mi sentii raschiare la gola e fischiare le orecchie, per nulla abituate a tutto quel trambusto nel silenzio notturno tipico di casa Stilinski. Non appena ripresi conoscenza dopo quella visione, del silenzio tranquillo tipico della notte non rimase nulla. Assolutamente nulla.
Scalciai via le pesanti coperte, dimenandomi come un’ossessa mentre mi sentivo il cuore andare a pezzi e le guance bruciare ad ogni nuova lacrima che le attraversava. Continuai così per un’infinità di tempo, chiedendomi se fossi sul serio sveglia e cosa fosse peggio: la realtà o il sogno. Non lo sapevo. Non sapevo più nulla, se non che Victoria Argent fosse morta. Anche per colpa mia. Quell’ennesimo pensiero mi strappò un’altra fitta di dolore allo stomaco, tanto forte che gemetti e urlai ancor più forte. Ero sveglia, forse, l’incubo era diventato realtà e mi stava capitando ciò che mi meritavo. Ma mi sentivo morire e non volli accettarlo. Almeno finché una luce improvvisa m’investì e un paio di braccia corsero a stringersi contro il mio corpo. Le conoscevo bene, conoscevo quel profumo. Stiles. Lo aggredii letteralmente con un abbraccio fortissimo, come se stringerlo a me in modo convulso potesse bastare a rimettere assieme i pezzi della semplice ragazza texana che ero stata un tempo. Quella che non aveva altri problemi all’infuori di un brutto voto a scuola e una cotta all’apparenza non ricambiata. Mi maledii per quell’ennesimo doloroso pensiero, piangendo forte di fronte al desiderio irrealizzabile di fermare il mio cervello per sempre. Volevo silenzio, volevo smetterla di pensare, volevo non avere un cuore, non provare tutte quelle tremende emozioni e sensazioni. «Fallo smettere, S-Stiles», pregai, urlando ancora dal fondo del mio baratro. Speravo che mi sentisse, speravo che capisse. Sapevo che poteva riuscirci, perché per quanto potesse sembrare assurdo, nessuno mi conosceva come Stiles. E non c’era nessuno che avrei voluto con me in quel momento. Non c’era nessuno a cui avrei permesso di vedermi in quello stato: distrutta, orribile… Nessuno. «Fallo smettere», ripetei, e quella volta la voce mi si affievolì. Mi sentivo all’improvviso stanca, tanto che smisi di dimenarmi all’improvviso tra le braccia di Stiles e chiusi gli occhi. Avrei solo voluto dormire per sempre. Ma non appena mollai la presa, mi pentii subito di averlo fatto. Gli occhi intensi di Victoria Argent mi bucarono le palpebre e le urla di Allison mi rimbombarono nel petto. Di nuovo la imitai, più forte di prima, stringendo la t-shirt di Stiles tra le dita come se ne fosse dipeso della mia stessa vita. Probabilmente gli feci anche male, ma non me ne resi conto sul serio. Non capivo più nulla, nemmeno ciò che stava cercando di dirmi da quand’era accorso in mio aiuto. Sapevo che mi stesse parlando solo perché – nonostante tutto – l’ombra della sua voce mi aveva catturata un paio di volte, tirandomi fuori dal mio baratro oscuro anche se solo per pochi secondi. «Stiles», lo richiamai, tentando di controllare i gemiti e fare silenzio. Magari così avrei potuto finalmente sentirlo. «Stiles, non mi lasciare». Glielo chiesi comunque, anche se sapevo che non l’avrebbe mai fatto. Glielo chiesi perché in quell’esatto momento – come sempre – non c’era nient’altro che desiderassi. Volevo solo che lui restasse. Allora Stiles rafforzò la stretta, tanto che mi sentii mancare il respiro – ma non provai a lamentarmi della cosa – e finalmente lo sentii. «Non ti lascio, Harry», mi rassicurò, in un sibilo così tanto dispiaciuto che credetti addirittura di sentire l’ennesimo crac del mio cuore già completamente distrutto. Lo stavo facendo soffrire da morire. Stavo facendo soffrire anche lui. «Non ti lascio». Funny you’re the broken one
but I’m the only one who needed saving. Ringraziamenti A quel gran bel pezzo di donna che è Rihanna: ormai lei ha un posto d’onore nella ristretta lista di persone che ascolto durante la stesura di kaleidoscope, e proprio non potevo non utilizzare Stay per quest’ultimo capitolo. Note Sappiate che Harry mi stringe il cuore sempre di più. Come potrete capire già da soli, i segreti continuano ad essere il filo conduttore della serie e com’era prevedibile che fosse, ce ne sono un po’ anche qui – e continuano ad avere un effetto drastico sulla mia piccolina. :( Natalie è una componente della famiglia Carter che non vedevo l’ora di farvi conoscere e sono davvero contenta di esserci riuscita in questo capitolo, soprattutto dopo tutto il teasing (?) di quello scorso, AHAHAH. E inoltre ha rivelato un piccolo particolare riguardo alla nuova fiamma di suo fratello Walt, che per un attimo pareva fosse la famosa Sharon del capitolo 1, ma poi… Non voglio rivelarvi granché su Shanti, vi dirò solo che nel suo cognome c’è la risposta a tutto. Ho cercato di regalarvi un po’ di Starriet!fluff, ma sono finita a farmi del male da sola con l’ultima scena. Credo di non aver mai scritto niente di più straziante, tanto che io stessa alla fine ne sono uscita coi lacrimoni. Se vi ho fatto soffrire, giuro che mi dispiace. Ma non poteva proprio andare altrimenti. Finalmente i nostri guerrieri si avvicinano un po’ di più alla verità e in questo capitolo abbiamo la rivelazione di Matt. Non voglio spoilerarvi granché sul prossimo, ma vi dico solo di stare pronti. Ci avviciniamo alla fine e ci sono ancora un sacco di cose da raccontare; io spero solo che la storia possa continuare a piacervi sempre e di fare il buon lavoro che desidero con essa. Alla prossima! |
Capitolo 9
*** Save me ***
Keep your head up,
nothing lasts forever. kaleidoscope
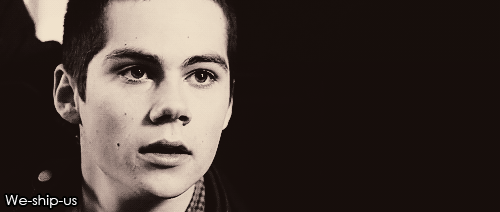 9. Save me
Un rumorio confuso di passi giù per il corridoio mi risvegliò all’improvviso ed aprii gli occhi, purtroppo immediatamente consapevole di quanto mi dolesse la testa. Non ebbi nemmeno tempo di chiedermi come mai che le immagini delle ore precedenti m’affollarono la mente e mi ricordai non solo della mia atroce visione – del lutto che avevo vissuto insieme a Chris ed Allison – ma anche del pianto infinito che l’aveva seguita. Era per quello che mi sentivo così scombussolata. Deglutii, stiracchiandomi le gambe e passandomi una mano fra i capelli. Avrei voluto restare a letto per tutta la vita, ma sapevo che non mi sarebbe stato concesso. Era l’inizio di un altro giorno e c’erano un sacco di cose che dovevo ancora affrontare. Capii ben presto che per cominciare avrei dovuto mettermi in piedi. E ci provai – provai a scivolare fuori dal letto e vivere – ma le dita di Stiles mi strinsero il polso all’improvviso ed io sobbalzai trattenendo un urlo. Merda. Mi ero completamente dimenticata di lui. Lo fissai col terrore negli occhi – sapevo cosa mi sarebbe toccato – e lui ricambiò il mio sguardo, ancora assonnato ma già fin troppo vigile. Non potevo scappare. Non ancora. «Non provarci», soffiò Stiles nella mia direzione, confermando le mie supposizioni e lasciandomi andare il polso a rallentatore. Non avrebbe voluto, ma sapeva che in fondo non avrei osato disubbidirgli. Ed io in effetti non lo feci. Abbandonai ogni proposito di fuga e mi rimisi a letto con lui: nel suo letto, nella sua camera – quella che non avevo neanche lontanamente riconosciuto, accecata dal sonno e dalla foga di andar via. Me ne rimasi in silenzio ad evitare lo sguardo di Stiles, ben sapendo che c’avrebbe pensato lui stesso a parlare ancora. Che bisogno c’era che ci provassi io, quindi? «Mi spieghi cos’è successo stanotte?». «Niente». «Harriet», Stiles richiamò il mio nome – niente soprannomi né nomignoli; solo il mio nome di battesimo completo, segno di tempesta, «Non cominciare, per favore. Pensi che sia uno stupido? Mi sono svegliato nel bel mezzo della notte, terrorizzato dalle tue urla. Sembrava ti stessero uccidendo. Dio! Tu non hai idea di quanta paura ho avuto». Il suo tono di voce aumentò ad ogni parola, ma non potei far altro che sobbalzare dallo spavento. Non ebbi nemmeno tempo di pensare ad una replica soddisfacente, perché ad interrompere tutti i miei pensieri sconnessi ci pensò la voce vagamente allarmata di Stephen. «Ragazzi?», chiamò insicuro dal fondo del corridoio. Era stato lui a svegliarmi poco prima col rumore dei suoi passi. Era tornato. «Siete già svegli?». Non ebbi la forza di rispondergli. Di nuovo lasciai che fosse solo Stiles a parlare. «Arriviamo subito, papà!», rassicurò lo sceriffo, ed io non me lo feci ripetere due volte: colsi immediatamente la palla al balzo. «Sarà meglio andare». Diedi le spalle a Stiles e provai a scappare. Speravo che lui avesse ormai abbassato la guardia e che sarei finalmente riuscita nel mio intento, ma Stiles mi conosceva tanto bene che non gli servì che più di qualche secondo per immobilizzarmi nuovamente al centro della sua camera. «Non scappare», mi ammonì, stringendo nuovamente il mio polso tra le dita mentre tratteneva imprecazioni. «Parlami. Parlami, ti prego». Quella richiesta mi strinse il cuore in una morsa e i miei occhi scuri non persero tempo ad imitare quelli di Stiles: si riempirono di lacrime alla velocità della luce. Parlargli era l’unica cosa che avrei voluto fare al mondo. Ma non potevo. E non aspettai più a dirglielo. «N-Non posso. Ho paura. Ho paura che non mi vedrai più allo stesso modo dopo che te l’avrò detto». «Cosa, Harry? Cosa non puoi dirmi?». La voce di Stiles si affievolì sempre più ed io tirai su col naso, tentando inutilmente di trattenere nuove lacrime. Lo stavo uccidendo. Gli stavo facendo del male, proprio come sempre. Ero una persona orribile. Stiles probabilmente capì – ancora una volta – cosa mi frullava nella testa in quel momento, perché proprio un attimo prima che potessi cadere a pezzi mi afferrò il viso con entrambe le mani e mi tenne tutta intera. Di nuovo. «Harry», mi richiamò in un sussurro, facendo di tutto per attirare la mia attenzione su di sé. «Niente potrà mai cambiare ciò che provo per te. Niente. Mi hai capito?». Ed era sincero. Ne fui consapevole subito. Me lo suggerirono i suoi occhi ambrati, la morsa delle sue dita sulle mie guance umide, il tono della sua voce. Tutto. Era sincero. E potevo parlare con lui. Dovevo. «Ho avuto una visione», sputai infine. «Su Victoria Argent. Derek l’ha morsa e lei si è suicidata». Vidi Stiles aggrottare le sopracciglia. Ma sul suo viso non passò nemmeno l’ombra del disgusto che ero convinta di trovarci. Era ancora nient’altro che confuso. Prima che riprendesse a parlare, rafforzò la stretta delle sue mani sul mio viso. «È per questo che hai avuto una crisi? Sei triste per Victoria? O per Allison?». Se avessi avuto un po’ di forza avrei scosso la testa energicamente. Ma mi limitai a parlare, con la voce ridotta ad un sussurro e i sensi di colpa che mi divoravano viva. «Io lo sapevo già. Sapevo tutto. E non l’ho detto a nessuno. Non l’ho detto ad Allison, a Scott… Non l’ho detto a te. Avrei potuto salvarla e non l’ho fatto. Ho coperto Derek». Bastò quello, e le mani di Stiles lasciarono libero il mio viso – ed io mi sentii andare in pezzi, con le guance fredde e i denti che tremavano nello sforzo di trattenere gemiti. Mi sentii vuota e abbandonata, proprio come credevo di meritare. «Perché l’ha fatto?», mi domandò Stiles dopo qualche attimo, facendosi lontano da me ma restandomi comunque accanto. Lui c’era ancora, e me ne resi pienamente conto solo in quel momento. Cercai di non farmi sopraffare da quella consapevolezza, provando a capire a chi si riferisse sul serio. E compresi che volesse sapere di Derek quando vidi la fiammata di risentimento che brillava nel fondo dei suoi occhi ambrati. «N-Non lo so», singhiozzai, facendo spallucce perché davvero non lo sapevo. «Mi ha detto che avrebbe ucciso sia lui che Scott. Si è difeso». Cadde il silenzio e Stiles distolse gli occhi da me di corsa, come se non potesse più guardarmi. Si passò più volte le mani tra i capelli cortissimi, prendendo ad imprecare sottovoce mentre girava a zonzo per la stanza e calciava qualunque cosa gli capitasse sotto tiro. «Perché l’ha detto proprio a te?», urlò, facendomi sobbalzare per l’intensità del suo sguardo. Era infuriato. «Voleva togliersi un peso, forse». «Certo, e ha lasciato che dovessi conviverci anche tu. DANNAZIONE!». Raggiunse la scrivania a grandi falcate, sbattendo il pugno sul legno così forte che non potei far altro che sussultare dallo spavento. «Stiles», soffiai, raggiungendolo di corsa. «Smettila, ti prego». Non volevo che Stephen ci sentisse. Non volevo che Stiles si facesse male. Non per me. Né tantomeno per Derek. Sembrò calmarsi, ma non osò rivolgermi mezzo sguardo. Mi permise di restargli accanto, ma si comportò per diversi minuti proprio come se non esistessi. Ed io mi lasciai soffocare dal silenzio pesante sceso nella stanza, almeno finché non lo reputai abbastanza. «Ce l’hai con me?», gli chiesi infine, anche se avevo terribilmente paura di ciò che avrebbe potuto dirmi. «Non lo pensare neanche», ordinò Stiles, guardandomi nuovamente negli occhi dopo quelli che m’erano parsi secoli. «Non sei una persona orribile, Harry. Anche se so che ne sei convinta. Tu non sei come Matt». Matt. Matthew Daehler. Il fratellastro di Victor. Il padrone del kanima. L’assassino. «È lui, non è vero?». Stiles non ebbe nemmeno bisogno di chiedermi a cosa mi riferissi. Lo sapevamo entrambi benissimo. Semplicemente annuì. «Cosa farai adesso?». Stiles ci pensò su brevemente. «Cercherò di farlo capire a papà». Poi mi guardò di nuovo, più attento che mai. «Tu cosa vuoi fare?». Anche a me bastarono solo pochissimi secondi per decidere cos’avrei fatto allora. «Parlerò col fratello di Matt». «Ciao!». Sobbalzai sotto il suono di quella voce cristallina, ricercandone il proprietario con estrema curiosità. Mi ritrovai di fronte una donna bellissima, dai capelli dorati e gli occhi azzurri come il cielo d’estate. Non avevo idea di chi fosse, ma potevo benissimo immaginarlo. Ero andata a casa Daehler come da piano e la signora aveva deciso di aprirmi quando ormai avevo perso ogni speranza, cogliendomi completamente di sorpresa. «B-Buonasera», balbettai, ancora un po’ scossa dalla sua apparizione improvvisa. «Victor è in casa?». Andai subito al punto, non avevo certo tempo da perdere. La giovane donna annuì, regalandomi un altro radioso sorriso. «Certo». Ma non provò nemmeno ad invitarmi dentro. Ed io avvampai al solo pensiero di ciò che avrei dovuto chiederle. «Potrei… entrare? Sono una sua amica». «Prego». Ce l’avevo fatta. Misi piede – di nuovo – in casa di Victor, attendendo spiegazioni prima di muovermi ancora. «È nella sua stanza. Prima porta a destra, di sopra». Ringraziai brevemente quella signora bellissima, poi seguii le sue indicazioni fino a giungere alla porta chiusa di quella che aveva tutta l’aria di essere una normalissima camera da letto. La camera da letto di Victor Daehler. Dall’interno proveniva della musica a volume altissimo, ma provai comunque a bussare nella speranza che potesse sentirmi. Cosa che ovviamente non successe, tanto che alla fine decisi di ricorrere a rimedi estremi. Io stessa infatti spalancai la porta d’ingresso, catapultandomi nella stanza come una furia. Gli occhi di Victor mi furono subito addosso. «Cosa ci fai tu qui?», quasi urlò, scattando in piedi sulla sedia di fronte alla scrivania sulla quale era stato seduto fino a poco prima. Pareva stesse studiando. Con la musica a palla? Che concentrazione invidiabile. «Dobbiamo parlare». Victor sollevò un sopracciglio con aria scettica, fissandomi a lungo. «Sei venuta a scusarti con me, per caso?». Scusarmi con lui? «Non vedo di cosa dovrei scusarmi». Ma in realtà lo immaginavo bene e i miei sospetti furono confermati proprio da Victor. Abbandonò la scrivania velocemente, raggiungendomi sull’uscio della camera con un paio di falcate. «Di questo, forse?», domandò, indicandosi l’occhio divenuto nero in seguito al pugno carico di rabbia che gli avevo sferrato la sera del rave. Indurii la mascella, incrociando le braccia al petto con aria decisa. «Non ti chiederò scusa per quello. Te lo sei meritato». «Ah, sì? E perché?». Deglutii. Victor era davvero troppo vicino. Ma costretta contro la porta com’ero, non avevo possibilità di scappare. «Mi terrorizzi. E credi di potermi dare ordini», spiegai, cercando di non far tremolare la voce. Dovevo dimostrarmi forte, ancora una volta. «Al rave non volevi lasciarmi libera e ho dovuto metterti KO». A quelle parole, Victor si aprì in una risata improvvisa che mi fece rabbrividire. Aveva qualcosa di profondamente storto. Ma come al solito, non avrei saputo dire cosa. «Come vuoi», concesse infine, con un ultimo sorriso tutto fossette. «Abbiamo finito? Starei studiando». «No che non abbiamo finito. Ho bisogno di farti delle domande su Matt». Di nuovo il sopracciglio dorato di Victor svettò verso l’alto. «Matt? Cosa vuoi da mio fratello?». Di nuovo decisi di andare subito al punto. «Voglio sapere qual è il suo problema». «Il suo…», Victor boccheggiò confuso, poi l’irritazione ebbe la meglio, «Qual è il tuo problema, Harriet!». Mi urlò contro quelle parole con tutta la cattiveria di cui era capace, ma cercai di non farmi scalfire affatto da queste ultime. Ero stanca di tremare. «Non fingere di non saperne nulla, perché so che stai mentendo!». Alzai la voce anch’io. Purtroppo, con pessimi risultati. «Mio Dio. Io ho preso una botta e tu sei impazzita?». Quasi sgranai gli occhi, incredula. Victor sembrava genuinamente sorpreso. Quell’idea mi trapassò la mente all’improvviso, regalandomi una fitta di consapevolezza molto più forte delle altre. Premetti due dita sulla tempia e fu in quel momento che capii: vidi sul serio la confusione di Victor e tutto mi fu chiaro all’improvviso, senza che potessi spiegarmi sul serio come diavolo potessi esserci riuscita. Mi era sembrato quasi di essere nella sua mente. «Tu non ne sai niente sul serio», soffiai infine con aria sconfitta. E Victor continuò a confermare le mie supposizioni. «Non ho idea di cosa tu stia dicendo», mormorò, accennando poi alla porta. «Puoi andartene adesso?». Evitai di boccheggiare solo perché ci tenevo a portare avanti la mia farsa fino all’ultimo, eppure la voce mi venne fuori fin troppo tremolante. «S-Sì. Vado». E ci provai, ma ad un passo dalla porta ebbi l’ennesimo ripensamento e mi voltai a chiamare ancora il nome di Victor. «Cos’altro c’è?». Lui m’inchiodò sul posto coi suoi occhi nerissimi e l’aria scocciata. Capii che dovevo fargli la domanda giusta, perché quella era l’ultima possibilità che mi sarebbe stata data. Deglutii. «Tuo fratello ce l’ha con qualcuno, per caso?». Bastò l’espressione di Victor a rappresentare alla perfezione quanto avessi toppato. «Che domanda è? Si può sapere cosa vuoi da Matt?». Ma non avrei ancora mollato. «È pericoloso. E se c’è anche solo una piccola cosa che sai… ti prego, devi dirmela». «Pericoloso? Ha sedici anni, Harriet!», Victor alzò la voce di nuovo, tanto che questa quasi prevalse sulla musica altissima. «Credimi», lo scongiurai quasi. La mia era una preghiera. Ma Victor non la colse affatto. «Non so niente. Ora va’ via». Avevo perso. Di’ all’agente che sei con noi. Se insiste a non farti passare, chiamaci. Grazie a quell’sms inviatomi da Stiles avevo speso l’intero tempo impiegato nel tragitto casa Daehler-centrale di polizia a pensare a delle scuse tanto convincenti da permettere all’agente nell’ingresso di lasciarmi via libera senza troppi sforzi. Sapevo che la vicesceriffo Deyes fosse una tipa tosta, ma mi ero preparata fior fior di argomentazioni per metterla da parte ed ero soddisfattissima. Ecco perché quando misi finalmente piede nella centrale e non trovai anima viva alla reception, sentii un flebile moto di delusione fare di me la sua preda. Sapevo che avrei dovuto essere semplicemente grata di poter passare oltre e basta, ma la delusione si trasformò presto in allerta e un brivido di terrore mi scosse la spina dorsale. Perché mai l’agente Deyes non era lì? Continuai a chiedermelo mentre avanzavo lentamente nella direzione della reception, cercando di scacciare via dalla mia mente – con pessimi risultati – la paura cieca che mi aveva colta. Non avrei nemmeno saputo spiegare perché, eppure sentivo che ciò che avrei trovato dall’altra parte avrebbe potuto non piacermi affatto. E ne ebbi la dolorosa conferma nel momento in cui mi sporsi oltre il bancone in legno. Quella visione mi provocò un violento conato di vomito tanto doloroso e disgustoso che dovetti piegarmi sulle ginocchia nella speranza di non finire a rovesciare l’intera cena di quel giorno. Rosa Deyes era sul pavimento, avvolta da una pozza di sangue fuoriuscito dal petto squarciato. Erano profondi segni di artigli quelli che le avevano lacerato la pelle, uccidendola. E capii subito a chi appartenessero. Una nuova ondata di terrore mi tolse il respiro, ma prima ancora che potessi anche solo provare a scappare da quel posto, la mia coda alta ondeggiò smossa da qualcosa e un’improvvisa fitta di dolore al retro del collo mi accecò la vista. Prima ancora che potessi anche solo rendermene conto, ero completamente immobilizzata. Dal kanima. Mentre sentivo la presa delle mie dita sul bancone venire meno e finivo a terra con un tonfo, provai ad urlare. Stiles, Stephen e Scott erano lì e stavano bene – perlomeno, così speravo. Se fossi stata un minimo fortunata, avrei ricevuto l’aiuto di cui avevo bisogno. Ma sentivo le corde vocali completamente atrofizzate e il mio urlo si ridusse ad un flebile gemito. Ero caduta di pancia sul pavimento, quindi non potevo guardare il kanima negli occhi. Ma lo sentivo sibilare alle mie spalle e muoversi: ad un certo punto una sua zampaccia mi artigliò la spalla e mi voltò di schiena sul pavimento. Poi prese a trasportarmi per un polso verso chissà dove, proprio come se fossi nient’altro che una vecchia bambola da buttare. Non mi ero mai sentita più impotente di così. Avrei voluto urlare e ribellarmi, ma non potevo far altro che starmene nelle grinfie di quell’essere viscido, sperando che non mi avrebbe uccisa. «J… J-ack-son», sillabai con immensi sforzi, sperando che sarebbe riuscito a captare il mio sussurro. Sapevo che il mio fosse un tentativo molto azzardato, ma dovevo quantomeno provare a salvarmi la pelle. «Questo non sei tu». Era vero. E la verità, si sa, fa sempre male. Il kanima arrestò di botto la sua camminata decisa, balzandomi addosso e togliendomi il respiro col suo peso imponente. Poi, con l’aria di qualcuno che si era quasi offeso, mi ringhiò contro tutta la sua rabbia. Ed io non potei far altro che strizzare gli occhi, mentre pregavo che l’incubo finisse una volta per tutte. Ma era appena iniziato e me ne resi conto solo due secondi più tardi, quando le zampe del mostro si chiusero attorno alla mia gola e persi il respiro per decisamente troppo tempo. Credetti che sarei morta così, soffocata da una bestia infernale e senza la minima possibilità di anche solo provare a difendermi, ma un rumore improvviso gelò il kanima e lo fece balzare via dal mio corpo. Anche se continuavo a non potermi muovere, mi sembrò di essere comunque in Paradiso. Tossii violentemente, cercando di riacquistare almeno metà di tutto l’ossigeno che il kanima mi aveva rubato. Mi doleva la gola terribilmente ed ero convinta che la pelle sensibile del mio collo forse ormai rossa da morire. Ma ancora sentivo come se il peggio dovesse ancora arrivare. Il kanima mi afferrò nuovamente il polso, trascinandomi giù per uno stretto corridoio dal pavimento… bagnato? Aggrottai immediatamente le sopracciglia. Strano. Molto strano. Quella di cui si stavano imbrattando i miei capelli e il retro dei miei vestiti non sembrava nemmeno acqua. Era qualcosa di molto più denso. E allora capii. Vidi ammassati in un angolo i corpi senza vita di altri tre agenti e scoppiai a piangere silenziosamente. Mi stavo bagnando del sangue che avevano versato a causa di quella creatura immonda e del suo padrone – Matt. Per un attimo provai il violento impulso di ucciderli entrambi con le mie stesse mani, ma sapevo che non ne sarei stata in grado – non in quel momento – e mi limitai a subire ancora. Il kanima alla fine mi lasciò andare nel bel mezzo di una grande stanza vuota. Si fece lontano da me e mi osservò dall’angolo, la coda che ondeggiava pigramente e gli intensi occhi gialli che mi perforavano da parte a parte. Ed io semplicemente continuai a piangere mentre facevo volare i pensieri e capivo che mi avesse portata lì per tenermi ben lontana dagli altri. Non ero mai stata in quella zona della centrale prima, ma ero sicura che fosse più che distante da dove erano in quel momento lo sceriffo, Stiles e Scott. In nessun modo avrebbero potuto aiutarmi. Chiusi gli occhi, esausta, e rimasi in quella posizione per attimi infiniti. Almeno finché non ridonai un’occhiata fugace al kanima e scoprii che avesse finalmente distolto lo sguardo dalla mia figura sofferente. Era distratto tanto che all’improvviso mi piombò in testa un’idea suicida. Gli altri non avrebbero potuto raggiungere me, ma io avrei provato comunque ad andare da loro. Magari l’effetto del veleno paralizzante era scemato almeno un po’ e sarei riuscita a muovermi. Un centimetro alla volta avrei potuto farcela. La speranza è l’ultima a morire, dicevano. La mia sfumò nel giro di due secondi. Avevo appena appena mosso l’indice quando gli occhi gialli del kanima mi ritornarono addosso di slancio ed evidentemente avevo scritto in faccia il mio piano oppure era anche un sensitivo, fatto sta che mi ripiombò addosso in un attimo, più irritato che mai. Mi ringhiò contro furiosamente e falciò il mio petto coi suoi artigli, strappandomi un urlo fortissimo e riducendo la mia maglia a brandelli. Ripresi a piangere, maledicendo tutto e tutti mentre il kanima continuava a farmi soffrire in ogni modo. Non voleva uccidermi, ma punirmi. Mi artigliò anche un braccio e una gamba e il dolore ad un certo punto fu così forte che semplicemente mollai la presa e mi lasciai andare nel baratro buio di sofferenza che già da fin troppo tempo mi aspettava a braccia aperte. Un’altra volta ancora avevo perso. Furono il rimbombo di un proiettile e delle urla lontane a riportarmi a galla all’improvviso. Sgranai gli occhi lucidi, terrorizzata dall’idea di chi avesse sparato e di chi fosse stato ferito. Preferii non pensarci. Non potevo peggiorare la situazione con un attacco di panico, davvero. Perciò mi limitai a richiudere gli occhi mentre prendevo dei grossi respiri e pregavo intensamente che almeno qualcosa di buono mi succedesse. Capii dopo pochi minuti che il mio desiderio fosse divenuto realtà quando riprendendo a guardarmi intorno scoprii che il kanima mi avesse lasciata sola. Pensai di sbagliarmi – che era tutto troppo bello per essere vero – ma del kanima non c’era sul serio più traccia. E allora quasi sorrisi, capendo che avrei dovuto approfittarne per scappare. L’effetto del veleno paralizzante era un po’ scemato, ma comunque non mi sentivo né il braccio né la gamba sanguinanti e il petto mi doleva da morire – molto più del collo arrossato. Continuai comunque a strisciare verso la porta, trattenendo gemiti e pregando che tutto andasse bene almeno quella volta. Ma di nuovo la mia fuga fu interrotta all’improvviso e quella volta da un blackout che capii subito fosse stato tutt’altro che casuale. Non appena la centrale fu avvolta dal buio completo, infatti, un’ondata di spari la travolse e il rumore della sparatoria peggiore della mia vita mi riempì le orecchie. Strizzai gli occhi, immobilizzata dalla paura e desiderando solo di non poter sentire più tutto quel rumore. Non avevo idea di chi stesse sparando e perché, ma non volevo saperlo. Volevo solo silenzio e lo ottenni. Ma durò pochissimo. Il sogno si sovrappose alla realtà e delle immagini sfocate mi brillarono sotto le palpebre serrate: dapprima vidi Chris Argent affiancato da Allison e Gerard, poi mio padre. Un torrente violento d’emozioni m’investì a quella vista improvvisa, tanto che persi la concentrazione e la visione sfumò velocemente via dai miei occhi. Ma strinsi i denti e la catturai di nuovo, osservando Philip che affiancava Chris con un’aria a dir poco disturbata in volto. «Smettetela di sparare!», urlò ad un passo dal viso del cacciatore. «C’è mia figlia lì dentro! È ferita!». Solo allora capii. Phil mi aveva vista, proprio come io avevo visto lui. Ed era lì per salvarmi. Mi resi conto di aver perso nuovamente i sensi solo nel momento in cui li riacquistai, sollevata da un paio di braccia che sapevo già avrei imparato a conoscere bene. Aprii piano gli occhi stanchi, cercando di abituarli al buio della centrale, e allora lo vidi. Philip Carter era lì di fianco a me, mi teneva tra le sue braccia e mi guardava come se fossi la cosa più preziosa del mondo intero, con quei suoi grandi occhi azzurri e lucidi. Avevo bisogno che qualcuno mi salvasse e lui era arrivato. Finalmente. «Papà», soffiai, cercando inutilmente di stringere le dita sulla sua giacca profumata. Ma ancora avevo la tossina in corpo e non riuscivo a muovermi bene. In più il dolore mi rendeva così tanto frastornata che temetti fosse tutto un mio stupido sogno. Ecco perché richiamai mio padre ancora ed ancora, finché lui non decise finalmente di rispondermi. «Sono qui, bambina». Era lì. Sorrisi, socchiudendo gli occhi. «Fa m-male». Da morire. Faceva male da morire, tanto che non mi sentivo più la gamba e riuscivo a malapena a respirare. «Non voglio morire». Philip mi accarezzò piano i capelli incrostati di sangue, tirandomi meglio a sedere. «Non morirai. Siamo qui per salvarti». L’utilizzo del plurale mi colpì immediatamente, per quanto avessi il cervello ormai fin troppo annebbiato dal dolore. Avrei voluto chiedergli a chi si riferisse, ma non ne ebbi la forza. Mi limitai semplicemente a seguire la direzione dello sguardo azzurro di Philip e la persona che vidi al suo fianco mi fece sgranare gli occhi dalla sorpresa. Non poteva essere. «Mamma?», la chiamai, sperando con tutte le mie forze che non si trattasse dell’ennesimo doloroso sogno. Ma Jenette Good – precedentemente in Carter – era sul serio lì, e la osservai mentre nella penombra della stanza abbandonava la sua posizione rigida per inginocchiarsi vicino a me. Al fianco di mio padre, il suo ex-marito, l’uomo col quale aveva deciso di mettermi al mondo. Vederli l’uno accanto all’altra – come non mi era mai stata data la possibilità di fare – mi riempì gli occhi di lacrime. Non scoppiai a piangere solo perché mia madre mi parlò, distraendomi. «Piccola mia», mormorò con la voce già rotta dal pianto mentre mi accarezzava con lo sguardo. Ancora non riuscivo a credere che fosse sul serio lì – di nuovo insieme a me quando ne avevo più bisogno che mai – ecco perché feci un ulteriore test. «Non sono morta, vero?». Philip scosse immediatamente la testa bionda, fissandomi con aria divertita mentre mi stringeva un po’ più forte nel suo abbraccio protettivo. Ma io tenni gli occhi fissi su mia madre: era da lei che volevo sentirmi dire la verità. L’osservai a lungo, finché non la vidi trattenere un sorriso e scuotere la testa. «Non sei morta, sei qui con noi», mi rassicurò, stringendomi forte una mano. C’era ancora una cosa che avevo bisogno di chiarire. «Non mi odi?». Jenette scosse la testa ripetutamente. «Non potrei mai, piccina. Ti voglio bene». Non avevo bisogno di sentire nient’altro. Semplicemente sorrisi, lasciandomi poi andare al sonno esausto che pensavo di meritarmi. Mio padre non aggiunse nulla, limitandosi a sollevarmi tra le sue braccia. Lo sentii nel dormiveglia mentre ordinava a mamma di seguirlo e mi sembrò che dicesse qualcosa tipo: «Ti portiamo al sicuro, Harry», ma non ne sono sicura. Solo una cosa sapevo per certo: ero finalmente salva. E avevo di nuovo una famiglia. All lies into a degree,
losing who I wanna be. Ringraziamenti Agli Avenged Sevenfold, perché Save me è la meraviglia e mi ha ispirata un sacco. Sono una fan del genere di musica che fanno loro, eppure ho sempre creduto che non mi sarebbero piaciuti. Save me ha dimostrato l’esatto contrario e sono molto felice di averla scelta per questo capitolo. Note Le sentite le campane che suonano a festa, no? Spero di sì, perché ciò significa solo una cosa: pace. Avete capito bene, finalmente è arrivato il momento! D’ora in poi vi prometto che le cose si appianeranno sempre più, anche se i nostri guerrieri avranno ancora qualche altra piccola battaglia da affrontare (e per chi ricorda gli avvenimenti della 2x11, capirete già cosa intendo). Anche se non è ancora niente di definitivamente tranquillo, la situazione si è già risolta in più punti e davvero manca pochissimo perché ogni nodo venga al pettine e il puzzle sia completo anche stavolta. Solo pochissimi capitoli ci separano dalla fine ed io sono davvero orgogliosa di questo ennesimo viaggio che ho fatto insieme a voi e di come ho sviluppato kaleidoscope. Spero che penserete altrettanto! Matt ormai è fuori dai giochi, ma per Victor… Ecco, non chiedetemi di Victor perché ancora non so cosa ne farò di lui. AHAHAH. Ma riguardo alla sua scena, non avete notato niente di strano? *hint-hint* Vi giuro che saprete tutto quando sarà il momento (nel prossimo capitolo ci saranno altri indizi consistenti). Ma nel frattempo… Jenny is heeeere! E anche se Cassandra ancora non s’è vista, vi assicuro che c’è anche lei. La mia bimba ha sul serio di nuovo una famiglia. |
Capitolo 10
*** Pain ***
One day, you and I are gonna wake up and be alright.
Maybe not today, maybe not tomorrow. But one day. One day. I promise. kaleidoscope
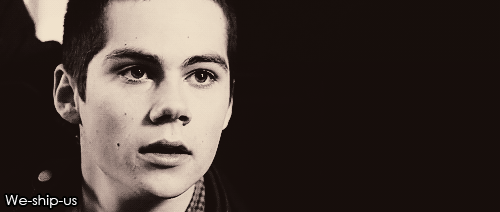 10. Pain
Avevo passato la gran parte del mio tempo in ospedale – già, c’ero finita di nuovo – assieme a mia madre e a mia sorella Cassandra – felice come una Pasqua di poterle avere accanto a me nonostante tutto; ecco perché quando quel lunedì pomeriggio di inizio dicembre mi trovai di fianco solo uno Stiles addormentato, non potei che stupirmi. Per un po’ mi limitai ad osservarlo a fondo, tanto per rendermi conto sul serio che fosse lì insieme a me e che non stessi semplicemente avendo allucinazioni causate dai farmaci. Il dolore delle ferite che il kanima mi aveva inferto – ancora non riuscivo a pensare a lui come a Jackson – era così forte che in ospedale mi avevano imbottita di anti-dolorifici, tanto che passavo buona parte del mio tempo a sonnecchiare stordita. Non mi sarei stupita se questi mi avessero anche fatto vedere cose che non c’erano oltre che collassare dal sonno. Ma Stiles era lì davvero e lo capii quando un mio movimento fin troppo brusco lo risvegliò dal suo sonno leggero. Lo vidi sobbalzare lievemente mentre si tirava su dal mio letto e si copriva il viso con le mani. Aveva un’aria esausta e mi sentii stringere il cuore al pensiero che stesse così anche per colpa mia, ma la mia mente si svuotò del tutto non appena gli occhi di Stiles ritrovarono i miei. «Ehi», mi salutò immediatamente, forzando un sorriso che comunque apprezzai moltissimo. «Non pensavo fossi sveglia». Si avvicinò al mio letto ancor di più, tendendo nella mia direzione una mano che non esitai ad afferrare. Strinsi le sue dita lunghe con tutta la poca forza che m’era rimasta, stremata com’ero dai medicinali e dal dolore persistente. «Sono appena risorta», gli raccontai poi, con un tono di voce tanto debole che per un attimo dubitai che Stiles mi avesse sentita. Ma lui era attento ad ogni mio gesto e me lo dimostrò subito, rafforzando un po’ di più la stretta delle nostre mani prima di parlarmi ancora. «Come stai?». Mi sforzai di fare spallucce, ma la pelle lacerata del mio petto si oppose immediatamente, strappandomi un flebile gemito di dolore. Rinunciai quindi a muovermi, deglutendo nell’attesa che le fitte scemassero ancora una volta. Poi parlai. «Non sono mai stata più stanca di così». E Stiles non aggiunse niente, perché non ce n’era proprio bisogno. Si limitò semplicemente a starmi vicino in silenzio, rassicurandomi con la sua sola presenza e cercando di non imprimere fin troppo dispiacere nel suo sguardo ambrato. Sapeva che mi avrebbe fatta solo stare peggio. Perciò per un po’ ce ne restammo così, l’uno accanto all’altra in assoluto silenzio. Almeno finché non realizzai di dovermi togliere l’ennesimo dubbio. «Dove sono mia madre e Cassandra?», gli chiesi dunque, guardandomi inutilmente intorno alla loro ricerca. Non c’erano più. «Sono tornate in albergo poco fa. Papà le ha praticamente cacciate. Erano esauste». Come te, pensai subito. Ma non glielo dissi, mi limitai ad osservare le sue occhiaie profonde col cuore in gola. Stiles era stravolto. E allora fui io quella a restarmene zitta perché non sapevo cosa avrei dovuto dire. Distolsi lo sguardo dalla sua figura con aria colpevole, provando a lasciargli andare la mano senza successo. Stiles capì subito che stessi provando a scappare – di nuovo – e me lo impedì, stringendo le dita più forte sulle mie e parlandomi ancora, di modo che dovessi per forza dedicargli tutta l’attenzione che si meritava. «Stamattina ho parlato con la Morrell». La Morrell? Al solo sentire quel nome scattai sulla difensiva. «Di cosa?». «Di tutto». «Tutto tutto?». Stiles sgranò gli occhi, incredulo. «Ma no! Mica posso parlare di lupi mannari e kanima anche a lei che non ne sa niente». Avrei voluto davvero che fosse così: che Marin fosse semplicemente la mia professoressa di francese, un’ottima psicologa e anche la mia tutor, ma sapevo che quella donna bellissima nascondesse molto di più. Sapeva dei miei poteri, infatti. Conosceva la mia famiglia e sarebbe stata pura utopia immaginare che non sapesse nient’altro sul soprannaturale di cui era piena zeppa Beacon Hills. Ma decisi di non dirlo a Stiles: non aveva bisogno di preoccuparsi anche lui dell’ennesima persona coinvolta in tutto quello. «Cosa le hai detto, allora?», dissimulai quindi. «Le ho parlato di Matt». A quel nome, un’intensa fitta di dolore mi attraversò la gamba bendata. Matt. Matt era morto. Gerard Argent l’aveva ucciso e quel pomeriggio stesso ci sarebbero stati i suoi funerali. Per un brevissimo attimo m’immaginai Victor alla cerimonia, vestito di nero e affiancato dalla bellissima donna bionda che immaginavo fosse sua madre. E che era stata anche la matrigna di Matthew, il figlio adottivo che aveva perso decisamente troppo presto. Sapevo che non se lo meritasse poi tanto, ma in quell’esatto momento mi sentii malissimo per lui e per le persone a cui sarebbe mancato. Ma Stiles per fortuna non si accorse di niente – oppure decise di dissimulare come già avevo fatto io solo pochi secondi prima – e semplicemente continuò a parlare. «Le ho detto di come non riesco ad abbassare la guardia. Mi sento come se ci fosse ancora da combattere». Anch’io, Stiles. Anch’io. Non glielo dissi mai. Non ce n’era bisogno. Sentii la porta della mia camera cigolare e la cercai subito con lo sguardo nell’attesa di scoprire chi fosse venuto a farmi visita quel giorno. Quando vidi il viso abbronzato di mia sorella Cassandra fare capolino, non potei che illuminarmi con un grosso sorriso. Il quale aumentò a dismisura nel momento in cui entrò del tutto nella mia stanza, tirandosi dietro un’enorme busta firmata Nando’s. «Non dirmi che quello è per me», boccheggiai, indicandola già con l’acquolina in bocca. Cass si limitò ad annuire lievemente, sedendosi di fianco a me poco prima di consegnarmi un pacchetto. Non ebbi nemmeno bisogno di annusarlo per capire di cosa si trattasse: ali di pollo, le mie preferite in assoluto. «Ti voglio bene da morire», la ringraziai, scartando il mio secondo pranzo. Uno che finalmente, dopo i pasti terribili del Beacon Hills Memorial Hospital, avrei potuto davvero definire tale. «I brodini di questo posto mi stanno facendo diventare pazza». «Il purè è buono, però». Annuii, addentando subito un pezzo di pollo. Il purè dell’ospedale era sul serio buono. «Anche la marmellata della colazione», aggiunsi. «ma io ho fame da morire, e le porzioncine da mensa non mi aiutano affatto». Cass ridacchiò con aria divertita, poi riprese a rovistare nella busta di Nando’s. «Ti ho preso anche la Quinoa Salad, una porzione maxi di patatine fritte e succo d’arancia». Per poco non m’imbronciai. A quella lista mancava solo una cosa perché fosse perfetta. «E il dolce?». «Non approfittare della mia bontà, ora. Voglio farti mangiare bene, mica vederti diventare una balena», mi rimbeccò mia sorella, pizzicandomi le guance mentre io la ripagavo con una smorfia infastidita. Niente dolce, quindi. Avrei fatto meglio a rassegnarmi presto. «Dov’è mamma?», chiesi ancora a Cassandra, la quale non perse tempo a rubarmi più di un paio di patatine fritte dal sacchetto oleoso. Prima di rispondermi, fece spallucce. «È rimasta in albergo. Papà è venuto a trovarci. Penso che abbiano bisogno di tempo da soli. Per parlare, sai». Certo che sapevo. Eppure quella notizia mi sconvolse molto più di quanto avrei mai immaginato. «Tu non vuoi ascoltare ciò che ha da dire Phil?», domandai a mia sorella, osservandola attentamente alla ricerca di una risposta. Sicuramente mio padre avrebbe risposto a tutte le domande di Jenny e Cassandra, raccontando loro tutta la verità non solo sui nostri poteri ma anche su licantropi e kanima. Quindi perché mia sorella aveva rinunciato così a cuor leggero di essere informata su tutto? «Non c’è niente che papà debba dirmi», mi spiegò infine, all’apparenza tranquillissima. «Le cose sono così e basta. E poi preferisco stare con te». «Questi miei poteri…», deglutii, all’improvviso per niente sicura di come avrei portato avanti quel discorso improvviso. Ricomincia da capo, Harry. Okay. «Non è una passeggiata. E ci sono ancora un sacco di cose che devo risolvere. Non posso tornare in Texas con voi, Cass». «Nessuno te lo sta chiedendo». Sgranai gli occhi. «Ma io credevo che tu e mamma foste qui per–». «Siamo venute per capirci qualcosa. E l’abbiamo capito. Abbiamo capito che sbagliavamo a non crederti. Che è tutto dolorosamente vero – anche se difficilissimo da accettare – e che hai bisogno di restare qui, almeno per ora. Noi ti staremo accanto, Harry», mi spiegò Cassandra, interrompendo la mia frase a metà prima di darmi tutte le risposte che cercavo. «Volete restare a Beacon Hills? Ma mamma ha il lavoro e tu… Come farai con Jamie?». Non riuscivo a crederci. Non volevo crederci. Cassandra di nuovo scrollò le spalle, come se niente fosse. «Jamie aspetterà. Si tratta di poco più di due settimane; torneremo a casa in tempo per Natale. E allora non avrai scuse per non passare le feste con noi come pianificavamo già da tempo!». Sorrisi. Non avevo alcuna intenzione di lasciare Beacon Hills prima del tempo, ma niente m’impediva di tornare a casa per le vacanze natalizie. Ad Austin avrei ritrovato Randall e tutti i miei amici. Ma prima c’era un piccolo particolare da sistemare. «Vengo con voi solo se mi permettete di portare Stiles», imposi, e Cassandra – sorprendentemente – quasi non batté ciglio. «Non devi neanche dirlo», mi rassicurò, porgendomi il sacchetto di patatine fritte cosicché potessi mangiarne anch’io qualcuna. Ne afferrai una buona manciata, ma prima di buttarle giù me ne rimasi ferma ad aspettare che Cassandra completasse la sua frase. «Dalle un attimo e mamma avrà già invitato sia Stiles che suo padre». Sorrisi di nuovo. All’improvviso era tutto perfetto. Lasciai perdere per un attimo il pollo, portandomi un paio di patatine alla bocca. Una di queste finì quasi per soffocarmi quando Cass riprese a parlare, inaspettatamente. «Bel tipo Stiles, a proposito. È un fuscellino, ma carinissimo comunque», esalò. «Ho sempre saputo che avresti finito per innamorarti di uno così». Sgranai gli occhi, finendo a rantolare a bassa voce. Innamorarmi? Io? Di Stiles? Non ebbi neanche la forza di rispondere a Cassandra: semplicemente le lanciai contro le poche patatine fritte sopravvissute alla mia fame vorace e lei capì bene di non dover mai più accennare all’argomento. Un leggero bussare contro il legno della porta mi distrasse dalla mia lettura concentrata e misi subito via Il giovane Holden, curiosa di sapere chi sarebbe stato il mio nuovo visitatore. Da quand’ero in ospedale non c’era stato un momento che avessi trascorso da sola: la mia stanza era un continuo viavai di gente e non avrei potuto essere più felice di così. «Posso entrare?», mi domandò una voce dall’altra parte e subito la riconobbi come quella di Scott, ma non ero pienamente sicura del fatto che fosse lui e perciò mi limitai a richiamare il suo nome con aria confusa. «Proprio io», confermò lui stesso due secondi dopo, facendo capolino da dietro la porta e riservandomi un gran sorriso che subito ricambiai. «Entra!». Scott non se lo fece ripetere due volte. Si chiuse la porta d’ingresso alle spalle e poi mi raggiunse al centro della stanza, accomodandosi di fianco al mio letto. «Come stai?». Cercai i suoi occhi scuri, capendo che non avrebbe avuto senso dirgli una bugia. «Fa male». «Dammi la mano». Impallidii. Mi ero aspettata un tranquillo: «Tieni duro, prima o poi passerà» o qualcosa del genere, non di certo che mi chiedesse la mano. Per farci cosa, poi? Provai a chiederglielo, inutilmente. «Dammi la mano, su!», insisté Scott, e allora non potei far altro che arrendermi. Lasciai che mi stringesse una mano tra le sue e capii perché l’avesse fatto nel momento in cui una strana ed inaspettata sensazione m’avvolse completamente. Era sollievo: lo sentivo più forte ad ogni attimo, sovrapporsi al dolore che invece sembrava scivolare via dal mio corpo come semplice acqua. Quando Scott mi lasciò libera la mano, pochi secondi dopo, mi sentivo quasi un’altra persona. «Il dolore è passato», boccheggiai, ancora totalmente incredula. Scott trattenne una risatina. «Fantastico, vero? Credo sia la cosa migliore dell’essere un licantropo». «Puoi portare via il dolore?». Incredibile. «L’ho scoperto un po’ di tempo fa, ma non ho mai avuto occasione di parlartene». Mi sistemai meglio contro il cuscino fresco, sorridendogli. «Grazie». «Quando vuoi! Giuro che è molto più salutare di qualunque medicina». Scott ricambiò il mio sorriso ed io scoppiai direttamente a ridere, divertita da quell’assurda verità. «Come va a scuola?». «Non ti stai perdendo granché», fece spallucce, «Oltre alla partita di stasera, ovviamente». Aggrottai le sopracciglia. «Non ci andrai nemmeno tu, giusto?». «A dire il vero sì. Isaac mi ha detto che Jackson ha intenzione di giocare e devo andarci». Grandioso. Ancora grazie, Jackson. «Non puoi proteggere sempre tutti, Scott», sussurrai. Ero un po’ amareggiata: non mi andava di saperlo ancora in pericolo. «Posso comunque provarci». Scossi la testa a quella replica. «Hai sentito Allison?». Scott mi imitò ben presto. «La morte di sua madre l’ha sconvolta: vuole Derek morto a tutti i costi», esalò, stringendomi il cuore in una morsa. Tra tutti i miei amici, Allison era stata l’unica a non farmi nemmeno mezza visita ed io non l’avevo mai sentita più lontana di così. Ma se io stavo soffrendo, non osavo nemmeno immaginare come stesse Scott. «Mia madre non mi parla. Ha scoperto cosa sono e non riesce ad accettarlo». Mi morsi un labbro quasi a sangue all’improvvisa consapevolezza che quella situazione mi fosse fin troppo familiare. Senza farmelo ripetere afferrai la mano di Scott, sperando di poterlo rassicurare almeno un po’. «Si risolverà tutto, vedrai». «Lo spero», disse lui, poi diede una veloce occhiata all’orologio che portava al polso prima di scattare in piedi e mollarmi la mano, «Devo scappare agli allenamenti. Ci sentiamo più tardi?». Mi limitai ad annuire. «Sta’ attento», gli ordinai, quando già aveva raggiunto la porta. Scott si voltò a guardarmi giusto un attimo prima di sparire nel corridoio dell’ospedale. Mi sorrise come sempre, poi mi salutò col suo solito saluto da soldato. «Agli ordini, Comandante!». Mi addormentai col sorriso. Un’improvvisa fitta di dolore mi trapassò la testa e mi agitai nel letto, cercando di riacquistare conoscenza. Ma ero in quella specie di dormiveglia dal quale non puoi scappare per quant’è profondo: sei mezza sveglia ma non hai pieno controllo sul tuo corpo – non riesci nemmeno ad aprire gli occhi, proprio come non ci riuscii io quella sera. Da quando le mie visioni si erano intensificate e regolarizzate, avevo provato esperienze simili spessissimo. E fu proprio allora che lo capii: stavo avendo l’ennesima visione. Una porta cigolò e la mia retina fu riempita per un attimo brevissimo dallo spicchio di luce gialla che vi filtrò attraverso quando un uomo la aprì quanto bastava a farvi passare oltre… Stiles. Lo riconobbi ancor prima di poter vedere il suo viso, mi bastò leggere il 24 bianco sulla sua divisa da lacrosse affinché mi mancasse il respiro e desiderassi che quella visione potesse non finire mai. Avevo assoluto bisogno di capire dove fosse, ma non riuscii ad individuare nulla di familiare nel seminterrato buio nel quale l’avevano intrappolato. Avrebbe potuto essere dovunque e soprattutto, con chiunque. Non avevo la più pallida idea di chi l’avesse rapito o del perché, sapevo solo che Stiles fosse in pericolo e che dovevo assolutamente fare qualcosa a riguardo. Non appena la visione sfumò di fronte ai miei occhi chiusi, scattai a sedere nel letto. Provai a pensare al da farsi, ma ero così sconvolta che finii comunque a prendere la decisione sbagliata. Dopo aver osservato per due secondi l’ago che mi trapassava il braccio sano, decisi infatti di sfilarlo senza troppe cerimonie. Avevo deciso: sarei uscita da quell’ospedale – sarei andata a cercare Stiles – e non potevo di certo portarmi in giro la flebo. Perciò strinsi i denti ed abbandonai il mio letto, zoppicando sulla gamba non bendata alla ricerca dei miei vestiti. Mi servirono ore per riuscire ad indossare qualcosa che non fosse l’orribile camicia da notte che mi aveva fornito l’ospedale, ma alla fine riuscii a rendermi quantomeno presentabile e mi avviai fuori dalla porta. Ero prontissima a mettere in atto il piano più stupido di sempre. Feci capolino nel corridoio, controllando che fosse vuoto cosicché nessuno potesse vedermi. Prima o poi si sarebbero resi conto della mia fuga, ma non avevo tempo di pensarci in quel momento. Stiles era in pericolo e c’era davvero poco che contasse più di quella cosa. Avanzai velocemente giù per il corridoio, giungendo dopo infiniti sforzi all’entrata del Beacon Hills Memorial Hospital. Ma fino a quel momento era andato tutto fin troppo bene e avrei dovuto immaginare che non sarebbe durata per sempre. Ad un passo dalla libertà, difatti, lo sguardo scurissimo di Melissa McCall intercettò la mia figura ed io mi sentii tremare di paura di fronte all’urlo infuriato che la mamma di Scott liberò. «Cosa ci fai in piedi, signorina?», strillò, raggiungendomi a metà strada. Mi afferrò un braccio – quello che avrebbe dovuto essere legato alla flebo – e lo osservò con occhi sgranati. «Fila a letto», sibilò poi, minacciosa come mai l’avevo vista. Non ebbi nemmeno il coraggio di provare a replicare. Semplicemente le diedi le spalle e lasciai che mi scortasse di nuovo in camera mia mentre entrambe trattenevamo colorite imprecazioni. I know that you’re wounded.
You know that I’m here to save you. Ringraziamenti Ai Three Days Grace, perché Pain è la meraviglia e sono davvero felice di averci pensato per questo capitolo. ♡ Note Suuuurprise! Sì, lo so, avrei dovuto aggiornare domani come sempre. Il punto è che non sono sicura di potercela fare dato che sarò fuori città per il pranzo da mia nonna. Io ormai la conosco bene: i pranzi da lei durano otto ore minimo e non escludo di restare lì da lei anche per cena. Non volevo saltare l'appuntamento settimanale con l'aggiornamento, ecco perché ho preferito non rischiare e mettermi a lavoro in anticipo. Spero apprezzerete questa mia sorpresa halloweeniana (?). Il capitolo è abbastanza di passaggio, lo so, ma mi serviva un po’ della tipica tranquillità prima della tempesta. Come vi ho detto già tempo fa, la storia avrà in tutto dodici capitoli incluso l’epilogo; ergo, prima che finisca tutto ci rimane solo l’undicesimo. L’epilogo sarà ambientato diversi mesi dopo – quando la storia del kanima è ormai archiviata – ma succederanno comunque un sacco di cose, quindi davvero state pronti perché come al solito servirà da “trampolino di lancio” per il sequel (il quale ha già un titolo che, nel caso vi interessi saperlo, è storm). Visto che con kaleidoscope mi è andata benissimo e ultimamente sono molto più che ispirata, prometto che comincerò a lavorarci non appena potrò e che ve lo farò avere nel giro di sei mesi massimo: aspettare un anno per tornare nel fandom è stato controproducente non solo per voi ma anche per me; prometto che non commetterò più lo stesso sbaglio. BTW, ho inserito Il giovane Holden in questo capitolo perché è uno dei miei libri preferiti e anche uno dei preferiti di Victoria (mi pare, non vorrei dire una cazzata. Anyway c’è una gif in cui lei lo legge ed io vedendola ho troppo pensato ad Harry; dovevo citare questo piccolo particolare #grazietumblr). |
Capitolo 11
*** Stronger ***
The idea behind a kaleidoscope is that it’s a structure filled with broken bits and pieces,
but somehow if you can look through them, you still see something beautiful. And I feel like we’re all that way a little bit. kaleidoscope
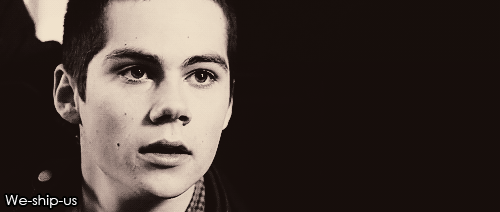 11. Stronger
Melissa McCall mi aveva scortata in camera mia senza sentire ragioni né togliermi gli occhi di dosso nemmeno per un attimo. Avevo provato a farla ragionare in qualsiasi modo, ma non c’era stato nulla che potessi fare per eludere nuovamente la sua stretta sorveglianza. La flebo era tornata al suo posto – l’ago infilato nel mio braccio sano e l’asta che la teneva sollevata di fianco al mio letto – ed io confinata nella mia stanza. Melissa non aveva voluto lasciarmi sola neanche quando mi ero infilata sotto le coperte: era rimasta seduta accanto a me senza mai perdermi d’occhio, tanto che ad un certo punto avevo preferito fingermi addormentata per non doverla più affrontare. Ma la signora McCall non mi aveva comunque lasciata sola, almeno finché non le era squillato il telefono. Nel silenzio assoluto della stanza l’avevo sentita scattare in piedi e rispondere alla telefonata prima che la suoneria potesse fare fin troppo baccano e risvegliarmi, poi mormorare un: «Arrivo» appena appena accennato e sgattaiolare finalmente fuori dalla mia camera. Non avevo idea di chi l’avesse chiamata e convinta a lasciarmi sola, ma non persi tempo a chiedermelo. Mi sollevai a sedere nel letto e recuperai il mio cellulare: avevo anch’io un’importante telefonata da fare. Ecco perché digitai velocemente il numero di Scott. Il beta rispose al settimo squillo, dopo avermi fatto morire ben bene dall’ansia. «Harriet, che succede?», mi domandò con aria trafelata e confusa – non riusciva a capire che motivo avessi di telefonargli nel bel mezzo della notte. «Dov’è Stiles?». Saltai tutti i convenevoli, com’era giusto che fosse. La mia non era certo una telefonata di cortesia: volevo sapere al più presto se la mia visione fosse già divenuta realtà. E il silenzio eloquente di Scott mi diede subito molte più risposte di quante ne volessi. «Non lo so». Non c’era bisogno che me lo dicesse. Gli occhi mi si riempirono immediatamente di lacrime. Era già troppo tardi? Speravo proprio di no. «Io l’ho v-visto, Scott», balbettai. «Quindi sai dov’è?». Il tono di voce di McCall assunse un’aria così sollevata che il cuore mi si strinse nuovamente in una morsa e la prima di moltissime lacrime rotolò giù lungo la mia guancia pallida all’improvvisa consapevolezza di essere – ancora una volta – perfettamente inutile. «No», piagnucolai, cercando di controllare i gemiti inutilmente. «Ho solo visto un seminterrato. Niente di più». Scott trattenne il respiro e masticò un’imprecazione: anche se non eravamo insieme lo sentii perfettamente e riuscii benissimo ad immaginare quanto male stesse in quel momento. Ma fece di tutto per non farmelo notare troppo: non voleva che anch’io stessi peggio di così. «Okay», mormorò a bassa voce, fingendosi tranquillo quando in realtà stava cadendo a pezzi anche lui insieme a me. «Calma. Sto venendo in ospedale con Isaac. Ci vediamo tra dieci minuti, d’accordo?». Annuii, anche se sapevo benissimo che non potesse vedermi. Ma avevo la mente troppo annebbiata per potermi rendere conto del silenzio pesante al quale avevo costretto Scott, obbligato ad ascoltare nient’altro che il rumore del mio pianto. «Harriet», lo sentii richiamarmi infatti dopo un po’, e il mio nome pronunciato con quel suo tono tanto dispiaciuto mi riportò subito alla realtà. «Stai tranquilla, ti prego». Chiusi gli occhi, poi inspirai ed espirai un paio di volte. Scott aveva ragione, come sempre. Dovevo stare tranquilla. Piangere come una bambina non avrebbe risolto niente. Dovevo essere forte e pronta a combattere – per Stiles. Espirai per l’ultima volta, poi riaprii gli occhi nel buio della mia stanza d’ospedale e strinsi più forte il cellulare tra le dita prima di riparlare a Scott. «Fate presto».  Un pugno. Due, tre, quattro. Stiles perse velocemente il conto. Sapeva solo di non essersi mai sentito peggio di così, di non aver mai provato più dolore di quanto ne sentisse in quel momento. Non era solo dolore fisico, no. Sarebbe stato troppo bello se si fosse limitato solo a quello, ad un paio di graffi e lividi che sarebbero spariti nel giro di poche settimane senza lasciare tracce. No. Era molto di più. Era il dolore dell’abbandono e della solitudine, era il dolore che sentiva anche per Erica e Boyd. Ed era straziante, così tanto che non se lo fece ripetere due volte prima di mollare la presa e semplicemente cedere ai colpi di quell’uomo malvagio, steso sul pavimento polveroso di una cantina che non avrebbe mai immaginato di dover visitare. Perlomeno, non in quelle condizioni. Non trascinato lì dopo l’ultima partita di campionato, non con Erica e Boyd che venivano torturati di fronte ai suoi occhi ambrati e ricolmi di preoccupazione. Era tutto fin troppo sbagliato per poter essere vero, ma Stiles aveva sentito fino a quel momento una piccola speranza di salvezza. Sapeva che Scott avrebbe potuto trovarlo seguendo il suo odore e che Harriet – se solo si fosse impegnata un po’ di più – avrebbe capito subito che c’era qualcosa che non andava. Ma mentre l’uomo lo sovrastava e lo malmenava, si chiese cosa avrebbe fatto se né il suo migliore amico né la sua ragazza si fossero resi conto della sua sparizione. Sarebbe morto lì, per mano di quel mostro? O qualcun altro l’avrebbe salvato, risparmiandogli finalmente tutto quel dolore? Altri millemila quesiti simili continuarono ad affollare la mente di Stiles, tutti fonte di sofferenza e soprattutto senza risposta. Almeno finché quest’ultimo non cedette finalmente e si lasciò andare nel nero assoluto dell’oblio.
 Sgranai gli occhi all’improvviso, incespicando nel bel mezzo del corridoio deserto e scarsamente illuminato del Beacon Hills Memorial Hospital. Strinsi le dita sull’asta che reggeva la mia flebo, cercando a tutti i costi di tenermi salda sulle gambe traballanti. Continuavo ad avere visioni su Stiles, ma ero tanto debole da non riuscire a vedere nient’altro che il suo viso ricoperto di sangue. C’era un uomo insieme a lui: lo stava torturando – come stava facendo con Erica e Boyd – ed io non potevo nemmeno sapere chi fosse. Avrei potuto sforzarmi fino a farmi scoppiare la testa, ma sapevo già che non sarei riuscita a vedere nient’altro oltre la sua schiena curvata su Stiles.
Mi morsi l’interno guancia quasi a sangue nella speranza di non sentire più il dolore dell’emicrania né quello delle mie ferite. Avrei dovuto essere a letto a riposare per potermi riprendere dallo scontro col kanima e lo sapevo, ma non potevo permettermi un sonno rigenerante quando chissà dove Stiles veniva malmenato da qualcuno che non avevo idea di chi fosse. Ecco perché strinsi i denti e continuai ad avanzare nella penombra dell’ospedale, almeno finché non sentii le voci di Scott ed Isaac più vicine che mai e capii di essere finalmente giunta alla meta. Non ero più sola. «Non ha una buona cera». Avevo appena appena svoltato l’angolo quando Isaac parlò, gli occhi azzurri puntati su un sacco mortuario contenente… Jackson Whittemore. Sentii un improvviso moto di disgusto risalirmi in gola e mi strinsi le mani sulle labbra nella speranza di trattenere terribili conati di vomito. Ma la mia espressione mutò subito in terrore nel momento in cui vidi il corpo di Jackson vibrare vistosamente. Non poteva essere tutto frutto della mia mente. Non ancora. Jackson era vivo? Me lo chiesi mentre avanzavo nella stanza occupata da lui, Isaac, Scott e Melissa McCall. Senza che riuscissi ad ottenere risposte soddisfacenti. «Mamma, chiudilo», ordinò il beta a Melissa, scoccandomi nient’altro che una velocissima occhiata piuttosto infastidita. Non gli diedi retta, portando lo sguardo sulla figura di mamma McCall. La vidi guardare suo figlio con occhi incerti e pieni di paura, poi tremolare nei pressi del sacco di Jackson e cominciare a chiudere lentamente la zip sul suo corpo ricoperto di… Cosa diavolo era quella cosa che avvolgeva il busto dell’ex-kanima? «Scott», soffiai, indicando proprio l’oggetto del mio interesse, «cosa diavolo è?». McCall sospirò, facendomi segno di raggiungerlo dall’altra parte del tavolo per autopsie. «È il suo veleno», mi spiegò poi, facendomi sobbalzare dal terrore che quell’ennesima notizia mi provocò. «Derek dice che si sta evolvendo». Evolvendo? Cos’è ora, un Pokémon? Evitai di fare quella battutaccia inopportuna, ma Scott ed Isaac dovettero comunque leggere benissimo tutto lo sgomento che traspariva dalla mia espressione attonita perché non persero tempo per provare a tranquillizzarmi. «Lo stiamo portando via». Fissai Isaac. Sembrava tranquillo, ma sapevo che avesse paura – ce l’avevamo tutti. Eppure era lì, ancora pronto a battersi in una guerra molto più grande di lui e per nulla disposto a scappare. Fu quell’improvviso pensiero a riscuotermi completamente. Ma la mia tranquillità durò poco. Un improvviso e basso ringhio mi costrinse infatti a distogliere gli occhi da quelli chiarissimi di Isaac e la paura prese di nuovo possesso del mio corpo quando realizzai che ad emetterlo fosse stato Jackson, il quale era ormai trasformato per metà nel kanima. Sobbalzai come tutti all’interno di quella stanza mentre Scott urlava a Melissa di chiudere il sacco mortuario e ad Isaac di portare via Jackson al più presto. Quasi mi persi in tutto quel caos improvviso, almeno finché la figura di Jackson sparì dalla mia visuale e la squillante suoneria del telefono di Scott ruppe la trance. McCall lasciò andare il sacco ed osservò il suo cellulare con aria affannata: quando lo vidi mettere su un debole sorriso credetti di stare ancora sognando. Ma: «Stiles è tornato!», trillò il beta all’improvviso, e allora capii che il sogno fosse diventato realtà. Mi portai le mani alle labbra, ancora incredula. Poi un altro improvviso movimento da parte di Jackson fece capire a tutti che non ci fosse altro tempo da perdere. Scott e Isaac ripresero a trasportare via il sacco mortuario, con me e Melissa che li seguivamo in silenzio. Ma prima che i due licantropi potessero lasciare il Beacon Hills Memorial Hospital, li fermai. «Devo andare da Stiles», dissi, e Scott si voltò a guardarmi con un lieve sospiro. «D’accordo», concesse velocemente, poco prima di voltarsi a guardare sua madre, «Puoi accompagnarla tu, per favore?». Melissa accanto a me s’irrigidì all’improvviso. Capii subito che non sarebbe stato facile. «Non dovrebbe nemmeno essere in piedi!», strillò infatti, puntandomi con l’indice. Scott sospirò nuovamente, poi alternò occhiate preoccupate da me a sua madre. «Harriet sta bene. Non è vero?». Annuii ripetutamente senza farmelo ripetere due volte. Poi cercai gli occhi scuri di Melissa. «Starò ancor meglio dopo che avrò visto Stiles». «Harriet». Melissa richiamò il mio nome all’improvviso ed io mi voltai a cercarla nella penombra della sua auto, stringendo un po’ più forte il cellulare contro l’orecchio nella paura che potesse scivolarmi di mano e farmi perdere la risposta di Stephen che attendevo con fin troppa ansia. «Devi promettermi che starai attenta. Se dovessi sentirti anche un minimo male–», pregò; ma all’improvviso suono della voce dello sceriffo la mia attenzione nei suoi confronti scemò completamente. «Piccola, che succede?», mi richiamò dall’altro capo del telefono, ed io distolsi prontamente gli occhi dal viso preoccupato – fin troppo – della signora McCall. «Stephen», soffiai. «Sto tornando a casa». Dall’altra parte ci fu un secondo di troppo di silenzio. Poi finalmente lo sceriffo si riprese dalla propria confusione tanto da riuscire a parlarmi di nuovo. «Com’è possibile?». «C’è Melissa con me», tentai di rassicurarlo, guardando di sfuggita la mamma di Scott che ancora guidava con aria contrita nel bel mezzo di una Beacon Hills dormiente. «Tranquillo, è tutto a posto». «Ma stai bene? Ne sei sicura?». Annuii, anche se sapevo benissimo che non avrebbe potuto vedermi. «Sto bene. Stiles dov’è?». Pregai che non mi dicesse una bugia. Ma sapevo già di quanto le mie speranze fossero vane. «Dorme. Cosa che dovresti fare anche tu a quest’ora». Lo sceriffo cercava solo di proteggermi. Ma io non ne avevo bisogno. Non allora. «So tutto, Stephen», gli rivelai quindi, ingegnandomi subito alla ricerca di una buona scusa che m’impedisse di dovergli rivelare tutto riguardo i miei poteri. «Scott è venuto in ospedale e me l’ha detto. Fammi parlare con Stiles». «Harry…». «Ti prego», implorai, e probabilmente qualcosa nel mio tono di voce lo convinse tanto da decidere di lasciar perdere. Stephen infatti non aggiunse nient’altro, semplicemente sospirò e prima ancora che potessi rendermene conto aveva lasciato il suo cellulare nelle mani di Stiles. Stiles che, comunque, non mi rivolse nient’altro che un pesantissimo silenzio. «Stiles», lo richiamai io quindi, ben sapendo che toccasse a me far partire quella conversazione. «sto arrivando». Diedi un’occhiata alla strada: eravamo vicinissime a casa Stilinski. Avrei voluto sorridere, ma la replica di Stiles congelò la mia espressione a metà. «Torna a dormire, Harry. Ci sentiamo domani. Ti richiamo io». Non l’avevo mai sentito così stravolto. E quell’improvvisa consapevolezza mi tolse il respiro. Pensai a cosa dire – a cosa fare – mentre Melissa s’infilava finalmente nel vialetto di casa ed io aspettavo con trepidazione il momento in cui sarei potuta scendere dalla sua auto e correre dentro. Al sicuro, con Stiles. «Sappiamo entrambi che non lo farai», gli dissi, aprendo lo sportello in fretta e furia e correndo verso il campanello mentre Melissa McCall arrancava dietro di me. Suonai piano, poi attesi la risposta di Stiles. Un’altra risposta che mi uccise. «Non ho voglia di parlare ora, okay?», borbottò, proprio nel momento in cui il viso stanco di Stephen si parava di fronte a me. Avrei voluto abbracciarlo – sapevo che la cosa mi avrebbe fatta stare meglio – invece mi limitai a scansarlo con una spallata per prendere la rincorsa verso la camera di Stiles, il quale aggiunse in un sussurro: «E tu devi riposare. Sei stanca». Quasi sorrisi. «Non più di te». Ed era vero. «Dimmi che stai bene, almeno». Di nuovo, dall’altro capo del telefono mi arrivò nient’altro che silenzio. E sapevo già che a seguirlo ci sarebbe stata una tremenda bugia. «Sto bene», soffiò Stiles difatti, confermando i miei presentimenti col suo solo tono di voce. Ma capii ancor meglio quanto mi stesse mentendo nel momento in cui raggiunsi la sua camera e lo osservai dalla soglia. «Non è vero», esalai quindi, incapace di aggiungere altro. Al suono improvviso della mia voce – molto più vicina di quanto avrebbe dovuto essere – Stiles scattò in piedi e sgranò gli occhi sulla mia figura. «Cosa ci fai tu qui?», chiese, sorpreso a dir poco. Feci scivolare via il cellulare dal mio orecchio, liberandomene poi senza remore mentre mi avvicinavo a Stiles. «Te l’avevo detto che stavo arrivando». Quando fui abbastanza vicina per poterlo fare, allungai una mano verso la sua pelle chiara e rovinata in quel momento da una grossa macchia di sangue rappreso che subito mi strinse il cuore in una morsa. Aveva lo zigomo completamente tumefatto e il labbro spaccato. Ed io, come al solito, non avevo potuto far niente per impedire che gli succedesse tutto ciò. «Mi dispiace così tanto», gli dissi quindi mentre i miei occhi si riempivano di lacrime al vederlo che si faceva lontano da me. Ma Stiles subito capì – per fortuna – e allora smise di indietreggiare, come se finalmente avesse realizzato di starsi comportando come uno stupido. Perché ero io che gli stavo di fronte in quel momento, e mai – mai – avrei potuto fargli del male come aveva temuto lui solo pochi secondi prima. Stiles sembrò capirlo all’improvviso e qualcosa nel suo sguardo ambrato cambiò tanto da farmi vacillare sotto i suoi occhi, mentre prendevamo entrambi coraggio per incontrarci a metà, stretti nel calore confortante di un abbraccio che non capirò mai per mano di chi dei due fosse nato. «Harriet», mi richiamò Stiles in un soffio, muovendo piano le dita tra i miei capelli lunghi. «grazie». Riaprii gli occhi lucidi all’improvviso, stringendo la sua t-shirt grigia tra le mani. «Per cosa?», gli domandai poi, confusa a dir poco. Stiles sospirò lievemente prima di stringermi a sé ancor di più. «Per essere qui». «Melissa se n’è andata. Dice che se stai attenta ai punti andrà tutto bene». Un po’ di tempo dopo, Stephen raggiunse me e suo figlio in camera di Stiles, parlandomi e costringendomi a sollevare la testa dalla spalla di quest’ultimo. Non gliene feci una colpa comunque, limitandomi ad annuire mentre gli sorridevo tranquilla. Lo ero fin troppo perché una cosa tanto stupida potesse sul serio infastidirmi. Stephen ricambiò velocemente il mio sorriso, poi cercò con lo sguardo azzurro il viso ammaccato del figlio. «Cosa voleva Lydia?», gli domandò, sedendosi alla scrivania insieme a noi. Stiles semplicemente scrollò le spalle, io invece aggrottai le sopracciglia mentre mi chiedevo cosa mi fossi persa esattamente. «Appoggio», rivelò infine Stiles. «Ha perso il ragazzo di cui era innamorata». Jackson. Lydia lo amava sul serio. E non osavo nemmeno immaginare come potesse sentirsi in quel momento. Le successive parole di Stephen comunque mi distrassero quanto bastava. «So che tutta questa situazione ti ha scosso parecchio, Stiles. Ma puoi sempre essere felice per la partita, no? Sei stato grande». Stiles scosse subito la testa con aria incredula, poi soffocò una risata. Io strinsi un po’ di più le dita sul suo braccio scoperto e misi su un sorrisone al solo pensiero della partita di lacrosse che ahimè mi ero persa quella sera. «Dico sul serio. La partita era quasi finita, ma tu non ti sei arreso. Hai preso la palla, hai iniziato a correre e hai segnato. La fortuna ha cominciato a girare. Poi hai segnato ancora – e ancora. Non sei stato solo il migliore in campo. Sei stato un eroe». Il mio sorriso crebbe ancor di più nel sentire il tono di Stephen ricolmo di orgoglio, ma la successiva battuta di Stiles mi congelò completamente. «Non sono un eroe, papà», lo corresse, rifuggendone lo sguardo mentre io gli riservavo nient’altro che una lunga occhiataccia indispettita. Non volevo che si sminuisse in quel modo. E non lo voleva nemmeno Stephen, che semplicemente gli sorrise prima di defilarsi con un ultimo: «Alla partita lo sei stato». Allora nella stanza cadde il silenzio ed io mi strinsi nuovamente a Stiles, tornando a poggiare la mia testa sulla sua spalla. Non mi aspettavo certo di sentirlo ripetere: «Io non sono un eroe». Ecco perché scattai subito seduta composta. Avrei voluto contraddirlo prontamente, ma all’improvviso le parole mi mancarono e riuscii solo a stringere la sua t-shirt tra le dita. Almeno finché non ritrovai almeno un po’ del mio coraggio perduto. «Stiles», sussurrai quindi, direttamente contro il suo orecchio. «Tu sei il mio eroe». Ed io ti amo. Quel pensiero sparì veloce com’era apparso, scappando via a braccetto con quel poco di coraggio che mi era bastato a far capire a Stiles di quanto fossi orgogliosa di lui e di quanto lo considerassi il mio eroe. Ecco perché non gli dissi nulla, limitandomi a ricambiare il suo intenso sguardo con aria frastornata. Mi sembrò di restare a guardarlo per secoli e ricordo perfettamente di essermi figurata nella mente i più vari scenari riguardo a ciò che mi avrebbe detto Stiles a quel punto, ma scoprii ben presto di come la realtà fosse ben lontana dal sogno. «Dobbiamo andare», mormorò infatti Stiles all’improvviso, deviando il mio sguardo scuro e scattando in piedi. Rimasi a fissarlo con aria confusa, la quale aumentò nel momento in cui il cellulare di Stiles mi piombò addosso. Me l’aveva lanciato contro. E capii perché non appena proprio lui ordinò in un sussurro: «Chiama Lydia». Era bastata una chiave. Una semplicissima chiave e l’inspiegabile potere dell’amore umano erano tutto ciò che serviva per portare indietro Jackson. Lo osservai col cuore in gola mentre afferrava la chiave dorata che Lydia gli porgeva, piangendo lacrime silenziose di fronte alla figura del ragazzo che amava da sempre trasformato nel kanima solo a metà. Avevo immaginato potesse succedere di tutto, tranne ciò che poi si trasformò in realtà. Vidi Jackson che si faceva lontano da Lydia, poi Derek e Peter Hale raggiungerlo. Successe tutto così velocemente che a malapena me ne accorsi: semplicemente mi limitai a sussultare vistosamente afferrando la maglia di Stiles, mentre Jackson gemeva dal dolore infertogli dalle ferite dei due licantropi. Oh mio Dio. Non doveva andare così. Non potevamo salvare Jackson, lo sapevo. Ma perché mai ucciderlo? «Tu…», soffiò Whittemore, cadendo sulle ginocchia di fronte ad una Lydia sempre più sconvolta. «…ancora–». Lei non gli lasciò aggiungere altro. «Sì», confermò tra le lacrime. «Ti amo ancora. Io ti amo ancora». Mi sentii stringere il cuore in una morsa al suono flebile di quelle parole, mentre Lydia stringeva Jackson a sé come se all’improvviso ne dipendesse della sua stessa vita e Allison cercava una mano di Scott per intrecciarvi le proprie dita e sentirsi meno sola. «Dov’è Gerard?», la sentii domandare mentre Lydia lasciava andare Jackson e Chris Argent si guardava intorno con aria lievemente spaesata. «Non può essere andato molto lontano», concluse infine, adocchiando una pozza di quello che aveva tutta l’aria di essere sangue. Mi chiesi immediatamente cosa fosse successo prima che io, Stiles e Lydia giungessimo lì, ma non riuscii mai a trovare una risposta. I miei pensieri furono infatti interrotti da Stiles, il quale abbandonò il mio fianco per avanzare in direzione di… Lydia. Lo capii subito e un nodo mi serrò la gola, togliendomi il respiro. Ma comunque non lo fermai. Non gli impedii di starle vicino come voleva in quello che per lei doveva essere un altro momento terribile. O perlomeno, così credetti che avrei fatto. Quando però sentii gli artigli di Jackson raschiare il pavimento non riuscii a resistere. Scattai in avanti e afferrai una mano di Stiles per tenerlo vicino a me e proteggerlo, così mi dissi. In realtà volevo solo che non mi abbandonasse. Ero – di nuovo – schifosamente egoista. Ma Stiles alla fine decise di accontentarmi, perché rinunciò ai suoi propositi di raggiungere Lydia e mi rimase al fianco mentre Jackson rivelava un paio di occhi azzurro brillante e si rimetteva sorprendentemente in piedi, ululando tanto forte che mi sembrò di sentire i muri tremare. Era vivo, ancora. Ed era un licantropo, finalmente. Alla fine – per fortuna – l’ululato cessò e Jackson ritornò in sé, di nuovo tanto umano da non spaventare più Lydia, la quale gli corse in contro velocemente e gli si gettò letteralmente tra le braccia. Sentii Stiles soffocare un sospiro e strinsi più forte le sue dita tra le mie. «Stiles», lo richiamai in un sussurro, combattendo contro i miei occhi lucidi. Non avrei pianto in quel momento. «Andiamo a casa». Sapevo fosse solo quella la cosa più giusta da fare in quel momento. E all’improvviso lo capì anche Stiles, perché si voltò a guardarmi finalmente e infine – dopo minuti interi di silenzio – annuì e mi trascinò, sempre tenendomi per mano, verso la Jeep azzurro cielo. E ce ne andammo sul serio. Insieme. Ancora. When your heart is feeling bruised turn the focus, clear your view.
All the ghosts of the past crash with mine and all collide, collide – kaleidoscope. Ringraziamenti Da come avrete potuto capire, credo, la canzone citata a fine capitolo è anche quella che dà il titolo all’intera storia: Kaleidoscope degli Honor Society. Ho voluto inserirla qui perché l’epilogo avrà ben altro “carattere” e perché questa canzone fa un po’ da filo conduttore a tutto il sequel; se la ascoltate e leggete bene il testo capirete anche perché. Il titolo comunque non è legato alla canzone, ma è piuttosto un parallel col primo capitolo che ho voluto a tutti i costi inserire per dimostrarvi quant’è cresciuta Harriet nel corso di quest’altra avventura. Il primo capitolo si conclude infatti col verso “I’m getting weaker everyday”, cosa che si è vista bene nel corso di kaleidoscope, e qui invece abbiamo come titolo la parola “stronger”: perché è proprio così, ora Harry è più forte. E lo vedrete bene già a partire dall’epilogo. Note Parlando ancora di parallels: ormai dovreste sapere quanto mi piace farne e, se siete state attente, sicuramente ne avrete scovato un altro – oltre a quello del titolo – in quest’ultimo capitolo della storia. In caso non ci foste arrivati, comunque, vi do un indizio: ricordate le ultime due parole del capitolo 1? Quali erano? Insieme. Ancora., no? E rieccole qua, a chiudere perfettamente il cerchio e a dimostrarvi meravigliosamente di come NONOSTANTE TUTTO #StarrietLives. ♡ Vi dico che durante la stesura ho versato molto più che qualche lacrimuccia, ma immagino fosse inevitabile. È un altro cerchio che si chiude ed io sono super-soddisfatta del lavoro che ho fatto, ma anche molto dispiaciuta di dover dire addio a quest’ennesima long. Prima che ciò accada comunque avete ancora un po’ di cose da leggere quindi vi consiglio vivamente di non disperarvi troppo. Come mi sembra di aver già detto un sacco di volte, l’epilogo sarà ambientato un sacco di mesi dopo questo capitolo ed è proprio per questo motivo che ho deciso di scrivere una raccolta di missing moments per riempire i buchi al quale questo salto temporale vi obbliga. A proposito della raccolta e dell’epilogo che la seguirà vi prego di leggere le righe sotto! ATTENZIONE Attualmente col timeline della storia ci troviamo ad inizi dicembre e il primo capitolo della raccolta sarà ambientato durante la Vigilia di Natale. A proposito di questo, lo pubblicherò domenica prossima e avrete gli altri a seguire, uno dopo l’altro, sempre di domenica. Ciò vuol dire quindi che finché la raccolta non sarà completa non pubblicherò l’epilogo di kaleidoscope, il quale – giacché la raccolta è composta da quattro capitoli – arriverà solo il 13 dicembre. Ovviamente non siete obbligati a seguirla, ma vi consiglio comunque di farlo per non perdervi niente della trama che in occasione di questi missing moments si alleggerirà anche di molto dato che andremo a vivere insieme agli Starriet le vacanze natalizie, il ventottesimo compleanno e il matrimonio di Cassandra. Insomma, tutte cose felici I PROMISE. Spero che deciderete di seguirmi anche lì, in caso ci vediamo il 15 novembre col primo capitolo! :) Grazie comunque. |
Capitolo 12
*** Ever after ***
Da parachute: Tutto sembrava partire dalla figura di Charles Shelby Carter […]. Nato a New York nel 1888, secondogenito in una famiglia di umili trasportatori di merci, dopo aver servito per dieci anni nell’esercito americano e aver raggiunto l’alta carica di secondo luogotenente d’artiglieria terrestre, aveva deciso di congedarsi per trasferirsi a Beacon Hills nel 1919. […] Nel ventotto ottobre del 1920 prese in sposa la giovane Rita Fitzgerald, che diede alla luce il suo primogenito – Eric – esattamente un anno dopo. I tre vissero una vita più che agiata, affermandosi come una delle famiglie più celebri della piccola cittadina di Beacon Hills […]. La fortuna era senza dubbio a favore dei Carter, cosa che riempì d’invidia alcuni nemici, colpevoli dell’organizzazione di un vero e proprio attentato ai danni del patriarca […]. A seguito di un tragico incidente che subì il primo luglio del 1935 […] Charles […] perse l’abilità di sognare […]. Charles affrontò un iniziale periodo di aggressività comportamentale quasi incontrollabile, che poi si tramutò in allucinazioni tanto vivide che diventò sempre più difficile, per lui, distinguere la realtà dalla finzione […]. Il terzo ed ultimo stadio che l’uomo si ritrova ad affrontare in assenza di sogni è quello della morte per insufficienza surrenale e Charles lo sapeva così bene che si dimostrò fin da subito disposto a tutto pur di riottenere la capacità di sognare. Tutti i rimedi che provò risultarono inutili, almeno finché Charles non riuscì ad entrare in contatto col popolo indiano e a scoprire così la Silene Capensis, pianta meglio conosciuta come “erba del sogno”. Ritenuta sacra dal popolo Xhosa ed utilizzata dagli indiani per l’iniziazione di aspiranti sciamani, era capace di provocare – se ingerita – vivide e profetiche allucinazioni e lucidi sogni durante la fase REM [...].
kaleidoscope
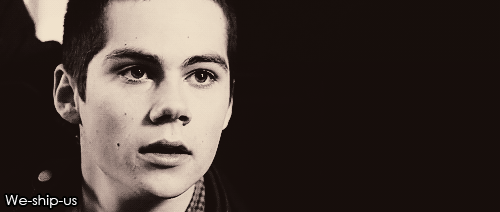 12. Ever after
Quando sei felice pensi stupidamente che tutta la tranquillità e serenità del momento debbano sul serio non finire mai. Soprattutto quando si tratta di un buon periodo arrivato dopo mesi e mesi di buio. Tutto il nuovo benessere ti coglie completamente impreparata, ma ci fai subito l’abitudine e te lo godi fino all’ultimo secondo – convinta del fatto che più niente e nessuno te lo strapperà di mano. Ma solo quando di nuovo tutto precipita nell’oblio capisci sul serio e all’improvviso quanto stupide fossero tutte le tue convinzioni. E ritorni alla realtà di botto: una realtà che fa schifo e che faresti di tutto purché non fosse proprio la tua realtà. Ma lo è, e per quanto ti piacerebbe, non puoi scappare. Ecco cosa mi successe dopo le festività natalizie e l’inizio dell’anno nuovo passati in completa tranquillità: precipitò tutto in un battibaleno e la notizia improvvisa della malattia di mio nonno Thomas mi colpì allo stomaco con la violenza di un pugno sferrato quando meno te lo aspetti. Proprio nel momento in cui sembrava che nella mia vita ogni tassello fosse tornato al proprio posto, qualcosa andò profondamente storto ed io – proprio come ognuno dei Carter – ne risentii profondamente. La porta d’ingresso della magione che abitavano i miei nonni paterni si spalancò velocemente, portandosi dietro uno spiffero di vento che mi fece rabbrividire vistosamente nel violento freddo di marzo. Comunque ebbi poco tempo per avvertire quella spiacevole sensazione perché immediatamente un paio di braccia mi si strinsero attorno al corpo ed io mi godetti improvvisamente il calore di quell’abbraccio inaspettato. Riconobbi mia cugina dal solo intenso profumo di fragole che mi riversò addosso mentre mi teneva stretta a sé. «Finalmente sei arrivata», osservò poi in un sussurro, confermando la mia tesi col tono inconfondibile della sua voce e poi – quando mi lasciò andare – con la vista del suo viso pericolosamente pallido. Quella che avevo di fronte non aveva niente della sarcastica e sempre sorridente Oriesta Osbourne che avevo conosciuto mesi prima. Proprio come il ragazzino biondo di fianco a lei non aveva niente del suo allegro fratello. «Ciao, cugina», Niall mi salutò a malapena, invitandomi ad entrare in casa dei nostri nonni con un debolissimo cenno. Non me lo feci ripetere due volte prima di seguire i miei cugini all’interno della magione, lungo corridoi bui e vagamente polverosi. Non avevo idea di dove stessimo andando, ecco perché non indugiai più nel chiederlo. «Cosa succede?». Gli occhi color nocciola di Oriesta mi corsero subito addosso e potei vederli tanto lucidi da sentirmi male. «È nonno», mormorò poi, evitando il mio sguardo scuro e riprendendo a camminare con me e suo fratello Niall alle calcagna. «sta male». Questo lo sapevo già. Nonna Sarah mi aveva chiamata quella sera, non capace però di dirmi qualcos’altro di più utile perché distrutta dalla crisi di pianto che l’aveva colta al telefono. Nel sentirla così non c’avevo pensato su due volte a raggiungere la magione Carter. Continuai a seguire i fratelli Osbourne lungo i corridoi, fermandomi insieme a loro di fronte ad una grande porta chiusa. Niall – il più piccolo dei due – afferrò subito la maniglia d’ottone, ma prima di aprirla si voltò a cercare i miei occhi confusi. «È arrivato il momento», tentò di spiegarmi, ma fallì su tutta la linea perché quelle sue parole m’insospettirono ancor di più. Il momento per cosa?, non potei far altro che chiedermi infatti. Ma non ricevetti alcuna risposta. Se anche Oriesta e Niall mi avessero letto il pensiero, non diedero segno di accorgersi della mia confusione né provarono ad attenuarla. Semplicemente mio cugino aprì lentamente la porta – dietro la quale avrei trovato mio nonno? – e permise sia a me che a sua sorella di seguirlo all’interno della stanza. Realizzai subito che fosse una camera da letto, immensa e forse ancor più buia del corridoio lungo la quale era posizionata. E tutti i miei dubbi trovarono la loro dolorosa conferma nel momento in cui individuai la figura di mio nonno ad occupare il grande letto a baldacchino nel centro della camera. «Bambina», mi richiamò flebilmente, allungando una mano nodosa nella mia direzione con aria stanca. «che bello vederti». Lo raggiunsi con poche falcate, stringendo subito tra le mie la mano che mi porgeva. L’altra, realizzai con immensa sorpresa, era avvolta da quella abbronzata di una ragazza che poteva avere benissimo la mia stessa età. Avrei dovuto dedicare attenzioni solo a mio nonno e lo sapevo bene, ma comunque non potei far altro che fissare curiosamente la ragazzina dalla pelle ambrata e i lunghi capelli neri che mi stava di fronte. Non l’avevo mai vista prima d’allora, ma avevo la perfetta impressione di conoscerla di già. E le mani di mio cugino Walter posate sulle sue spalle curve diedero la risposta ad ogni mio dubbio. Quella di fronte a me doveva essere Shanti. Ne ero quasi convinta, ma non era quello il tempo perché indagassi. «Nonno», richiamai dunque l’attenzione di Thomas, distogliendo lo sguardo dagli occhi nerissimi della ragazza di fronte a me, «cos’hai?». Mio nonno rafforzò lievemente la stretta delle nostre mani, poi m’inchiodò sul posto coi suoi intensi occhi azzurri. Aveva un’aria stravolta. «Sto morendo, Harriet». La violenza di quella rivelazione mi colpì tanto che mollai la mano di mio nonno con uno scatto repentino, inorridita all’improvviso. «Non è possibile», sibilai, incredula. Doveva essere uno scherzo di pessimo gusto quello che Thomas – e tutti i Carter insieme a lui – mi stavano rifilando. Ma quando vidi mio nonno mettere su nient’altro che un debole sorriso dispiaciuto, qualcosa mi fece capire all’improvviso di come quella fosse la semplice e dura realtà dei fatti. «Posso prevedere il futuro, ma non sono immortale», spiegò. E lo sapevo – lo sapevo benissimo – ma non riuscivo ad accettarlo. Thomas Carter non poteva sul serio chiedermi di scendere a patti con l’idea che di lì a poco l’avrei perso di nuovo. «Non devi preoccuparti per me, bambina. Shanti mi sta aiutando moltissimo. Io sto bene». Il suono di quel nome già fin troppo conosciuto – Shanti – mi riportò alla realtà di scatto. Cercai nuovamente il viso abbronzato della ragazza di fronte a me, la quale mi sorrise non troppo convinta. «Chi è lei?», domandai a mio nonno, mantenendo però gli occhi fissi sulla figura di Shanti. Lei stessa si occupò di sanare immediatamente ogni mio dubbio. «Shanti Jādūgara», si presentò, porgendomi una mano che io non riuscii a stringere. Sentii gli occhi di mio cugino Walter bruciarmi le guance. Era indispettito dal mio comportamento. Ma doveva sapere bene anche lui quanto poco mi piacesse fare nuove inaspettate conoscenze. Ecco perché me ne rimasi ferma senza troppe remore, un solo materasso a dividermi da mio cugino e quella che aveva tutta l’aria di essere la sua nuova famosa ragazza. Quella che io avevo creduto per un attimo potesse essere Sharon. Mi sbagliavo, però. Si chiamava Shanti e il suo cognome figurava nei diari di mio bisnonno Charles. Jādūgara era il cognome del clan indiano che aveva utilizzato la Silene Capensis per l’iniziazione di giovani sciamani secoli prima di Charles Carter, il quale era ricorso all’assunzione di quest’erba magica per riavere indietro i suoi sogni e aveva così donato a tutta la sua discendenza grandi poteri di chiaroveggenza. Sapevo che non poteva essere solo un caso di omonimia, quello, e ci pensai tanto intensamente che mio cugino Walter mi lesse la mente senza sforzi. «Non è un caso di omonimia», confermò infatti, liberandomi dei miei atroci dubbi. «Shanti discende dagli stessi Jādūgara dei diari di Charles». «Sono una sciamana», annunciò proprio la diretta interessata, attirando nuovamente tutta la mia attenzione su di sé. «Posso aiutare tuo nonno». Bastò quella semplice frase a scacciare via ogni traccia di titubanza. Se Thomas, Walter e gli altri della famiglia si fidavano di lei, che motivo avevo io di essere diffidente? Le porsi una mano senza farmelo ripetere due volte. «Piacere di conoscerti, Shanti». «Grazie ai suoi poteri curativi», annunciò Thomas all’improvviso, la voce sempre più flebile ogni secondo che passava, «riuscirò a restare in vita quanto basta a prepararti». Non potei far altro che aggrottare le sopracciglia a quell’osservazione: già avevo un brutto presentimento riguardo le parole di mio nonno, ma preferii scacciarlo ed aspettare che si spiegasse meglio. «Prepararmi per cosa?», gli domandai quindi, cercando inutilmente di nascondere tutta la mia improvvisa apprensione. «Per la tua investitura, Harry. È giunto il momento che tu prenda potere sulla famiglia». Avrei dovuto sostituire mio nonno. A quell’improvvisa consapevolezza, l’ennesimo moto di orrore puro mi sconquassò lo stomaco. Mi feci lontana da Thomas di un paio di passi, osservandolo con gli occhi sgranati ricolmi d’incredulità. «Non erano questi i patti. Mi avevi promesso che finché non fossi diventata maggiorenne non avrei dovuto saperne niente di questa storia. Ho appena scoperto di avere questi poteri, non posso guidare un’intera famiglia di chiaroveggenti!». Avevo solo sedici anni. Non si poteva pretendere che così piccola dovessi sobbarcarmi tante responsabilità. «Dovrebbe farlo Walter. È lui il più grande dei cugini». Cercai i suoi occhi ambrati, ben sapendo che lui sarebbe stato più che capace di guidare la famiglia Carter – al contrario mio. Ma Walt non provò nemmeno a tranquillizzarmi. Semplicemente scosse la testa, facendosi lievemente lontano dalla figura di Shanti. «Non posso farlo io, Harry. Bisogna seguire la linea di sangue». Quella secondo la quale al comando della famiglia dovevano esserci solo secondogeniti. Mio bisnonno Charles era stato il primo leader, dopo era toccato a suo figlio Thomas. Mio nonno avrebbe dovuto lasciare il controllo della famiglia a mio padre – il suo secondogenito – ma Philip era scappato dalle sue responsabilità prima ancora che queste potessero divenire realtà. E ora che Thomas stava morendo, toccava a me riparare ai suoi sbagli. «O tu o tuo padre», mormorò Oriesta a quel punto, ed io mi voltai a guardarla velocemente. Quasi mi ero dimenticata della sua presenza e di quella di suo fratello Niall all’interno della stanza. Deglutii. «Philip non accetterà mai». E nemmeno io, pensai, non sapendo se sperare che qualcuno lì dentro leggesse di nuovo la mia mente. Quando avevo saputo tutta la verità sulla codardia di mio padre – grazie alla quale non era stato in grado di prendersi le sue responsabilità come erede della dinastia Carter – avevo giurato a nonno Thomas di essere ben diversa da lui. Gli avevo promesso che non sarei mai scappata come aveva fatto lui anni prima. Che sarei rimasta e avrei accettato fino in fondo i miei poteri e tutto ciò che ne sarebbe derivato. «Tocca a te, bambina», concluse Thomas in un sussurro, e fu in quel momento che capii di come non sarei mai stata in grado di tenere fede alle mie promesse. Perché la verità era che ero molto più simile a mio padre di quanto credessi. La verità era che volevo anch’io scappare dalla mia vita, in quel momento – lo volevo come non mai. La verità era che finalmente riuscivo a capire fin nel profondo Philip Carter e le scelte che fino ad allora avevo tanto criticato. Scelte che, di lì a poco, avrei compiuto anch’io. Una fitta dolorosa al cuoio capelluto mi risvegliò all’improvviso dalla mia trance fitta di pensieri, riportandomi velocemente alla realtà. Sussultai, allontanando la mano di Stiles dai miei capelli e sistemandomi meglio sull’amaca in terrazza che occupavamo in due. Eravamo alle Bahamas, ospiti di una mega-villa che mia sorella Cassandra e quello che ora era ufficialmente suo marito – nonché mio cognato, Jamie – avevano prenotato per la loro luna di miele. Stiles si scusò per avermi tirato inavvertitamente i capelli ed io sentii subito i suoi occhi ambrati bruciarmi la schiena. Si era reso conto perfettamente del fatto che fossi lontana da quel posto da sogno e persa in tutt’altri pensieri e ricordi, tanto che non mancò di farmelo notare. «A che pensi?», mi domandò infatti, e solo al suono della sua voce decisi di distogliere lo sguardo dalle onde del mare che s’infrangevano placidamente sulla battigia della spiaggia privata antistante la villa e mi voltai a cercare il suo viso rilassato. «A mio nonno», mormorai poi. Stiles s’irrigidì solo per un attimo. Ritornò subito in sé e mi accarezzò un braccio in punta di dita, al che non me lo feci ripetere due volte prima di farmi più vicina a lui. Lui che ancora una volta sapeva e capiva tutto. «L’hai più sentito dall’ultima volta che sei andata a trovarlo in ospedale?». Già, le cure miracolose di Shanti Jādūgara erano state utili per poco più di un mese. Poi la situazione era precipitata vistosamente e Thomas aveva avuto bisogno di un ricovero urgente al Beacon Hills Memorial Hospital. Ero stata a trovarlo un paio di volte – anche in compagnia di Stiles – odiando sempre più l’idea di doverlo vedere ridotto in quelle condizioni pietose per colpa di una malattia che sapevo semplicemente non esistesse. Mio nonno stava semplicemente morendo: dopo aver tanto resistito, il suo momento era giunto – ora finalmente capivo le parole di mio cugino Niall. «No», risposi infine a Stiles, di nuovo all’improvviso consapevole di essermi distratta completamente. «ma ho parlato con Natalie. Nonno sta sempre peggio e pare che Shanti non riuscirà a rimandare ancora a lungo l’inevitabile». Mio nonno sarebbe morto. Ed io l’avrei perso dopo così poco dall’averlo conosciuto che– «Cosa ne pensi di lei?». Quella domanda mi distrasse all’improvviso dai miei dolorosi pensieri. Feci spallucce, osservando attentamente gli occhi di Stiles. «Non lo so. La conosco a malapena», esalai. «Però sta aiutando moltissimo mio nonno e non posso far altro che apprezzarlo». Stavo dicendo la verità. Shanti era stata davvero una presenza preziosa, non solo per Thomas ma anche per Walter e noi altri. Ci aveva aiutati tutti, pur non conoscendoci granché. E l’aveva fatto senza – all’apparenza – pretendere nulla in cambio. Cominciavo seriamente a capire perché a mio cugino piacesse così tanto. «Della situazione in generale cosa ne pensi, invece?», domandò ancora Stiles, ed io mi morsi un labbro. Avrei davvero preferito non parlarne, ma sapevo di non poter scappare – non anche allora. Ecco perché mi limitai a tirare fuori nient’altro che la verità. «Non sono pronta. Non lo sarò mai», ammisi in un soffio. Provai ad evitare lo sguardo ambrato di Stiles, ma lui prontamente me lo impedì cercando le mie guance accaldate con entrambe le mani e costringendomi a sostenere il contatto visivo. «Io penso che potresti farcela. Non saresti sola», cercò di consolarmi, piuttosto inutilmente però. Sorrisi comunque, perché come al solito apprezzavo moltissimo i suoi tentativi. «Sappiamo entrambi che non è vero». Stiles trattenne a malapena un sospiro sconfitto, carezzandomi lievemente una guancia. «Che vuoi fare, quindi?». Scappare. Non volevo nient’altro e lo sapevo benissimo, nonostante tutto. Ma non ebbi il coraggio di dirlo a Stiles. Semplicemente lasciai che i miei occhi s’inumidissero di lacrime colpevoli e rifuggii finalmente il suo sguardo. «N-Non lo so», mentii. Sapevo benissimo cosa volevo fare e cosa avrei fatto. E mi sentivo una persona terribile. «Possiamo non pensarci, per ora?». Vidi a malapena Stiles annuire, poi lo sentii darmi ragione. Un’altra delle tante cose che non meritavo – non più. «Scusami», mormorò addirittura, facendomi sentire ancor più ad un passo dal pianto isterico. Spalancò le braccia nella mia direzione ed io non me lo feci ripetere due volte: mi rifugiai contro il suo petto e lo strinsi a me, ben consapevole del fatto che in nessun altro posto al mondo – nemmeno in Texas, dove avevo intenzione di tornare di lì a pochissimo – mi sarei mai sentita tanto sicura ed amata. Ho già cancellato milioni di parole e accartocciato miliardi di fogli scarabocchiati da quando sono scesa qui in spiaggia, ma tu questo non puoi ancora saperlo. Ti ho lasciato in terrazza a dormire tranquillamente, odiandomi per ciò che sento tuttora il disperato bisogno di fare. Sto scrivendo questa lettera a te, Stiles, perché so già che quando ti parlerò più tardi non avrò il coraggio di dirti nemmeno la metà di ciò che vorrei e mi odio per questo. Voglio che tu sappia tutto ciò che c’è da sapere, perché te lo meriti, e se l’unico modo per farlo senza che io perda quel poco di coraggio che m’è stato donato è scrivertelo, allora così sia. Purtroppo ogni parola mi sembra troppo poco. Troppo poco giusta, troppo poco meritevole. Perché è vero, Stiles: non te lo meriti. Non ti meriti nemmeno un quarto di tutto ciò che sto per riversarti addosso. E la cosa peggiore è che non so nemmeno spiegarti bene ciò che sento in questo momento. Non riesco a scriverlo né a dimostrartelo a gesti e la cosa mi uccide, te lo giuro. Mi uccide come mai niente prima d’ora, perché sono ben consapevole del fatto che se non riesco a parlare a te che sei la persona più importante della mia vita, non riuscirò mai più a parlare con nessun altro. E non posso permettermelo, Stiles. Non posso affrontare tutto questo da sola. Perché sono debole. Debole e codarda. Ma voglio smettere e so che l’unico modo per riuscirci è quello di compiere finalmente una scelta e portarla avanti nonostante tutto. Non voglio essere la copia di mio padre, Stiles. Non voglio scappare dalle mie responsabilità come una bambina, non voglio semplicemente lasciarmi vivere senza mai prendere decisioni ed osservando tutto dall’esterno come se nulla mi riguardasse sul serio. Voglio essere parte attiva della vita che mi è stata donata, voglio scendere in campo – sì, ancora – e combattere. Voglio farlo anche se so che soffrirò, anche se so che non farò sempre la scelta giusta. Ma ora come ora cerco di non pensarci. Non posso permettermi di stare peggio di così e spero davvero che tu lo capirai, come spero che capirai tutte le altre cose che probabilmente non sarò mai in grado di spiegarti – né a parole né tantomeno in questa lettera. Non so nemmeno se né quando la leggerai. Non so nulla in questo momento, se non che ti devo delle spiegazioni e devo a mio nonno una scelta. O dentro o fuori. E io ho scelto, Stiles. Ho scelto ancora. Ho scelto di seguirti quella sera di settembre alla Riserva di Beacon Hills, quando ci siamo fatti beccare da tuo padre a curiosare sulla scena di un crimine e Peter Hale ha trasformato Scott nel licantropo buono che è tutt’oggi. Ho scelto di entrare a far parte della tua vita, ho scelto di accettare la mano che mi porgevi pur senza conoscermi e ho scelto di restarti accanto fino all’ultimo. Solo Dio sa quanto vorrei poter continuare a fare quest’ultima scelta senza problemi. Ma non posso, Stiles. Non posso. E per questo come per tutto e niente, ti chiedo scusa. Infinitamente e in ginocchio. Per ogni più piccola cazzata, dalla prima all’ultima che ancora devo compiere a tua insaputa. Ti chiedo scusa ma ne approfitto anche per ringraziarti: per quello che sei e per quello che fai diventare me. Grazie per la fiducia, le risate, i baci – grazie anche per i bisticci, le mille preoccupazioni e tutte le volte in cui avresti semplicemente voluto mandarmi a quel paese ma sei rimasto accanto a me. Grazie, grazie, grazie. Grazie per avermi fatto capire cos’è l’amore. Perché sì, Stiles, ti amo. Sono innamorata di te e avrei voluto dirtelo già da tempo, da prima ancora che Jackson sparisse e noi lasciassimo Beacon Hills per il Natale. Avrei voluto dirtelo ma non ne sono stata in grado. Ecco perché te lo sto scrivendo: scrivere è più semplice – almeno all’apparenza – e so che queste due paroline rimarranno impresse nel tempo sulla carta più che nella mia voce e nelle tue orecchie. Vorrei che tu le rileggessi ogni volta che ne senti il bisogno e soprattutto che non le dimenticassi mai, perché se c’è una cosa vera e sicura della mia vita quella è solo il fatto che ti amo. Sono innamorata di te, Stiles. Ho scelto fin dal primo momento – inconsapevolmente – di innamorarmi di te e questa è probabilmente l’unica cosa che non mi pentirò mai – mai – di aver fatto. Mi pentirò invece di averti lasciato e già lo so, ma non posso fare altrimenti. Non posso restare a Beacon Hills nell’attesa che mio nonno muoia e tutto il resto della mia famiglia cominci a volere da me cose che io non potrò mai dare loro. Semplicemente non posso. Non sono pronta né lo sarò mai, proprio come ti ho detto solo poche ore fa sull’amaca in terrazza – quella sulla quale tu ancora dormi, inconsapevole di quanto male mi agita lo stomaco e mi costringe ad una scelta del genere. Ad un abbandono forzato. Non vorrei mai doverti lasciare, Stiles, e prego perché tu creda a queste parole con tutto te stesso quando le leggerai. Anche se non sarò più accanto a te e mi odierai più di chiunque altro. Vorrei dirti che andrà tutto bene, che ogni cosa tornerà al suo posto come speriamo entrambi e che potremo continuare ad essere felici come lo siamo stati per fin troppo tempo dopo la storia del kanima. Vorrei che fossimo sereni come ce lo meritiamo, ma evidentemente il Destino ha in serbo per noi qualcosa di ben diverso. Vorrei che mio nonno non si fosse mai ammalato, vorrei che potesse restare in vita altri due anni – quanto basta, spero, a fare di me la donna che serve alla famiglia Carter. Quella donna non sono io, Stiles. Perlomeno non ancora. Ecco perché ho deciso di andar via, proprio come da piano originale. L’Intercultura giustifica la mia presenza a Beacon Hills per soli nove mesi e questi sono passati già da un pezzo. È l’ora di tornare a casa, in Texas. È l’ora di scappare. E sai qual è la cosa peggiore? Non sento più sul serio il Texas come casa mia. Perché la mia casa sei tu, Stiles. Ed io ti amo. Ti amo così tanto «Ecco dov’eri finita!». Prima ancora che Stiles potesse finire di parlare scattai in piedi sulla sabbia umida della battigia, nascondendo la lettera dietro la schiena lasciata nuda dal mio bikini. Avevo in viso l’aria più colpevole del mondo e sono certa che Stiles lo capì – proprio come capiva sempre tutto – ma si limitò a distogliere lo sguardo dalle mie mani nascoste dietro la schiena e ritornò a guardarmi negli occhi, riservandomi un sorriso non troppo convinto. Come al solito, non intendeva farmi pressioni. Ed io ero la persona più orribile di sempre. «Cassandra e James vogliono andare a Nassau», esalò, facendomi presente il perché di quella sua visita improvvisa. Credevo che sarebbe rimasto a dormire ancora per molto, cullato dall’aria salmastra di quella favolosa villa sul mare. Ecco perché me n’ero rimasta tranquilla in spiaggia a buttare giù parole che già sapevo mi sarei pentita di aver scritto e pronunciato. Ma avevo deciso di affrontare le situazioni di petto, d’allora in poi, ecco perché presi finalmente coraggio e cercai gli occhi chiari di Stiles. «Ti devo parlare», mormorai, stringendo tra le dita la lettera che ancora non volevo vedesse. «Anch’io», si aggregò Stiles, muovendo un inaspettato passo nella mia direzione. Il mio comportamento aveva smorzato violentemente l’eccitazione che gli vidi riaffiorare sul viso a quella notizia. «Di cosa si tratta?». «È…», cominciai, ma dovetti fermarmi subito. Avevo l’improvviso sospetto che Stiles volesse dirmi qualcosa di davvero importante. Qualcosa che avrebbe potuto cambiare tutto. E volevo che parlasse. «Cosa devi dirmi?». Gliene diedi la possibilità. Ci provai. Ma di nuovo il Destino si mise tra di noi e la nostra felicità. «Può aspettare», liquidò infatti Stiles, e a me ritornò di botto l’immensa voglia di piangere che fino a quel momento ero riuscita chissà come a trattenere. Non avrebbe detto nulla. Non mi avrebbe salvata. «Prima tu». Prima io. Mi toccava. Dovevo parlargli. Ed infine lo feci, torturandomi le mani e l’interno guancia dall’ansia. «Devo tornare in Texas». Stiles non ebbe alcuna reazione. Mi ero aspettata di tutto, da parte sua, tranne quella calma apparente. Semplicemente annuì, osservandomi a lungo prima di uscirsene con un semplicissimo: «Lo so». Aggrottai le sopracciglia. «Lo sai?». Di nuovo, Stiles si limitò ad annuire. «Era anche di questo che volevo parlarti». Mi si seccò all’improvviso la gola. Di cosa voleva parlarmi Stiles? Avrei dato di tutto per poterlo sapere. Ma qualcosa mi trattenne. Perciò mi limitai a deglutire a fondo. «Ah sì?», domandai infine, schiarendomi la gola con un nervosissimo colpo di tosse. «Sì», confermò subito Stiles. Poi mosse un passo verso la mia direzione ed io dovetti trattenere con tutte le mie forze lo sbagliatissimo istinto di farmi lontana da lui. «Sai che non devi per forza andar via, vero?». Oh no. Pensavo di aver capito già benissimo a cosa Stiles stesse puntando. Voleva convincermi a restare a Beacon Hills – con lui – e sapevo che ci sarebbe potuto riuscire senza nemmeno troppi sforzi. Ecco perché feci di tutto per evitare quella scomoda situazione. Non potevo permettergli di cambiare ogni mio piano. «Austin è casa mia», mentii dunque, cercando invano di non far tremolare la voce. «Anche Beacon Hills lo è», mi corresse Stiles subito, ed io mi limitai a scuotere la testa ripetutamente. Ero in piena fase di negazione, ma ritornai immediatamente in me alle successive parole di Stiles. «Io non voglio perderti». Neanch’io, questo avrei voluto dirgli. Invece mi limitai a scoppiare a piangere. «Mi dispiace…», mormorai tra una lacrima e l’altra, piena di vergogna come non mai. «Cosa significa che ti dispiace?», chiese Stiles, con una forte nota di confusione a distorcergli il tono di voce. Ma io non gli risposi, semplicemente continuai a piangere finché lui non mi pregò di smettere. «Non piangere, per favore. Sai che non lo sopporto. Qualunque cosa sia, possiamo risolverla insieme. Come sempre». Di nuovo scossi la testa. No che non potevamo risolvere quella situazione. Nemmeno se fossimo rimasti ancora insieme. «M-Mi dispiace», ripetei dunque, cercando di asciugarmi il viso alla bell’e meglio senza mostrare a Stiles la lettera che ancora nascondevo dietro la schiena. Stiles provò ancora a chiedermi spiegazioni, ma all’improvviso capì di non averne più bisogno. Mi conosceva già bene abbastanza da leggermi tutto in viso ed è proprio ciò che fece in quel momento. Vidi la sua espressione mutare completamente e capii subito che ci fosse arrivato. Che il sentore di tempesta imminente fosse stato captato anche da lui. «Dimmi che è uno scherzo», pregò. Io mi limitai a scuotere la testa. Non era uno scherzo. «Devo andare via». «D’accordo. Posso provare a capirlo», Stiles riparlò dopo interi minuti di silenzio, «Ma con me cosa vuoi fare? Che intenzioni hai?». Mi morsi un labbro nella speranza di riuscire a fermare finalmente le lacrime. Poi scrollai le spalle. Sapevo che Stiles avesse già un’idea ben precisa di quali fossero le mie intenzioni, ma dovevo dirglielo comunque in maniera esplicita. Si meritava una spiegazione. «Non voglio costringerti ad una relazione a distanza. Sai che non ce la faremmo», provai quindi, ma Stiles non apprezzò nemmeno il gesto. Al contrario si animò subito, sgranando gli occhi sulla mia figura e riservandomi l’occhiata peggiore del mondo. Era un misto di incredulità, delusione e disgusto. Non mi aveva mai guardata in quel modo. «Non usare il plurale! Stai decidendo tu per entrambi, non provare a convincermi del fatto che questa cosa dipenda anche da me!», urlò, e mi sentii morire un po’ di più ad ogni nuova parola. Avrei dovuto parlargli ancora e lo sapevo – tentare di fargli capire il mio punto di vista e giustificarmi – ma di nuovo non ci riuscii. Le parole mi rimasero tutte incastrate in gola, proprio come avevo temuto ore prima quando avevo deciso di mettere le mie motivazioni per iscritto. Mi limitai a chiedergli scusa per l’ennesima volta. Ma a Stiles non importava nulla del mio dispiacere, non più. «Che vuoi fare, me lo spieghi? Vai via e mi dimentichi? Tabula rasa, come se non ci fossimo mai conosciuti? Pensi che sia così facile?». Mi mise alla prova, tanto che pensai di essere quasi ad un passo dal cedere. Ma ciò che aggiunse in seguito mi fece velocemente ritornare sui miei passi. «Forse per te lo è davvero. Forse non te n’è mai importato niente di me. Né di mio padre o Scott, Allison, Lydia…». Un’ondata improvvisa di rabbia m’infiammò completamente. No. Assolutamente no. Non gli avrei permesso di dubitare dei miei sentimenti. Mai. «Non osare, Stiles», sibilai quindi, stringendo i pugni dietro la schiena e stropicciando la maledetta lettera che ancora tenevo tra le dita tremanti. «Sai che non è vero». Ma Stiles non credeva più a nessuna delle mie parole. Lo vidi scuotere la testa più volte e realizzai tutto all’improvviso. Quella consapevolezza mi uccise. «Io so solo che stai mettendo fine a questa cosa prima ancora che potesse cominciare. E stai facendo tutto da sola», mormorò, allontanandosi da me ancor di più. «Dio mio. Pensa che figura di merda se non avessi lasciato parlare prima te». Quella sua ultima frase mi colpì all’improvviso, togliendomi del tutto il respiro. Cosa avrebbe dovuto dirmi, Stiles? Temevo di saperlo fin troppo bene. Ma volevo – masochisticamente – averne la conferma. Ecco perché mossi un passo nella sua direzione e provai a raggiungerlo. Allungai una mano verso di lui, ma Stiles la evitò come la peste. Nemmeno rispose al mio richiamo. Semplicemente scappò, con un ultimo e veloce: «Devo andare» che recepii a malapena. Era sparito dalla mia visuale prima ancora che me ne rendessi conto. Rimasi a fissare con occhi pieni di lacrime il posto di fronte a me che aveva occupato Stiles fino ad un momento prima, non curandomi minimamente della fredda brezza marina che mi riempì la pelle scoperta di brividi. Avrei voluto riprendere a piangere e sfogarmi, ma non ci riuscii. Semplicemente mi portai la lettera che avevo nascosto fino a quel momento di fronte agli occhi e l’osservai, rigirandomela a lungo tra le mani. Avrei dovuto completarla e darle un senso, ma sapevo già che non ci sarei riuscita. Ecco perché corsi in casa velocemente, ben decisa a liberarmene finalmente. Recuperai dalla cucina abitabile della villa uno spago e ripiegai la lettera su se stessa, legandola affinché potesse restare così chiusa e celare tutti i miei segreti. A Stiles non avrei lasciato altro che quello, pensai, mentre mi dirigevo verso la camera matrimoniale che avevamo occupato da quand’eravamo giunti alle Bahamas. Individuai subito la valigia di Stiles in un angolo e mi ci avvicinai, ben decisa a nascondere lì la lettera. Speravo che potesse leggerla una volta tornato a Beacon Hills – senza di me. Ma ad un passo dal lasciar andare quel pezzo di carta maledetta, mi ritrovai immobilizzata. C’era un’altra cosa che volevo aggiungere e lo feci senza più pensarci su: recuperai la penna che avevo abbandonato in cucina e scrissi sul retro Mi importerà sempre di te. Le parole più vere che ancora una volta potessi dedicare a Stiles. Solo allora riuscii a liberarmi della lettera. La nascosi sotto un cumulo di vestiti spiegazzati e mi feci lontana dalla sua valigia con un sobbalzo veloce. La crisi di pianto arrivò inaspettata: il respiro mi mancò all’improvviso e il cuore sembrò volere di botto scoppiarmi nel petto. Mi portai le mani alla gola, terrorizzata da ciò che avevo fatto e da chi stavo diventando, scappando da quella stanza ricolma di momenti che non avrei mai più potuto rivivere e mi rifugiai nel bagno del secondo piano, chiudendomi la porta in legno alle spalle con un sonoro tonfo. Poi scoppiai a piangere seriamente. All’inizio mi venne istintivo soffocare i miei gemiti contro i palmi delle mani, come già tante volte avevo fatto per nascondere a tutti la mia smisurata debolezza. Poi realizzai di essere completamente sola in quell’immensa e triste villa e semplicemente mi lasciai andare. Mollai la presa e urlai, scalciai e strepitai. Mi maledissi e piansi, piansi, piansi. Fino a non poterci vedere più e a sentirmi la testa scoppiare. Pensai a tutto e a niente: pensai alle persone che avrei perso e a quant’ero stupida. A quanto poco servisse quella mia crisi di pianto. Non avrei risolto nulla con le mie inutili lacrime, ne sarei semplicemente uscita spossata e distrutta. Ecco perché provai a rialzarmi in piedi. Mi costò immensi sforzi, ma alla fine ci riuscii. Utilizzai il lavandino come appiglio e ritornai stabile sulle mie gambe traballanti, cercando di soffocare i gemiti ed evitando il mio riflesso nello specchio da parete. Ma alla fine cedetti e mi osservai. Vidi sul serio ciò che avevo scelto di diventare. E mentre pregavo di ritrovare una forza che non sapevo nemmeno di aver mai avuto, capii che in vita mia – per quanto credessi stupidamente il contrario – non avevo mai sofferto tanto come in quel momento. You don’t know pain until you’re staring at yourself in the mirror
with tears streaming down your face and you’re begging yourself to just hold on and be strong. That is pain. Continuai a piangere per quelli che mi sembrarono secoli, combattendo inutilmente contro me stessa almeno finché non udii una porta sbattere contro i cardini nel fondo del corridoio. Allora sgranai gli occhi arrossati, balzando in piedi nel centro della stanza. Cassandra, Jamie e Stiles erano finalmente tornati dalla loro piccola gita a Nassau e ne ero all’improvviso più che sicura. Ecco perché fronteggiai velocemente il lavandino, sciacquandomi il viso nella speranza di potermi rendere un minimo presentabile mentre evitavo come la peste il mio riflesso nello specchio. Lavai via ogni lacrima e mi asciugai il viso, poi finalmente misi piede fuori dal dannato bagno, pronta ad affrontare qualunque sfida la vita avesse deciso di lanciarmi allora. Alla fine finii nella camera che io e Stiles avevamo sempre condiviso da quand’eravamo lì alle Bahamas, sentendomi il cuore scoppiare di fronte alla vista di quest’ultimo tutto preso dalla preparazione delle sue valigie. Non ero affatto pronta per quella sfida. Perciò me ne rimasi immobilizzata sulla soglia, accostando la porta senza chiuderla mentre osservavo con gli occhi lucidi Stiles mentre si preparava a lasciarmi. Se anche si fosse reso conto della mia presenza all’interno della stanza, non diede segno della cosa. Continuò invece ad ignorarmi come se niente fosse ed io glielo lasciai fare finché il silenzio nella stanza non cominciò a pesarmi addosso come un insopportabile macigno. Allora mi sentii in dovere di interromperlo. «Ti amo». Non era la cosa migliore da dire e lo sapevo bene. Ma in quel momento non c’era nient’altro che volessi o potessi far sapere a Stiles se non l’assoluta verità. Perché lo amavo – sul serio – e dovevo fare di tutto perché lui sentisse quelle due parole magiche abbandonarmi le labbra almeno una volta. Dubitavo seriamente che avrei avuto occasione di ripetergliele. Avevo parlato per poter finalmente attirare l’attenzione di Stiles e scoprii di aver raggiunto il mio obbiettivo quando lo vidi mollare di scatto un paio di calzini per voltarsi a guardarmi lentamente. Restammo a fissarci – occhi negli occhi – per ore e ore, almeno finché Stiles non mosse diversi passi nella mia direzione, facendomi sobbalzare dall’improvvisa aspettativa che mi colse. Deglutii sonoramente quando me lo ritrovai a soli pochissimi passi dal viso, ma non riuscii a fare nient’altro per tranquillizzarmi perché prima ancora che me ne rendessi conto sul serio Stiles aveva azzerato completamente – e inaspettatamente – quel poco di distanza che ancora ci divideva. Mi strinse il viso tra le mani e le sue labbra corsero subito a cercare le mie, trovandole già dischiuse proprio come se non aspettassi nient’altro che quello da fin troppo tempo. Mi lasciai andare contro ogni logica a quel bacio, chiudendo gli occhi per godermi il momento e Stiles – che non avevo mai visto così – fino in fondo. Sentii le sue mani lasciarmi il viso per attraversare il collo in una carezza fugace prima di posarsi sui fianchi, che strinse quanto bastava a spingermi contro il legno della porta, la quale si richiuse alle nostre spalle con un tonfo che mi fece saltare il cuore in gola all’improvviso ricordo del secondo bacio che ci eravamo scambiati a casa Stilinski, contro la porta della camera di Stiles. Non c’era niente oltre al luogo che rendesse anche solo lontanamente simili quei due baci: il primo era stato cauto e insicuro, quello invece era guidato da un mix letale di odio e amore che avrebbe sicuramente finito per farci male. Più che un bacio sembrava uno scontro, dal quale sapevo per certo nessuno dei due sarebbe uscito vincitore. Ma nonostante tutto, né io né Stiles ci tirammo indietro. Continuammo a combattere, cercando di farci valere l’uno sull’altra con morsi e affondi di lingua fin troppo irruenti. Non osai lamentarmi della cosa: in nessun caso Stiles avrebbe potuto farmi più male di quanto già gliene avessi fatto io con quella nostra rottura forzata. Lo lasciai fare, passandogli le mani tra i capelli già molto più lunghi di quando l’avevo conosciuto quasi un anno prima mentre Stiles artigliava le mani ai miei glutei quanto bastava a farmi perdere contatto con la morbida moquette che rivestiva il pavimento. Di nuovo lo assecondai completamente, rispondendo al suo chiaro invito e allacciandogli le gambe attorno al bacino mentre gli stringevo le braccia attorno al collo. La situazione ci stava chiaramente sfuggendo di mano, ma quella volta non avrei avuto paura. Riuscii a tenere fede alla mia promessa e mi godetti tutto fino in fondo, finché potei. Mi lasciai trasportare sul letto, ri-attirai Stiles su di me quando lui provò per un breve attimo a sfuggirmi e continuai a stringerlo contro il mio corpo, ben sapendo che nei mesi a seguire non avrei avuto più occasione di farlo. Mi lasciai spogliare del misero bikini che ancora indossavo da quella mattina e mi occupai in prima persona di fare altrettanto col costume ancora un po’ umido di Stiles. Gli permisi di entrarmi dentro e prendermi, non solo in senso fisico. Gli donai una gran parte di me stessa ancora una volta, ben sapendo che mai e poi mai avrei potuto pentirmi di quel gesto avventato. Sapevo però che mi avrebbe fatta soffrire e ne ebbi la dolorosa conferma nel momento in cui tutto finì – per sempre – e Stiles non ci pensò su due volte a lasciarmi sola, nuda e ansimante al centro del letto. Lo osservai con occhi nuovamente pieni di lacrime mentre si rivestiva velocemente, finendo poi a riordinare delle ultime cose nella sua valigia prima che la chiudesse e la trascinasse giù lungo il pavimento fino alla porta. Si era preso la sua vendetta e l’aveva fatto nel modo più atroce possibile. «Se davvero mi amassi», pronunciò prima di sparire definitivamente dalla mia vita, la mano stretta sulla maniglia d’ottone e lo sguardo ben lontano da me, «non mi lasceresti mai andare». Cosa che io feci. Anche se lo amavo, ancor più della mia stessa vita. Stiles si chiuse la porta alle spalle con un tonfo ed io aspettai di sentir svanire il rumore del trolley sul pavimento della villa prima di scoppiare a piangere come se il mondo mi fosse all’improvviso caduto addosso senza che avessi la minima opportunità di spostarmi un po’ più in là. Era proprio così che mi sentivo. Ma per quanto dannatamente doloroso fosse, sapevo di aver fatto la cosa giusta. È proprio perché ti amo che ti sto lasciando andare, Stiles. I could be your perfect disaster,
you could be my ever after. Ringraziamenti A gilraen_white e Axelle_, che ci sono state fin dall’inizio. A chiunque mi abbia seguita in quest’ennesima avventura pur restandosene – ahimè – in silenzio. A chi mi ha scoperta quest’anno e ha aggiunto kaleidoscope ai preferiti e alle seguite/ricordate. A chi non è più tornato. A me, che sto portando avanti un progetto che credevo non sarei mai stata in grado nemmeno di abbozzare. kaleidoscope non ha avuto gli stessi bei risultati di parachute, ma io ne sono orgogliosa comunque. Ho fatto davvero del mio meglio per questo sequel e penso che sia solo questa l’unica cosa davvero importante. A prescindere dal numero di recensioni/seguiti/preferiti/ricordate, ciò che conta è che la storia piaccia a me e che io mi senta bene riguardo a come l’ho gestita. Ed è proprio così che mi sento #sorrynotsorry. Note Per chi non l’avesse capito, la prima scena è un flashback. Harry, mentre è alle Bahamas con Stiles – Cassandra e suo cognato, rivive uno degli ultimi terribili incontri con suo nonno Thomas e Shanti. Shanti che finalmente è entrata in gioco (per mia grande gioia) e che spero possa piacervi. Agli occhi di Harriet – ma anche ai vostri, ne sono sicura – questo nuovo personaggio è ancora avvolto da parecchio fumo, ma tranquilli: in storm scoprirete tutto ciò che c’è da sapere su di lei e la vedrete parecchio. :) Nel frattempo vi basti sapere che è della sua famiglia che si parla nei diari di Charles, quelli che vi ho riportato anche ad inizio capitolo. Che gli indiani comparissero era una cosa che pianificavo di fare fin dall’inizio e sono davvero contenta di esserci riuscita. Come al solito, per qualsiasi dubbio assillatemi pure! u.u La lettera è un chiaro riferimento a parachute (l’ennesimo). Ormai è tradizione concludere le storie con Harry che scrive qualcosa e spero che vi sia piaciuto quest’altro parallel. Ce n’è un altro nell’ultima scena e chi ha letto parachute probabilmente l’avrà notato: in ogni caso, potete capirlo leggendo il capitolo 19. PER FAVORE, cercate di non massacrare Harriet. :( ATTENZIONE Per motivi di rating non mi sono potuta spingere troppo in là con le descrizioni della prima volta degli Starriet – i miei bambini, omg – ma se v'interessa leggere qualcosina di più potete andare qui: Everything that kills me makes me feel alive. Non vi aspettate chissà che, comunque, perché non sono brava a scrivere roba rossa. Sob. THE END |