La stirpe di Agena
(/viewuser.php?uid=27691)
Lista capitoli:
Capitolo 1: *** Orbita di Alcor, 27° di Veldor - 23/10/2289 ***
Capitolo 2: *** Orbita di Achernar, 30° di Veldor - 23/10/2289 ***
Capitolo 3: *** Provincia di Mira, 5° di Veldor - 23/10/2289 ***
Capitolo 4: *** Spazioporto di Haumea, 1° di Solaria - 24/10/2289 ***
Capitolo 5: *** Periferia di Saturno, 8° di Solaria - 24/10/2289 ***
Capitolo 6: *** Orbita di Gaia, 11° di Solaria - 24/10/2289 ***
Capitolo 1
*** Orbita di Alcor, 27° di Veldor - 23/10/2289 ***
 La stirpe di Agena
 Is this the morning we've been waitin for
You think you're walkin through a shinin door You wait for nothin and it never comes At least you know you're not the only one Questa è la mattina che noi stavamo aspettando Tu pensi che stiamo camminando attraverso una porta luccicante Tu aspetti il nulla e questo non arriva mai Almeno sai che non sei l'unica (Every Day, Planet Funk)  Orbita di Alcor, 27° di Veldor,
23/10/2289 Dire che non mi ero mai resa conto del potenziale che un singolo essere umano più sviluppare sminuirebbe la mia intelligenza, sopratutto se aggiungessi che me ne resi conto dopo ben tre anni dal mio arruolamento. Eppure è così, e vergognarsene non cambia la realtà dei fatti. La verità è che, forse, non mi piace ricordare quel periodo, la persona che ero: pensare a quanto fossi ingenua e fiduciosa mi fa male all’anima, e di dolore ne ho patito troppo. No, grazie. Mi piacerebbe molto più ricordare il presente. Gli anni della gloria. Gli anni felici. Dovrei andare con ordine, lo so: seguire il metronomo del tempo dal principio alla fine, finché tutto non vi sarà così chiaro che vorrete smettere di ascoltare. Che vorrete non aver mai saputo. Ma il cuore batte forte, troppo... Come ho fatto a non sentirlo mai? No. Con ordine, dicevo. E la prima cosa che devo mettere in chiaro è il perché. Il motivo di questo racconto. Una volta un ragazzo mi disse che un segreto è pericoloso solo finché rimane tale, che il mistero è la sua unica forza. Me lo disse mente nel cielo le onde elettriche delle navi degli invasori squarciavano l’aria della notte come se fosse fatta di metallo sottile. E mentre lo diceva la sua mano accarezzava il mio collo e scendeva, lenta e tiepida, fino al seno. Non abbiamo fatto l’amore, quella notte, e credetemi se vi dico che è il mio rimpianto più grande. Vi sembra strano che, con la prospettiva della morte così vicina, due giovani potessero pensare di darsi piacere a vicenda? Siatene felici. Vuol dire che non avete mai vissuto con la paura costante che una forza oscura e lontana calasse su di voi e vi sottraesse la vita. Siete i figli puri di questo mondo nuovo e pacifico, e qualcosa in me vi invidia tanto da darmi altra vergogna. A quel tempo le note metalliche delle navi spaziali che squarciavano l’aria erano un suono tanto normale quanto il canto di un uccello. Ne eravamo abituati, e dovevamo esserlo. Avete idea di quanti sono stati i morti suicidi all’inizio della guerra? I molti, quelli per cui quel suono era un peso del cuore e della mente, perirono di loro mano nei primi venti anni di conflitto. Furono i più deboli, i più audaci: scelsero di non lottare e, così facendo, non dovettero scegliere. Ironico, non è vero? Com’era quel vecchio adagio? “Pochi ridono, pochi piangono, la maggior parte sta zitta1”. Ecco, solo i pochi rimasero – quelli che avevano troppa paura o che sentivano di non poter subire più nient’altro. Noi eravamo i secondi: non avevamo niente da perdere perché tutto quello che ci era rimasto era in quella stanza, stretto fra le nostre braccia. Quando vivi nel costante terrore che un’arma nucleare spazzi via il mondo che conosci, il pensiero di una morte romantica non è poi tanto amaro. Io lo trovavo dolce, in effetti. Ma io avevo lavorato per sette anni in un’ospedale da campo, dove avevo visto morire da soli tanti ragazzi più giovani di me, e sapevo bene di cosa parlavo quando dicevo che non volevo andarmene da sola. Divago. È ancora non vi ho detto niente, niente di me. Mi chiamo Taissa e sono un soldato. Lo ero, perlomeno. Dicono che della divisa non ci si liberi mai davvero, che quel senso di cameratismo e unione ti resti attaccato alla pelle come la puzza dell’aglio, per giorni. Non so se è vero, ma di certo io non ho mai trovato una sicurezza maggiore di quella che avevo fra i miei commilitoni. Mai, neppure fra le braccia di Alexei. Lo incontrai all’ospedale militare, dopo poco meno di sedici mesi da quando avevo iniziato a prestare servizio come volontaria. Arrivò nel modo che avrei imparato a distinguere come suo: giacca sulle spalle, camicia bianca appena slacciata e i capelli neri e lunghi spostati su un lato, come se fosse appena uscito da una doccia – tutto il contrario di quel che mi sarei aspettata da un ufficiale. Scortava quelli che, di lì a mezz’ora, sarebbero stati i cadaveri dei suoi secondi, ma sorrideva. Lo faceva sempre quando era in uniforme. Una parte di me – la parte romantica e ingenua – ancora vuole pensare che fosse stato proprio il suo sorriso a conquistarmi, ma so che furono l’uniforme e gli occhi. La manica vuota della giacca e il blu chiaro e irridente, per la precisione. A quel tempo io avevo già perso il braccio sinistro. Mi davo da fare con quel che mi era rimasto, ma la mia mano dominante era rimasta sotto le pareti della nave-laboratorio, assieme all’ultimo dito della destra e alla mia storia. Ripensando al mio braccio, credo che perderlo sia stato un colpo di fortuna. Non avrei potuto vivere la mia seconda vita – la vita umana – con i marchi della mia diversità sotto gli occhi di tutti. Vedete, ora gli interventi di bioingegneria sono routine, la base della chirurgia estetica; allora erano riservati ai ricchi e al personale militare della genia Hadar2. Io non avevo soldi – la mia famiglia, già modesta, aveva perso tutto quando ero bambina, nell’attacco che aveva distrutto la nostra colonia e i miei genitori, lasciandomi a crescere con mio nonno fra le macerie di una città fiorente – ma ero un militare, e a noi era fatto obbligo di essere al massimo della forma fisica. Potevamo solo scegliere cosa potenziare. Io ero un membro del Genio, il corpo militare addetto alle armi d’assedio: lavoravo come ingegnere meccanico in un battaglione di trecento anime, uno dei più piccoli ed efficienti. Ricordo che possedevo una bella uniforme blu, da Capitano, che non avevo mai smesso d’indossare da quando avevo ricevuto i gradi; e, come tutte le divise formali degli Ufficiali, alla vita aveva una cintura e una spada, di taglio classico e tanto più pesante quanto maggiore era l’importanza di chi la possedeva. Ovviamente, nessuno la usava: il metallo allora era un bene raro e, comunque, pensare di combattere con un’arma primitiva come la spada era ridicolo per i più. Io non l’ho mai pensata così: se possiedi qualcosa, mi dicevo, devi saperla usare. Tutto, nella mia vita, ha da sempre dovuto avere un senso. Avevo cominciato a prendere lezioni di scherma e avevo scoperto, con piacere, che le sessioni in palestra mi distendevano, aiutandomi a pensare. Perciò, quando vennero da me chiedendomi quale fosse il potenziamento che desideravo, chiesi un intervento a testa e braccio. Il cervello, perché più sinapsi voleva dire più trasmissione di dati, e il braccio sinistro, quello con cui impugnavo le armi. Assecondando una necessità di allora che adesso è diventata una moda, avevano tatuato sulla mia pelle le direzioni che avevano preso gli impianti, per poterne fare regolare manutenzione. Capite ora? Capite perché era un tormento e una fortuna aver perso proprio quel braccio? Non so quanti di voi abbiano mai visto un essere umano puro. Sono una razza in via d’estinzione, ormai: una genia schiacciata dalla loro stessa capacità di adattamento. Loro sono diversi da noi, anche se non sembra: tanto per cominciare, soccombono ai veleni e non riescono a vedere al buio. Il loro cuore batte dalla parte sbagliata del petto, a sinistra, e hanno cinque dita invece che sei. Poi, non hanno mai imparato a potenziare il loro corpo: la loro dipendenza da polimeri inorganici e metalli li aveva resi troppo ottusi per capire le potenzialità dei composti plastici biologici. Non tatuavano il loro corpo da secoli, ormai: ogni linea sulla pelle era una condanna a morte e una vergogna, perché gli ricordava noi. Gli esseri alieni a loro così simili che avevano osato sfidare Gaia. Potevo celare sotto i capelli neri i segni sulla testa, ma non avrei mai potuto tenere nascosti gli impianti grigiastri che dalla spalla arrivavano alla punta delle dita. Dita... Già. Quello più piccolo della mano destra ho dovuto tagliarlo io per riuscire a sopravvivere. Per passare inosservata. L’ho già detto che sarei andata con ordine, vero? Dovete perdonarmi, ma è difficile. La nave su cui viaggio compie balzi nell’iperspazio con la frequenza di uno ogni trentotto minuti-standard, e io non sono più tanto giovane. Non che abbia mai sopportato bene i salti – in effetti mi hanno sempre dato i capogiri e una tremenda nausea. Immagino che saprete capire la mia confusione e mi scuserete, perché è l’unica cosa che potete fare se volete sapere la verità su di noi. Anche il giorno dell’incidente stavo male. Avevo appena concluso il terzo dei miei viaggio quotidiani alla nave madre, ancorata a qualcosa come trenta anni-luce da Gaia, una distanza che già sembrava ridicolmente prudente. Il balzo dalla stazione di ancoraggio all’ammiraglia era una routine che dovevo compiere: la nostra missione primaria era quella di raccogliere campioni per stabilire se il giacimento che avevamo trovato era ricco di materiale radioattivo, indispensabile per completare le armi e, di conseguenza, l’assedio. Ci serviva anche del rame, ovviamente, ma quelle miniere erano sorvegliate ancora troppo strettamente. Stavo male, e non solo per il viaggio – anche se, lo ammetto, quello non aveva aiutato granché. Non ero la sola, ma ancora credevamo che la tosse e il malumore fossero una conseguenza della polvere sabbiosa nell’aria. Noi non abbiamo deserti su Agena, e io non posso spiegarvi cosa voglia dire non riuscire a respirare per il pulviscolo e l’aria cocente: non capireste, come non capivamo noi allora. Fu la mia debolezza a salvarmi. Stavo così male, quel giorno, che corsi nella nave-laboratorio e mi sedetti, aspettando che il Drez passasse in infusione. Era l’unica bevanda che rescisse a darmi sollievo: un rimedio rurale a cui mio nonno mi aveva indottrinata quando ero ancora una bambina. La trivella esplose mentre sollevavo la ciotola bollente, trasformando in polvere del deserto la mia intera squadra in poco meno di due secondi terrestri. La nave-laboratorio, una capsula ovoidale di trecento quintali di peso, venne scagliata in aria come una palla e ricadde su sé stessa, accartocciandosi e fondendosi nel tessuto molle che è alla base della Cjera. Venni scagliata contro un muro e mi ustionai una gamba, poi l’urto mi fece ricadere addosso lastre taglienti di silicati proteici, affilate come lame. Gridai, e il mio lamento era quello della struttura che si disintegrava e mi inghiottiva, portandomi con sé. Avete mai provato dolore? Io ne patì talmente tanto, quel giorno, che credevo di esserne diventata immune. Il cuore batteva come se volesse spaccare le costole e lacerarmi il petto per fuggire da quell’orrore, da quello strazio. Poi il cervello si arrese, e con un sibilo assordante la mia coscienza cadde nel nulla, lasciandomi in balia del destino. Quando mi svegliai, il calore del deserto e i microrganismi di Gaia avevano gia iniziato a trasformare i resti della capsula in rocce bianche e spolpate, che la sabbia avrebbe presto nascosto. Nessun segno del nostro passaggio sarebbe rimasto, così come volevamo. Perché avremmo usato quel materiale, altrimenti? Io non stavo bene: la ferita al braccio era stata cauterizzata dalla Cjera incandescente, ma nuove ustioni erano sorte mentre ero priva di sensi. Sapevo che non sarei potuta rimanere li. La nave-madre doveva aver ricevuto comunicazione dell’incidente quasi immediatamente dopo che si era verificato: non avrebbero mandato navi di soccorso, perché con un disastro di tali proporzioni non ci sarebbe stato niente da recuperare. Perfino io lo sapevo. Ma i figli di Gaia... loro avrebbero sentito e sarebbero accorsi. E se mi avessero trovata... Correvano voci sulla mania dei terrestri di sezionare tutto quello che arrivava dallo spazio. Io ero disarmata e sola, adesso, ma dopo essere sopravvissuta per puro miracolo non volevo finire su un tavolo operatorio, aperta ed esposta come una rana per il loro divertimento. Ero addestrata. La lingua è la maggiore barriera, sapete? La prima cosa che avevo fatto, dopo l’impianto al cervello, era stata mandare a mente i principali dialetti di Gaia. Potevo far credere loro di essere una terrestre, se solo avessi eliminato le differenze che correvano tra noi. La decisione di tagliare il sesto dito richiese solo un attimo: il tempo di guardarmi intorno e cercare un pezzo di Cjera abbastanza affilato e uno ancora caldo. Poi premetti con forza e seppellì quella parte della me Hadar sotto la sabbia, scavando come un animale. Cauterizzai la ferita il prima possibile, ma già sentivo di essere andata oltre. Poggiai tutto l’avambraccio sulla lastra calda, sapendo che il segno sarebbe stato cancellato completamente solo se l’intera area fosse sembrata tutta danneggiata dall’attacco. Che era l’unico modo perché la mia storia fosse coerente. Quindi iniziai a camminare verso il sole al tramonto. Mi trovarono a notte fonda, con le labbra secche e gli occhi sporchi. Parlarono in una lingua veloce e dura, un idioma impastato del gelo che li aveva creati. Io risposi nella lingua del deserto, sapendo che non si sarebbero aspettati altrimenti dai miei occhi allungati e verdi o dalla mia pelle olivastra per il sole. Viaggiai per quasi tre ore su un veicolo metallico di terra, pregando l’universo che non cercassero di controllarmi il cuore o la testa. Provai a parlare in quella stentata maniera che gli stranieri dovrebbero avere, ma quella gente non mi volle ascoltare. Non si fidavano, e potevo capirli. Scorsi la città da lontano, ma finsi di non riuscire a vederla: era un’ombra scura nella notte, silenziosa e pronta a inghiottirmi. I suoi palazzi, che un tempo sfidavano l’universo da altezze vertiginose, ora erano rovine al suolo, cumuli di roccia strana e lamine contorte. La trovai bellissima sin dal primo istante, come un’opera d’arte grezza e visionaria. E così reale da spaventarmi. All’ingresso le guardie ci fermarono e mi chiesero le generalità. Dissi che ero Taissa Shaaren, in fuga verso il nord con la mia famiglia. Dissi che avevamo incontrato un’avanguardia aliena e che ci avevano massacrati. Piansi, perfino, tanta era la paura che non credessero alla mia storia. Mi portarono in un edificio e mi puntarono il fucile alla testa, intimandomi di spogliarmi. Controllarono il mio corpo e io mi resi conto immediatamente che sarei stata salva perché, quando mi liberai dei resti della tuta da lavoro, ormai irriconoscibile, vidi sul volto dell’uomo al comando l’espressione della pietà. Fece il suo dovere, ma fu un esame sbrigativo e a suo modo dolce. Stampò un lasciapassare e me lo consegnò con mano tremante, intimando agli uomini di portarmi da un medico. Scoprii allora quanto sopravvalutavamo i terrestri. I loro ospedali, pieni da scoppiare e sporchi, offrivano il minimo delle cure possibili a chi era in grado di alzarsi e parlare. Due uomini disinfettarono le ferite alla spalla sinistra e bendarono tutti i tagli, dicendomi di liberare il letto entro un’ora. Da lì fui per strada, nell’oscurità amica che tanto mi ricordava Agena. Sentivo le pupille dilatarsi, alla famelica ricerca degli arbusti luminescenti del Drez, e la mano fantasma scivolare al fianco sinistro, dove fino a quel momento aveva giaciuto la spada. Nessuna delle due trovò l’altra: quelle due vecchie amiche riposavano nel deserto, ora. Contrassi dita che non avevo e mi spinsi oltre, pensando a cosa avrei fatto. Ero addestrata, ve l’ho detto, e come tutti i soldati di stanza ai pianeti assediati avevo delle direttive per situazioni del genere. Ora il mio scopo sarebbe stato sopravvivere e raccogliere informazioni, nell’attesa di una buona occasione per fare rapporto. Salto la parte dell’adattamento: è noiosa e non è quello che avete bisogno di sapere. Il potere di rigenerazione rapida tipico della mia genia mi fece recuperare le forze in fretta e fu un bene, perché adattarsi fu più difficile di quanto avessi immaginato. Sopravvissi con ogni metodo che mi fu possibile e cercai per anni di infiltrarmi nell’esercito, senza riuscirci. A cosa poteva servire un soldato menomato? Passai al freddo più inverni di quelli che avrei voluto, cercando invano prima un lavoro e poi la forza di farmi toccare per soldi. C’erano giorni in cui avrei potuto vendere la mia stessa anima per del cibo, ma non riuscivo a commerciare il mio corpo; in parte perché i figli di Gaia mi ripugnavano – la loro pelle sembrava voler rimanere sporca e maleodorante nonostante la cura che, almeno alcuni, avevano – in parte perché non volevo farmi vedere com’ero. Ogni volta che un maschio mi si avvicinava – e avveniva anche troppo spesso, data la mia menomazione – il braccio fantasma si contraeva, annaspando in cerca dell’arma, di quella sublime, perfetta eleganza e della calma che il mio corpo sapeva trovare solo quando mi allenavo. O quando lavoravo. Alla fine del mio terzo anno su Gaia i miei attaccarono. Fu una ricognizione rapida e pulita, pienamente nel nostro stile: tre navi leggere apparvero per un istante in cielo, calando sulla città umana onde di luce ustionanti. Bruciarono vivi almeno quattrocento terrestri e due quartieri prima che gli scudi di difesa potessero intercettare le armi e rimandarle indietro, senza successo. Le navi erano scomparse. Agena aveva già avuto tutti i dati che le servivano. Io mi trovavo vicino alla zona dell’attacco. Con lo stridore delle sirene che ancora mi assordava e il sogno di casa nell’anima, corsi a vedere. Non trovai alcun Hadar, ma inciampai su Ivan. Lo ricordo come se fosse ieri, perché fu quel ragazzo a segnare indelebilmente il mio futuro. Durante l’attacco Ivan si trovava nella sua macchina, stracarica di materiale elettrico: l’onda d’urto delle armi aveva innescato un singolare processo, attivando simultaneamente tutti i conduttori che trasportava. La scossa elettrica, veloce e ad alta frequenza, aveva bloccato i circuiti dell’auto e folgorato Ivan. Io lo trovai attaccato al volante, con le mani ancora contratte e il respiro intermittente. Avrei dovuto abbandonarlo lì e continuare la mia ricerca. Aveva l’età per essere un soldato – anzi, probabilmente già lo era, dato il materiale che trasportava – e un nemico, ma gli occhi! Gli occhi erano marroni e carichi di quella paura che non ha genia. Non sono mai stata di cuore duro – nessuno che abbia davvero perso tutto lo è, ne sono convinta. E nel caos nessuno si domandò come una ragazza senza un braccio avesse potuto trasportare un ragazzo più alto di lei per due chilometri, o perché non mostrassi segni di stanchezza. Nell’ospedale c’era il finimondo. Ricordo che qualcuno mi chiese di dare una mano, e poi il sangue troppo rosso di una donna che mi scorreva caldo fra le dita. La faccia contratta di una bambina. Il lamento di un ragazzo che mi chiese di poter affondare la faccia nel mio seno, perché non voleva morire senza sapere che sapore avesse una donna. Entrai nell’ospedale con Ivan e non ne uscì. Rimasi finché quelli che avevano bisogno di me non furono dimessi o morti – e poi ne arrivarono altri, e io chiusi gli occhi e pregai Agena di perdonarmi del piccolo tradimento che compivo. Ma non riuscivo, oh, non ero in grado di lasciare che tutto questo succedesse. Non ero mai scesa in guerra. Io riparavo macchine e costruivo accampamenti, per l’Universo! Non avevo mai, mai visto qualcuno morire. Rimasi nell’ospedale. Pian piano, dagli impianti d’assedio Hadar passai agli umani, e scoprii che fra un essere vivente e una macchina non correva poi molta differenza – solo, noi eravamo fatti di caldi ingranaggi organici e le nostre creature di tiepido biomateriale. Ed eccoci ad Alexei, di nuovo. Finalmente. Mi manca così tanto che, certe volte, mi sembra che potrebbe scoppiarmi il cuore. Ne sento l’assenza ancora, pesante come se gli avessi detto addio ieri. Ottant’anni: nemmeno io, nella mia più fulgida innocenza, avrei mai pensato che l’amore potesse durare così a lungo. Che potesse far male per così tanto tempo. Avevo rinunciato all’idea di infiltrarmi e stavo venendo a patti con la possibilità di dover vivere la mia vita così, aiutando le creature che avrei dovuto combattere – non potete non vedere la poesia, la dolce ironia in tutto questo! – quando arrivò Alexei. Un segno dell’universo. La prima conversazione che avemmo riguardava i suoi sottoposti. Gli dissi che non eravamo stati in grado di salvarli e lui scrollò le spalle e sorrise, spostandosi i capelli sul lato sinistro del volto – poi allungò il braccio destro e afferrò il mio, trattenendomi. «Che hai fatto all’altro?» mi chiese, stringendo il polso come a sottolineare il soggetto. «Alieni» risposi semplicemente, sapendo che non sarebbe servito altro. «Lasciami!» «Non volevo offenderti» disse Alexei, e sollevò la mano in un gesto di scuse. La giacca scivolò indietro e io potei vedere il segno rosso e irregolare dell’amputazione, poco sotto all’ascella. Lui sorrise di nuovo e scrollò la spalla sinistra, lasciando che la giacca mostrasse il moncherino. «Pensavi di essere l’unica? La guerra ha toccato tutti noi in maniere molto simili.» Non gli risposi. La mia pelle bruciava dove l’aveva toccata, come se il contatto con lui fosse stato urticante. Avevo voglia di lavarmi, sciacquare via il sangue dei soldati e il calore della pelle dell’umano come facevo a ogni istante libero, ma non potevo. Lui si alzò, avvicinandosi mentre sollevava la giacca con un gesto esperto che sottolineava l’abitudine alla sua menomazione. Io bramavo a mio modo riparo: lo spettro della me Hadar contraeva le mani, cercando l’arma che avrebbe tolto di mezzo quel fastidio, liberandomi dalla necessità di doverlo ancora assecondare. E forse avrei anche potuto avere la meglio con la destra, se avessi provato: se c’era una nota positiva nella mia permanenza su Gaia era che avevo dovuto imparare a usare il mio braccio debole. Non feci nulla, in realtà. Rimasi immobile mentre Alexei mi si avvicinava e slacciava il nodo al collo della mia divisa blu da medico, lasciando che osservasse le cicatrici da ustione che correvano dalla scapola fino a quel che restava della spalla. Tremai quando le sue dita sfiorarono la mia pelle, e lui se ne accorse. «Che spreco. Dovevi essere stata una vera bellezza, prima» commentò, lasciando andare il bavero della maglia. «Non preoccuparti, non ti toccherò più. Ora siamo pari.» E se ne andò. Senza una parola, senza voltarsi indietro una volta. Io rimasi ad osservarlo, odiandomi: ero troppo intelligente per non rendermi conto di aver appena sprecato l’occasione che rincorrevo dal giorno in cui avevo messo piede a Taraz3. Potrei descrivere ogni parola, ogni gesto, ogni più piccola esitazione: la mia mente potenziata ricorda tutto con una chiarezza disarmante e graffiante. Ricordo la temperatura dell’acqua quando corsi nei bagni, a sciacquare viso e collo – calda da bruciare – e le volute di vapore dietro le quali nascondevo la mia debolezza, per non doverla osservare allo specchio. Avrei voluto gridare, tanta era la frustrazione. Mi imposi la calma. Respirai, cercando di ragionare, di rimediare al mio errore – e poi seguii a ritroso la chiazza rossa che si allargava con il calore e mi allontanai di scatto, amareggiata da tutto in quel pianeta dimenticato dall’Universo – me compresa. Sentivo il bisogno di qualcosa di antico, di mio. Cercai la spada e sentii in bocca il sapore del Drez, aromatico e carico proprio come quello che bevevo da piccola. Chiusi gli occhi per trovare il buio familiare del mio pianeta natale, e assaporai per un lungo istante l’illusione che tutto questo non fosse mai accaduto, che fossi ancora una bambina innocente e integra, lontana da tutto il dolore della guerra. Poi aprii gli occhi e mi ritrovai davanti ad uno specchio senza condensa, sul quale la mia immagine si rifletteva sempre più nitida e chiara, sempre più desolante. Non ero altro che un essere a metà. Tre settimane dopo Alexei tornò. Si presentò da solo e piombò nella camerata dell’ospedale come se fosse suo diritto stare lì. Ricordo che mi afferrò per l’avambraccio e prese a trascinarmi via dalla ragazza che stavo assistendo, senza alcun riguardo per me o per lei. Forse si aspettava che lo seguissi docilmente, o magari era solo abituato a trattare tutti come suoi sottoposti, non so; fatto sta che io piantai le gambe e feci resistenza, strattonandolo anche col braccio. Lui si bloccò e ruotò appena su sé stesso, l’espressione del volto che passava dal sorriso strafottente alla sorpresa e poi, per appena un secondo, alla collera. Io ne approfittai per far scivolare via il braccio dalla sua presa e presi a massaggiarmelo, più infastidita che ferita. «Se mi tocchi ancora ti amputo anche l’altro, da sveglio. È una promessa» gli dissi. E l’avrei fatto: mi spostavo di un passo alla volta verso il carrello con gli attrezzi, ben attenta a non perderlo di vista. «Siamo d’accordo. Volevo solo darti questo» Alexei mi allungò una tessera metallica. «È una memoria. Va in un pc» precisò poi, in risposta al mio sguardo interrogativo. «Ti sembra che questo posto possa anche solo pensare di permettersi un computer?» gli feci notare, indicando la camerata spartana attorno a noi. «Merda» il suo sorriso si allargò ancora, mentre stazionava su di me senza nessun vero disappunto. Sollevò la mano e fece un cenno verso la porta, invitando qualcuno ad avvicinarsi. «Aspetta qui» ordinò passandomi accanto. Io mi girai solo per vederlo parlottare con Dima, il medico alle cui dipendenze lavoravo. Mezz’ora dopo ero seduta su una macchina, accanto ad Alexei, diretta alla base militare di Taraz.  1 https://it.m.wikiquote.org/wiki/Robert_Oppenheimer
2 Hadar, altro nome di Agena, una stella; il significato è “la terra stabile”. Tenetelo a mente! 3 Città del Kazakistan (scelta col nobile criterio del dito puntato a caso sulla parte di mondo che mi interessava)  Piccolo spazio-me: due parole veloci, in realtà, dato che il commento che vorrei fare è infestato da spoiler (lo leggerete all'ultimo capitolo, qui di vedete di arrivarci :D).
Innanzitutto, il link al contest > per chi volesse dare un'occhiata al pacchetto da cui è nata la storia (Spoiler!) Poi, i credits: Zephyrhant & Las-t (amo questi artisti *_* passate a rifarvi gli occhi) Fatemi sapere che ne pensate della storia: ci tengo! |
Capitolo 2
*** Orbita di Achernar, 30° di Veldor - 23/10/2289 ***
 La stirpe di Agena
  Just when I'm thinkin it was always you Just when I'm thinkin it was always youThe sun has gone and let the rain come through The things I'm hearin I've already heard But now I'm walkin in a different world Proprio quando sto pensando che eri sempre tu Il sole se n'è andato e ha lasciato spazio alla pioggia Le cose che sto sentendo sono cose che ho già sentito Ma ora sto camminando in un mondo diverso (Every Day, Planet Funk) Orbita di Achernar, 30° di Veldor,
23/10/2289 Salti, di nuovo.
Quanto potrò ancora sopportare questo viaggio? Periferia di Achernar, 30° di Veldor, 23/10/2289 Dov’ero rimasta? Ah, già. La base militare. Cosa posso dirvi di quel posto? Tranne che per il filo spinato e gli scudi mimetici piantati su strutture metalliche, era terribilmente simile a una delle nostre. Immagino che i luoghi in cui riposa la guerra siano tutti fratelli: file spartane di casermoni tutti ugualmente fragili, facili da sostituire. La sensazione di attesa, il respiro trattenuto di un luogo temporaneo sull’orlo dell’abbandono e l’odio - non va scordato! Odio per gli edifici, per ciò che avviene dentro e fuori – erano le stesse che avevo respirato su Agena, prima. Così familiare. Alexei mi fece scivolare attraverso i luoghi che per tanto tempo erano stati il mio solo scopo con una facilità tale che, se avessi potuto, avrei riso per la gioia. Il mio cervello potenziato registrava, interamente concentrato su ogni minimo particolare che avrei potuto usare a nostro vantaggio. “Nostro”... Era bastato mettere piede in un luogo di guerra per far riemergere la me Hadar. Il soldato. Individuai il centro di comando in meno di un minuto e vidi che non era quello il nostro obiettivo. Il mezzo meccanico sul quale viaggiavo compì una lunga curva, mantenendosi lungo il perimetro esterno, costeggiando la recinzione verso la zona di riposo degli ufficiali di grado superiore. Una fila di edifici bassi, in muratura, apparve pian piano fra le costruzioni in cartongesso e le macchine da assedio pronte al contrattacco. La facciata, da cui si staccavano scaglie di vernice colorata, tradiva un passato maestoso che nessuna mano avrebbe mai potuto recuperare interamente, tanto quel luogo era stato violentato. Ma dentro... oh, dentro l’anima di quel palazzo risplendeva della gloria che le vecchie donne umane ancora cantavano, di tanto in tanto. Le pareti, segnate da crepe e fratture, erano coperte di pitture raffiguranti le più belle scene che avessi mai visto: campagne e alberi, uomini e donne, creature fantastiche e cieli immensi, spazi profondi come nessun umano avrebbe mai potuto vedere. Era il vero volto di Gaia, quello: splendente di colori e segnato dalle rughe dell’età e della sofferenza, ma non per questo meno affascinante. Avete mai visto un dipinto che non sia impresso su una lastra d’energia? Avete mai guardato un quadro i cui colori non fossero fasci di luce liquida? Se l’avete fatto, se i vostri occhi hanno mai avuto la fortuna di posarsi su un’opera di pittura stesa su superfici solide, allora saprete capirmi quando dico che, per la prima volta, scoprii che un sogno può prendere corpo. Rimasi a guardare a bocca aperta, sconcertata, per quelle che mi parvero ore. Registrai ogni dettaglio di quell’immagine per poterla vedere ancora e ancora in futuro: per farla vivere in eterno, anche dopo che gli Hadar l’avessero ridotta in polvere. L’hanno fatto, sapete? Taraz non esiste più e ora solo io posso ammirare quelle pitture, nei miei ricordi. Unica visitatrice di un museo che nessuno conosce. Alexei interruppe la mia meraviglia afferrandomi ancora per un braccio e trascinandomi avanti. dLo lasciai fare, tanto ero presa, e registrai solo parzialmente il percorso che stavamo compiendo. Porte e corridoi e altre meraviglie nascoste nelle ombre. Non incontrammo nessuno, ma credo che Alexei avesse pianificato così. Non aveva mai avuto il permesso di portarmi lì, ma a chi importava? Ci fermammo davanti a una porta anonima e ingrigita dal tempo, e con un sussulto mi resi conto che quella era la sua stanza, che mi aveva trascinata nel cuore del suo regno senza che io opponessi resistenza. E cosa avrebbe fatto di me? Scansai le opzioni e mi preparai a doverlo assecondare, certa che non avrei avuto occasione migliore per portare avanti la mia missione. E cosa poteva essere il sesso con un umano in confronto alla vittoria di Agena? Un sacrificio accettabile. Ma avevo lo stesso cominciato a tremare, mentre la sensazione di negazione e orrore mi assaliva a livello dello sterno, lottando contro la ragione. Alexei spinse la porta e mi sentì tirare un sospiro di sollievo vedendola aprirsi su una stanza medica. «Non pensavo che l’idea di finire a letto con me fosse tanto tragica per te, ragazzina» disse Alexei. «Rilassati. Non ti avrei mica portata fin qui solo per scopare. Se avessi voluto, mi sarei fatto invitare da te, a casa tua» «Come sei sicuro di te, soldato» lo schernì io, con una nota di disprezzo ben chiara. D’un tratto ero furiosa: in quella dannata stanza c’erano così tante macchine e medicine! Con quelle avremmo potuto salvare la vita a chissà quante persone, e loro la tenevano chiusa! Come potevano? «Pensavo mi chiedessi come avevo fatto a capire la tua paura» sorrise Alexei, invitandomi ad entrare. Mi tenne la porta aperta e la chiuse a chiave alle mie spalle, intrappolandomi lì dentro. «Sudorazione e reticenza. Hai i gradi da Colonnello, quindi penso che tu sia abbastanza addestrato per arrivarci. No, mi interessa più sapere perché l’esercito ha una sala operatoria all’avanguardia nascosta nelle viscere di un palazzo cadente. Puoi spiegarmi?» «Taraz ospita quasi un milione di persone. Quanto pensi ci metterebbe una “sala all’avanguardia” a diventare obsoleta se dovesse servire a tutta quella gente?» «E questo dovrebbe voler dire qualcosa?» «Questo posto c’è costato troppo. Tendiamo a non sprecare le cose preziose» disse Alexei, e poi alzò la mano in un gesto brusco, che gli fece scivolare la giacca dalla spalla. «Zitta adesso! Non ti ho portata qui per discutere delle risorse militari, ma per questo...» e mi tese la memoria metallica, stretta fra indice e medio. Io la presi con rabbia, concentrandomi per non romperla e lanciargli i resti in faccia. «Il pulsante rosso. Non ha la password. Aspetta che abbia caricato la schermata prima di inserire la memoria o mi toccherà chiamare un tecnico» disse, indicando il computer. Mentre mi spostavo per sedermi davanti allo schermo, Alexei prese a slacciarsi la camicia. Lo fece con gesti rapidi e stizziti, come se ogni bottone lo stesse personalmente insultando. Dal riflesso dello schermo potevo vedere i muscoli del braccio sano tendersi, come se quel gesto semplice fosse una sfida più dura delle battaglie che affrontava per mestiere. Aveva tagliato malamente la manica dalla parte dell’arto sano, lasciandolo scoperto, mentre l’altra era stata annodata con cura appena sotto l’articolazione e pendeva inerte, come in attesa di una parte di lui che non sarebbe mai tornata. Notai che il bottone al polsino era allacciato e che Alexei sorrideva ancora, con rabbia, prima che il computer emettesse un bip sordo, annunciandomi che era pronto. Inserii la memoria e quella cominciò a girare da sola. Lo schermo, una sottile lastra metallica coperta da un vetro, si riempì di schemi e progetti che si aprirono l’uno sopra all’altro, lottando per la mia attenzione. Allungai una mano, incerta, e cominciai a sfogliare i disegni con meraviglia crescente, la mente che tornava a vagare su terreni che non esploravo da quasi dieci anni. «Stupefacente, vero?» Alexei mi si avvicinò, nudo dalla cintola in su, e si sporse oltre la mia schiena, premendomi la sua pelle calda addosso, senza riguardo. Pescò un file e lo ingrandì con due dita, facendo sorgere un intrico di linee meccaniche e ingranaggi prima nascosti, mentre io lottavo contro la voglia di allontanarlo, sbatterlo a terra e colpirlo fino a che non avesse capito che doveva starmi lontano. «I miei lavorano da quasi sei anni su questi progetti e mi assicurano che sono realtà. Che possono essere realizzati. Ho messo in produzione due di... di questi...» Alexei scansò tre progetti prima di trovare quello che cercava: il dettaglio di un arto meccanico di metallo, completo della circuiteria necessaria a farlo muovere «... quattro mesi fa. Finiranno di assemblarli in settimana e poi saranno pronti alla fase tre. Sai di cosa parlo, vero?» Scossi la testa, allontanando contemporaneamente la sedia da lui, ma Alexei si attaccò di nuovo a me e sorrise, invitandomi a sfidarlo. «Sperimentazione umana. La fase tre di ogni cosa è sempre la sperimentazione umana, tienilo a mente ragazzina.» «E hai scelto di usare me come cavia?» domandai, stringendo le labbra. Il braccio fantasma si mosse, ribellandosi all’idea, e spinse contro la faccia di Alexei, frantumandogli il naso mentre lo atterrava; sentii perfino lo scricchiolio delle ossa e il gemito dei nervi rimbalzare lungo i tendini bionici e galvanizzarli, accendendo tutta la forza della tecnologia Hadar... e mi trovai ancora seduta, col cuore che correva per la paura. Se mi avessero operata avrebbero scoperto che, dentro, non ero così umana come sembravo, e allora sarei stata spacciata. «Ti piacerebbe, vero? No, questa meraviglia costa troppo per regalarla a una civile. Vedi, a questo punto il problema non è verificare che il prototipo funzioni, ma trovare qualcuno a cui valga la pena di lasciare un braccio da quasi tredici milioni di Rubli. Qualcuno che sia nello stesso tempo anche sacrificabile, nel caso le simulazioni a computer fossero sbagliate.» «Ti hanno...» «Mi sono offerto volontario. Credo tu possa capirmi quando dico che venderei l’anima per poter tornare a essere un uomo integro.» Non risposi, limitandomi ad annuire senza convinzione. Come potevo dirgli che no, non lo capivo? Come potevo spiegargli che la sola idea di fondere me stessa con un pezzo di metallo era semplicemente vomitevole? Che avrebbero dovuto sedarmi pesantemente per evitare che, con tutte le mie forze, io mi opponessi a una tale mostruosità? «Io che c’entro?» domandai invece, girandomi di scatto a fronteggiarlo. Lo trovai ancora sorridente e decisamente più pericoloso, ora. Più preoccupato, avrei capito poi. «Per farmelo muovere, bisogna che sia connesso al mio sistema nervoso. O qualcosa del genere, a quanto dicono il cervelloni. Hanno provato a spiegare la procedura ai medici del campo ma tutti si sono rifiutati. Dicono che mi avvelenerà il sangue, che morirò durante l’intervento o... Beh, altre belle cose del genere. Ho smesso di ascoltare dopo le prime minacce di morte e sofferenza, tanto il concetto era chiaro. Il messaggio di fondo è che quei codardi non vogliono rimetterci il loro bel posto di lavoro, in caso andasse male. Qui è piuttosto facile la vita per il personale civile, sai?» Alexei si avvicinò, abbassando la voce a un sussurro complice e spostandosi i capelli di lato. «Non sono motivati. Non sanno che vuol dire essere assegnato all’unità più merdosa dell’esercito perché non possono cacciarti via. Perché sei così fottutamente bravo che hanno bisogno di te, anche se te è un catorcio che fatica a ricaricare la propria arma da solo. O ad allacciarsi la camicia, che è peggio.» «Ti stai dando molta importanza, per essere una cavia» risposi io, aspra. Ero irritata da tutto, in lui: la sua confidenza, il tono amaro, l’odore della sua pelle, il linguaggio. «Io voglio tornare in guerra, ragazzina! Voglio uscire da questo palazzo di merda e scendere in campo con i miei soldati. Voglio guardare in faccia quegli alieni del cazzo e fargli vedere che vuol dire mettersi contro i terrestri. Io sono nato per questo!» «Anche se volessi, come pensi che potrei operarti?» e sollevai il braccio destro, frullandolo in aria con amarezza. «Ti ho vista ricucire Yegor. Il ragazzo biondo. Hai fatto un bel lavoro, per una che poteva usare solo una mano. Sei stata tenace. E, quando ce l’avevi sotto la mano, non lo guardavi come un medico, ma come un meccanico. Come se quella con cui stavi lavorando non fosse una vita ma un’insieme di circuiti che dovevi riconnettere. È questo che voglio: la freddezza, l’autocontrollo. L’assenza di quel fattore umano che rende quegli altri geni dei codardi miserabili.» «Resta il fatto che ho una mano sola. Non sarei in grado di...» iniziai a protestare, ma Alexei mi bloccò con un gesto imperioso. «Quella macchina là è un computer. Basta programmarlo. I cervelloni lo setteranno per te. E poi avrai un’equipe ai tuoi ordini. Tu dovrai solo... Solo controllare che non facciano cazzate» tagliò corto lui, sollevando le spalle. «Io non sono medico. È bene che tu lo sappia.» «Sai dove mettere le mani, però. E puoi capire perché sono disposto a fidarmi di te» Alexei allargò il sorriso e mi posò una mano sulla spalla sinistra, in una carezza che scese troppo verso il petto. «Accetta, ragazzina. Fallo e, entro dieci anni, forse sarai diventata abbastanza indispensabile da averne uno anche tu.» «Dovrò restare qui?» domandai, brusca, facendo un passo indietro e indirizzando un cenno all’angolo di caserma che si intravvedeva dalla finestra chiusa da inferriate. «Immagino che vorrai familiarizzare con le attrezzature meccaniche e umane. In caso contrario...» Alexei indicò la porta con un mezzo inchino, allungandomi la chiave. Aveva in volto un sorriso freddo che sembrava dirmi che, in fondo in fondo, aveva sempre saputo che non ero all’altezza, ma che quello era solo un errore suo, non mio. Accettai, e non nego che in quel momento fu solo per cancellargli quell’espressione dalla faccia. Rimasi. Finsi reticenza e disprezzo, a volte persino odio, ma non mi mossi. Ero dove volevo, dopotutto. Scoprì ben presto che la mia inesperienza era secondaria solo per Alexei: il team che lavorava a quel progetto – tre medici con più di trent’anni di esperienza e il doppio fra assistenti e infermiere – mi accettò malvolentieri, condividendo con me solo mezze verità... almeno, fino a quando il paziente non lo venne a sapere. Da me. Se Alexei voleva usarmi per tornare intero, io volevo usare lui per far fruttare quel tempo. Avevamo stabilito una tregua singolare: entrambi fingevamo di corteggiarci, di tenere l’uno all’altra, certi che l’idea di un coinvolgimento romantico potesse rafforzare i nostri veri interessi – lui convinto che io l’avrei tenuto in vita con maggiore forza se l’avessi amato, io che mi avrebbe confessato ogni cosa se solo avesse pensato che poteva servire a conquistarmi. Oh, con questo non intendo che Alexei mi fosse indifferente. Mi avrebbe portata a letto più che volentieri, se glielo avessi permesso. Quella sua mano troppo lunga non perdeva occasione per scivolare su di me – all’attaccatura del collo o nell’incavo fra il braccio sano e il seno, ad esempio. Io lo notavo e contraevo le dita fantasma, lasciandolo fare: finché era solo questo, potevo resistere. Dovevo. Lui era insistente in maniera imbarazzante. Si lasciava sfuggire frasi come “Ti sei fatta male cadendo dal paradiso?”. Tremende già per loro natura, diventavano a dir poco squallide quando lui le pronunciava con quella spudorata, lasciva disillusione che sottintendeva il suo totale disinteresse. Non le tolleravo, non potevo. Cominciai a rispondere con frecciatine tipo “Ho perso un braccio, tu che dici?” o “Gli occhi li ho presi da mia madre, ma non l’ho mai conosciuta e pensare a lei mi ferisce” ma scoprii che era controproducente con lui. Alexei allargava il sorriso e mi cingeva con un braccio, stringendomi a sé e toccando quante più parti del mio corpo poteva mentre mi compativa con una studiata pena, dietro la quale potevo benissimo vedere l’indifferenza e il disprezzo per la mia debolezza. Mi avrebbe schernita se non gli fossi servita. Così smisi di rivolgergli qualunque frase che non fosse strettamente necessaria al mio scopo. Come corteggiatore era pessimo, non lo nego, ma come cane da guardia si rivelò ottimo. Quando mi “lasciai sfuggire” a fior di labbra che gli altri medici non volevano rendermi partecipe, Alexei spostò i capelli di lato, sorrise di più e mi afferrò alla mascella, dolcemente, per un lungo minuto. Poi si alzò come se nulla fosse. Sentii le grida del capo del team passare attraverso tre porte ma, quando feci di nuovo la mia comparsa, nessuno osò parlarne. Fu così che scoprii che quei progetti non erano altro che vecchi schemi, salvati da chissà quale perduta biblioteca e studiati per anni, per capirne il significato. E non era il solo caso. I figli di Gaia, lo scudo contro cui ci infrangevamo da anni, si difendevano usando una tecnologia vecchia di più di due secoli! Come potevano aver resistito tanto? Da allora studiai e basta. Procedure mediche, rudimenti di meccanica, principi di anatomia. Lessi informazioni frammezzate su vecchi tomi di carta – carta, per l’Universo! – e cercai di mostrarmi più sapiente che intelligente. Quanti umani potevano vantarsi di essere in grado di leggere e apprendere un intero compendio di fisiologia in un’ora? Il mio cervello potenziato, ancora una volta, era mio rischio e fortuna. Alla faccia della settimana preventivata da Alexei, il team fu pronto ad operare dopo tre mesi quasi esatti. A quel punto sapevo degli umani tante di quelle cose che avrei già dovuto capire... Ma ero eccitata, sapete? La prospettiva di applicare il campo di studi di tutta una vita a un essere vivente mi elettrizzava. Operai Alexei. Collegai i nervi a una piastra e la piastra ai cavi metallici, fondendo il tutto con ordini e gesti. E quanto avrei voluto essere completa anche io, in quel momento! Affondare le dita di entrambe le mani sin nel cuore di quella chimera e sentirla pulsare, viva e interamente mia. Mi mancava, eccome. Persi la cognizione del tempo, persi interesse nello scopo della mia missione autoindotta. E poi fui fuori, mentre Alexei veniva portato via e delle voci si congratulavano con noi. Con me.  Piccolo spazio-me: i credits > Zephyrhant (passate a rifarvi gli occhi) Fatemi sapere che ne pensate della storia: ci tengo! |
Capitolo 3
*** Provincia di Mira, 5° di Veldor - 23/10/2289 ***
 La stirpe di Agena
  Is this the dawning of a vacant age Is this the dawning of a vacant ageI'm turnin over to a ripped up page You look around with every step you take 'Cos someone's watchin every move you make E' l'alba di un'era vacante Sto superando la pagina strappata Ti guardi attorno ad ogni passo che compi Perché qualcuno controlla ogni mossa che fai (Every Day, Planet Funk) Provincia di Mira, 5° di Veldor,
23/10/2289 La mia residenza temporanea divenne la mia seconda casa.
Rimasi alla base e mi fu dato l’ordine di occuparmi di Alexei: dovevo monitorare i parametri vitali e la risposta d’adattamento dell’organismo, oltre alla funzionalità dell’arto meccanico... E quanto era affascinante vedere quelle dita scheletriche, aliene e metalliche, contrarsi all’ordine della mente di Alexei! Era come osservare la nascita di una nuova stella. Un momento unico. Cominciai a seguire Alexei un po’ ovunque, monitorandolo. Annotavo su un tablet i parametri vitali e nella mia mente le mappe e gli schemi che vedevo nelle stanze degli ufficiali, abbassando la testa con tutta la modestia di cui ero capace. Una spia perfetta. Alexei si stancò presto di fingersi un corteggiatore romantico e tornò a essere il militare freddo e cinico che era sempre stato. Dal canto mio ero sollevata: ora, quando si avvicinavano, potevo respingere le sue mani con violenza invece che dover subire passivamente. Un bel passo avanti. Dopo sette mesi di Alexei non sentivo quasi più parlare. Poco male, a dire il vero: in quel periodo la maggior parte delle sue missioni era al fronte, lungo la linea di terra che delimitava la zona di estrazione mineraria; io, d’altro canto, avevo ormai il mio pass e potevo entrare nella caserma a mio piacimento. Alexei non mi serviva più. Facevo parte di un nuovo team, per giunta: non più in veste di direttrice, come anche io ritenevo ovvio, ma con mansioni di comando minori e un piccolo stuolo di assistenti. Cercavamo di implementare le funzioni dei bracci meccanici e nuove cavie su cui impiantarli – soldati che avrebbero trasformato le loro menomazioni in armi dalle molteplici funzioni. La mia testa, allora, era piena di idee meravigliose: tutte le implicazioni potenziali di questa tecnologia, unita alle mie conoscenze Hadar, mi facevano passare notti in bianco, a disegnare schemi che avrei tenuto per me. Non volevo arrivare al punto di creare armi per i miei nemici. Per mantenere il mio posto, tuttavia, dovevo pur contribuire alla ricerca; e sarebbe assurdo dire che non ero orgogliosa del mio lavoro, o che non ne prendessi i meriti. Dopo un anno e mezzo dal mio arrivo avevo abbastanza familiarità con gli ufficiali devoti al progetto che cominciai a suggerire la creazione di un corpo militare scientifico, che avrebbe avuto il compito di condurre la terra alla vittoria. Ne ottenni una divisa, dello stesso blu del linoleum negli ospedali, così assurdamente simile a quella da Capitano che, un tempo, avevo indossato su Agena, da farmi accarezzare l’idea di comprare una lama e legarla al fianco sinistro. Non lo feci, ovviamente: era inutile. E, in ogni caso, bastava la divisa a farmi sentire quell’unità che amavo. Casa. Familiarità. Nessun Hadar poteva resistere a questi richiami. Nessuno può nemmeno ora, vero? È la nostra debolezza, amare troppo il nostro mondo buio. Osai troppo. Feci il passo più lungo della gamba e, da superficiale, divenni essenziale. Quanto mi ero ripromessa di evitare quella linea? Di starne lontana il più possibile? Tanto. Ma la giovinezza è anche questo: audacia. E, se di qualcosa ero satura in quel periodo, era la fiducia in me. Fu così che, quando la fase tre della nuova sperimentazione fu approvata, la lista dei candidati per l’impianto fu arricchita del mio nome. Era logico, scontato quasi; ero una ragazza nel fiore degli anni che sembrava non voler invecchiare, forte e intelligente, frenata solo dal proprio corpo: perché non avrei dovuto essere completata? E chi, meglio di me, avrebbe potuto offrire un resoconto sulla funzionalità dell’apparecchio? Sapevo cosa aspettarmi che facesse, d’altronde. Sentii ripetere questo concetto per giorni dai miei colleghi e superiori, che cercavano di calmarmi e convincermi a dare il mio consenso; che mi invidiavano; che mi pregavano di farlo di mia spontanea volontà, perché sarebbe stato peggiore finire sotto i ferri da prigioniera. Non mi importava, dissi; non lo avrei fatto. Non diedi altre spiegazioni, mi limitai a gridare e protestare. Come potevo dirgli che temevo quel che avrebbero scoperto? Mi lasciarono parlare, mi fecero sfogare e cominciarono a preparare la protesi, usando le misure standard che io stessa avevo calcolato. Lo fecero dietro le mie spalle, ma non potevano nascondersi, non quando io avevo tutte le loro password celate nei ricordi. E quando capii che non avrei potuto uscirne, decisi di fuggire. Avevo tutto quello che mi serviva da tanto tempo, ormai; e il come avessi potuto rendermene conto solo mentre strisciavo fuori dalla base militare resta una fonte di vergogna per me. Mi stavo mentendo, mi illudevo: amavo quel lavoro, ma cosa credevo? E di che tradimento mi ero macchiata? Non ero umana, né avrei mai potuto esserlo. Oh, per l’Universo, quanto vorrei ridere adesso! Se non stessi così male, lo farei. L’ironia di quel pensiero mi ferisce ogni volta, nonostante gli anni. Ero... Beh, ero in strada, alla fine. Con niente altro che una divisa blu e la paura che martellava nel petto, facendo a gara con l’euforia, nel tentativo di causarmi un attacco di cuore proprio mentre ero a un passo dalla libertà. Avrei aspettato. Ricominciato. C’erano altre città a Nord, altre case, altre persone da spiare... Scivolai per le strade deserte con tutta la sicurezza che avevo, passando inosservata proprio per questo; e infine fui alle porte di Taraz, spalancate sulla lunga via del deserto. Uscì dalle ombre fresche della roccia salutando una guardia, che ricambiò con un’occhiata distratta alla divisa che, lo sapevo, di lì a qualche ora gli sarebbe costata il lavoro. E mi trovai a fissare il volto sorridente di Alexei, mentre il bagliore metallico del sole sul fucile puntato alla mia testa mi feriva gli occhi. Orbita di Mira, 5° di Veldor, 23/10/2289 «L’idea è questa, ragazzina» attaccò Alexei, distendendosi sulla piccola sedia di metallo e allungando i piedi sul tavolo di legno graffiato che faceva da scrivania. «Io ti riporto indietro sana e salva e tu smetti di fare i capricci, oppure ti lego come un salame e ti chiudo in una cantina finché non ti ammorbidisci un po’.» Io mi mossi, a disagio. L’ufficio della guardia di perimetro era caldo da impazzire, e la ventola che girava pigramente sul soffitto col suo sibilo contribuiva solamente ad aumentare il fastidio. Io ero a terra, il braccio immobilizzato alla parete da una catena: una mossa che mi metteva in ridicolo più di quanto il mio orgoglio poteva sopportare. Avrei gridato se solo non fosse stato controproducente: la mia gola era già in fiamme per la sete. «Potresti lasciarmi andare» obiettai, cercando di assumente lo stesso tono sereno e distaccato che aveva Alexei. «Ho degli ordini» ribadì lui, imbastendo un sorriso che voleva essere di dispiacere e che sembrava solo di feroce soddisfazione. «Hai un braccio nuovo perché io te l’ho fatto impiantare. Direi che mi devi di più di una risposta da manuale» sbottai io, strattonando il gancio che mi legava il polso. «Ho un braccio obsoleto che tu hai montato, è vero. Ma avrei trovato qualcun altro, prima o poi. E, se ti lascio andare, pensi che il mio nome sarà ancora nella lista degli aggiornamenti?» «Molto cavalleresco da parte tua, vendermi per un’arma più grande. Non ti fa molto onore» sibilai, cercando di fargli arrivare tutto il mio odio. Avevo gli occhi umidi e una rabbia nel cuore che, lo sapevo, non fossi stata legata mi avrebbe dato la forza di soffocare quel sorriso. «Che cazzo di problema hai?» sbottò a sua volta Alexei, piantando i piedi a terra e allungando il busto verso di me. «Ogni persona sana di mente darebbe tutto ciò che possiede per avere quello che l’esercito vuole regalarti e tu ci sputi sopra. Tu! Con tutti i tuoi talenti... potresti diventare il capo di quella fottuta squadra di scienziati da quattro soldi e invece lasci che la tua menomazione vinca, lasci che gli altri ti scavalchino solo per paura di...» «Credi che abbia paura di mettermi in mostra? È grazie alla mia vanità se ora tu sei qui invece che in un ufficio, senza un braccio e a controllare reclute. Io ho avuto il coraggio di mettermi in gioco per te! E tutta la tua rabbia...» «Oh non osare nemmeno pensarci, carina. Io ho tutto il diritto di arrabbiarmi come e quanto cazzo mi pare. Io...» «Tu hai il tuo braccio e nessuno te lo toglierà. Io ho il diritto di non volerlo e tu non dovresti prenderla così sul personale!» a quel punto gridavamo entrambi, a meno di venti centimetri l’uno dalla faccia dell’altra e tesi come onde di un theremin. «No? Ma certo. Tu sputi su quello che io ho combattuto per avere, sulla ricerca per cui ho rischiato la mia carriera e la mia vita. Tu sputi sul mio cazzo di sogno, per la miseria!» «Io non voglio essere una cavia. Non voglio essere un mostro di metallo solo per...» e mi bloccai, improvvisamente consapevole di avere una lama nella mano della mia voce, un arma puntata dritta al suo cuore. Potevo colpirlo, ma cosa ne sarebbe stato di me, poi? «No, ora lo dici. Voglio sentirlo o giuro che ti trascino fuori di qui a calci in culo e ti faccio operare questa sera stessa. Da sveglia, così potrai vedere ogni secondo della tua trasformazione in un mostro» Alexei mi afferrò entrambe le spalle e, stringendo, mi spinse contro il muro. Piantò la sua faccia rossa e ferita davanti alla mia, riempiendomi il naso del nauseante odore di Gaia. «Non è un giudizio per te, dannazione! Non tutto quello che le persone dicono ruota intorno al Colonnello Alexei Rubjakov!» cercai di sviare il discorso verso altri lati del suo orgoglio, ma ormai ero andata troppo oltre. Lui mi tirò a sé e mi spinse contro il muro ancora una volta, facendomi sbattere le scapole e la testa. Ansimai, e lui ripeté il gesto ancora una volta, gridando. «Che stavi per dire? Parla!» «Che non voglio diventare qualcosa che non amo solo per paura di non riuscire a farcela con quello che ho. Io sono più forte della mia menomazione. E sono in grado di vivere una vita grandiosa anche senza un braccio. Lo capisci?» gli gridai in faccia, aggredendolo con la mia rabbia. «Capisci che accettare di passare sopra a quello che voglio, alle mie idee, sarebbe come ammettere che, dal giorno in cui ho perso il braccio, non sono stata altro che uno scarto debole e inutile? Che non ho il coraggio di rimboccarmi le maniche e rialzarmi e vivere con quello che ho? Lo capisci che il tuo sogno è un incubo per me, Alexei? Perché io sono più forte di te! E non lascerò che loro... che tu... mi sbattiate in faccia il fatto che per essere migliore devo diventare come voi mi volete. Tu sei scivolato sempre più in basso dal giorno in cui hai avuto l’incidente, io mi sono sollevata dalla polvere e dalla miseria, l’ho fatto con un braccio solo e continuerò a cavarmela egregiamente anche senza l’altro!» a quel punto mi resi conto di averlo spinto due volte, violentemente, e di esserae tesa al limite della possibilità che la catena al polso mi offriva. «È sempre bello sapere quello che gli altri pensano di te» Alexei attese che l’eco delle mie parole si spegnesse prima di parlare, passandosi una mano chiusa a pugno sul volto e poi lisciandosi i capelli da una parte, alla ricerca di un contengo che non sembrava più avere.«Beh, questo debole schiavo del sistema sta per portarti dai suoi superiori e venderti per un braccio nuovo. Non sarà virile o eticamente bello, ma sai che ti dico? Me ne fotto! E sarò in prima fila mentre verrai operata» allargò le labbra in un sorriso feroce, un ghigno da bestia selvaggia. «Non vedo l’ora che anche tu provi cosa vuol dire tornare a essere completi. E quando succederà, quando ti vedrò scendere da quel maledetto piedistallo, sarò lì ad aspettare le tue scuse. Condite con una bella notte di sesso, magari. Non servirà nemmeno un invito: i capoccioni avranno sicuramente il tuo indirizzo. E poi vedremo se ti farò ancora così tanto schifo» mi disse, allungando la mano metallica al mio basso ventre e carezzando con violenza. Io mi ritrassi, la testa che pulsava al ritmo della mia rabbia. Sentivo la mano fantasma contrarsi e stringersi attorno al suo collo, scavare fra pelle e tendini fino a lacerarli e restare immobile, godendosi la rigenerante sensazione della vita che scorreva via da lui. Non è detto che non succeda, disse una voce primordiale e feroce dal fondo della mia coscienza. Io annuì, convinta. Se fosse entrato in casa mia, l’avrei ucciso. A meno che non ne avessi l’occasione prima. Orbita di Mira, 5° di Veldor, 23/10/2289 Alexei mi fece rinchiudere davvero in uno scantinato. Ricordo l’umidità fredda, il modo in cui serpeggiava dal pavimento fino al collo, arrotolandosi sulla spina dorsale come un animale feroce. Ricordo che piansi, sbattendo i pugni su pareti che sapevano di muffa e polvere, supplicando di essere liberata. Ricordo che pregai Agena di perdonarmi, e sentii la voce di mio nonno ripetermi che me l’ero cercata, che chi troppo vuole nulla ottiene.
Un proverbio decisamente troppo umano per i miei gusti, ma tant’era. Poi mi calmai. Accettai di star per morire e attesi, certa che quella era solo la fine a cui ero scampata senza diritto anni addietro. Chiusi gli occhi e dormii, allora, l’animo sereno come raramente mi era capitato da molto tempo. Fu Alexei a svegliarmi. Mi scosse senza tante cerimonie e allungò la mano di metallo verso di me, frullando appena le dita per mettermi fretta. Io non mi mossi, limitandomi a fissare il suo volto che, per la prima volta, tradiva agitazione e incertezza. «Sei in ritardo» gli dissi semplicemente, accennando alla stanza e poi a me con fare teatrale. «Ormai sono in pace con l’inevitabile.» «Lo dici come se, invece di aiutarti, ti stessimo condannando a morte» sbottò lui, afferrandomi per il bavero dell’anonima divisa da lavoro blu e sollevandomi in piedi senza tante cerimonie. «In un certo senso è così» risposi io, calma, guardandolo interrogativa. «Prima o poi dovrai fare qualcosa per il tuo orgoglio. E la tua testardaggine» Alexei prese ad armeggiare con un mazzo di chiavi dall’aria pesante. «State per pensarci voi, no?» ancora calma, divinamente rassegnata. Senza alcuna emozione. «No» sibilò, trovando infine la chiave giusta. «Che vuol dire?» «Ho parlato con Aibek. L’ho convinto che, in fondo, non sei una buona candidata. Gli ho esposto la tua teoria e il caro Generale ha detto che poteva capire. Lui, che non ha mai perso nemmeno un’unghia in battaglia. Ridicolo. E hai cercato di fuggire. Chi ci da la certezza che, un giorno, non deciderai di farlo di nuovo? Quella meraviglia potrebbe finire nelle mani di qualche alieno. O di qualche stato che comincerà a commerciarla prima di noi. O potresti semplicemente sbarazzartene, il che vorrebbe dire tanti soldi sprecati. Saresti in grado di operati da sola, immagino, e sei abbastanza instabile da farlo» Alexei mi liberò dalle catene e mi si piantò davanti, guardandomi con un misto di astio e vergogna talmente genuino da ferirmi. «La verità è che non te lo sei meritato. E anche io sono una persona orgogliosa! Non mi sono sbattuto tanto per regalare perle ai porci.» «Quindi?» domandai io, cominciando di nuovo a sperare. «Quindi ti porto a casa e ti riprendi. Hai tre giorni, trascorsi i quali devi presentarti al lavoro. Comincerai a montare i bracci a, le gambe e le mani nuovi candidati da mercoledì prossimo. E, nelle pause, dovrai parlare con uno strizzacervelli. Quelli di sopra hanno paura che prima o poi darai di matto, altrimenti.» «E finisce così? Niente punizioni, niente sanzioni, niente di niente?» non potevo crederci, era fuori da ogni logica. Nessun soldato, su Agena, avrebbe potuto sottrarsi a un’ordine di un superiore e restare illeso. «Benvenuta nel mondo degli eletti e degli indispensabili. Abituati con cautela, il potere dà dipendenza» Alexei sorrise di nuovo, questa volta con una traccia di quella vecchia audacia che era sua. Si fece avanti e mi spinse contro la parete con il suo corpo, senza violenza questa volta, intrappolandomi fra lui e il muro. Le sue labbra scesero verso il mio orecchio e la sua mano di carne mi si posò su un fianco, stringendo. «Se però dovessi ancora sentire il bisogno di essere punita, ragazzina, sarò più che felice di farlo. Ripetutamente» sussurrò, quasi toccandomi il volto con la bocca. Poi si ritrasse quel tanto che bastava per spingermi avanti, la mano ora sulla schiena. Non si staccò mai veramente da me, ma non ci feci caso. Nessuno aveva mai lottato perché io avessi quello che volevo, prima. Nessuno si era mai esposto così tanto per un mio capriccio. Con un gesto, Alexei era diventato una persona diversa per me. E, per la prima volta, non provai ribrezzo nel contatto con un essere umano.  |
Capitolo 4
*** Spazioporto di Haumea, 1° di Solaria - 24/10/2289 ***
 La stirpe di Agena
  And when it gets too late, I'll be chasin you home And when it gets too late, I'll be chasin you homeQuando si farà troppo tardi, io ti seguirò a casa (Every Day, Planet Funk) Spazioporto di Haumea, 1° di Solaria,
24/10/2289 Siamo fermi da un’ora. Ne ho approfittato per mangiare qualcosa, sperando di riuscire a tenerla nello stomaco.
Per l’Universo, quanto vorrei poter avere ancora del Drez! Mi avrebbe aiutato con il viaggio, senza dubbio... No, non saltiamo alla fine. Ho pochi minuti solamente, ora, e devo sbrigarmi. Solaria – che, meno di vent’anni fa, era ancora il Sistema Solare – è relativamente piccola e io devo aver terminato prima di atterrare, o non avrà avuto senso. Dunque, riassumo. Cominciai a pensare ad Alexei in maniera diversa, da quel momento. Inizialmente lo feci senza quasi accorgermene, tirandolo mentalmente in ballo in discorsi in cui la sua presenza era più o meno giustificata; poi cominciai a cercarlo. Non fu difficile avvicinarci, in realtà: anche per lui il forte e la cella avevano tracciato una linea di demarcazione netta. Cosa dire? Parlammo. Sentendomi man mano sempre più in colpa io gli raccontai della mia infanzia, trasformando la notte eterna e gli alberi luminescenti in un deserto arido e caldo; e lui mi descrisse la sua, senza imbarazzo e con sincerità. Smise di sorridere, almeno in mia presenza: ora il suo volto era serio e spesso perso in qualche pensiero lontano, gli occhi celesti che sfidavano il cielo, come cercando risposte. Io allora tacevo e aspettavo che parlasse, godendomi per la prima volta la pace di Gaia. Furono le parole ad avvicinarci. Ma fu nei silenzi che ci innamorammo davvero. Periferia di Haumea, 1° di Solaria, 24/10/2289 A quel tempo, casa mia era una stanza in cui stava a malapena un letto, un lavandino e un comodino. Mi piaceva, forse la amavo addirittura. Non ho più provato quel senso di appartenenza per un luogo. Era mio, interamente, dall’odore ai piccoli oggetti che avevo collezionato. Alexei vi entrò come se ne avesse avuto diritto, portandosi dietro quel sentore di Gaia che avrei imparato ad amare. Chiuse la porta, catapultandoci ancora una volta nella penombra del tramonto che ai miei occhi era così congeniale. Lo vedevo con chiarezza, nella maniera ancora naturale con cui avevo osservato i luoghi della mia infanzia, su un pianeta oscuro e forse già dimenticato. Forse fu quello, il senso di familiarità che da sempre l’oscurità mi trasmetteva, a non farmi reagire. Alexei superò la distanza che ci separava con tre rapidi passi, e mi fu addosso. Non parlò neppure una volta; solo, mi scivolò accanto e sollevò la mano ad accarezzarmi il viso in un gesto carico di naturalezza. Come fosse nato per farlo. Potevo vedere la sua bocca contratta in una smorfia di sorpresa e dolore, il volto magro e appuntito esitare mentre gli occhi sbattevano, in cerca di una luce che scompariva. Sarebbe stato quasi comico se non fosse stato... Se non fosse stato così dannatamente perfetto. Nella mia testa, una voce – forte, militare, categorica! – mi avvertiva che era sbagliato. Sentivo la mano fantasma contrarsi, ma stavolta non cercava un’arma: era Alexei che voleva stringere. E lo volevo anche io. Con tutta la forza che avevo nel corpo. Cercai di ritrarmi, ma Alexei mi circondò con il braccio meccanico, tirandomi con forza verso di lui. Io rabbrividì al contatto col metallo, ma non opposi resistenza. La mano di carne di Alexei – quella calda e morbida che continuava a sfiorare la mia pelle come se io fossi fatta di vetro – scese lungo il collo e fino al seno, insinuandosi sotto la divisa da lavoro che indossavo come pigiama. Cominciò a stringere, delicatamente, e le sue labbra si dischiusero in un sorriso che avrebbe riservato solo a me: un’espressione di calma e dolcezza che stonava con l’uomo duro che avevo conosciuto. Libero dal peso della luce, Alexei lasciò che quel sorriso si sfogasse e poi chinò la testa, cercando con le sue labbra le mie. Io lo contrastai, spostando il volto in modo che quella ricerca durasse ancora, e intanto inspirai, riempiendomi i polmoni del suo odore – buono, caldo, inebriante. «Smetti di scappare» mi disse sottovoce, lasciando una scia tiepida sulla mia guancia. Vicino, ma non abbastanza. Gli risposi girandomi appena, e finalmente le nostre labbra si incontrarono. Il sapore di Alexei era più inebriante di qualsiasi cosa avessi mai provato: a occhi chiusi, mi sentii catapultata indietro, a una vita che non esisteva più, a una me giovane e sicura di sé. Alexei sapeva di protezione, di cura, di passione, di amore – e come potessi esserne così sicura non lo so. Dischiusi le labbra, allungando la lingua per assaggiarlo ancora, per sentirlo più vicino. Le nostre mani – quelle calde e umane – scivolavano leggere fra pelle e abiti, cercando di liberarci a vicenda del tessuto. Io attaccavo la sua camicia, combattendo contro quegli stessi bottoni che erano stati un incubo per lui, strappandoli senza neanche accorgermene; lui spingeva via i miei pantaloni da lavoro, strattonando l’elastico senza alcun riguardo. Io lo desideravo per questo. Mai, in tutta la mia vita, ho mai amato di meno una divisa. La mano meccanica di Alexei si spostava pigramente sulla mia schiena, assorbendone il calore. Non mi importava: persa in quel bacio, avrei accettato perfino il tocco di quelle dita scheletriche di metallo. Senza staccarsi da me che il minimo necessario, Alexei mi sfilò pantaloni e biancheria in una mossa sola, sfidandomi con uno sguardo a fare lo stesso. Io avvolsi le gambe alle sue, ben consapevole che non poteva vedermi raccogliere la provocazione con un sorriso, e con la bocca cominciai a scendere piano alla curva del volto e poi al collo, continuando ad assaggiare il suo sapore. Lui emise un gemito e le nostre mani si incontrarono ai suoi pantaloni, desiderose di raggiungere lo stesso obiettivo. Cooperammo, e ben presto solo la mia maglia ci divideva. Alexei si limitò a sollevarla mentre la mano meccanica si spostava sulle mie spalle, la gemella di carne al mio inguine e la sua bocca scendeva al seno. Allora fui io ad ansimare, questa volta più a lungo. E lui rise piano, in maniera genuina e spontanea: un suono che mi fece venire voglia di baciarlo finché non avessi avuto più alcuna forza. Perché era così libero, così assurdamente e meravigliosamente libero e felice in quel momento! Come me. Mossi le mani – quella fantasma e quella reale – e l’attirai più vicino quasi nello stesso istante in cui lui sollevava entrambe le sue verso il mio viso. Ci incontrammo ancora, e questa volta completamente. Scivolò in me e il ritmo della nostra passione fu una danza, scandita dalla musica dei nostri sospiri. Un’armonia fuori dal tempo, un ballo solo per noi. Dopo, quando la passione smise di aggredirci, rimanemmo sfiniti e sdraiati l’uno accanto all’altra. Contemplavamo il vuoto immenso nel buio, godendoci le sue infinite possibilità e respirando l’odore acre e violento del sesso, e nessuno dei due poteva volere nient’altro. Lo sapevamo entrambi. «Perché hai deciso di assecondarmi, alla fine?» domandai all’improvviso. «Per avere questo?» chiese lui di rimando, ironico, mentre con due dita mi pizzicava una natica. «Dico seriamente.» «Lo so» Alexei sospirò, all’apparenza seccato; nel buio, tuttavia, il suo volto tradiva la gioia dell’aspettativa soddisfatta. «L’ho fatto per quello che mi hai detto quando ti ho presa, dopo la fuga. Per... Beh, per la forza con cui hai esposto le tue idee. E perché avevi ragione.» «Ripetimelo, ti prego. Mi piace parecchio sentirlo» gli dissi, ridendo. «Stronza» soffiò lui, con allegria. «Dovrai accontentarti di altre cose piacevoli, da me.» «Prima finisci di raccontare» lo respinsi io con malizia, guardandolo scuotere il capo, divertito. E poi tornare serio, con la stessa velocità con cui una nuvola oscura il sole. «È stato sopratutto per il coraggio. Io ho sempre ammirato la temerarietà e ho cercato di vivere secondo un principio semplice: non aver paura, non farti mettere sotto da niente e da nessuno, tranne che da te stesso. E pensavo...» «Pensavi che il tuo incidente ti avesse messo sotto?» «L’unico ostacolo ero io, mi dicevo. Se fossi stato completo avrei potuto...» Alexei agitò la mano di carne nell’aria, rimestando alla ricerca delle parole giuste. «Non lo so, vincere questa maledetta guerra! Salvare la terra e diventare una sorta di eroe. Ma, finché non me l’hai sbattuto in faccia, non mi ero reso conto che l’unico ostacolo ero davvero io, giusto?» L’ombra di quel vecchio sorriso, lo scudo delle sue vergogne, si affacciò ancora, adombrandogli il volto. «Cazzo, non mi sono spiegato per niente.» «No, ho capito» sussurrai io, timorosa di rompere il momento. «È stato quando ho sbollito la rabbia per quel tuo... Per quel tuo darmi del vigliacco che ho capito che avrei potuto amarti per quello. Per aver avuto il coraggio di dirmelo in faccia» contrasse le labbra, l’orgoglio che cercava invano di trattenere le parole. «Sei stata più forte di me e questo io lo ammiro e lo rispetto.» «Io ho pensato la stessa cosa quando mi hai tirata fuori da lì.» «Anche se non avevo ancora veramente capito perché fosse così importante per te» mi interruppe lui, parlando rapidamente e bloccandosi di colpo alla fine, quasi con rammarico. «Cioè?» domandai io, improvvisamente tesa. Alexei dovette avvertirlo. La sua mano meccanica scivolò nella mia, ma ormai non ne avevo più ribrezzo: ora era tiepida e sapeva dell’aroma di Gaia, mio e di Alexei. La strinsi senza pensare e l’onda elettrica del mio gesto viaggiò attraverso i circuiti meccanici fino alla placca del trasformatore e poi ancora, nei nervi e al cervello, vibrando come corrente e chimica insieme. Lui reagì con un sibilo, come se il mio semplice gesto avesse potuto ferirlo, e ruotò sul fianco sinistro, allungando la mano di carne verso il mio seno. Lo sfiorò appena e poi si infilò nell’incavo, dove rimase. In silenzio, trattenendo il respiro. «Il tuo cuore» disse, in un sussurro timido e debole alla fine. «Sappi che non mi importa se corre dalla parte sbagliata, se lo fa per me solo.» Orbita di Eris, 4° di Solaria, 24/10/2289 Da quel momento non ci furono più segreti. Come potevo averne? Alexei aveva capito.
Quella notte non mi fece altre domande e io non gli diedi alcuna risposta: sarebbe venuto il tempo per la curiosità, ma in quel momento non aveva senso. Libera, lasciai che mi cingesse fra le braccia e mi abbandonai lì, sicura che non avrei avuto nulla da temere. Da allora facemmo coppia fissa. Nessuno di noi fu diretto a riguardo e, nonostante il mio tentativo di ignorare il bisogno di Alexei, alla fine nessuno dei militari fu troppo sorpreso di scoprirci insieme. Gli esseri umani hanno il dono di capire molto bene i loro simili tanto da anticiparli, talvolta, e in questo sono sorprendenti. Io non diedi comunque alcuna spiegazione e Alexei raccontò fin troppi dettagli, così il pettegolezzo durò poco, lasciandomi priva della mia stupida notorietà e ripiombandomi ancora nelle frecciate allusive sul mio folle rifiuto di un braccio meccanico. Poi successe. Ricordo che stavo controllando il movimento di una delle nuove mani, appena impiantata a un ragazzo, quando mi mandarono a chiamare. Codice rosso, richiesta di soccorso immediato nel padiglione medico militare. Arrivai, chiedendomi perché un ufficiale scientifico fosse stato chiamato per una crisi ordinaria e dicendomi che forse gli alieni – gli Harad avevano cominciato a esserlo anche per me, sebbene cercassi di ignorarlo – dovevano aver attaccato e lasciato sul campo un disastro che l’ospedale cittadino non poteva contenere da solo. Ero pronta ai cadaveri, al sangue e alla sofferenza, ma non a lui. Alexei. Disteso su un lettino e con la camicia bianca macchiata da una sola, ampia chiazza di un rosso troppo scuro, quasi nero. Diverse voci cominciarono ad aggiornarmi tutte insieme. Dissero che era da cinque giorni che il Colonnello era ricoverato nel presidio medico dell’ accampamento nella zona delle miniere, affetto da dolore. Scansai le parole e gli infermieri e mi avvicinai a lui, tastando con la mano il suo volto bollente, chiedendo cosa fosse successo e dove fosse la ferita. Qualcuno, dietro di me, disse che non era stato colpito. Qualcun altro biascicò qualcosa su un veleno, ma io avevo già capito. «Da quanto senti dolore?» chiesi ad Alexei mentre cercavo una siringa con la mano, senza guardare cosa facevo o quali oggetti delicati stessero cadendo per terra a causa mia. «Definisci dolore» biascicò lui, ironico. «Non metterti a fare lo stronzo adesso. Dolore. Fastidio. Un bruciore sordo a livello della piastra o...» sollevai il capo al soffitto e chiusi gli occhi, cercando di trovare le informazioni fra il caos e la paura che avevo in testa. «o un formicolio insolito. Una leggera aritmia, la pesantezza degli arti, un colorito anomalo...» «Ho capito. Tranquilla» Alexei cercò di sollevare il braccio meccanico, ma desistette quasi subito con un gemito. «Sette mesi» confessò, abbassando la voce. Era affannato, come se parlare gli costasse un’enorme fatica. Io lo guardai, atterrita. «Non fare quella faccia. Poteva essere qualunque cosa.» «Qualunque? In sette mesi il tuo... Il tuo sistema...» Scossi la testa, scacciando via le immagini e cercando la calma. Un’infermiera mi toccò una spalla, facendomi cenno di passarle la siringa. Lo feci e la osservai prelevareun campione di sangue, la mente che sfogliava pagine e pagine di appunti alla ricerca di una soluzione. «Già da tre mesi dovresti aver cominciato a sentire un dolore lancinante nell’addome e al petto, il segno del cedimento dei tuoi organi interni. Ora i polmoni...» «Potresti smettere di dirmi cose che so?» sbraitò Alexei, squadrandomi con quell’odio che celava il suo senso di colpa. Lo sguardo di un bambino sorpreso a barare durante un’esame. «Come ho fatto a non accorgermene?» dissi, a voce bassa, e questo parve demoralizzarlo ancora di più. «Mi passava delle droghe» si scusò, indicando con un cenno delle dita uno dei dottori venuti con lui dal pronto soccorso militare. Io mi girai di scatto, fulminando il ragazzino con gli occhi, mentre Alexei mi stringeva il polso, dolcemente. «Lascialo stare. Ne prendevo parecchie anche prima, comunque. Il deserto non è un posto salutare per nessuno.» «Antidolorifici oppiacei. Con regolare prescrizione del capo medico militare» si giustificò il giovane, sollevando le mani davanti a sé come per proteggersi. Troppi testimoni, pensai io, annotando il suo volto per il futuro. «Perché non me l’hai detto?» ringhiai invece, tornando su Alexei. «Cosa sarebbe cambiato?» lui sollevò le spalle e contrasse il viso, morsicandosi il labbro fino ad inciderlo. Pensai che il dolore doveva aver raggiunto un livello tale che solo una dose massiccia di oppiacei avrebbe potuto attenuarlo... Sempre che già non si fosse assuefatto. Lui strinse il pugno della mano meccanica e la distese, cercando di sorridere. «Dovresti averlo già capito. Io non sono forte come te.» Io guardai quel pezzo di metallo che era il suo sogno e mi resi conto, con incredibile lucidità, che era proprio quello che lo stava uccidendo e che ero stata io a dare il via a tutto questo. Allora dominai l’impulso, forte e violento, di strappare via quel braccio e farlo a pezzi, perché non sarebbe servito ad altro che a umiliare Alexei. «Andrò a fare delle analisi. Potrebbe... potrebbe non essere troppo tardi, ancora» dissi. Ma sapevo che non era così. Avevo studiato tutto di quella tecnologia, dannazione! I tempi di risposta, le complicazioni, lo sviluppo dell’avvelenamento. Come potevo mentire così a lui? A me? «Và a giocare. Io non mi muovo da qui» mi rassicurò lui, riuscendo finalmente a completare quel sorriso doloroso che voleva essere coraggioso. Che nascondeva la sua paura.  Piccolo spazio-me: i credits > Las-t (passate a rifarvi gli occhi)
Fatemi sapere che ne pensate della storia: ci tengo! |
Capitolo 5
*** Periferia di Saturno, 8° di Solaria - 24/10/2289 ***
 La stirpe di Agena
 Just when I'm feelin like I'd made it through And still had somethin that they never knew The artificial is controllin me And I dont' recognise the thing I see Proprio quando mi sto sentendo come se ce l'avessi fatta E ho ancora qualcosa di cui loro non sono mai stati a conoscenza L'artificiale mi sta controllando E io non riconosco le cose che vedo (Every Day, Planet Funk)  Periferia di Saturno, 8° di Solaria,
24/10/2289 La nave è ferma da tre ore. A fare rifornimento, dicono, ma non accennano mai di cosa.
Minerali radioattivi, carburante, persone? Non lo so. Non voglio saperlo, a dire la verità. Per la prima volta da quando la nave ha lasciato Agena mi sento bene. Devono aver aggiunto qualcosa al mio pranzo, anche se avevo dato espresso ordine di non ricevere più Drez... Ma cosa potevo aspettarmi? Sono troppo indispensabile per poter essere libera di scegliere. Alexei lo troverebbe ironico. Dove ero rimasta? Ah, l’avvelenamento. Analizzai il sangue di Alexei e poi convocai un consiglio militare e medico, che si riunì in meno di mezz’ora. Riferì loro come stavamo le cose: i fluidi che muovevano il braccio meccanico avevano infettato il sangue di Alexei, avvelenandolo lentamente. Come fosse stato possibile non potevo dirlo con certezza: la piastra si era corrosa? Un connettore si era forato? Lo sforzo eccessivo e il calore avevano danneggiato la struttura di rivestimento? O forse, semplicemente gli esseri umani non erano compatibili con le macchine. Quello che contava era che quei prototipi erano potenzialmente dannosi per chi li aveva. Avremmo dovuto controllare anche gli altri soldati, vedere se mostravano segni dell’avvelenamento e cominciare a lavorare su un antidoto – o pensare alla dismissione del programma. «Dovremmo iniziare dall’autopsia del Capitano Rubjakov. Capire cosa non ha funzionato e se era un difetto dovuto al prototipo obsoleto, a un errore nel montaggio o alla macchina in sé» disse qualcuno ad un certo punto. Sembra assurdo ma non ricordo chi fosse; solo la frase mi rimase impressa – mi colpì quasi a morte, a dire il vero. «Avete già deciso che sia spacciato?» gridai, ritrovandomi in piedi. Avevo un polpaccio che mi bruciava, probabilmente a causa del gesto brusco e della tensione che fino a poco prima avevo ai nervi, ma non me ne curavo. Sentii qualcun altro dire che una dose letale di oppiacei sarebbe stata la soluzione più umana, a giudicare dai risultati degli esami medici. Li guardavamo in tempo reale, proiettati dal soffitto sul tavolo da riunioni, e non erano buoni. Non erano compatibili con la vita, in effetti. Doveva già essere morto. La speranza è irragionevolezza. Allontanai la sedia e lasciai la riunione, certa che niente di quello che avrebbero detto da quel momento in poi avrebbe potuto interessarmi. Nessuno mi fermò, nemmeno quando sbattei fuori le infermiere dalla piccola sala in cui era stato portato Alexei. Pensavano che fosse giusto per me avere un attimo per dirgli addio da sola. Era un bene. Io non avevo alcuna intenzione di lasciarlo andare: avevo una soluzione, drastica e rischiosa, ma l’avrebbe salvato se l’avesse accettata. «Stai per morire, stupido eroe vigliacco» gli dissi all’orecchio, con dolcezza, mentre abbassavo a zero il dosaggio di antidolorifico. La sua carne, corrosa e demolita dal veleno, aveva una sfumatura violacea e cominciava a mandare un odore greve e acidulo, ma io non vedevo né sentivo nulla più che il suo respiro che continuava, intermittente ma vivo. Alexei mi rispose con una smorfia che poteva essere un “mi dispiace” come un “che vuoi, sono fatto così” e io lo accarezzai, piano, sentendo il sudore freddo sulla pelle bollente. «Posso salvarti.» La sua gola ebbe un guizzo, ma non diede altro segno di aver capito. Io continuai ad accarezzarlo e ripresi a sussurrare, dolcemente, cercando di scegliere le parole con cura: frasi semplici, che il suo cervello martoriato dalla febbre e dal veleno non dovesse faticare a capire. Ne andava della sua vita. «Sai chi sono. Sai da dove vengo. Ma quelli come me... gli Hadar, gli alieni... noi veniamo da tanti posti. Piccole lune, planetoidi che ruotano intorno ad Agena. Il mio... la mia casa natale è un pianeta buio e velenoso. Ma noi ci viviamo, capisci? E per questo siamo immuni alla maggior parte delle sostanze che uccidono gli altri esseri viventi. Veleni, radiazioni, onde e raggi...» non sapevo perché quelle informazioni mi sembrassero tanto vitali, ma in quel momento non pensavo di star perdendo tempo. Mi rendevo conto che ogni respiro era uno in meno, sottratto ai pochi che gli rimanevano, ma avevo bisogno che sapesse. Doveva accettarlo, completamente, perché se così non fosse stato avrei solo guadagnato tempo. Io volevo salvarlo, non allungare la sua agonia. «La nostra immunità è un dono per i nostri fratelli Hadar. Noi possiamo condividerla. Possiamo condividere la resistenza alla decadenza tramite il nostro sangue» Alexei distese ancora di più le labbra e sussurrò un «Ok» stentato. Io scossi il capo. «Se fossi venuto da me anche solo tre mesi fa, sarebbe bastata una trasfusione regolare per salvarti la vita. Ora, se anche sanificassi il tuo sangue, cosa cambierebbe? I tuoi organi interni stanno marcendo» «Bella imma... gine» disse Alexei, storcendo le labbra secche e pallide. Io salì alla testa e gli spostai i capelli su un lato, com’era solito fare lui, e ripresi a parlare. «Ma c’è un altro modo. Un altro... un altro dono che possiamo condividere. Ma è rischioso per entrambi. E tu devi accettarlo, accettarlo interamente e completamente, perché se non lo fai prima o poi lo rigetterai, e allora sarà la fine per entrambi. Mi capisci?» Lui annuì appena. «Dobbiamo unirci in un matrimonio Hadar» dissi, seria e timorosa insieme. Assurdamente, Alexei trovò la forza di ridere. Fu un suono gutturale e spezzato, che si spense quasi subito in tosse e gemiti di dolore. «Non... dovrei essere io a... pro... proporre...» «Non è come per gli umani. Gli Hadar intendono il matrimonio come un’unione tra anime oltre che tra corpi. Un’unione fisica e tangibile, non una vuota serie di parole e promesse. L’anima... esiste e non è altro che una forza, energia condensata. Ed è quell’energia a mandare avanti il corpo e la mente. Noi siamo un popolo che ha studiato come plasmare l’energia e usarla... usarla per sopravvivere. Per fare arte. Per commerciare. Come voi con plastica e metallo» «Magia?» domandò lui, affascinato nonostante tutto. «Non più di quanto lo sia la fusione nucleare o... o la corrente elettrica, o un microonde! L’energia è concreta come qualsiasi altra cosa, se la si sa osservare e lavorare. Solo che ci sono delle complicazioni. Dei rischi. Se ora io... se noi celebriamo delle nozze Hadar, ora, la mia energia e la tua si fonderanno in un’unica essenza. Potremmo scambiarci informazioni con la stessa facilità con cui le scambiano con noi stessi, e lo stesso varrebbe per malattie e debolezze. Come... come il materiale genetico dei fluidi corporei o le malattie sessuali, quando si fa l’amore, per capirci. Io sono sana e forte: potrei guarire la tua debolezza e quella del tuo corpo, perché tu saresti parte di me. E tu potresti fare lo stesso. Potrei usare la mia capacità di... di rigenerarmi in fretta, di vincere la morte e di curare me stessa per aiutarti a riprenderti, e allora anche il mio sangue potrebbe essere d’aiuto. Ma l’unione funziona anche al contrario: se io non dovessi riuscire a guarirti, se la mia energia non fosse abbastanza, moriremmo entrambi, consumati dalla tua debolezza, dalla tua morte. E comunque, se riuscissimo a salvarti, tu diventeresti molto simile a me. Saresti in parte Hadar, un alieno. Uno di quelli che stanno distruggendo il tuo mondo. E lo saresti per sempre, senza alcuna possibilità di tirarti indietro o di unirti a un’altra persona» spiegai concitatamente, abbassando il tono alla fine con un moto di insicurezza. Come poteva farmi paura il fatto che potesse rimpiangere questa scelta, un giorno? Come potevo essere così egoista da mettere il rischio di abbandono davanti alla sua vita? «Puoi...? io sono già...» cominciò lui, ma lo fermai prima che lo dicesse. Prima che anche lui cominciasse a credere di non avere più speranze. «Se ci sbrighiamo, forse.» «Io non ho... anelli» disse lui, cercando ancora una volta di alzare le spalle e sorridendo. Io presi un respiro profondo, sentendo che non avrei potuto perderlo, non ora: lo stavo amando per non aver esitato, per aver ancora una volta avuto fiducia in me e nelle mie capacità. Aveva accettato qualcosa che era possibile solo nelle mie parole, qualcosa che lo avrebbe privato della sua preziosa umanità, senza chiedere altro. C’era forse altra prova che potesse darmi della sua devozione? «Me lo comprerai poi. Un bell’anello, di quelli che ti costano un braccio. Ma ora rilassati e sta zitto. Ho bisogno di concentrarmi: non l’ho mai fatto prima.» Lui rise e chiuse gli occhi, esponendo alla luce il viso e le macchie scure che vi si allungavano. Io presi una siringa e cominciai a cercare un buon punto in cui inserirla. Non racconterò altro. Se avete mai celebrato le nozze Hadar sapete bene che è un momento talmente intimo che, a confronto, fare l’amore davanti a una folla assume lo stesso peso del bere una tazza di Drez in un bar. E, nel caso non abbiate ancora trovato una persona della quale vi fidiate abbastanza da concedergli la vostra stessa esistenza, immagino che non capireste comunque il significato dei gesti e delle parole, dei movimenti e del rituale. Posso solo dire che, per un istante, tenni l’essenza di entrambi nelle mani e fu insieme esaltante e terrificante: possedevo Alexei e me con un’intensità che non so spiegare, e avrei potuto plasmare le nostre esistenze – sogni, desideri, obiettivi – con un solo gesto, rendendoci degli esseri completamente diversi. Poi tutto finì e io mi alzai, debole e nuova. Aprì la porta, decisa ad affrontare ora la folla che avrebbe desiderato assistere al miracolo, e risposi infine alle loro domande nascondendo quella poca forza che mi restava e traendo conforto dal respiro sempre più deciso di Alexei, e dalla vita rinsaldata che sentivo scorrere anche dentro di me. Ci furono medici che vollero ripetere immediatamente gli esami e ufficiali smaniosi di carpire il segreto della mia cura e usarlo sulle altre cavie. Li ricacciai tutti, dicendo che ora non avrei avuto la forza di parlare che un prelievo di sangue dal paziente era impossibile. Dissi che avrei spiegato ogni cosa appena mi fossi ripresa. Dissi che avevo tentato e avuto successo, ma che ancora non sapevo se sarebbe durata. Poi mi feci portare una branda e chiesi loro di lasciarci soli, a riprenderci. Prima di cedere alla stanchezza e al bisogno di ricostruire quella parte di me danneggiata dalla morte che avevo ricevuto da Alexei, mi allungai verso colui che ora era, senza falsità, l’altra parte di me e gli diedi un lungo bacio, assaporando la sensazione di sollievo che saliva da entrambi. Dormii per circa due ore, il tempo massimo che i miei colleghi poterono sopportare di attendere. Quando si presentarono nella stanza, mi offrii di fare il prelievo ad Alexei e di portarlo al laboratorio. «Voglio essere io stessa ad analizzare i risultati e studiare i risvolti della mia soluzione» dissi, ma la realtà era che chiunque avesse avuto a esaminare quel sangue avrebbe scoperto la verità. Qualcuno doveva anche averci pensato, credo. I test furono ripetuti e i risultati discussi da tre diversi dottori nei giorni seguenti, che arrivarono alla stessa conclusione: il paziente sembrava essere miracolosamente guarito. Non c’era traccia di – e cito letteralmente – “alcuna sostanza sconosciuta nel campione ematico”. Non poteva essere altrimenti, dato che quel sangue proveniva da una delle nostre riserve per le trasfusioni. Quando venne il momento di spiegare, dissi che avevo provato a iniettare una miscela di farmaci e anticorpi che avrebbe dovuto combattere le principali tossine, sapendo che al peggio avrei accelerato la fine; mostrai loro le fiale che ritenevo più credibili e le azioni che avevo compiuto nelle cinque ore che avevo passato con Alexei, in una sequenza teoricamente logica e praticamente assurda. Dovettero credermi. Come potevano spiegare altrimenti la guarigione miracolosa? Mi dissero che avrei dovuto controllare anche gli altri militari con protesi, preparandomi a trovare una soluzione altrettanto brillante e meno invasiva se i problemi si fossero ripresentati: lo stato maggiore aveva in programma di vendere la tecnologia anche ad altri Paesi e, date le cifre che preventivavano, doveva essere almeno perfetta. Pienamente convinta delle mie parole, io li assicurai che non avrebbero avuto problemi e che, già dal giorno successivo, avrei iniziato a lavorare. Parlai delle mie idee e inventai di sana pianta soluzioni che non potevano capire, quindi li congedai con gentilezza e fermezza. Con le mie utopie avevo strappato il permesso di portare Alexei con me fuori dal campo, quel pomeriggio, e l’avrei sfruttato. Non cominciai mai a lavorare sulla cura. Quella notte gli Hadar attaccarono. Sorpresero la città quando era più vulnerabile, all’alba: comparvero ad Est, sette piccole navi oblunghe nascoste dai raggi rossi del sole, e fecero piovere fasci di luce incandescente sulle strade, incendiandole. Ricordo che ero con Alexei a letto quando la fine cominciò: avevamo fatto l’amore fino a cadere sfiniti l’uno fra le braccia dell’altra e riposavamo così, inermi e assurdamente sicuri. Poi una vampata di calore ci investì. I muri cominciarono a scottare e le persiane si incendiarono, accese dalla sola onda di impatto. Noi corremmo via, la pelle rossa e coperta di sudore che gridava, e scendemmo in strada nudi e lucidi. Nessuno badò a noi. La gente scappava in tutte le direzioni, spintonandosi nel tentativo di salvarsi la vita. All’orizzonte una macchia di fumo si alzava, rossa e trafitta dal sole nascente, imbrattando la parte di cielo che copriva la base militare. Io presi a correre e Alexei mi trattenne, stringendomi il polso con la mano metallica e indicando il cielo con l’altra. Allora li vidi e capii. Le navi avevano individuato il forte e lo stavano radendo al suolo. Lampi di luce cadevano dall’alto, contrastati dal tuono sordo dei proiettili e dei missili che si levavano da terra. L’impatto delle armi creava strane ondate di vento caldo, che facevano danzare attorno a noi una polvere che sapeva di morte. Rimanemmo fermi per un tempo irragionevolmente lungo; poi qualcuno ci urtò, facendomi perdere l’equilibrio. Caddi a terra, sentendo il fondoschiena scaldarsi e i piedi ustionati ringraziare, e Alexei si chinò e mi prese fra le braccia prima che potessi alzarmi da sola. Mi trasportò via, ignorando il mio muto grido a correre verso il forte, verso i difensori che conoscevamo e gli attaccanti da cui volevo tornare. Non possiamo, continuò silenziosamente a ripetermi mentre mi trascinava verso uno degli ingressi ai rifugi e poi giù, lungo rampe di scale polverose e sottoterra, in gallerie buie e in disuso. Qualcuno ci diede una coperta da dividere e una storia da ascoltare per dimenticare i tonfi e le vite che si consumavano sopra la nostra testa, ora dopo ora. Io ascoltai in silenzio ogni cosa, registrando dolorosamente ogni istante – per me sola, stavolta. Pian piano i rumori scemarono. Aspettammo finché non parve assurdo rimanere ancora fermi e poi ci alzammo, seguendo la folla come due civili qualunque. Emergemmo solo per trovare una città ferita e semivuota: niente cadaveri, niente sangue, solo rovine e polvere. Troppa polvere. Taraz sopravvisse cinque settimane. I soldati rimasti istituirono un coprifuoco e trasportarono viveri e medicinali sottoterra, dove gli umani si sentivano stranamente al sicuro. Gli attacchi si ripetevano con la costanza di uno ogni due giorni, all’inizio: sempre più navi per raid veloci, che sfoltivano una popolazione già allo stremo, regalandoci polvere. Altro deserto, inarrestabile. Le foto degli scomparsi fiorivano numerose dopo ogni sortita: immagini di persone di tutte le età e le razze, ritratte nei momenti felici che avevano ritagliato in una vita di paura. Io le osservavo adornare i muri dei palazzi e le pareti della rampa per scendere nei rifugi, pensando che c’era una sorta di macabra bellezza in tutti quei volti persi, per sempre legati ai luoghi della vita e a un sorriso dimenticato. Intrappolati in un eterno momento felice. E mentre noi ci estinguevamo, gli alieni aumentavano. Poi accadde. Un attimo prima io e Alexei eravamo stesi l’uno accanto all’altra, a parlare di segreti e pericolo; un attimo dopo le pareti della casa esplosero in polvere e io mi trovai in strada, ferita e sola. Intorno a me, i raggi Hadar disegnavano arcobaleni intermittenti che segnavano la retina, stampandosi come fulmini sul nero della notte. Accecanti, violenti, feroci. Alexei gridava. Mi disse di correre, mi trascinò e poi mi spinse. Ricordo il calore della sua mano sulla schiena e poi solo la polvere e il rumore, il disorientamento e quella sensazione di paura che avevo imparato ad associare ad Agena. Quando mi voltai, finalmente al riparo nel sottosuolo, Alexei non c’era più. Orbita di Saturno, 8° di Solaria, 24/10/2289 Vedo nella mia testa i ricordi, nitidi come se ancora vivessi in quel mondo. Rievoco immagini e colori, odori e suoni. Emozioni. Cercai Alexei con tutta la forza che avevo. Lo cercai per ventitré ore, sette minuti e cinquanta secondi precisi. E, in quel tempo, Taraz tirò il suo ultimo respiro. La fine della mia ricerca coincise con la morte della mia città. Calarono dal cielo, ancora. Scesero come una pioggia, centinaia e centinaia di Hadar coperti di tatuaggi serpeggianti e vestiti del tessuto blu elettrico dei soldati di Agena. Sfoderarono le armi e con un gesto delle dita distrussero Taraz, demolendola mattone dopo mattone. Io scesi in campo, decisa a morire con lei. Che altro mi restava, ancora? Agena mi aveva portato via Alexei. Durai meno di un battito di ciglia: loro erano in tanti, troppi, e le loro armi erano nuove di zecca. Dovevano aver conquistato ben più di un giacimento di rame, per aver potuto assemblare tutto quell’arsenale. Gaia doveva essere caduta, alla fine. E io con lei. Venni circondata per pura forza di numero e decisi che non ne valeva la pena. Non era mai valsa, probabilmente. Allargai il braccio e sollevai la testa, pronta a unirmi alle forze che governavano l’Universo – e lo vidi. Alexei. Che mi veniva incontro, vestito di blu e con entrambe le braccia di carne tese verso di me. Il mio cervello si spense. I connettori di biomateriale persero segnale e io rimasi al buio, incapace di comprendere. Docile, svuotata, sentii che Alexei spiegava cos’ero e mi tirava via, dicendomi che andava tutto bene. Che sarebbe finita presto. Orbita di Giove, 9° di Solaria, 24/10/2289 Tre balzi in sette minuti! Per l’Universo, finirà mai questo viaggio?
Orbita di Marte, 10° di Solaria, 24/10/2289 Il comando mi avverte che mancano meno di venti minuti all’atterraggio. Sto male, ma sono forte – e devo finire. Me ne pentirò per tutta la vita, se non lo faccio.
Dunque, Agena, di nuovo. Un viaggio di due giorni-standard attraverso l’iperspazio, che tollerai solo grazie ad Alexei al mio fianco. Fui fortunata, sapete? Quando gli ufficiali Hadar verificarono la mia identità, riconobbero il mio servizio e assegnarono a me e Alexei una cabina in uno dei trasporti più piccoli e più tranquilli. Gli altri, quelli che ancora non avevano scelto, finirono ammassati nella grande nave-prigione, un trabiccolo di Cjera dura e quasi morta sul quale erano stipati solitamente carichi inorganici. Non parlai molto durante la traversata. Il mio letto era di tessuto caldo e vibrante, il frutto dell’intreccio di materia ed energia grezza che era il vanto della mia genia, e io ero stanca e nauseata. Chiesi di dormire e fui accontentata. Tornai su Agena con la stessa apatica tensione che si ha nei sogni. Osservai i lucidi edifici bianchi in Cjera e ascoltai il loro sommesso respiro, assaporando l’aria immobile e limpida dell’eterno tramonto del mio pianeta e tentai di immaginare la mia vita come lo era stata quattordici anni prima. Il bisogno di camminare annullato dalle passerelle nascoste, i quadri di comando che si aprivano nell’aria al solo tacco delle dita, i piccoli congegni da applicare al polso per materializzarsi altrove o chiamare a casa. Il sospiro elettrico e vibrante dell’aria, degli edifici, degli abiti e nostro, sincronizzato su un’unica frequenza. E io, vestita di un’anonima tuta da lavoro. Ancora. Chiusi gli occhi e andai d’istinto. Toccai il bracciale al polso di Alexei e sentii la vibrazione che annullava e ricostruiva ogni nostra più piccola cellula in un luogo lontano attraversarmi per meno di un secondo, prima che gli odori della città si trasformassero in quelli di un luogo chiuso da troppo tempo, impersonale e asettico. Casa mia. «Pensavo che vivessi su una luna, non su Agena» fu il solo commento di Alexei. Si era abituato alla sua nuova realtà con una naturalezza che mi spaventava, considerato il fatto che io, Hadar dalla nascita, non riuscivo a trovare la via di casa con altrettanta facilità. «Vivevo. Il mio planetoide natale è stato distrutto quando ero piccola.» «Dagli umani?» domandò con indifferenza lui, lasciandosi cadere su uno dei miei divani. «Dai nemici del tempo. Quando si è così grandi la guerra trova sempre il modo di raggiungerti. E noi sembriamo attirarla come se fosse un insetto molesto» commentai, aspra. Alexei si alzò di scatto, come rispondendo a un ordine, e si mise a gironzolare per casa, evitando il mio malumore. Io guardavo lui e il luogo che una volta era stato mio – bianco, lucido, pulito, inodore – e mi chiedevo come potevo sentire così tanto la mancanza di una stanza povera, scura e polverosa. «Quindi ora questo posto è nostro» commentò Alexei, rompendo il silenzio che si era allargato. Doveva percepire anche lui la tensione, dato che si sforzava di essere allegro. «Si, anche se non capisco perché. Mi davano per morta.» «No. Non era una domanda, ma un’affermazione» rise lui, tornando verso di me con un sorriso sereno. «Hai parlato con qualcuno per... per la riassegnazione?» «Era il minimo che potessero fare per te. Sei stata preziosa per loro, e ancora non gli hai rivelato nulla di quello che hai imparato» Alexei mi avvolse con le braccia e affondò entrambe le mai nei miei capelli, stringendosi a me. Potevo sentire il suo cuore accelerare mentre la convinzione che tutto fosse a posto, finalmente, cominciava a farsi largo in lui. «Non credo che ci fosse stata molta richiesta per questo posto. Sembra abbandonato da... da quando l’ho lasciato» provai a scherzare io. Alexei rise, ma non accennò a lasciarmi andare. Un nodo di tensione, elettrica e pesante come pietra, scese a livello del mio stomaco e io avvertì che c’era qualcosa che lui mi teneva nascosto, qualcosa che ancora lo preoccupava. «Che mi devi dire, Alexei?» «Tra poco verranno qui e ti spiegheranno loro. Io non so molto più di te» mi disse, allontanandomi e abbozzando uno dei suoi strafottenti sorrisi umani. Non gli riuscì che una misera ombra di quel vezzo umano, ma non mi sarei aspettata nient’altro, dopo le nozze. «Combattevi per loro» dissi, pensando che fosse il momento buono per affrontare l’argomento. «Era giusto così» tagliò corto lui, invece, muovendosi per girarmi le spalle e ripensandoci all’ultimo. Io rimasi in silenzio, aspettando che avesse il coraggio di andare avanti. Non lo fece. Si limitò ad avvicinarsi ancora e prendermi il volto fra le mani, guardandomi come un fedele che stesse recitando una muta preghiera. «Perché tutto mi sembra così estraneo?» sussurrai io, amareggiata. Alexei assunse un’espressione dispettosa e mi soffiò in faccia, un refolo che non aveva nessun odore. Un altro briciolo della sua umanità persa. «Scommetto che, dopo aver inaugurato questa casa insieme, non sentirai più tanto la mancanza dell’altra» attaccò, lasciando scivolare le mani lungo il mio collo e più giù ancora. «Se vuoi, possiamo cominciare anche ora» disse, malizioso, avvicinando le labbra alle mie. Non gli avrei detto di no, questo è certo: umano o Hadar, provavo sempre una forte attrazione per lui. Lo cinsi con il braccio e lo attirai a me nell’esatto momento in cui il trillo melodico del campanello di casa cominciava a squarciare l’aria. «Maledizione» fede Alexei, staccandosi. Aveva di nuovo quello sguardo preoccupato, ora. Io feci per muovermi ma lui mi fermò, indicandomi con un cenno della testa e dell’anima di restare dov’ero. «No, tranquilla. È il tuo momento. E io non sono invitato» disse, spostandosi i capelli lunghi e scuri a sinistra della testa. Fu allora che lo vidi: la parte destra del capo, rasata, era coperta da una fitta tela di tatuaggi da impianto, che gli abbracciavano il collo e il primo tratto della spina dorsale. Anche la parte visibile del polso sinistro mostrava tratti di colore più scuro – i segni dell’intervento. «Quando...» cominciai a domandare, ma le immagini della cattura di Alexei mi scorsero nella mente senza che io le avessi evocate. Esplosioni. Polvere. Grida e un fascio di luce troppo calda. Gli occhi accecati, la gola in fiamme, il respiro rotto. Una stanza bianca. La paura, il gelo dell’ago nella vena, la pace. Accettazione. Ne stavo ancora venendo a patti quando entrò un Nobile. Lo riconobbi dagli occhi, gialli e brillanti, e dal colore rosso con cui erano marcati gli impianti; allora scattai in piedi, assecondando un impulso radicato. «Riposo, soldato» mi disse il Nobile, perentorio. Aveva una voce alta, di quelle che fanno male alle orecchie, e un corpo troppo massiccio. Io mi lasciai andare su un divano e lui richiamò con un gesto nell’aria i comandi della casa, selezionò una sedia di energia e la acquistò senza battere ciglio, attende meno di un secondo che questa sorgesse dalle Cjera del pavimento. «Le consegne sono sempre più lente in periferia» commentò il Nobile. Si sedette con un gesto flemmatico e misurato e lasciò che il fascio semitrasparente gli si assestasse intorno prima di riprendere. «Immagino che sia anche la disabitudine. Questo quartiere è rimasto vuoto per parecchio tempo.» «Solo i soldati vivono da queste parti» convenni io, ragionevole – e poi decisi che non ne valeva la pena. Ero stanca. «Cosa siete venuti a offrirmi per il mio silenzio? Non una sedia e una casa da quattro soldi, spero.» «Si spieghi, soldato» disse lui, il tono che voleva essere condiscendente e sorpreso, ma che sembrava solo seccato. Io decisi di ignorarlo e presi a seguire il filo del mio pensiero. «Gli occhi, Signore. È tutto lì il trucco, vero? Gli occhi.» Spostai il viso in avanti, spalancando i miei. «Occhi verdi. Da cittadina comune, da provinciale, da figlia dei planetoidi minori. Ma non è solo questo, vero?» Il Nobile non rispose. Aveva irrigidito la schiena, adesso, e assottigliato le palpebre, oltre le quali i suoi occhi gialli mi intimavano di tacere. «“Hai gli occhi di tua madre, bambina mia” mi diceva mio nonno da piccola. E io mi sentivo così triste per questo. Ogni volta che mi guardavo allo specchio pensavo a lei, all’entità familiare e misteriosa che mi aveva generato, e piangevo accorgendomi che non avrei mai potuto verificare di persona se quel che diceva il vecchio era la realtà o no. Non avrei mai conosciuto mia madre, perché mi era stata portata via dalla guerra.» «Una storia senza alcun dubbio drammatica, soldato, ma non molto dissimile da quella di centinaia di altri Hadar. Dovrebbe questo darti diritto a un trattamento di favore?» «Oh, no di certo. Doveva solo darmi la spinta giusta per scendere in battaglia, e così è stato. Il pensiero di quello che avevo perso mi ha spinta verso l’esercito e il miglioramento continuo, in una folle corsa per prepararmi a questa guerra. Ditemi, Signore, ce ne sono mai state altre prima?» Il Nobile fece per parlare, visibilmente a disagio, ma io sollevai la mano e lo bloccai, intimandogli con quel gesto di tacere e mettendoci tutta la rabbia che avevo. «No. Lasci stare. Sarebbe una verità a metà, e io ne so anche troppe. Non mi interessa. Voglio solo che sappia che la smania della guerra mi è passata, ma che ho ancora tanto odio dentro. Perché io ho visto mia madre alla fine, Signore. Lo sa questo, vero? L’ho vista e le vostre bugie non mi hanno permesso di riconoscerla in tempo per gettarmi fra le sue braccia e lasciare che mi dicesse chi sono veramente. Ma mi sono resa conto, adesso... ho capito. E lei non sa quanto mi sta costando trattenermi dal saltarle alla gola e prendere la sua vita come trofeo.» «Dove abbiamo sbagliato?» domandò secco il Nobile, fissandomi come una bestia pericolosa, la paura che gareggiava con l’ira sul suo viso. «Crede davvero che risolverò ancora i vostri problemi per voi? No, non funziona più così. Prima voglio che mi raccontiate cosa avete fatto a me e a tutti gli esseri umani che avete catturato. Voglio sapere di quale scelta parlava Alexei. E, se sarà così sincero da meritarsi il privilegio di uscire da questa stanza incolume, voglio una garanzia. Protezione, benefici, denaro. Per me e Alexei» dissi, risoluta. L’altro non batté ciglio, come se non si fosse aspettato niente di meno. «Il tuo fidanzato è al sicuro. Noi non uccidiamo i nostri simili.» «No. Ma tutti vi sono simili alla fine, vero?» «Touché» disse il Nobile, chinando il capo in un segno di resa. Poi sogghignò, accavallando le gambe con tranquillità. «Sai che questa parola ha origini umane? Uno dei tanti vocaboli coniati da una delle razze che ha abitato quella roccia spersa in un sistema solare desolato. È nata in un luogo sconosciuto, quella parola, e ha viaggiato di bocca in bocca fino a diventare di uso comune. Poi qualcuno da un altro luogo, da un’altra tribù, l’ha sentita e trovata piacevole, così l’ha portata con sé nella sua casa. E così è stato ancora e ancora: altre case, altre tribù, altro viaggi, finché c’erano abbastanza persone che ne conoscessero il significato da renderla universale. Ossia senza più un’anima. Tante influenze l’hanno spogliata, depredata, resa gioco per le masse... e il tutto senza che se ne rendesse conto. O che ne soffrisse. Ha avuto fama di gloria e ha viaggiato ancora, talmente tanto lontano che viene ancora usata da una razza diversa, secoli dopo che la tribù che l’ha ideata è stata cancellata e dimenticata. È tutto questo per cosa? Per non rimanere una goccia fra le altre. Per evolversi. Per migliorare» «Ma una parola non ha volontà sua.» «Nemmeno un neonato. Ma il suo scopo resta comunque quello di migliorarsi. Evolvere, crescere: due sinonimi. E se una sola parola può pesare talmente tanto da inserirsi in una cultura radicata e accrescerne la capacità di comprensione reciproca, allora cosa può fare un essere vivente e senziente?» cominciò a spiegare, assumendo l’atteggiamento seccante di un professore costretto a rispondere alle domande di una bambina particolarmente tarda. «Voi siete il nostro esperimento più riuscito. Siete la dimostrazione che due mondi diversi possono fondersi e migliorarsi a vicenda, contribuendo alla stessa grandezza in nome di un’ideale di patria e sicurezza.» «Bel modo per dire che avete rapito dei bambini umani, gli avete fatto il lavaggio del cervello e li avete mandati a combattere contro i loro fratelli e la loro stessa madre.» «Gaia non è mai stata vostra madre. Il grembo che vi ha generato e dimenticato può essere una madre anche solo paragonabile a quella che vi ha accolto, nutrito, amato e protetto?» «Che ci ha mentito. Quanti nonni amorevoli ci sono nella mente dei vostri esperimenti? Quante notti passate nella paura della guerra, quanti rimpianti, quanta muta nostalgia di un pianeta buio che non è mai esistito? È amore, questo? È protezione? Come potete anche solo pensare che si possa amare una madre che non ci ha mai accettati per quelli che siamo?» la mia pazienza stava decisamente finendo, minata dalle dure rivelazioni e dal tono accondiscendete del Nobile. «Agena vi ha accolti...» «E trasformati senza chiederci se fosse quello che volevamo. Avete cambiato la posizione del nostro cuore, per l’Universo! Avete aggiunto un dito alle nostre mani e manipolato il nostro patrimonio genetico perché diventassimo la brutta copia di voi Nobili. I veri Hadar, i veri alieni. Ma gli occhi... Gli occhi non avete voluto cambiarli, vero? Senza quelli come avreste potuto riconoscere le copie dagli originali?» «È stato questo, il nostro errore? Gli occhi?» il tono del Nobile era diventato improvvisamente stizzito. Senza volerlo l’avevo messo di fronte a un fallimento della sua genia e questo sembrava essere intollerabile, per lui. «Che avete fatto agli altri esseri umani?» ne approfittai io, continuando a colpire. «Quello che ora tu mi rimproveri. Gli abbiamo dato una scelta: vivere come rinnegati su un pianeta che sta morendo o scegliere di evolversi e dimenticare. E sai cos’è accaduto, soldato? La legge fondamentale dell’Universo ha trionfato ancora. Meno dell’un per cento degli umani ha deciso di rimanere tale. Gli altri si sono uniti a noi e sono rinati, evoluti e forti. Hanno deciso di scordare la loro casa e di abbracciare quella menzogna su cui tanto sputi. Ora hanno un passato migliore che li rende compagni, figli e genitori migliori. Esseri che guardano al futuro e al proprio miglioramento invece che a vivere fino a domani. E cosa c’e di male in questo?» Niente, pensai. Ha ragione. Ma non ero pronta a capitolare, non ancora. «E Alexei?» «Era già un Hadar. Tu l’hai fatto diventare tale, usando senza saperlo un processo che è molto simile a quello che ha trasformato te, un tempo. Noi abbiamo solo dovuto rimetterlo in sesto. Ora ha un braccio che non lo ucciderà e un corpo in grado di fargli superare tutte le più ambiziose sfide che potranno mai venirgli in mente. E ha te, ancora: tutto quello che è successo su Gaia è rimasto, solo la sua percezione di sé è cambiata. Ora, per quanto ne sa, lui è sempre stato un Hadar. E ti ha sposata non per salvarsi la vita, ma per amore. Non lo trovi più romantico e vero ora?» Si. Ma non potevo darglielo a vedere. «Come avete fatto a trovare la base militare di Taraz? Perché so che era ben nascosta» dissi con tono duro, cercando di mostrarmi ancora battagliera e di trovare una falla nella ragionevolezza che il Signore Hadar mostrava. «Lo sai» mi disse il Nobile, piantandosi un dito all’altezza dello sterno. «Energia. Quando hai celebrato le nozze Hadar, hai sviluppato un tipo di energia che ogni figlio di Agena sa riconoscere. Seguire le tracce, poi, è stato automatico» «Perché anche nella testa di Alexei c’è il Drez?» tentai ancora, cercando di trovare altrove un combustibile che mantenesse acceso il fuoco della mia rabbia. «Serve a stabilizzare la trasformazione. È in effetti l’unico motivo per cui inseriamo una componente emozionale forte nel vostro passato: ogni Evoluto deve assumere il Drez regolarmente, per evitare regressioni spontanee.» Io corrucciai la fronte e strinsi le labbra, ma non lo interruppi. Dovette prenderlo come un invito, dato che proseguì. «Tare genetiche. Errori comuni. La natura tende a limitarsi, a volte, ma l’Universo le è superiore e la combatte. La volontà, però, deve aiutarlo.» Lo capivo. Ero stata educata ad accettarlo, dopotutto. Il Nobile lo intuì e vidi sul suo volto l’espressione di chi sappia di aver vinto. «Credo che tu ora possa capire perché me ne sono rimasto qui ad ascoltarti. E perché sono sicuro che verrai con me, ora.» «Dove?» «In una delle nostre cliniche. Dobbiamo valutare quali danni ha provocato in te l’astinenza» tagliò corto e si alzò, indirizzando un gesto alla sedia, che si disattivò lasciando dietro di se solo un piccolo cerchio al suolo: la sua sorgente. «E poi?» chiesi io, con un groppo alla gola. «Poi ti offriremo un lavoro. Un bel lavoro, molto simile a quello che hai svolto su Gaia. Ufficiale Scientifico, con un grado maggiore e una nuova, bella uniforme, completa di una spada del metallo che preferirai.» «Ora ne avete a sufficienza, immagino» constatai, non così amaramente come avrei voluto. «Già. E tu ci aiuterai a trovare modi sempre migliori per utilizzarlo. Evoluzione!» tuonò il Nobile, estasiato. «La mia memoria?» «È fondamentale ai nostri piani. Non ti toccheremo, a meno che non sia tu a volerlo.» «Anche Alexei lo diceva» commentai, e poi cominciai a ridere. Fu liberatorio. Scacciò via i dubbi e mi schiarì la mente, lasciando che quel mondo una volta mio riprendesse a scorrere in me. «E le mie richieste?» «Sarai parte dell’élite. Potrai comprare da sola tutto quello che vorrai. E per la protezione... Noi Hadar siamo tutti figli della stessa energia. L’Universo e i tuoi fratelli baderanno a te come è sempre stato e come sempre sarà, finché tu e la tua genia sarete dei nostri.» «D’accordo» dissi solamente. Il Nobile si rilassò visibilmente, arrivando addirittura a sorridermi bonario, alla fine. Mi fece strada e attese paziente che salutassi con un bacio Alexei, poi mi prese per mano e attivò il congegno trasportatore al polso. Sentii una vibrazione e chiusi gli occhi, scacciando nel profondo quella parte rabbiosa e impaurita di me che mi gridava di non farlo. Che diceva che, se alla resa dei conti non fossi più stata una dei loro, nessun Hadar avrebbe mosso un dito per salvarmi la vita. E se la privazione del Drez mi avesse cambiata troppo da rendermi instabile o pericolosa, mi sibilava nelle orecchie quel piccolo demone, per colpa delle nozze Alexei avrebbe subito il mio stesso destino.  |
Capitolo 6
*** Orbita di Gaia, 11° di Solaria - 24/10/2289 ***
 La stirpe di Agena
  Everything I needed Everything I needed Every Day I know Tutto quello di cui ho avuto bisogno Ogni giorno lo so (Every Day, Planet Funk) Orbita di Gaia, 11° di Solaria, 24/10/2289 Eccoci alla fine.
Della storia, ma anche del mio viaggio attraverso lo spazio. Andai alla clinica e mi visitarono. Mi trovarono in buona salute e programmarono un intervento di ricostruzione del braccio sinistro per quel pomeriggio, assicurandomi che l’esercito avrebbe coperto tutte le spese. Non dissero nulla sulla mia dipendenza e io non chiesi, dando per scontato che non mi avrebbero regalato un braccio nuovo se avessero dovuto abbattermi. Uscii e trovai ad attenermi quelli che, poi, sarebbero stati i primi membri del mio staff tecnico. Mi consegnarono una nuova divisa e io mi trasferii a casa mia per indossarla, per poter allungare la mano sinistra alla spada decorativa e ritrovarmi. Ritrovare il Capitano Taissa Shaaren che aveva lasciato quella casa la prima volta, con le illusioni di una bambina solide come realtà. La sentii muoversi, dentro di me, e cominciai a sperare di aver lasciato tutto indietro. Fui stupida. Ero giovane e innamorata, senza una vera casa e in cerca di qualcosa che potesse essere reale. Lavorai. Sviluppai progetti. Ebbi tre figli, un maschio e le femmine, e due di loro avevano gli occhi di Agena. Né io né Alexei dicemmo mai a Jesahel che aveva lo sguardo di sua madre: le insegnammo la cultura del Drez e lasciammo correre, sentendoci più che sollevati quando lei non chiese. Alexei aveva saputo tutto. Come avrebbe potuto essere altrimenti? Eravamo uno, e io non volevo nascondergli nient’altro. Come me aveva capito e accettato, ritenendo che le parole del Nobile avessero più di un fondamento di ragionevolezza. E comunque ora eravamo su quella giostra, volenti o nolenti: quale beneficio avrebbe portato a noi o a Gaia fatto che ne scendessimo? In effetti io ero più utile per la terra da Hadar che da umana: grazie al mio lavoro, avevo creato aree protette e verdi per gli umani che vi abitavano e vegliavo su di loro, cercando di non interferire con la vita che avevano scelto di condurre. Avevamo vinto tutti, alla fine: e l’Universo aveva il suo equilibrio. La mia pace durò ventotto meravigliosi anni prima di incrinarsi: il doppio del tempo che avevo trascorso su Gaia, per fato o per beffa. Vedete, avevo sviluppato una singolare allergia al Drez che mi aveva costretta a interrompere quasi del tutto l’assunzione. Questo non sembrava aver avuto un effetto troppo negativo sul mio sistema: il cuore batteva ancora e io ero in grado di dominare me stessa con la stessa abilità con cui l’avevo sempre fatto. Poi, una mattina, sentii la mia anima fremere e mi alzai, cercando di capire cosa stesse accadendo. Ricordo solo che Alexei mi era accanto e si teneva il petto, ansimando; poi ero a terra, circondata dai resti distrutti di quella che era la nostra stanza da letto. Scintille di energia multicolore si levavano in onde intermittenti dai quadri appesi alle pareti – due riproduzioni della pittura di Taraz che avevo fatto stampare dai miei ricordi – e l’odore di sangue riempiva l’aria. A terra, con mezzo fianco squarciato, c’era Arkady, il mio figlio minore. Alexei era accanto a lui, con il braccio sinistro percorso dalle strisce irregolari e rosse delle mie unghie e un morso profondo sul collo. Entrambi mi guardavano con un misto di paura e delusione, indecisi se chiedermi aiuto o fuggire da me. Io li afferrai e ci portai nella clinica più vicina prima ancora di pensare davvero a cosa stessi facendo. Scoprii allora quali erano gli effetti dell’astinenza dal Drez. Il mio corpo e la mia anima, in bilico fra due realtà, aveva ceduto, disfacendosi: sarei invecchiata prematuramente – a ritmo sicuramente meno veloce di quello umano, ma decisamente prima di un Hadar – e sarei andata incontro a quei blackout violenti, durante i quali era impossibile prevedere il mio comportamento. Mi definirono “una creatura allo stato primordiale, senza ragione o sentimenti” e mi liquidarono con le loro scuse, dicendomi di non temere, che crisi come quella non si sarebbero per forza dovute ripete e che, se anche fosse stato così, la mia famiglia avrebbe di sicuro avuto il tempo di prepararsi adeguatamente alla prossima. Nessuna sciagura colpisce due volte di seguito lo stesso luogo, mi assicurarono. La mattina successiva aggredì Raisa e Jesahel, mandando la mia primogenita in ospedale senza due dita del piede e lasciando la mia seconda figlia – quella con gli occhi verdi carichi di paura – traumatizzata e urlante. Fu allora che decisi, ma ci vollero altre cinque crisi in due anni per darmi il coraggio di fare quello che sapevo giusto. Non fu facile, credetemi: ho raccontato tutto questo solo per farvi capire il dolore che mi costò questa scelta. Chiamai i miei superiori e gli dissi che dovevo andare via. Che ero instabile e pericolosa e che avrei fatto del male alle persone che amavo, se fossi rimasta. Organizzai con loro tutto: mi avrebbero aiutato a sparire e portata in un posto sicuro, un luogo in cui avrebbero potuto studiare quegli effetti che, fino ad allora, erano stati solo un teorico miraggio. Mi avrebbero curata, dissero. Io annuì, ben conscia che quelle parole le avevo ripetute per anni a umani che non ero stata in grado di salvare. Mi convinsi che non c’era altra soluzione, continuando per giorni a cercare una via di fuga dal mio stesso piano, mentre tenevo Alexei fuori da quella parte di me e facevo progetti per un futuro che, lo sapevo, non avrei avuto. Così fu. Una mattina uscì di casa e non rientrai più. La polizia militare e quella civile si mossero per cercarmi, senza successo: seguirono le mie tracce, cercarono sui video la mia faccia e mandarono in onda messaggi della mia famiglia che prometteva cifre da capogiro a chi avesse avuto informazioni utili a trovarmi – tutto senza successo. Ho visto le vostre facce ogni anno sugli schermi, sapete? Il tredici di dicembre di ogni anno. Accendevo la televisione e vi ascoltavo pregare Agena tutta che vi aiutasse, che non si scordasse di me, che continuasse a sperare con voi. Mi sono vista in centinaia di proiezioni, sui muri esterni dei palazzi e sui contenitori del cibo. Ho visto le vostre lacrime e il dolore che vi avevo causato e mi sono sentita come fosse di nuovo intrappolata in una sfera di Cjera in caduta libera, su un pianeta ancora sconosciuto. Sarei morta o tornata indietro, se non fosse stato per il mio legame con Alexei. Perché, se io mi arrendessi e accettassi il mio destino, lui colerebbe a picco con me. Già lo sto condannando a una vita più corta: come posso metterlo ancora di più in pericolo? Devo dare una possibilità a questo progetto. Lo devo fare per colui che amo e per voi, figli miei. Mi mancate da morire, lo sapere? Ma sono orgogliosa di quello che siete riusciti a diventare nonostante me: Raisa, con i suoi sogni di parole che danno ali alla fantasia di tutta Agena; Jasahel, che ha fatto della sua paura una virtù e ora la trasmette agli altri dall’altro di un pulpito accademico; Arkady, che somiglia così tanto a suo padre in temperamento e volontà, con le sue missioni di esplorazione. Vedervi riuniti lì, ogni anno, con i vostri figli al fianco, mi rende fiera e mi fa male. Vorrei essere con voi ogni giorno. Vorrei svegliarmi e baciare Alexei, stringerlo a me e sentire che lui è completo tanto quanto lo sono io. Vorrei esserci per consigliarvi e vedervi scegliere, per guidarvi al giusto e stringervi a me quando, com’è naturale, tornerete abbattuti e sconfitti; per esaltarvi quando otterrete le vostre vittorie e ridere assieme per le piccole gioie della vita. Vorrei potervi stringere ancora una volta, una sola, e farvi sapere quanto vi amo, quanto vi ho sempre amati. Vorrei trovare le parole per farvi capire l’immensità del vuoto che provo ogni giorno, il dolore della vostra perdita, il rancore e la delusione che mi dà essere la creatura pericolosa e spezzata che sono. Vorrei non avervi dato nessun dolore e, più di tutto, vorrei avervi potuto portare qui con me. Ma che vita sarebbe stata? Trascinata da un laboratorio all’altro, isolata e sommersa dal lavoro per Agena e su di me. Instabile e raminga. Che futuro avreste potuto avere? Quali traguardi avreste raggiunto con una madre a metà e senza una casa? Non lo so, ma non sono mai stata disposta a mettere a rischio il vostro futuro per il mio. Se non altro siete insieme, e questo mi consola più di ogni altra cosa al mondo. E farò tutto quanto è in mio potere perché almeno Alexei rimanga con voi il più a lungo possibile. La nave atterra. Fra poco scenderò e incontrerò il mio destino, la mia ultima possibilità. Il mio corpo invecchia e non mi resta più molto tempo, ormai. Questo diario ha due copie: una tornerà ad Agena, l’altra rimarrà con me. Se l’Hadar che è in me riuscirà a vincere questa battaglia contro il vuoto che mi divora allora sarò io stessa a consegnarvi la memoria. La proietteremo insieme e potrò vedervi arrossire mentre racconto della mia giovinezza. Poi ci sederemo tutti intorno a qualcosa di caldo e parleremo, a lungo e di tutto, come una famiglia. Se non dovessi riuscire, invece... se il tempo a mia disposizione finisse prima che io abbia completato le mie ricerche o se questo si rivelassero l’ennesimo busto nell’acqua, allora saprete che non c’è più bisogno di cercarmi. E mi odierete un po’ per avervi portato via vostro padre, immagino – come mi odio io al solo pensiero di farlo. Ma saprete perché è successo, e che nonostante tutti gli errori della mia vita io sono felice e orgogliosa di aver vissuto abbastanza per dare il tempo a voi di iniziare la vostra. E, anche nel dolore, saprete chi siete e da dove venite. 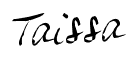  Piccolo spazio-me: oddio, ho della sincera paura a postare questa storia per una serie di motivi che, assurdamente, sono anche quelli per cui ci tengo e che mi hanno fatto lavorare tanto duramente per finirla.
Quali sono? Beh, il pacchetto che ho ricevuto, in primis. Amo la fantascienza, profondamente, ma non gli alieni: datemi mondi distopici, utopici, tecnologici o regrediti e io sarò felice; obbligatemi a scrivere o leggere di alieni e mi vedrete storcere il naso (sarà un caso se gli unici libri di Stephen King che mi mancano da leggere sono quelli con gli alieni? :D) Altro problema: il personaggio buono che non deve morire. Ecco, anche qui ho avuto dei grandi dubbi, perché una parte di me (quella brutta e cinica, credo, o quella che mi vuole molto poco bene) pensa che i buoni finiscano sempre male, e che sia quello il vero dramma. Per non dover ammazzare brutalmente i personaggi positivi, solitamente le mie storie tristi hanno come protagonista un... beh, un caotico-neutrale (un cinico menefreghista che sa come comportarsi bene, a volte), a cui capitano le peggio cose, anche e sopratutto per colpa delle sue scelte. Ho dato già un’idea della difficoltà? Bene, aggiungo che le caratteristiche aliene mi ricordavano troppo quelle di un Drow, e non cadere nel fantasy è stato arduo. Io ci ho provato con tutte le mie forze, davvero! Infine, io ho una sorta di avversione per le storie scritte in prima persona. Non le leggo e praticamente mai le scrivo: allora come ha fatto a venire fuori così, questa? Ancora me lo chiedo. Credo che Taissa abbia voluto scavalcarmi, in qualche modo: deve aver capito che io da sola non ce la potevo fare e ci ha messo del proprio, usando la sua voce e non quella di un narratore esterno per raccontare la sua storia. E questo mi ha sorpresa tanto. Dunque mi scuso se questa long non sarà perfetta: sono una neofita praticamente in tutto! Ma sono soddisfatta, e lo devo dire: finirla stava diventando un’ossessione, ma mi è piaciuto vedere di aver creato un personaggio così distante da me, così diverso dal mio solito. Spero che sia piaciuta anche a te, che hai appena finito di conoscerla! Mi prendo solo un secondo per giustificare i pezzi di canzone all’inizio: non c’entrano granché, lo so, ma è sentendo quella traccia che mi è venuta in mente la storia, quindi mi è sembrato giusto inserirla. Concludo con un piccolo appunto: lo so che ci sono una marea di congiunzioni, pause e ripetizioni (tante di loro fanno male anche a me, credimi!) ma ho pensato che questo... diario? Registrazione? Video? Insomma, questo racconto, non fosse scritto ma registrato, e che quindi Taissa avesse parlato per tutto il tempo. Ora, lei è un alieno superiore e cerca di essere anche forbita, ogni tanto, ma nel parlato a tante cose non si fa caso, per cui le ho lasciate come sono venute. Stessa cosa per i dialoghi diretti, anzi peggiore: lì, per me, non ci sono mai state molte regole che tenessero xD Ok, la smetto. By the way (per dirla alla Red Hot Chilly Pepper) grazie per aver letto. Ecco l’identikit su cui si basa la storia: -Maschio o femmina? Femmina -Buono o cattivo? Buona. -Umano o non umano? Ehm... alieno umanoide (sei dita e cuore a destra). -Occhi? Verdi, come quelli di sua madre. -Vestiti? Praticamente sempre: Uniforme blu di capitano delle guardie o uniforme da lavoro sempre blu (non ama gli abiti da civile). -Poteri? Sì. Se è sì, quali? Vede al buio (come i gatti basta un piccolo chiarore perché per lei sia come pieno giorno) ed ha una naturale predisposizione a combattere i veleni. -Dove vive? Ovunque la porti il suo dovere (detesta i balzi nell'iperspazio, le danno nausea e mal di testa). -Cosa il protagonista fa spesso? Che tic lo caratterizza? Sfiora la spada, che porta al fianco sinistro per rassicurarsi. -Bevanda preferita? Un infuso di drez, erba aromatica presente sul pianeta notturno in cui è nata e che gli preparava sempre suo nonno. -Storia comica, drammatica o commedia? Drammatica ma, vi prego, non uccidetela! (Ovviamente scherzo, fate di lei quello che volete.) -Cosa la tormenta? Nel suo passato è successo qualcosa che le ha spezzato l'animo, ora tiene i suoi sentimenti lontani e non sopporta che qualcuno la sfiori (emotivamente e fisicamente). Ultimi ma fondamentali, i credits > Las-t (passate a rifarvi gli occhi) Fatemi sapere che ne pensate della storia: ci tengo! |