GODZILLA E IL DRAGONE DORATO

Al largo delle Hawaii, il sole del primo pomeriggio scaldava l’immensa distesa del Pacifico, sovrastata da un cielo senza nuvole. L’oceano era calmo e le onde facevano muovere dolcemente una piccola imbarcazione a vela ferma in mezzo a quella vastità blu. Era una rudimentale barca a remi con un piccolo albero al centro e una botola per depositare casse e scorte. A bordo c’era un uomo sulla trentina dalla pelle olivastra, gli occhi azzurri e meditabondi e capelli e barba neri e incolti. Era alto e tozzo, al punto di essere un poco ingrombrante sulla sua barca. Aveva le braccia grosse dai muscoli definiti e le spalle larghe, ma al contempo dalla sua pancia sporgeva un rotolo di grasso poco accennato, ma ben visibile: aveva smesso di tenersi allenato molti anni prima. La sua acconciatura era ancora più trasandata: i suoi capelli erano crespi e gli scendevano oltre le spalle, li teneva legati in una semplice coda; alla barba, invece, dava giusto una spuntata una volta ogni due o tre mesi, giusto per non farla crescere troppo, ma restava sempre selvaggia. Appesa al collo, portava una grossa conchiglia.
Il marinaio, in quel momento, stava tirando su l’ultima delle reti che aveva gettato la notte prima. Per ripararsi dal sole, si era avvolto la sua veste di lino attorno alla testa a mo’ di turbante e cercava di ignorare i raggi roventi sul suo petto peloso e sulla sua schiena sfregiata e solcata per intero da una cicatrice ramificata, di quelle lasciate dai fulmini. A giudicare dal peso della rete, quel giorno aveva preso poco o niente. Quando vide il pescato, sbuffò per la delusione: solo due piccoli tonni. Non avrebbe avuto senso venderli, tanto valeva mangiarne uno quella sera e conservare l’altro. L’uomo tolse i pesci dalla rete, li decapitò e li mise in una cassetta che mise nella botola. Negli ultimi giorni, aveva avuto proprio sfortuna: nelle altre reti non aveva trovato nulla. Non era il suo primo periodo di magra, da quando abitava alle Hawaii, ma quello era senz’altro il peggiore. Non se lo spiegava: in teoria, quello era uno dei periodi più pescosi dell’anno. Spiegò la vela, si mise seduto e afferrò i remi. Tuttavia, appena sollevò lo sguardo per tornare a navigare, vide qualcosa: una piccola sagoma all’orizzonte. Era un puntino nero che si avvicinava sempre di più: una nave. Sospettando di chi potesse trattarsi, il marinaio prese subito il suo cannocchiale dalla botola, andò a prua e osservò l’imbarcazione in arrivo. Era uno sloop piuttosto malandato, col legno consumato e coperto di cirripedi. Quando guardò l’albero, l’uomo vide la conferma di ciò che pensava: una bandiera nera con un teschio e due spade incrociate. Pirati.
“Grandioso, quelli non mancano proprio mai”
Provare a scappare era inutile: lo sloop aveva il vento a suo favore, l’avrebbe raggiunto in pochi minuti. Perciò si rassegnò ad aspettarli e a occuparsene, in un modo o nell’altro. Così ammainò la vela e si sedé a poppa a braccia incrociate, in attesa dei suoi visitatori. Nel giro di pochi minuti, lo sloop si accostò alla barchetta e gettò l’ancora. L’uomo si alzò e guardò il parapetto del vascello, a cui si affacciarono quattro uomini sudici, sfregiati, vestiti di stracci e con facce da galera. L’uomo li fissò tutti senza battere ciglio, riconoscendo subito il capitano dal cappello. Il pirata, sfoggiando un sorriso ad appena sei denti, mise le mani sui fianchi e ridacchiò:
«Pesca grossa oggi, brav’uomo?»
Il marinaio non rispose, limitandosi a corrugare la fronte. Il pirata alla sinistra del capitano, un Indiano con la testa ustionata e le orecchie tagliate, diede un’occhiata delusa alla barca a vela e si lamentò:
«Capitano, perché ci avete fatto cambiare la rotta? Per questo tizio? Avrà solo una manciata di pesci, su quel guscio di legno!»
Il capitano lo fulminò con lo sguardo e tuonò:
«Razza di idiota! Guardalo: questo è un Inglese, è chiaro come il sole! E si sa, signori, gli Inglesi sono ricchi»
Il bucaniere alla sua destra, un tipo basso e muscoloso coi capelli rossi, inclinò la testa perplesso:
«Capitano, cosa vedete di inglese in questa gallinella di mare? A me sembra uno di queste isole, con quella pelle»
Il capitano alzò gli occhi al cielo, frustrato:
«Come se non fossi un uomo di mondo! Siete stati a Londra, di questi tempi? Vi sembrano tutti bianchi? No! Ce n’è di tutti i colori, ce ne sono pure di verdi, con tutto il whiskey che ingollano! Ma lo sguardo inglese non si può confondere: guardatelo bene! Vedete quella superbia velata? Quell’arroganza? Gli Inglesi si credono i padroni del mondo e i loro occhi lo dimostrano!»
Il quarto pirata sembrò ancora più confuso:
«Siete sicuro? A me sembra che ci stia guardando come se fossimo dei buffoni»
Il capitano guardò meglio e rimase interdetto, notando che il marinaio aveva cominciato a fissarli con una faccia a metà fra l’imbarazzato e il divertito. Strinse i pugni e ringhiò:
«Be’, c’è solo un modo per scoprirlo! Da dove vieni, brav’uomo? Se menti, metterò la tua testa nel cannone e la sparerò in cielo!»
L’uomo rispose con tono infastidito:
«Mio padre è inglese»
Il capitano batté le mani soddisfatto:
«A-ha! Che vi dicevo, signori? E tua madre, brav’uomo? No, non dirmelo, non mi interessa. Hai qualcosa di scintillante per noi?»
«No» rispose il marinaio, secco.
Il capitano sogghignò:
«Bene! Sarai tu il nostro bottino! Prendetelo!»
Gli altri tre pirati lanciarono un entusiasta grido di battaglia e sfoderarono i coltelli, pronti a saltare sulla barca e rapirlo, ma quello che accadde li lasciò senza parole: il marinaio si tuffò e raggiunse la scala a pioli dello sloop, salendo a bordo di sua spontanea volontà. I quattro bucanieri sembravano confusi e interdetti. L’uomo rivolse loro un sorriso beffardo e tese i polsi congiunti, come a chiedere di farseli legare. La ciurma si scambiò degli sguardi disorientati, finché l’Indiano non domandò:
«Sei pazzo? Abbiamo intenzione di venderti come schiavo a qualche re del mercato nero cinese o turco, sai?»
Il pescatore fece spallucce e rispose, calmo e composto:
«Lo so»
«Be’, che aspettate? Prendete le catene!» ordinò il capitano, ancora confuso.
Il rosso rivolse uno sguardo circospetto all’ostaggio, mentre l’Indiano correva nella stiva, e gli chiese:
«Tu ci nascondi qualcosa, Inglese color fango. Chi sei? Ti prendi gioco di noi?»
L’uomo non rispose. Abbassò le mani e si tolse il sorriso dalla faccia, iniziando a guardare il pirata basso con irritazione. Passò qualche secondo di silenzio, poi l’Indiano tornò sul ponte con la corda. Il capitano gli ordinò di legare il marinaio, ma il rosso lo fermò e, andando su tutte le furie, riprese il coltello che aveva rinfoderato e si parò davanti all’uomo, paonazzo:
«Non mi piace quando mi ignorano! Tua madre non ti ha mai detto che è maleducato non rispondere, eh? Ora dimmi chi sei, o regalerò le tue trippe agli squali! Come ti chiami, eh?»
Il barcaiolo indugiò, prima di rispondere alla domanda.
«Mi chiamo Alford» rispose.
Il capitano inclinò la testa, intrigato:
«Alford, eh? È un nome insolito, dov’è che l’ho già sentito?» si chiese, lisciandosi i baffi luridi.
«Io non l’ho mai sentito – protestò il quarto pirata – Sicuro che non sia Ford o altro?»
«No, Alford» lo corresse il prigioniero.
Il capitano continuò a rimuginare:
«Eppure giurerei che c’era un periodo in cui tutti non facevano altro che dire Alford»
Il pescatore chiuse gli occhi, scosse la testa e sospirò, stizzito. D'un tratto, prese la conchiglia sulla sua collana, se la portò alle labbra e ci soffiò dentro; la melodia fece eco per l’oceano, disperdendosi nel vento.
«Perché l’hai fatto?» chiese l’Indiano, perplesso.
«Ho visto che a quelli delle Hawaii piace suonare le conchiglie appena possono. Volevi suonare per l’ultima volta, brav’uomo? Fai bene, perché potresti anche dire addio alle tue mani lungo la rotta. Sai com’è, il viaggio è lungo e la ciurma si annoia, ma dobbiamo tenerci allenati» sghignazzò il capitano, sarcastico.
«Volete vivere?» chiese Alford, serio.
«Eh? Cosa?» domandò il rosso.
«Via dal centro della nave» suggerì il prigioniero, prima di indietreggiare con calma verso poppa.
L’Indiano sembrò spazientirsi:
«Quest'uomo è pazzo. Lasciamo perdere, uccidiamolo e basta»
Fece per sfoderare il suo coltello quando, a un certo punto, i pirati si accorsero di un rumore in lontananza: rumore di acqua agitata che diventava più forte ogni secondo che passava. Alford non si voltò, non ne aveva bisogno: sapeva già cos’era e cosa stava per succedere. Non gli rimaneva che godersi lo spettacolo. I pirati corsero verso il parapetto sul fianco sinistro della nave e guardarono il mare. Allora anche Alford non seppe più resistere e si voltò per tenere d’occhio la scena: dall’oceano erano emerse tre file di placche scure e dai bordi frastagliati, che fendevano il mare come scogli durante una burrasca. Man mano che si avvicinavano, quelle creste emergevano sempre di più dall’acqua, finché non si rivelarono essere poco più alte dello sloop. I pirati impallidirono e iniziarono a urlare in preda al panico.
«Abbandonare la nave!» esclamò il capitano, terrorizzato.
A quel punto, si divisero e presero a correre come forsennati verso le estremità opposte del vascello. Alford ne approfittò per andare a poppa e tuffarsi nell’oceano con loro: tra poco non ci sarebbe più stata una nave su cui stare. Quando saltò in acqua, nuotò in apnea per un breve tratto prima di emergere, strofinarsi via l’acqua dal volto e girarsi per guardare cosa stesse succedendo. In quel momento, le creste travolsero lo sloop. Squarciarono in due lo scafo, ci passarono attraverso e scaraventarono via le due metà della nave. I quattro pirati non si tuffarono in tempo: lo schianto li fece letteralmente volare, prima che cadessero in acqua a peso morto. Mentre le due parti distrutte dello sloop imbarcavano acqua e iniziavano ad affondare, quelle maestose file di placche si immersero con calma, svanendo com'erano apparse. Alford non poté fare a meno di ridere sommessamente: era stato troppo divertente. Il suo unico, lieve rammarico fu il fatto che i primi a non riconoscerlo dopo anni fossero stati dei pirati.
Si guardò intorno, in cerca della sua barca a vela, e la ritrovò non molto lontano da lì. La raggiunse con delle agili bracciate, merito di tutti gli anni che aveva passato in mare fin da ragazzo, e tornò a bordo. Si tolse il turbante inzuppato dalla testa e, stando in piedi sulla prua, osservò con aria di sfida i bucanieri che si sbracciavano per aggrapparsi a delle assi di legno che si erano staccate dalla loro nave. Una volta che tutti e quattro ebbero trovato un oggetto che galleggiava, il capitano individuò Alford con lo sguardo e digrignò i denti, alzando un pugno:
«Maledetto! Non la passerai liscia, miserabile! Possa questo malefico mostro divorare anche te e farti in mille pezzi!»
«Fossi in te starei attento a non dargli idee» lo provocò Alford, sornione.
I pirati sembrarono di nuovo confusi. Almeno finché l’Indiano, dopo aver meditato per qualche secondo, trasalì ed esclamò:
«Ah! Capitano! Cosa abbiamo fatto! Lo stavamo prendendo in ostaggio!»
«Sì, e allora?» chiese il rosso, irritato.
«La conchiglia! Ha chiamato lui la bestia! È sua! E quel nome… »
Dopo un attimo di silenzio, gli altri lupi di mare sbarrarono gli occhi e il loro terrore raddoppiò:
«L’Ammazzatitani!» esclamarono, sbigottiti.
Ed eccola lì: la paura. La stessa reazione che chiunque, ai quattro angoli del mondo, aveva quando incontrava Alford e scopriva chi era. Gli occhi impauriti, la soggezione e il timore troppo grandi per rivolgergli la parola o guardarlo in faccia che ormai lo accompagnavano da anni. Non aveva importanza se la gente conoscesse il suo aspetto e il suo nome oppure no: appena la sua identità veniva svelata, qualunque cosa Alford avesse detto o fatto prima di quel momento smetteva di contare: a prescindere da tutto, lui era un mostro per chiunque.
“Come al solito: non si scappa” si disse Alford, demoralizzato.
A un certo punto, però, il capitano strinse gli occhi:
«Bada bene, Ammazzatitani: non mi importa quello che si dice di te, chi distrugge il mio sloop è un uomo morto! Morto! Mi hai sentito? Ti seguirò fino in capo al mondo per…»
All’improvviso, però, il mare alle spalle dei pirati prese a ribollire e, quando lo vide dalla sua barca, Alford riuscì a scacciare la malinconia: era arrivata la sua parte preferita. Allarmati dal ribollio, i pirati si voltarono a guardare e si ritrovarono faccia a faccia con l'imponente muso di una bestia colossale, immersa fino alle narici come un coccodrillo. I pirati urlarono terrorizzati e il mostro gigante dilatò le narici, travolgendoli con uno sbuffo di vento bagnato che fece volare via il cappello del capitano. La creatura fissò i bucanieri stringendo i minacciosi occhietti arancioni e scoprì i denti acuminati. Emerse a poco a poco fino alle spalle e oscurò i bucanieri con la sua ombra. Adesso, un gigantesco rettile marino con tre eleganti creste ossee sul dorso si stagliava sui pirati immerso fino alle spalle, fissandoli da sette metri di altezza.
Alford sorrise e incrociò le braccia, osservando i quattro lupi di mare urlare in preda al panico, incapaci di distogliere lo sguardo dalla creatura per il terrore. Il rettile gigante socchiuse la bocca con un grave muggito gorgogliante e sbuffò del fumo azzurro, come se fosse provocato dalle loro grida. A quel punto, il panico prese il sopravvento e i pirati persero il lume della ragione: abbandonarono le assi di legno e presero a sbracciarsi, nuotando in tutte le direzioni per fuggire, come se potessero andare da qualche parte. Dopo averli osservati incuriosito per un po', il mostro rivolse uno sguardo interrogativo ad Alford, in attesa di scoprire cosa voleva che facesse. Lui sollevò entrambe le braccia: se le avesse allargate tenendole in alto, significava che la creatura doveva risparmiare i pirati; se l’avesse fatto abbassandole, i bucanieri sarebbero stati spazzati via. Era un piccolo codice che i due avevano imparato a usare con gli anni, per comunicare a distanza. Alford divaricò le braccia tenendole sopra la sua testa:
«Hanno recepito il messaggio, Godzilla» disse.
Il suo titano gli rispose con un grave verso gutturale che gli fece vibrare i timpani e il diaframma, poi aggirò il pezzo di legno a cui i pirati erano aggrappati con la poca delicatezza che riuscì ad avere e si accostò alla barca di Alford, avvicinando il muso alla scialuppa. L’Ammazzatitani, allora, prese una cima fissata alla prua che terminava con un enorme lasso, prese la mira e lo lanciò, centrando il collo di Godzilla. A quel punto strinse il lasso, lo assicurò e si aggrappò all’albero, prima di fischiare. Il gojirasauro, allora, iniziò a nuotare mantenendo il muso e la cresta in superficie, trainando dolcemente la barca. Mentre navigavano verso l’isola di Oahu, Alford si ricordò di fare un meritato complimento al suo fedele compagno di avventure:
«Sei stato bravo, amico, stai imparando: per pirati e banditi, resta sul semplice. Il raggio lascialo pure ai titani, quando serve. Speravo che l’avessi capita!»
Godzilla sollevò leggermente il muso dall’acqua ed emise un basso gorgoglio di contentezza, riconoscendo la lode dal tono dell’umano. Con un sorriso compiaciuto, Alford si sedé a poppa e si godé la piacevole brezza sul viso e sul petto ad occhi chiusi, in attesa di arrivare alla terraferma.
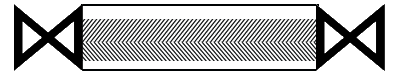
Godzilla nuotò fino alla costa nord-orientale di Oahu e approdò sull’isoletta di Kukuiho’Olua, a qualche centinaio di metri dall’entroterra, dove Alford abitava come un eremita. Certe volte non riusciva proprio a capire se era contento di quella solitudine o se gli dispiaceva. Quando il suo titano appoggiò le zampe sul fondale, Alford sciolse il lasso e remò fino alla sponda. Una volta che scese a terra, la spiaggia fu adombrata di colpo e lui non sentì più il calore del sole. Si voltò e sorrise: Godzilla si era alzato del tutto, torreggiando sulla piccola isola dai suoi trentuno metri di altezza.
Come tutte le volte, Alford non poté fare a meno di prendersi un momento per ammirare il suo compagno di avventure ereditato da suo padre, da suo nonno prima di lui e dal bisnonno prima ancora: la sua impressionante armatura di grosse e spesse scaglie, così dure e ruvide da sembrare, a occhio come al tatto, scolpite nella roccia viva, una corazza durissima segnata qua e là dalle cicatrici delle battaglie più temibili; i fianchi, le placche addominali e il muso erano marchiati da vecchi sfregi molto simili a quelli del padrone. Aveva un’elegante coda larga ma flessibile, che frustava l’acqua e gli avversari allo stesso modo: era un’efficace arma che non deludeva mai. Le tozze e imponenti zampe posteriori sostenevano come colonne un massiccio corpo soltanto in apparenza goffo e ingombrante, ma che apparteneva a un fiero combattente, un guerriero nato per tenere testa a qualunque minaccia dovesse affrontare. Le zampe anteriori corte, ma dalla forza sorprendente e armate di artigli affilati, erano spesso lasciate a riposo lungo i fianchi. E, infine, c'era la più grande meraviglia dei gojirasauri: la cresta a tre file sul dorso. Maestose placche scanalate e dai bordi irregolari, simili ai rami di un albero spoglio, in cui scorreva la devastante energia degli atomi, l’arma più potente e temuta della specie di Godzilla. Il padre di Alford gli aveva garantito che non si sarebbe mai sentito abbastanza fiero di avere una creatura simile al suo fianco, quando l’enorme responsabilità del titano della famiglia era passata a lui, e ogni giorno l’Ammazzatitani constatava che era proprio vero.
Godzilla si scrollò l’acqua di dosso con un paio di pigri scossoni e, con uno sbuffo, si incamminò placidamente verso la baia in cui andava sempre a riposare, facendo tremare la terra coi suoi passi. Alford, allora, si riscosse da quel momento di contemplazione e tornò alle sue faccende: era ora di pranzo. Prese la cassa coi tonni dalla botola e scese a terra, quindi si avviò verso il suo modesto e solitario bungalow circolare in legno e paglia in mezzo ad una macchia di palme. La sabbia calda gli scottava le piante dei piedi nudi mentre camminava. Una volta che fu in casa, lasciò la cassa accanto alla soglia e andò ad aprire la credenza in cui teneva il sale, le spezie e i condimenti, accanto alla cucina da campo. Appena aprì lo sportello, però, Alford rimase di sasso: aveva esaurito il sale e gli rimaneva solo mezzo sacco di pepe nero e cumino. Non avrebbe potuto tenere da parte il secondo tonno. Questo non gli lasciava alternative.
“No, dannazione! Non di già!” pensò, scoraggiato.
Era costretto ad andare a Honolulu per fare rifornimento. Questo significava fare i conti con la paura che la gente aveva di lui. O meglio, la paura che avevano di Godzilla e, pertanto, di lui, a causa di tutte le voci che giravano per il mondo sui suoi trascorsi

Alford tornò a passo spedito alla sua barca, la slegò e iniziò a seguire la costa aiutandosi col vento. Quando passò davanti alla baia personale di Godzilla, vide che il suo titano stava già dormendo: riusciva a sentire i suoi profondissimi respiri. Erano già accorsi diversi uccelli, venuti a posarsi in riga sulle placche dell’enorme rettile mentre rimaneva lungo disteso. Di lì a poco, qualche rettile si sarebbe arrampicato su di lui per prendere il sole come sulle rocce. Alford circumnavigò l’isola godendosi la brezza oceanica, fino ad arrivare al porto di Honolulu. Gli attracchi erano aumentati all’inverosimile negli ultimi anni, da quando i viaggi attraverso tutto il globo erano diventati così frequenti. Le grandi nazioni dell’Occidente e dell’Oriente investivano sempre di più nei commerci tra continenti e le Hawaii erano passate da una semplice fermata per chi faceva la traversata del Pacifico a uno di molti punti di incontro insulari tra mercanti e uomini d’affari di tutto il mondo.
Alford era sempre stato affascinato dal fatto che le isole fossero da sempre considerate dei porti franchi: da Capo Verde ai Caraibi, dalla Polinesia alle Hawaii, in quei punti isolati nell’oceano si faceva sempre finta che le grette rivalità e tensioni tra monarchie e imperi vari non ci fossero. A partire dal 1745, cinque anni prima, il fenomeno gli pareva ancora più evidente. Gli era capitato di sentire che uno di quei cosiddetti “illuministi”, nei loro salotti in Francia, aveva scritto in una rivista che il mondo era partito di corsa dopo aver camminato a passo pigro per secoli. A quanto pareva, non aveva torto. Alford non aveva dubbi che questo repentino sviluppo globale fosse dovuto in parte al fatto che le nazioni avevano iniziato a fidarsi sempre di più dei Padroni di Titani come lui e a chiedere loro una mano per accelerare i loro progressi economici e intimidire i regni rivali. I titani erano stati anche utilissimi per spedizioni ed esplorazioni: grazie a loro, il globo era stato mappato per intero in pochissimi anni. I geografi dicevano che, senza quegli interventi, ci sarebbero voluti ancora dei secoli.
Alford si riscosse dalla sua riflessione sull’attualità quando si avvicinò alle decine di vascelli da tutti gli angoli del mondo attraccati a Honolulu: doveva trovare un ormeggio libero tra le barche come la sua. Si aggirò tra galeoni e brigantini, iniziando a sentire il vivace brusio del villaggio; alla fine, trovò un posto libero tra due scialuppe lungo uno dei pontili più esterni. Approdò, legò la sua barca a vela e attraversò il molo preparandosi a trattenere il disagio che lo attendeva: era ora di apparire in pubblico; purtroppo, per quanto autonomo si sforzasse di rendersi, non poteva sfuggire all’inevitabile ritorno alla società che gli toccava ogni tanto. Iniziò a dirigersi verso il mercato per prendere il sale. Lungo il percorso, fiangheggiò un terreno disboscato in cui i contadini fertilizzavano il suolo coi concimi derivati dallo sterco dei titani, ironicamente una merce quasi più pregiata dei metalli preziosi.
Honolulu era ormai in tutto e per tutto un villaggio cosmopolita come tutte le città isolane: oltre ai tradizionali bungalow degli Hawaiani, si trovavano varie locande, botteghe e edifici costruiti dai visitatori dal resto del mondo; era anche possibile suddividere il centro abitato in piccoli “cantoni” in cui si raccoglieva la gente che parlava la stessa lingua. Il contrasto culturale era stato quasi sconvolgente per i nativi delle Hawaii, fino ad alcuni anni prima, ma col tempo era diventata la nuova normalità. Tutti stavano accettando a poco a poco la nuova realtà in cui tutti stavano diventando "cittadini del mondo". Alcuni mercanti e imprenditori avevano cavalcato quell’onda con talmente tanto successo che le loro compagnie erano conosciute dappertutto e avevano almeno una sede in tutti i continenti. E, proprio in quel momento, Alford si accorse di qualcosa che attirò la sua attenzione: in mezzo a un palmeto stavano costruendo una nuova fucina e gli operai stavano issando l’insegna: I Ferri di Franchi.
“Franchi? Alla fine ha raggiunto anche il mio buco” pensò Alford, sarcastico.
Non c’era esploratore, soldato, mercenario o chiunque lavorasse brandendo un’arma che non conoscesse il mercante italiano Luigi Franchi, il padrone della più grande compagnia di fabbri del globo. Aveva la sua sede centrale a Venezia e da lì, nell’arco di dieci anni, aveva fatto una fortuna espandendo la sua attività in tutto il mondo, con la sua competitività feroce e le sue politiche aziendali aggressive. Era il migliore sulla piazza e Alford lo conosceva di persona; ma faceva tutto parte del passato. Il passato che ora gli era costato la sua reputazione.
A quel punto, raggiunse il mercato. Si mise a seguire la strada cosparsa di tende e banconi che radunavano tutte le culture dai sei continenti. La gente discuteva sugli affari, trattava sui prezzi, trasportava oggetti e alimenti lungo la strada, i bambini hawaiani osservavano e ascoltavano curiosissimi i mercanti da terre lontane, alcuni venditori con pochi clienti conversavano e raccontavano storie coi loro vicini di bancarella; tutta quella frenesia e vivacità si congelava per alcuni momenti, all’arrivo di Alford. Alla sua vista, i presenti nativi e non iniziarono a lanciargli occhiate sospettose e diffidenti, quando lo vedevano passare. Cessavano le loro conversazioni o i loro affari per osservare l’Ammazzatitani, i loro occhi passavano dal sorpreso al guardingo e intimorito in un battito di ciglia. Dopodiché, in modo forzato, tornavano a fare quello che stavano facendo, ma ormai erano distratti da lui. Alford sentiva ognuna di quelle occhiate su di sé, le percepiva mentre i loro occhi si puntavano su di lui e non lo lasciavano più andare, come se fosse una mosca in una ragnatela. E gli sguardi aumentavano, si accumulavano, lo schiacciavano come macigni: lo giudicavano. Lo giudicavano e lo condannavano, lui lo sapeva. Lo sentiva dentro di sé; ma, finalmente, trovò quello che cercava: un mercante di sali dall’India. Alford scacciò tutti i pensieri angoscianti dalla testa e si concentrò su quello che doveva fare. Si avvicinò alla bancarella e salutò, cercando di sembrare il più naturale possibile.
«Salve. Ho bisogno di fare scorta di sale»
Si morse la lingua senza darlo a vedere: come al solito, era stato freddo e meccanico. Gli succedeva tutte le volte, il che di certo non lo aiutava con le persone. Il mercante lo fissò sorridente per alcuni attimi, poi sembrò capire chi avesse davanti e rimase di sasso. Restò interdetto, con gli occhi sbarrati e la bocca semi-aperta, per vari secondi, tanto che Alford iniziò a sentirsi in imbarazzo e cercò di smuovere la situazione:
«Mi serve sale per almeno un mese. Devo conservare del pesce»
A quel punto, il venditore si riscosse e farfugliò il prezzo in rupie per un sacco di sale con fare intimidito. Alford disse di non avere rupie, solo corone britanniche. Il mercante reagì come se fosse appena stato minacciato di morte e lo rassicurò sudando freddo che andava bene lo stesso, che si sarebbe arrangiato ad andare da un cambiavalute. Alford annuì, sconfortato dal modo di fare dell’Indiano, e frugò in un sacchetto che aveva portato dal suo bungalow, porgendogli l’equivalente in corone del prezzo. A quel punto ricevé il sacco di sale e iniziò ad andarsene, senza ringraziare né salutare: aveva fatto quello che doveva, ora la sua unica preoccupazione era levare le tende il più in fretta possibile, finché riusciva a sopportare le occhiate. Sapeva bene che il suo atteggiamento lo faceva sembrare uno stronzo, ma non gli importava più da parecchio tempo. Tanto, ormai, lo evitavano a prescindere.
Tornò al molo a passo svelto. La calma del pontile delle barche lo fece sentire liberato da un peso: lì c’erano solo alcuni pescatori che maneggiavano le cime o le reti o conversavano tra loro, si sentiva molto più a suo agio che in mezzo al villaggio. Muovendosi in fretta per farsi notare il meno possibile dai pochi presenti, Alford raggiunse la sua barca a vela e sistemò il sacco di sale nella botola. Era ora di tornare da Godzilla e godersi finalmente il pranzo. Ma, mentre si preparava a sciogliere la cima, sentì dei passi sul legno dietro di sé e il gracchio di un pappagallo. Poi una voce allegra lo chiamò:
«Ehi, tu! Il tizio dei titani, giusto?»
Perplesso, Alford si voltò e vide un giovane uomo hawaiano a petto nudo dal fisico in ottima forma, coi capelli lunghi, un pizzetto, dei tatuaggi sul braccio sinistro e un sorrisetto spiritoso stampato in faccia. Posata sulla sua spalla, c’era un’amazzone dalla corona rossa, un pappagallo verde originario delle Hawaii. L’approccio del ragazzo stupì Alford al punto da disorientarlo: cos’era quel tono scherzoso, quasi di sfida? Come doveva interpretare quell’espressione spensierata? Non sapeva chi avesse davanti? No, impossibile: ormai tutti alle Hawaii lo conoscevano di volto e di nome. Quindi perché non lo evitava e disprezzava come tutti? Guardandolo bene, però, Alford intuì che quella faccia era forzata: stava solo fingendo di essere così disinvolto. Quindi, sotto la superficie, anche lui era intimorito come gli altri; ma allora perché era venuto da lui? Non si rese conto di essersi perso nelle sue riflessioni finché la smorfia del ragazzo non si spense poco alla volta, lasciando il posto a un’espressione genuinamente perplessa.
«Ehi, ti sei incantato? Sei quello che va in giro a scannare titani o no?» gli chiese.
Alford cercò ancora un po’ di provare a intuire che intenzioni avesse quel tipo, prima di riuscire a elaborare una risposta diffidente:
«Sì. Sarebbe “l’Ammazzatitani”»
Il sorrisetto ritornò sulla faccia dell’Hawaiano:
«Oh, allora sai parlare! Io sono Kilani» si presentò.
Alford tacque un secondo, prima di decidere di assecondare quel tentativo di conversazione: non gli capitava un’occasione come quella da anni, valeva la pena godersela.
«E io sono Al…»
Fu interrotto dal pappagallo di Kilani che, di punto in bianco, gracchiò:
«Craaaaaaa! Bella signorina! Bella signorina!»
Kilani trasalì e strabuzzò gli occhi, diventando subito paonazzo. Alford rimase a bocca aperta, più confuso che mai, chiedendosi sul serio se aveva capito bene quello che aveva appena sentito. Credé davvero che l’uccello si riferisse a lui, prima di notare che sia l’amazzone che il suo padrone stavano guardando oltre le sue spalle. Si girò, incuriosito, e vide una giovane ragazza che fissava Kilani con uno sguardo colmo di disagio. Era seduta sul pontile per fissare l’orizzonte, ma si alzò subito e si allontanò facendo finta di nulla. Alford, davanti a quella scena, non poté fare a meno di lasciarsi sfuggire un sorriso divertito. Tornò a guardare Kilani, che si stava coprendo gli occhi con una mano. Poi guardò il suo pappagallo e lo rimproverò scherzosamente:
«Ma che fai? Così mi fai fare brutta figura! Davanti al tizio dei titani, poi! Hai imparato a fare il trucco, ma non a scegliere il momento, eh?»
Alford, intanto, lo fissava senza proferire parola, indeciso su cosa dire o se fosse anche solo il caso di fare un commento. Quel momento era già imbarazzante di per sé, non gli sembrava il caso di peggiorare la cosa. Si sentiva più a disagio ogni secondo che passava. Quando Kilani se ne accorse, fece una faccia da ebete per un rapido istante, per poi tentare in fretta e furia di giustificarsi, rimettendo subito la maschera di sicurezza che aveva all’inizio:
«Eh, sai com’è, “Al”… non si sa mai chi la prende bene, chi la prende male e chi ha un padre geloso, così lascio il lavoro sporco a lui! Se lo dice un pappagallo, nessuna si offende: anzi, funziona meglio perché le fa ridere!»
Alford continuò a tacere, iniziando a considerare l’idea di ignorarlo, salpare e fare finta di niente, come aveva fatto la ragazza. Kilani si affrettò a continuare a difendersi:
«Eddai, questa era una cilecca sfortunata! Tutte le altre volte funziona, è un metodo garantito»
Finalmente, Alford riuscì a decidersi e rispondergli:
«Non ne dubito. Hai bisogno di qualcosa?» chiese, andando subito al punto.
Notò che Kilani aveva tirato un sospiro di sollievo, anche se cercava di non darlo a vedere: si era salvato dalla gaffe imbarazzante, quindi recuperò la sua compostezza. Stavolta, però, si fece più serio:
«A dire la verità, tutte le Hawaii hanno bisogno di aiuto, soprattutto noi pescatori di Ohau. Solo che tutti i miei compagni hanno troppa paura di te, così mi hanno chiesto di andare a chiederti un favore. Li capisco bene, in fondo nessuno resiste al mio carisma» ridacchiò.
Dentro di sé, Alford era pronto a scommettere che i pescatori dell’isola avessero mandato il più scemo, sapendo che non si sarebbe fatto problemi a parlare con lui. Ma non vedeva alcun motivo per lamentarsene; a quel punto, anche quel palese dongiovanni gli andava benissimo, se signficava non essere trattato come il demonio. Riflettendoci bene, se aveva capito l’antifona, quella era un’opportunità preziosa come l’oro: se gli avessero chiesto un aiuto importante e lui si fosse reso utile, forse avrebbe potuto fare qualcosa per dimostrare agli Hawaiani che, in realtà, non avrebbe mai fatto del male a nessuno. D’altronde, un po’ era anche colpa sua se, da quando aveva cambiato vita, non aveva mai svolto neanche un “lavoro” da quelle parti, ma solo in posti troppo lontani perché la notizia arrivasse fin lì. E così, spinto da quella speranza di ripulire la sua reputazione sulle “sue” isole, scese dalla barca e tornò sul pontile, incrociando le braccia e guardando Kilani con attenzione:
«Ti ascolto» si limitò a dire.
Allora Kilani gli si avvicinò, facendo crescere a dismisura il disagio di Alford, e gli sussurrò come se stesse per confidargli un segreto:
«Prima di tutto, giusto per sicurezza… non sei tu che ci stai rubando tutti i pesci, vero? Sai com’è, credo che un bestione come il tuo debba mangiare tanto»
«Ehm… cosa?» domandò Alford, più confuso che mai.
Kilani gli rivolse un’occhiata inquisitoria talmente esagerata da essere quasi caricaturale, prima di scoppiare a ridere:
«Ahaha! Rilassati, ti stavo solo mettendo alla prova! Si vede che non hai idea di cosa parli, quindi sei innocente»
«Godzilla mangia solo balene, quando non assorbe l’energia da sottoterra» spiegò Alford, con naturalezza.
Kilani strabuzzò gli occhi:
«Ah… uao. Lo dicevo che deve mangiare tanto. Vabbè. Il fatto è questo: ormai è da una settimana che nessuno riesce più a portare a casa un pescato decente. È una fortuna se riusciamo a prendere uno o due pesci nelle reti!»
Alford era molto intrigato: allora la sua pesca scarsa degli ultimi tempi non era stata una sua sfortuna, tutte le Hawaii stavano attraversando un periodo di magra inaspettata. I mari dell’arcipelago erano sempre stati molto pescosi, specialmente in quel periodo dell’anno, quindi una scomparsa improvvisa di tutto il pesce poteva significare solo che c’era una moria o qualcosa che li faceva scappare tutti. E in natura c’era solo una cosa che potesse provocare questi squilibri in natura: un titano.
«Un titano si è fermato qui e ha iniziato a mangiare tutti i pesci» affermò, quasi pensando ad alta voce.
Kilani schioccò le dita e annuì:
«Sì! È quello che abbiamo pensato subito anche noi! Allora ci siamo riuniti per decidere cosa fare e abbiamo subito pensato a te: sappiamo che sei famoso perché dove passa il tuo amicone i titani tagliano la corda. E quindi eccomi qua. Allora, che ne dici? Insomma, è un problema anche per te: tutti abbiamo bisogno di pescare! Sarebbe un vantaggio per tutti»
Questo era innegabile. Ma era anche il momento di mostrare a tutti la vera natura del nuovo Ammazzatitani. Quindi Alford annuì:
«È vero. Vi aiuterò»
Kilani sorrise, raggiante:
«Fantastico! Passiamo subito alla nota dolente: cosa ti dovremo, in cambio?»
Di solito, quella domanda era l’unica parte davvero importante di un ingaggio, per Alford. La risposta cambiava sempre: a volte gli serviva solo l’ospitalità di una comunità per qualche settimana, a volte doveva rimpinguare i suoi soldi ma, in quell’occasione, aveva un nuovo scopo: fare bella figura. E poi, anche se persino una parte di lui la trovava una scemenza filosofica, l’eventuale riconoscenza degli isolani sarebbe stata tutto quello che gli serviva. Tanto avrebbe dovuto provvedere da solo a pescare, dopo che i pesci sarebbero tornati. Così alzò la mano e scosse la testa:
«Non vi preoccupate, questa disinfestazione ve la farò gratis»
Kilani parve non crederci:
«Però, è molto altruista da parte tua. Sul serio, quanto o cosa vuoi?»
«No, no, sono serio: non voglio niente. In questo caso, conta solo riportare i pesci, allora non mi servirà un pagamento per andare a prenderli»
Preferì trovare una scusa concreta: sarebbe stata molto più credibile della storiella della gratitudine. Kilani fu indeciso per qualche secondo, ma alla fine si convinse e fece spallucce:
«Contento tu, contenti noi. Affare fatto!»
Anche il suo pappagallo sembrò contento, perché emise un paio di gracchi vivaci e si scrollò le piume. L'Ammazzatitani e l'Hawaiano fecero per stringersi la mano per siglare l'accordo, ma furono interrotti all'ultimo secondo da grida ed esclamazioni da tutto il porto. Perplessi, si guardarono intorno e si accorsero che tutti i presenti sui pontili e a bordo dei vascelli stavano osservando l'oceano, spaventati e sconvolti. Dopo essersi scambiati uno sguardo allarmato, si voltarono verso il Pacifico e sobbalzarono, alla vista di quello che stava succedendo al largo: a qualche centinaio di metri della costa di Oahu, un brigantino stava venendo risucchiato sott'acqua. Il mare tutt'intorno al vascello spumeggiava e girava furiosamente in cerchio, intrappolando la nave in un ampio mulinello che le impediva di allontanarsi e che la trascinava sempre più in fretta nelle profondità. Nel giro di pochi minuti, davanti agli sguardi sconvolti e impauriti dei marinai e degli abitanti di Honolulu accorsi per guardare la scena, il brigantino si rovesciò su un fianco e fu inghiottito del tutto dall'oceano, che smise di vorticare e ribollire pochi istanti dopo. All'improvviso, fu come se quella nave non fosse mai stata lì. Era stata portata negli abissi, con tutto il suo equipaggio e il suo carico, da un momento all'altro. Dalla folla che si era radunata in fretta al porto, si sollevò un gran trambusto carico di panico e sgomento. Kilani rivolse uno sguardo preoccupato e stravolto ad Alford:
«Maledizione! Questo è... è stato...»
Presumendo che stesse per chiedergli cosa fosse stato, Alford gli rispose:
«Sì, era per forza il titano che ha spaventato i pesci. Non c'è dubbio: ha stabilito il territorio, adesso penserà anche a difenderlo, non solo a cercare il cibo. Nessuno sarà al sicuro al largo, finché starà qui»
«Devi fare qualcosa! Non possiamo permettere che succeda di nuovo!» esclamò Kilani, serio, indicando l'oceano.
L'Ammazzatitani annuì:
«Assolutamente. Questo problema va ben oltre la pesca. Vado dal mio amico e inizio subito la caccia: non c'è tempo da perdere» affermò, determinato.
«Bene. Buona fortuna, Al!» lo incoraggiò Kilani, prima di allontanarsi a passo svelto.
Alford borbottò un ringraziamento e sorvolò su quel nomignolo su cui ormai Kilani si era fissato, saltando sulla sua barca e slegando le cime. Uscì dal porto di Honolulu e iniziò la rotta di ritorno alla sua piccola isola, stando il più vicino possibile alla costa. Godzilla doveva intervenire subito: quella faccenda si era rivelata molto più grave di quanto sembrasse. Non poteva lasciare che altri marinai venissero uccisi dal misterioso titano che aveva fatto dell'arcipelago il suo territorio di caccia: era il momento che l'Ammazzatitani agisse e desse prova del suo titolo.
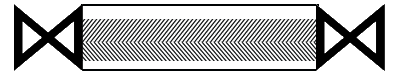
ANGOLO AUTORE:
Il personaggio di Kilani è una citazione, un cameo di un personaggio originale della mia mentore Maya Patch: si tratta di uno dei sopravvissuti nella sua FF di ARK. Ve la consiglio!


